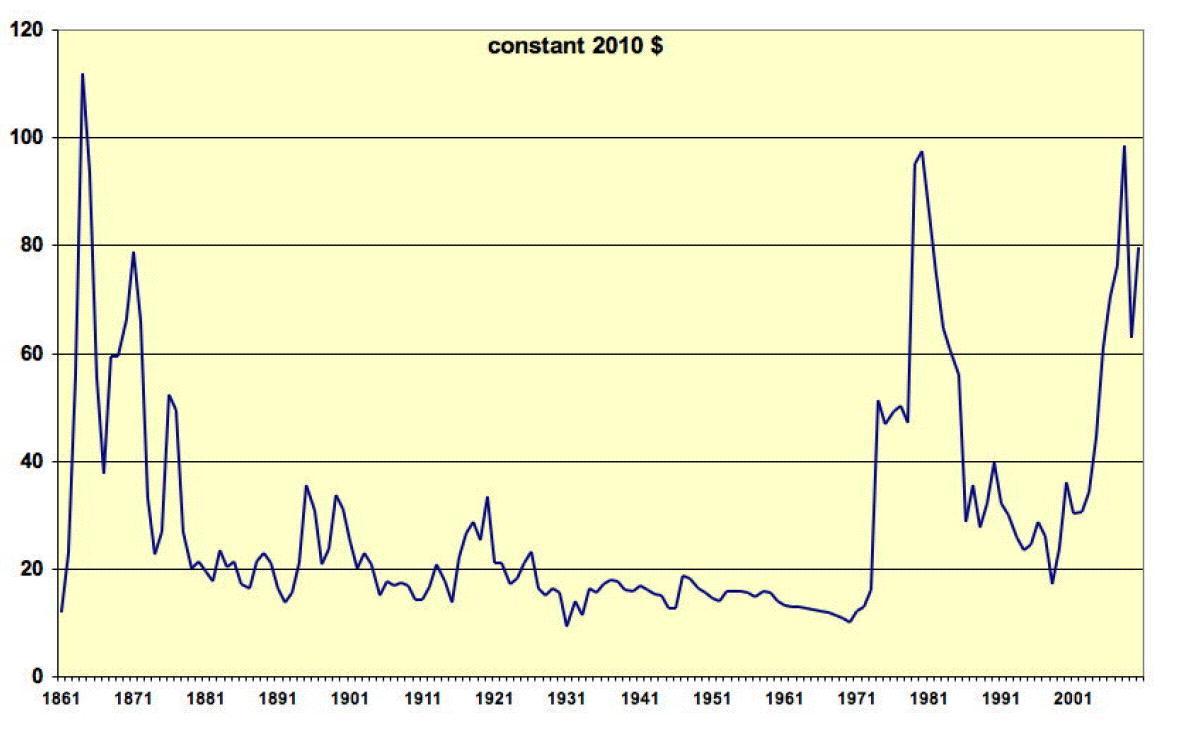
|
|||
|
Il petrolio, i monopoli, l’imperialismo (Il Partito Comunista, n.357, 2013 - 373, 2015)
|
|||
| 1. Corsa all’oro nero e
monopoli - 2. Il petrolio in Russia - 3. Il gioco si allarga all’Asia - 4. Concentrazione
e monopoli - 5. La
nostra bussola: Lenin - 6. La
nuova funzione delle banche - 7. Il capitale
finanziario - 8.
Esportazione di capitale - 9. La spartizione del
mondo tra i grandi
trust - 10. La contesa tra le potenze imperiali
- 11. Il posto
dell’imperialismo nella storia - 12. Lo scontro
per il petrolio
mediorientale - 13. I ladri di Baghdad - 14. Prove di guerra tra
fratelli - 15. Imperialismo e Rivoluzione in
Russia - 16. Epoca usuraia
del Dollaro - 17. Una Linea Rossa sul
Medioriente - 18. La dittatura
delle Sette Sorelle - 19. Le api sul miele- 20. Immoralità o
rendita fondiaria? - 21. Italia vaso di coccio
- 22. Messico e
Venezuela - 23. La crisi del 1929 - 24. Una Germania a secco - 25. Iran
crocevia dello scontro tra imperialismi - 26. Giappone
e petrolio - 27.
Il grande affare della Seconda Guerra - 28. Il
nuovo ordine mondiale - 29. Usa-Urss
collaborazione e contenimento
- 30. Porta aperta agli Usa
- 31. La chimera del panarabismo - 32. Lo scontro per il petrolio
algerino - 33. Sovrapproduzione e nascita
dell’Opec - 34. La guerra dei
Sei Giorni - 35. La spallata di Gheddafi - 36. La crisi economica
mondiale, 1973, il primo choc petrolifero - 37. 1979,
il secondo choc
- 38. Il petrolio del Caspio - 39. In
Africa - 40. In Iraq - 41. Il
prezzo del greggio - 42. Produttori,
produzioni, consumi - 43. Le
riserve - 44. Una sola alternativa: la
rivoluzione |
Oggi
come ieri, un fattore non secondario nella contesa fra le potenze
imperialiste è costituito dal controllo delle materie prime e
delle
fonti di energia indispensabili per il funzionamento della macchina
produttiva capitalista. In particolare, la storia del petrolio è
piena di insegnamenti sui conflitti per la spartizione dei profitti e
delle rendite, e del potere, fra i monopoli e fra gli Stati.
Si può dividere questa storia in due grandi tappe separate dallo spartiacque della Seconda Guerra mondiale. Nella prima assistiamo alla formazione dei grandi monopoli petroliferi, alle lotte senza quartiere per il controllo dei mercati internazionali, alle guerre di spartizione coloniale, alla ricerca di nuovi giacimenti – dal Venezuela al Messico e dall’antica Persia all’Indonesia.
Dopo la Seconda Guerra mondiale, la storia del petrolio s’intreccia con la presenza dell’imperialismo occidentale nel Medio Oriente. Quest’area, con il suo petrolio a buon mercato e le aspettative di immensi profitti, diventerà preda di tutti gli imperialismi: qui le grandi industrie petrolifere internazionali, soprattutto a base Usa, a rimorchio degli interventi militari delle potenze cui fanno capo, si impadroniranno delle ricchezze dei paesi produttori.
Le rivolte sociali che nel corso del 2011 hanno sconvolto l’Egitto, la Tunisia, la Libia ed altri paesi soggetti alle potenze imperialiste, determinate dalla crisi economica generale che attanaglia il capitalismo, hanno trovato nell’area mediorientale un terreno fertile: è qui che si annodano gli interessi politici, economici e strategici del capitale finanziario mondiale. Se le scosse hanno per ora risparmiato paesi quali l’Algeria e il Marocco ciò è dovuto al fatto che le borghesie locali hanno utilizzato la manna petrolifera o hanno fatto ricorso ad un massiccio indebitamento per soddisfare i bisogni di una parte della classe media, comprandosi la pace sociale, sull’esempio delle borghesie dei paesi occidentali, dove l’opportunismo ha da un secolo e mezzo messo le sue salde radici.
Tralasciando qui gli aspetti di natura politica conseguenti la penetrazione economica, questa lotta per la conquista dei mercati è divenuta accanita in seguito ai mutamenti nel mercato mondiale a partire dall’inizio del Novecento e caratterizzati dalla importanza acquisita dall’esportazione di capitali rispetto all’esportazione di merci, dal predominio del capitale finanziario in campo internazionale e dalla periodica ripartizione del mondo tra i grandi Stati. Dietro a questi importantissimi mutamenti rispetto all’epoca del capitalismo concorrenziale, e che Lenin definirà come imperialismo, non bisogna vedere una particolare politica economica di aggressione, ma una fase del capitalismo in cui prevale una struttura monopolistica della società.
Il modo di produzione capitalista, nato nel XVI secolo, alla fine del feudalesimo, con la creazione del mercato mondiale, si caratterizza per una legge intangibile: produrre per produrre. La necessità dell’accumulazione spinge il capitale ad abbassare i costi di produzione e aumentare la produttività del lavoro. All’iniziale divisione tecnica del lavoro basata sulla cooperazione e la manifattura, farà seguito lo sviluppo del macchinismo e un conseguente mutamento delle fonti di energia utilizzate nella produzione: fino ad allora erano ancora quelle del Medioevo: acqua, legna, vento, forza animale.
La prima rivoluzione tecnica si ebbe a mezzo del XVIII secolo, in Inghilterra, con il passaggio al carbone e l’invenzione della macchina a vapore che permise al capitalismo di avviare il processo mondiale di industrializzazione e di sviluppare una tecnica adeguata al suo specifico modo di produzione. Come scrive Marx nel Capitale, il genio di Watt si rivela nel fatto che presenta la sua macchina a vapore non come una invenzione a scopi particolari, ma come agente generale della grande industria.
Alla fine dell’Ottocento altre due grandi innovazioni tecniche, l’elettricità, un’energia facilmente trasportabile, e il motore a combustione interna, metteranno le ali alla produzione e ai trasporti. Il motore a scoppio e il motore elettrico determinano l’abbandono dei motori azionati dal vapore.
Prima
della diffusione di massa dell’automobile e dei consumi domestici e
produttivi dell’elettricità, il petrolio è solo la
materia prima
da cui si ricava il cherosene da illuminazione e da riscaldamento dei
quali copre non più del 4% del fabbisogno mondiale. Solo con la
Prima Guerra mondiale sarà avvertita la sua importanza
strategica
come fonte di carburante per i motori terrestri, navali ed aerei.
Oggi, con una quota dieci volte più grande, il petrolio è
la prima
fonte mondiale di energia.
1.
Corsa all’oro nero e monopoli
La storia del petrolio nell’era capitalista comincia nel 1859 sulle rive dell’Oil Creek nei pressi della cittadina di Titusville in Pennsylvania, nel Nord-Est degli Stati Uniti, quando il petrolio zampillò da un pozzo scavato dal leggendario colonnello Edwin L. Drake con una nuova tecnica di perforazione. La notizia si sparse in un baleno e fece accorrere migliaia di cercatori che nell’oro nero vedevano un’alternativa all’olio di balena o al gas naturale diventati troppo costosi per l’illuminazione. Peraltro i nativi e i primi coloni già lo adoperavano a questo scopo.
Noto fin dall’antichità (Assiri, Bisanzio, ecc.), ma utilizzato come pece e bitume, ora il greggio fu per la prima volta distillato. Uno studio del professor Silliman, chimico dell’Università di Yale, accertò che il petrolio poteva essere portato a vari gradi di ebollizione distillando in maniera frazionata quei composti di carbonio ed idrogeno: la prima frazione, la benzina, sarà a lungo considerata un sottoprodotto; la seconda frazione chiamata cherosene troverà immediato impiego nell’illuminazione.
Ci fu la corsa all’accaparramento dei terreni da trivellare, sorsero città, ferrovie, raffinerie, oleodotti. La Guerra di Secessione che allora insanguinava gli Stati Uniti non solo non fu un ostacolo alla frenesia generale per il petrolio, anzi rappresentò uno stimolo per lo sviluppo degli affari. Ma la nuova industria era soggetta, assai più che quella del carbone, alle eccedenze di produzione e quindi ad improvvisi crolli dei mercati: la curva del prezzo era inversa a quella del numero dei pozzi trivellati e le ambizioni dei primi spregiudicati affaristi del settore furono rivolte non tanto al controllo diretto dei giacimenti quanto a quello delle reti di trasporto (soprattutto ferroviario) e di vendita.
Un uomo, il cui nome è diventato il simbolo dell’animal spirit del capitalismo americano, l’industriale di origine francese John D. Rockefeller (il suo vero nome era Roquefeuille, e suo padre, fervente calvinista, era già un filibustiere del commercio), fu coinvolto nel boom del nascente mercato del petrolio di cui intuì subito le enormi potenzialità economiche. Come molti imprenditori dell’epoca, Rockefeller, poco più che ventenne, aveva fondato insieme al socio Maurice Clark una società che operava nel territorio di Cleveland, in cui si commerciava di tutto purché avesse un prezzo, ma soprattutto nei mercati della carne e del frumento. Si lanciarono nel campo dei lumi a petrolio e avviarono alcune piccole industrie di raffinazione e di distribuzione di nafta e cherosene lungo la ferrovia di Cleveland. Il trasporto su rotaia era l’unico modo per trasportare il greggio dai luoghi di estrazione ai grandi mercati dell’Est e la città di Cleveland si trovava in una favorevole posizione geografica, oltre ad essere una città molto attiva che aveva tratto grandi vantaggi dalla guerra ed ora si apprestava a sfruttare il boom petrolifero.
I profitti elevati provenienti dalla raffinazione convinsero Rockefeller a dedicarsi esclusivamente al petrolio. In breve liquidò il socio e si dette ad una politica commerciale ambiziosa e aggressiva. Nella raffinazione operavano diverse società in concorrenza tra loro e Rockefeller ambiva al controllo monopolistico dell’intero mercato. Definì il contesto come “il grande gioco”: le aziende erano guidate da uomini che si sfidavano in affari come in aspre guerre personali senza esclusioni di colpi.
Ma l’entusiasmo nella corsa al petrolio si risolse rapidamente in una situazione di sovrapproduzione e tra il 1865 e il 1870 il prezzo si dimezzò causando perdite economiche sia ai produttori-estrattori sia alle aziende di raffinazione. Il tipico panico che segue una fase di grande entusiasmo portò molti investitori a svendere. Rockefeller comprese l’importanza del momento, un’occasione unica per acquistare le industrie di raffinazione concorrenti. Nel 1870, usando metodi di guerra commerciale poco ortodossi, assai lontani dalla morale “puritana” che ostentava di seguire, unificò le migliaia di piccole Compagnie della Pennsylvania fondando la società per azioni Standard Oil Company del New Jersey. Con la vendita delle azioni Rockefeller riuscì ad ottenere nuova liquidità e poté acquistare le aziende concorrenti in svendita. All’inizio del 1872, nel pieno della depressione, Rockefeller ebbe il coraggio di andare controtendenza realizzando una serie di grandi fusioni industriali allo scopo di raggiungere il predominio nella raffinazione del petrolio. Costituì allo scopo un Consorzio che prese il nome di South Improvement Company.
Fu la vicinanza alla ferrovia a dare la grande occasione: la società si accordò segretamente con le Compagnie ferroviarie, già organizzate in monopolio, per ottenere ribassi nei noli per i grandi quantitativi di petrolio da spedire. La Standard Oil divenne in breve tempo l’industria di raffinazione più forte del mercato americano, arrivando a controllare, alla fine degli anni Settanta, il 90% della capacità di raffinazione degli Stati Uniti. A quell’epoca pressoché tutto il petrolio consumato nel mondo era americano, e delle 36 milioni di tonnellate di petrolio prodotte nelle raffinerie americane ben 33 provenivano dagli impianti della Standard Oil. Per attraversare i mari il petrolio viaggiava allora sui velieri, all’inizio dentro fusti poi in cisterne.
La Standard aveva la propria rete di rappresentanti che battevano in lungo e in largo l’Europa e l’Asia, e un proprio servizio di informazioni e di spionaggio per scoprire in anticipo le iniziative delle società concorrenti e dei governi. All’occorrenza i mercati, come quello cinese, furono inondati di lampade a prezzi stracciati o addirittura gratuite per indurre la popolazione ad acquistare l’olio illuminante. In questo modo la Compagnia strangolava i concorrenti.
All’inizio degli anni Ottanta Rockefeller aveva il controllo di quaranta diverse società che gestiva attraverso la Standard Oil Trust: gli azionisti delle varie società si limitavano ad accordare la loro “fiducia” (trust) a un direttorio di nove membri che di fatto gestiva la holding. In altre parole, si trattava di un sistema per cui una società “madre” capogruppo controllava un certo numero di società “figlie” mediante il possesso di partecipazioni azionarie. La Standard teneva in amministrazione fiduciaria i titoli per conto dei piccoli azionisti delle varie società, che si limitavano a riscuotere i dividendi. In questo modo aggirava le leggi che disciplinavano la libera concorrenza e nessuno poteva accusare la Standard di possedere e controllare direttamente altre società.
In questo periodo quasi tutti gli Stati ricorsero al protezionismo, espressione della concorrenza internazionale fra i capitali e della lotta per il controllo del mercato mondiale. La politica del libero scambio fu messa da parte per i prodotti agricoli quando ne apparvero più a buon mercato dall’oltremare, poi, a poco a poco, il protezionismo si estese anche all’industria. Il capitalismo doveva difendere il mercato interno contro l’invasione delle merci estere per proteggere la base dei suoi sovrapprofitti monopolistici. Al protezionismo ricorsero la Germania (1879), la Russia (1881), l’Italia (1887), gli Usa (1890), la Francia (1892). Solo l’Inghilterra, ormai esportatrice più di capitali che di merci, restava fedele al liberismo.
Nel contempo gli imperialismi emergenti si atteggiavano ad una politica “antimonopolistica”, non al fine di ostacolare il processo di centralizzazione avviato dai monopoli nazionali all’interno dei singoli Stati, ma per opporsi alla penetrazione dei capitali stranieri. Un esempio è fornito dal cosiddetto “Sherman Act” statunitense, una legge federale del 1890 per contrastare la formazione di cartelli, trust e monopoli che le imprese costituivano per evitare la concorrenza e la caduta dei prezzi di vendita. La legge dichiarò illegali i trust e gli accordi tendenti a frenare il commercio e la produzione, considerati un “attentato alla libertà del commercio”! Era il trionfo dell’ipocrisia: il puritanesimo americano non poteva ammettere che la libera concorrenza è in realtà soltanto una tappa nello sviluppo del capitalismo, un mezzo in mano ai più forti per eliminare i più deboli! Non poteva confessare che sotto il capitalismo il monopolio è ineluttabile! Di fatto la legge non pose alcuna limitazione alle società di possedere azioni di altre aziende, e questo consentì un’ondata di fusioni e un aumento delle concentrazioni. La conseguenza sarà quella di far ricadere i costi di questa politica neo-mercantilista sui lavoratori, che non potranno usufruire di eventuali abbassamenti dei prezzi.
Quando all’inizio del Novecento il petrolio in Pennsylvania si esaurì, gettando la regione nella crisi, i pionieri sciamarono a decine di migliaia verso gli Stati del Sud, che in breve si ricoprirono di torri di trivellazione. Importanti ritrovamenti vi furono nel Kansas, nel Texas, in Louisiana ma soprattutto in California. Questo Stato, con 73 milioni di barili (il 22% della produzione mondiale), diverrà il maggiore produttore statunitense. Con la scoperta dei nuovi giacimenti nacquero nuove Compagnie: in California la principale era l’Unocal, l’unica grande Compagnia che era riuscita a sottrarsi all’abbraccio mortale della Standard Oil; nel Texas nel 1901 fu costituita la Gulf Oil e nel 1902 la Texas Company (la futura Texaco), la quale, grazie all’appoggio di uomini politici texani, acquisì molte concessioni e assumerà un ruolo di primo piano nel campo della ricerca e della produzione.
Nel 1910 la Standard Oil della famiglia Rockefeller regnava su un impero sconfinato: commercializzava l’84% del greggio Usa e raffinava 35 mila barili di petrolio al giorno; distribuiva l’80% della produzione di cherosene domestico; aveva il monopolio delle forniture dell’olio lubrificante alle ferrovie; era proprietaria di oltre la metà dei vagoni cisterna che viaggiavano in America; disponeva di una flotta di cento navi, quasi tutte a vapore; era padrona di svariate banche e di 150 mila chilometri di oleodotti.
La stampa cominciò a battere la grancassa di lesa “libera concorrenza” accusando i monopoli di controllare il governo attraverso corruzioni e scambi di favori. Furono rispolverate le leggi anti-trust con la creazione di una Sezione speciale di controllo, che nel 1906 imbastì un nutrito numero di processi contro la Standard sulla base della legge Sherman. Nel 1911, dopo sette anni di indagini, di ricorsi in appello e di rinvii, la Corte Suprema di giustizia decretò che entro sei mesi la Standard era obbligata a dividersi dalle altre società da essa controllate. Sull’onda emotiva della sentenza il Congresso varò una nuova legge antimonopolistica.
Ma anche questa volta la conseguenza fu un rafforzamento delle imprese monopolistiche. Bastarono due mesi a Rockefeller e soci per parare il colpo. L’impero fu frammentato in più società gestite da prestanome: la prima e più importante, con quasi metà del fatturato complessivo, fu la ex Standard Oil del New Jersey che si chiamò Exxon, destinata a diventare l’emblema stesso della potenza petrolifera americana; la seconda, con il 10% del valore patrimoniale totale, fu la Standard Oil di New York (la futura Mobil). A queste si affiancarono la Standard Oil della California (la futura Socal), la Standard Oil dell’Indiana (che assumerà il nome di Amoco), la Continental Oil (che si chiamerà Conoco), la Standard Oil dell’Ohio, ecc. Alla resa dei conti, le nuove aziende, pur avendo consigli di amministrazione autonomi, mantennero i rispettivi mercati e marchi di fabbrica; anzi, la frammentazione della vecchia holding spinse le singole società a svecchiare il gruppo dirigente e a diventare più aggressive sui mercati.
Rockefeller incentivò la sua politica di espansione mondiale e puntò innanzitutto verso l’America del Sud (Messico, Venezuela) utilizzando tutti i mezzi leciti e illeciti nei confronti di proprietari privati e di governi per mettere le mani sulle terre in odore di petrolio. John D. Rockefeller vivrà felicemente fino all’età di 98 anni, padrone di un impero ramificato in tutti i settori, dalle banche alla politica, orgoglioso simbolo della fortuna costruita da un oscuro contabile, e di cui l’imponente Rockefeller Center di Manhattan a New York rappresenta la potenza visibile e il vivo insegnamento di come la libera concorrenza porti al... monopolio!
Lo sviluppo dell’elettricità assestò un colpo fatale al mercato del petrolio da illuminazione. Ma se un mercato si chiudeva, un altro si apriva. Nel 1907 l’impero di Rockefeller era stato salvato da quello nascente dell’industriale Henry Ford, dai cui stabilimenti cominciavano ad uscire le prime automobili in serie: la Standard Oil si convertì alla benzina. Le prime macchine erano destinate non alla città ma alla grande produzione agricola in sostituzione della trazione animale (le macchine agricole erano ancora azionate da tiri anche di 40-50 cavalli!) e i solchi dei campi furono aperti dai primi trattori a benzina con il marchio Ford.
Come
l’elettricità si rivelerà perfetta per l’illuminazione,
così
il petrolio troverà il suo sbocco nel settore automobilistico,
il
cui boom fu fenomenale: negli Usa le immatricolazioni passarono da 8
mila nel 1900 a 900 mila nel 1910. Lo stesso sviluppo si ebbe nei
paesi più avanzati d’Europa: nel 1914 in Francia circoleranno
700
mila veicoli a motore. L’avvento del motore a combustione interna
farà della benzina il prodotto principale della produzione delle
raffinerie, insieme al gasolio, che cominciava a trovare utilizzo
nelle caldaie, nei camion, nei treni e nelle navi. All’alba del XX
secolo, con lo sviluppo mondiale dell’industria e del capitalismo,
la corsa alla nuova fonte di energia, che si rivelerà non
soltanto
molto più economica del carbone ma anche più efficiente e
meglio
rispondente alle esigenze dell’industria moderna, si trasformerà
ben presto in una sfida senza quartiere tra i maggiori imperialismi.
In Russia la raffinazione del petrolio era iniziata fin dal 1820 a Baku, nell’Azerbaigian russo, dove l’esistenza di pozzi era nota a partire almeno dal XVII secolo, ma l’industria era primitiva, i pozzi scavati a mano e la produzione scarsa. Lo sfruttamento intensivo dei giacimenti non cominciò che negli anni Settanta dell’Ottocento, quando il governo russo aprì le porte all’iniziativa privata. Le concessioni messe all’asta dallo zar finirono all’inizio nelle mani di ricchi affaristi tartari e armeni, che si arricchirono rapidamente e dilapidarono i loro profitti in palazzi e banchetti. Le condizioni di lavoro degli operai tartari e georgiani, servi o lavoratori liberi che fossero (uno zio di Stalin era tra essi), erano spaventose: trattati come bestie, preda dell’alcol, venivano selvaggiamente repressi dai cosacchi ogni volta che tentavano di ribellarsi alle loro miserabili condizioni.
A partire dal 1873 a dare il primo impulso all’industria petrolifera russa furono i Nobel, svedesi emigrati a San Pietroburgo e che vantavano legami con lo zarismo. Possedevano immense concessioni e numerose raffinerie collegate alla ferrovia mediante oleodotti: il petrolio era trasportato attraverso la Russia fino a Riga, sul Baltico, e da qui in Svezia. A Baku operavano anche i fratelli Rothschild, banchieri francesi grandi esportatori di capitali in Russia. Nel 1886 avevano acquistato dei giacimenti di petrolio e fondato la Compagnia Petrolifera del mar Caspio e del mar Nero per la distribuzione del kerosene russo. Nel 1893 i loro capitali servirono a finanziare la costruzione di una ferrovia che collegava Baku al porto di Batum sul mar Nero. Batum era allora uno dei porti più importanti del mondo (qui si sarebbero fatte le ossa il giovane comunista Stalin e altri capi bolscevichi). Il greggio a mezzo di navi petroliere veniva trasportato da Batum fino al porto di Trieste, dove i Rothschild possedevano una raffineria. Anche i Nobel si associarono all’operazione in cambio di azioni della loro Compagnia cedute ai Rothschild. Nel 1888 le società dei Nobel e dei Rothschild, che costituivano un vero e proprio fronte russo del petrolio, avevano una produzione pari all’80% di quella del gigante americano Standard Oil. Presto la Russia comincerà ad esportare il suo petrolio in Europa mettendo a rischio il predominio americano.
3. Il gioco si allarga all’Asia
La crescente produzione mondiale richiederà sempre nuovi mercati di sbocco, e costringerà i nuovi giganti del petrolio ad una guerra economica permanente. E l’Europa diventerà assai presto un terreno di caccia troppo ristretto. Nel 1891 i Rothschild, per aggirare lo strapotere di Rockefeller, si associarono ai mercanti inglesi Sam e Marcus Samuel i quali praticavano l’import-export in Asia ed erano specializzati nel commercio di prodotti esotici e di conchiglie (Shell) che servivano per ricoprire piccole scatole, allora molto di moda nell’Inghilterra vittoriana. In Asia i due fratelli Samuel possedevano depositi nei punti strategici e una collaudata rete commerciale.
Divenuto agente generale della Bnito, il Consorzio petrolifero dei Rothschild in Russia, Marcus cominciò a trasportare con i suoi cargo il petrolio russo destinato all’Asia. Con una politica commerciale molto aggressiva, i Samuel misero segretamente in cantiere la costruzione di una flotta di nove petroliere con i requisiti richiesti dai responsabili inglesi del canale di Suez: nel 1892 la prima petroliera dal nome di una conchiglia, la Murex, attraversò il canale con destinazione estremo Oriente. La nuova rotta abbreviava enormemente il percorso e aumentava il vantaggio competitivo sulla Standard.
La riuscita del progetto mise a nudo il ritardo della Standard nel sistema del trasporto verso l’Asia, col petrolio che viaggiava ancora nei barili. Ma la guerra dei prezzi scatenata da Rockefeller in tutto il mondo, se causò il fallimento di centinaia di piccoli produttori, non riuscì a scalfire il controllo sul petrolio russo dei Samuel, forte delle petroliere e di una collaudata rete di capisaldi commerciali. Anzi, allargarono il loro impero: nel 1897, dopo aver ottenuto una concessione nel Borneo, fondarono la Shell Transport and Trading Company. All’inizio del Novecento, dopo che a Londra si era saputo del nuovo giacimento texano di Spindletop, Marcus sbarcò addirittura in America. La Shell, da una parte voleva svincolarsi dalla dipendenza dal petrolio russo, dall’altra mettere le mani sul greggio texano che, pur scadente per l’illuminazione, era adatto per produrre nafta per le navi. Samuel firmò un contratto con la Gulf con il quale si impegnava per la durata di venti anni a ritirare ad un prezzo fissato 100 mila tonnellate di petrolio all’anno, la metà dell’intera produzione.
Marcus Samuel non era il primo ad aver messo gli occhi sull’Indonesia. Un’altra società più piccola, fondata a Rotterdam nel 1885 da August Kessler, la Royal Dutch, aveva scoperto giacimenti petroliferi nell’isola di Sumatra, nell’Indonesia olandese, e vi aveva costruito un oleodotto e una raffineria per smerciare sui mercati asiatici il petrolio con marchio Crow Oil. La Compagnia era sotto l’ala protettrice del re d’Olanda in persona, Guglielmo III, che aveva concesso l’uso del titolo “Royal” nella ragione sociale e vietava l’attracco delle navi dei Samuel nei porti delle Indie olandesi.
Questa società, che controllava il terzo polo petrolifero mondiale, attirò l’interesse della Standard Oil, che aveva assoluto bisogno di una fonte di petrolio più vicina al mercato asiatico. Ma la proposta americana di quadruplicare il capitale della Royal Dutch, a patto di detenerne le azioni supplementari e quindi il controllo, non venne accettata dai dirigenti olandesi, evidentemente non all’oscuro dei metodi usati da Rockefeller per impadronirsi delle aziende concorrenti. A questo punto, gli uomini di Rockefeller, sempre più decisi a neutralizzare il fastidioso intruso, tentarono un accordo con Marcus Samuel. Ma quest’ultimo preferì accordarsi con la Royal Dutch, anche per mettere fine alla sua rovinosa guerra commerciale con questa società sui mercati asiatici.
Ma aveva sbagliato i conti, perché il gioco alla fine fu condotto alle condizioni di Henry Deterding, un giovane e brillante contabile di Singapore scelto da Kessler come esperto del mondo del petrolio e che nel 1900, a soli ventinove anni, era stato nominato direttore della Compagnia olandese, e che doveva passare alla storia come l’architetto della rovina della Shell. Deterding aveva la spregiudicatezza e la decisione che mancavano ormai a Sir Marcus Samuel il quale, diventato baronetto del petrolio e sindaco di Londra, era ormai al culmine della carriera, distratto dagli affari per gli impegni mondani e la vita di gentiluomo di campagna. Deterding invece, che controllava riserve di enorme valore nelle Indie orientali, era in grado di pagare dividendi del 50% contro appena il 5% pagato dalla Shell. Inoltre era riuscito a consorziare gli altri principali produttori in una nuova concentrazione guidata dalla sua Compagnia, fedele al motto di Kessler: la collaborazione fa la forza.
Per di più, il giacimento di Spindletop si prosciugò e la Gulf non poté onorare il contratto, cosicché sir Marcus si trovò di fronte ad una pericolosa carenza di rifornimento di petrolio e dovette convertire le petroliere Shell in navi da carico di bestiame. Quando nel 1907 le due società si fusero dando vita alla holding Royal Dutch-Shell, con Deterding divenuto direttore generale, le azioni delle consociate andarono per il 60% alla Royal Dutch e per il 40% alla vecchia Shell di Marcus. L’operazione farà della Shell la principale concorrente dell’americana Standard Oil e per un quarto di secolo di Deterding il più potente petroliere del mondo che dal suo ufficio nella City di Londra esercitava la sua indiscussa autorità su tutti gli affari della Compagnia.
Nel 1911, per rispondere alla Standard che aveva creato una propria consociata in Olanda allo scopo di ottenere concessioni a Sumatra, la Royal Dutch-Shell portò la guerra nel cuore stesso dell’America. L’obiettivo era scalzare il vantaggio competitivo di cui godevano gli americani, i quali, grazie agli alti prezzi (e alti profitti) praticati negli Stati Uniti, si potevano permettere di vendere a prezzi ribassati in Europa, attuando quella forma di protezionismo attivo noto come dumping. La Compagnia anglo-olandese sbarcò dapprima sulla costa occidentale inserendosi nella produzione della California, poi si spostò all’interno del continente per sfruttare il boom petrolifero in Oklahoma. Le insegne della Shell – il “pericolo giallo”, come venivano chiamate – cominciarono ad invadere le strade dell’America.
D’altronde la Shell era sempre stata costretta a cercare il petrolio all’estero: possedeva campi petroliferi in Egitto, nella zona degli Urali, in Messico, in Venezuela. La Shell diventerà il primo produttore dell’industria petrolifera in Romania grazie ai giacimenti scoperti nei Carpazi, soppiantando l’imperialismo germanico della Deutsche Bank. Il progetto di Deterding di formare la prima multinazionale del petrolio insieme alla Deutsche Bank e alla famiglia Rothschild fu silurato da Rockefeller attraverso una feroce campagna di stampa e la solita guerra dei prezzi. Alla luce degli avvenimenti successivi, la scelta di Deterding di non voler dipendere troppo dal petrolio russo si rivelerà lungimirante, non soltanto perché l’industria petrolifera di Baku continuerà a declinare fino alla prima guerra mondiale (anche a seguito della rivoluzione del 1905, che aveva messo fuori uso quasi due terzi delle installazioni petrolifere), ma soprattutto perché la nazionalizzazione degli impianti disposta dai bolscevichi nel 1918 farà perdere alla Shell una grossa fetta dei suoi rifornimenti.
Al
volgere del secolo, la maggior parte della produzione petrolifera
proveniva da tre regioni: gli Stati Uniti, la Russia e l’Indonesia.
Stranamente il Medio Oriente, dove pure la nafta era conosciuta fin
dalla più remota antichità, arriverà al petrolio
solo molto tardi,
parecchio tempo dopo gli Stati Uniti e la Russia, ma anche dopo la
Romania e il Messico. In compenso, l’area diventerà il campo
prediletto di scontro degli imperialismi. Dopo la scoperta dei grandi
giacimenti iracheni negli anni Venti e di quelli sauditi e kuwaitiani
negli anni Trenta, la storia del petrolio e delle lotte tra
petrolieri non si distinguerà più da quella globale per
il dominio
del mondo.
Nel 1916, tenendo conto della censura zarista, Lenin scrisse il fondamentale saggio “L’imperialismo, stadio supremo del capitalismo”. Questo libro, faro di continuo riferimento, ci indica come scansare i pericolosi scogli del kautskysmo, del democratismo e del pacifismo piccolo-borghese che, oggi come allora, tentano di nascondere la profondità delle contraddizioni del capitalismo e l’inevitabilità della crisi rivoluzionaria che da esse deriva.
Il capitale monopolistico non elimina la lotta di concorrenza tra le grandi potenze, che si svolge in un lavoro di Sisifo fatto di manovre diplomatiche, di ricatti economici e finanziari, e infine di guerre locali e mondiali. Afferma Marx:
«Concettualmente la concorrenza non è altro che la natura interna del capitale, la sua determinazione essenziale che si presenta e si realizza come interazione reciproca dei molti capitali, la tendenza interna come necessità esterna (...) Un capitale universale che non abbia di fronte a sé altri capitali con cui scambiare (...) è quindi un assurdo» (“Lineamenti fondamentali...”).
Se non si chiariscono le radici economiche del fenomeno “imperialismo”, se non se ne valuta l’importanza politica e sociale non è possibile comprendere né la crisi odierna né le cause della guerra e la futura rivoluzione sociale.
Lenin descrive il processo che dalla libera concorrenza evolve ineluttabilmente verso il monopolio. Spiega come proprio quella libera concorrenza, che oggi tanto a sproposito viene invocata da riformisti e piccolo-borghesi di ogni sponda contro la potenza “criminale” dei monopoli, rappresenti la strada maestra che porta al monopolio e sia lo strumento più idoneo per il rafforzamento dei monopoli già esistenti. Il processo di concentrazione e di centralizzazione delle produzioni e del capitale non è una patologia ma una necessità immanente al modo di produzione capitalistico, e trova la sua ragion d’essere nel suo normale funzionamento, che richiede economie di scala e un incremento delle dimensioni minime d’investimento.
Già Marx aveva osservato nel Capitale che
«contemporaneamente alla caduta del saggio di profitto aumenta il minimo di capitale necessario al capitalista individuale per l’utilizzo produttivo del lavoro (...) e nello stesso tempo si accelera la concentrazione perché, oltre certi limiti, un grande capitale con un basso saggio di profitto accumula più rapidamente di un capitale piccolo con un elevato saggio del profitto».
Dialetticamente, il monopolio crea le basi della società comunista perché rappresenta enormi progressi nella socializzazione della produzione e dell’innovazione tecnica. Lo sviluppo della forza produttiva del lavoro sociale è il compito storico del capitale, che appunto mediante tale sviluppo crea, inconsapevolmente, le condizioni materiali di una più elevata forma di produzione. Ma, in regime capitalistico, alla produzione sempre più sociale si contrappone l’appropriazione privata basata sul capitale, sul lavoro salariato e sul valore di scambio.
Questi
rapporti di proprietà sono disperatamente difesi da schiere di
parassiti, per mantenere l’umanità lavoratrice sotto il loro
intollerabile giogo. La distruzione di questi rapporti è la
missione
storica del proletariato.
Scrive Lenin ne “L’Imperialismo”:
«Uno dei tratti più caratteristici del capitalismo è costituito dall’immenso incremento dell’industria e dal rapidissimo processo di concentrazione della produzione in imprese sempre più grandi (...)
«I raggruppamenti di monopoli capitalistici – cartelli, sindacati, trust – si dividono innanzitutto il mercato interno impadronendosi, più o meno completamente, della produzione del paese. Ma, in regime capitalistico, il mercato interno è necessariamente legato al mercato estero. Il mercato mondiale è ormai una creazione consolidata del capitalismo. E, man mano che cresce l’esportazione di capitali, man mano che si estendono in tutte le forme le relazioni con i paesi esteri e con le colonie, man mano che si consolidano le “zone d’influenza” dei grandi gruppi monopolistici, le cose “del tutto naturalmente” procedono verso una loro intesa generale e verso la creazione di cartelli internazionali (...)
«Le tappe principali della storia dei monopoli possono così riassumersi: 1) 1860-1870: apogeo della libera concorrenza. I monopoli sono soltanto in embrione. 2) Dopo la crisi del 1873, ampio sviluppo dei cartelli, che rappresentano però ancora l’eccezione e mancano di stabilità; sono ancora un fenomeno di transizione. 3) Ascesa degli affari alla fine del secolo XIX e crisi del 1900-1903: i cartelli diventano una delle basi di tutta la vita economica. Il capitalismo si è trasformato in imperialismo (...) I cartelli si mettono d’accordo sulle condizioni di vendita, sui termini di pagamento, ecc. Si ripartiscono i mercati, stabiliscono la quantità delle merci da produrre, fissano i prezzi, ripartiscono i profitti tra le singole imprese, ecc.
«In Germania il numero dei cartelli ammontava a circa 250 nel 1896 e a 385 nel 1905, e vi partecipavano circa 12.000 aziende. Ma è generalmente ammesso che queste cifre restano al di sotto del vero. Dai dati della statistica industriale tedesca per il 1907 risulta che 12.000 grandi aziende disponevano sicuramente di oltre la metà dell’intera forza-vapore e dell’energia elettrica del paese. Negli Stati Uniti d’America il numero dei trust era stimato in 185 nel 1900 e in 250 nel 1907. La statistica americana suddivide tutte le imprese industriali secondo che esse appartengono a singoli, a società o a corporazioni. A queste ultime apparteneva nel 1904 il 23,6% e nel 1909 il 25,9% (vale a dire un quarto) del numero totale delle imprese. Queste aziende occupavano nel 1904 il 70,6% e nel 1909 il 75,6% (vale a dire i tre quarti) del numero totale degli operai, e la loro produzione ascendeva rispettivamente a 10 miliardi e 900 milioni di dollari e a 16 miliardi e 300 milioni, vale a dire al 73,7% e 79% del valore totale della produzione degli Stati Uniti.
«Nei cartelli e nei trust si concentrano talora i sette o gli otto decimi dell’intera produzione di un determinato ramo industriale. Nel 1893, anno della sua fondazione, il sindacato carbonifero della Renania-Westfalia forniva l’86,7% e nel 1910 già il 95,4% dell’intera produzione di carbone della regione. Il monopolio in tal guisa creatosi assicura profitti giganteschi e conduce alla formazione di unità tecniche di produzione di enormi dimensioni.
«Il famoso trust del petrolio degli Stati Uniti (Standard Oil Company) fu fondato nel 1900. Il suo capitale dichiarato ammontava a 150 milioni di dollari. Furono emessi 100 milioni di dollari di azioni ordinarie e 106 milioni di dollari di azioni privilegiate. A queste sono stati pagati, tra il 1900 e il 1907, i dividendi del 48, 48, 45, 44, 36, 40, 40, 40 per cento, per un totale di 367 milioni di dollari. Tra il 1882 e la fine del 1906 sugli 889 milioni di dollari di utile netto conseguiti, furono distribuiti 606 milioni di dividendi e il resto assegnato alle riserve. Nel 1907, nel complesso delle imprese del trust dell’acciaio (United States Steel Corporation) erano occupati non meno di 210.180 operai e impiegati (...)«La concorrenza si trasforma in monopolio. Ne risulta un immenso processo di socializzazione della produzione. In particolare si socializza il processo dei miglioramenti e delle invenzioni tecniche. Ciò è già qualche cosa di ben diverso dalla vecchia libera concorrenza tra imprenditori dispersi e sconosciuti l’uno l’altro, che producevano per lo smercio su mercati ignoti. La concentrazione ha fatto progressi tali che ormai si può fare un inventario approssimativo di quasi tutte le fonti di materie prime (per esempio i minerali di ferro) di un dato paese, anzi, come vedremo, di una serie di paesi e perfino di tutto il mondo. E non solo si procede a un tale inventario, ma quelle fonti vengono accaparrate da colossali consorzi monopolistici. Si calcola approssimativamente la capacità di assorbimento dei mercati che questi consorzi “si ripartiscono” in base ad accordi. Si monopolizza la mano d’opera qualificata, si accaparrano i migliori tecnici, si mettono le mani sui mezzi di comunicazione e di trasporto: le ferrovie in America, le società di navigazione in America e in Europa. Il capitalismo nel suo stadio imperialista arriva alla soglia della socializzazione integrale della produzione; esso trascina, per così dire, i capitalisti, a dispetto della loro volontà e senza che essi ne abbiano coscienza, verso un nuovo ordinamento sociale, che segna il passaggio dalla completa libertà di concorrenza alla socializzazione universale.
«Viene socializzata la produzione, ma l’appropriazione resta privata. I mezzi sociali di produzione restano proprietà privata di un ristretto numero di individui. Rimane intatto il quadro generale della libera concorrenza formalmente riconosciuta, ma l’oppressione che i pochi monopolisti esercitano sul resto della popolazione viene resa cento volte peggiore, più gravosa, più insopportabile (...)«È sommamente istruttivo dare almeno uno sguardo all’elenco dei mezzi dell’odierna, moderna e civile “lotta per l’organizzazione” a cui ricorrono i consorzi monopolistici: 1) privazione delle materie prime (...) ”uno dei più importanti metodi coercitivi per imporre l’adesione ai cartelli”); 2) privazione della manodopera mediante “alleanze” (cioè accordi tra i capitalisti e i sindacati operai per cui questi ultimi si obbligano a lavorare soltanto per le imprese cartellizzate); 3) privazione dei mezzi di trasporto; 4) chiusura degli sbocchi; 5) accaparramento dei clienti mediante clausole di esclusività; 6) sistematico abbassamento dei prezzi allo scopo di rovinare gli “outsiders”, ossia le aziende indipendenti che non vogliono sottomettersi ai monopoli; si gettano via milioni vendendo per qualche tempo al disotto del prezzo di costo (nell’industria della benzina si sono dati casi di riduzione da 40 a 22 marchi, cioè quasi della metà); 7) privazione dei crediti; 8) boicottaggio. Questa non è più la lotta di concorrenza tra aziende piccole e grandi, tra aziende tecnicamente arretrate e aziende progredite, ma lo iugulamento, per opera dei monopoli, di chiunque tenti di sottrarsi al monopolio, alla sua oppressione, al suo arbitrio».
6. La nuova funzione delle banche
Lenin affronta poi il nuovo ruolo assunto dalle banche dopo i grandi processi di concentrazione, nonché l’importanza che il reperimento di capitali riveste per i monopoli industriali. Alla base del processo produttivo c’è la necessità di un capitale iniziale e diventa una necessità economica impadronirsi di un grande capitale. Uno strumento essenziale in tale campo sono le società per azioni. Ma la fame di capitale ai fini dell’accumulazione non può essere soddisfatta dal ricorso a questo solo strumento: occorre avere il dominio delle masse dei capitali fluttuanti non stabilmente investiti nonché dei risparmi che si formano tra i consumatori. Di qui la necessità di quei particolari istituti chiamati banche. La banca deve concentrare la ricchezza monetaria sul mercato e ritrasformare in capitale il plusvalore che circola nella forma di denaro. La centralizzazione del capitale monetario è strettamente legata al processo di concentrazione del capitale industriale.
Nella fase imperialistica, più ancora che nella fase concorrenziale, il capitale diviene indifferente a quel che si produce. Lo scopo di chi detiene il “pacchetto di controllo” è ottenere il massimo profitto, non investendo necessariamente nell’impresa produttiva principale, se può ottenere un profitto maggiore spostando gli investimenti in altri settori. La banca cessa di essere un semplice intermediario del credito, un apparato di intermediazione nella circolazione delle merci, per diventare creatrice di credito e di moneta, domina la vita produttiva e lo stesso mondo industriale. Le banche diventano i centri operativi in cui si effettuano gli investimenti più rilevanti e le speculazioni più spregiudicate, rivolte alla circolazione del capitale e alla sua accumulazione basata sull’accrescimento della produzione agricola e industriale in tutto il mondo.
Si è imposta la fusione di capitale produttivo e capitale bancario, cioè ha prevalso quel tipo particolare di capitale che viene detto finanziario, superamento dell’antitesi fra le due frazioni del capitale in una unità superiore. Non soltanto per il fatto che ogni banca è strettamente collegata a determinati settori monopolistici, non soltanto perché il dominio delle imprese viene esercitato attraverso istituti finanziari (Investiment Trust, Holding, ecc.), ma per il fatto che esso determina uno specifico indirizzo in tutti i campi della produzione e della società.
Nei primi anni del Novecento trionfava, soprattutto in Germania, il modello della cosiddetta “banca mista” che, oltre alle funzioni di raccogliere il risparmio ed esercitare il credito commerciale a breve termine, svolgeva la funzione di credito a lungo termine alle industrie e fungeva da banca d’investimento assumendo partecipazioni azionarie nelle imprese. In tal modo le banche non si limitavano a finanziare le aziende, ma sedevano nei consigli di amministrazione e ne orientavano la gestione. Anche negli Stati Uniti il risultato fu essenzialmente il medesimo: i banchieri ebbero la parte principale nell’acquisto delle azioni e per tal via conseguirono una posizione predominante nella struttura delle società. Per rendere l’idea basta pensare che la banca Morgan controllava un terzo delle ferrovie americane, in un’epoca in cui le ferrovie detenevano il 60% di tutte le azioni della Borsa di New York, il 70% del settore dell’acciaio e le tre principali Compagnie assicurative. Nel 1907, quando la Federal Reserve ancora non esisteva, la Morgan salvò Wall Street dal crollo svolgendo funzioni di banca centrale.
Il modello della banca mista resisterà fino alla crisi del 1929 e al conseguente Steagall-Glass Act del 1933, una legge che separerà le banche commerciali da quelle d’investimento industriale; ma tornerà a dominare alla fine del secolo scorso, quando cadranno i vincoli normativi eretti contro la banca mista: nel 1999 lo Steagall-Glass Act viene ufficialmente abrogato.
Lasciamo parlare Lenin:
«La concentrazione dei capitali e l’aumentato giro d’affari hanno modificato radicalmente il ruolo delle banche. In luogo dei capitalisti separati sorge un unico capitalista collettivo. La banca, tenendo il conto corrente di parecchi capitalisti, compie apparentemente una funzione puramente tecnica, esclusivamente ausiliaria. Ma non appena queste operazioni assumono dimensioni gigantesche ne risulta che un pugno di monopolisti si assoggettano le operazioni industriali e commerciali dell’intera società capitalista, giacché, mediante i loro rapporti bancari, conti correnti e altre operazioni finanziarie, conseguono la possibilità anzitutto di essere esattamente informati sull’andamento degli affari dei singoli capitalisti, quindi di controllarli, di influire su di loro, allargando o restringendo il credito, facilitandolo od ostacolandolo ed infine di deciderne completamente la sorte, di fissare la loro redditività, di sottrarre loro il capitale o di dar loro la possibilità di aumentarlo rapidamente e in enormi proporzioni, e così via (...)
«Naturalmente, tra le poche banche che, grazie al processo di concentrazione, si mantengono alla testa della economia capitalistica diventa sempre più forte la tendenza ad entrare in reciproci accordi monopolistici, a formare un trust delle banche. In America non già nove banche ma due delle maggiori, quelle dei miliardari Rockefeller e Morgan, dominano un capitale di 11 miliardi di marchi».
Prosegue Lenin:
«Ma precisamente nell’intimo nesso tra le banche e l’industria appare, nel modo più evidente, la nuova funzione delle banche. Quando la banca sconta le cambiali di un dato industriale, gli apre un conto corrente, ecc., queste operazioni, considerate isolatamente, non diminuiscono di uno iota l’indipendenza di quell’industriale, e la banca resta nei modesti limiti di un’agenzia di mediazione. Ma non appena tali operazioni diventano frequenti e si consolidano, non appena la banca “riunisce” nelle sue mani capitali enormi, non appena la tenuta del conto corrente di un dato imprenditore mette la banca in grado di conoscere, sempre più esattamente e completamente, la situazione economica del suo cliente – e questo appunto si va verificando – allora ne risulta una sempre più completa dipendenza del capitalista-industriale dalla banca.
«Nello stesso tempo si sviluppa, per così dire, un’unione personale della banca con le maggiori imprese industriali e commerciali, una loro fusione mediante il possesso di azioni o l’entrata dei direttori delle banche nei Consigli di amministrazione delle imprese industriali e commerciali, e viceversa».
C’è un nesso evidente tra il processo di concentrazione e di centralizzazione dei capitali, ossia della formazione dei monopoli, e la loro crescente dipendenza dal mondo della finanza. Le risorse finanziarie eccedenti quelle aziendalmente disponibili per l’accumulazione vengono fornite dal mercato internazionale dei capitali a condizione che dalle politiche industriali derivino profitti adeguati al capitale investito. È facile capire come, in questo modo, il controllo dei progetti e delle strategie d’impresa passi dai decisori aziendali ai famosi “mercati”. Lenin afferma che l’imperialismo è il dominio del capitale finanziario su tutte le altre forme di capitale:
«In generale il capitalismo ha la proprietà di separare il possesso del capitale dall’impiego del medesimo nella produzione, di separare il capitale-denaro dal capitale industriale o produttivo, di separare il rentier, che vive soltanto del reddito tratto dal capitale-denaro, dall’imprenditore e da tutti coloro che partecipano direttamente all’impiego del capitale. L’imperialismo, vale a dire il dominio del capitale finanziario, è quello stadio supremo del capitalismo in cui tale separazione raggiunge dimensioni enormi. La supremazia del capitale finanziario su tutte le rimanenti forme del capitale significa l’egemonia del rentier e dell’oligarchia finanziaria, significa una situazione privilegiata per un piccolo numero di Stati finanziariamente più “solidi” degli altri.
«In quali proporzioni si verifichi tale processo ci è dimostrato dalla statistica delle emissioni di titoli di ogni specie (...) Ci si accorge subito da questi dati quanto sia netto il distacco tra i quattro paesi capitalistici più ricchi, che posseggono titoli per un importo di circa 100-150 miliardi di franchi ciascuno, e gli altri paesi. Tra quelli, due sono i paesi capitalistici più ricchi di colonie, cioè l’Inghilterra e la Francia; gli altri due sono i paesi capitalistici più progrediti in rapporto alla rapidità di sviluppo e all’ampiezza di diffusione del monopolio capitalistico nella produzione, cioè gli Stati Uniti e la Germania. Questi quattro paesi insieme posseggono 479 miliardi di franchi, vale a dire circa l’80% del capitale finanziario internazionale. Quasi tutto il resto del mondo, in questa o quella forma, fa la parte del debitore o del tributario di questi Stati, che fungono da banchieri internazionali di queste quattro “colonne” del capitale finanziario mondiale».
Lenin spiega come all’inizio del XX secolo l’esportazione dei capitali abbia raggiunto punte spettacolari soprattutto nei tre principali paesi: l’Inghilterra,che nel 1910 destinava i suoi capitali per una metà alle imprese industriali americane e per l’altra metà alle sue colonie d’oltremare; la Francia, i cui prestiti statali erano diretti soprattutto alla Russia: tipico caso di capitalismo usuraio; la Germania che, essendo povera di colonie, divideva equamente i suoi capitali tra l’America e l’Europa.
Nella precedente epoca del capitalismo concorrenziale ogni impresa era spinta a produrre al più basso costo possibile e a vendere la massima quantità di merci, cioè ad estendere il mercato perché l’esportazione di merci aveva l’assoluta preminenza economica; data la bassa composizione organica del capitale, i saggi di profitto non presentano grandissime differenze.
Ma la concorrenza porta all’aumento della composizione organica, alla diminuzione del saggio di profitto e all’aumento del divario tra i profitti nei diversi paesi, cioè tra i paesi avanzati capitalisticamente e quelli arretrati. Nei primi, ad un certo momento, il saggio di profitto diminuisce al punto da far diminuire gli investimenti e provocare la stagnazione. La lotta per la concorrenza si acuisce e per ciascun capitale diventa questione di vita o di morte allargare i mercati a scapito degli altri, sia come sbocco della produzione sia come fonte di materie prime.
La borghesia monopolistica, avendo a disposizione una pletora di capitali che cercano nuovi campi di investimento, non è più affamata di nuovi capitali, è affamata di sovrapprofitti. Non dispone più del monopolio della produttività che le assicuri la conquista “pacifica” dei mercati mondiali, ma deve fare i conti con concorrenti che producono in condizioni di produttività identiche se non superiori: inizia la lotta per il dominio del mondo da parte dei paesi capitalistici maggiori. Ma dominare significa investire capitali, impossessarsi delle miniere e sfruttarle, creare banche, stimolare la nascita di nuove industrie. A questo si è spinti sia per la differenza del saggio di profitto, più alto nei paesi arretrati, i quali hanno bassi salari e bassa composizione organica, sia per ragioni di dominio. L’esportazione di capitali acquista un ruolo centrale e si verifica in varie forme: prestiti fatti da privati o da enti pubblici, apporto diretto di beni strumentali con pagamento dilazionato, trasporto di intere imprese o di parti di esse con concessione di brevetti, partecipazione in imprese locali, eccetera.
La necessità dell’esportazione di capitali è determinata dal fatto che in alcuni paesi a capitalismo più che maturo la valorizzazione incontra sempre maggiori difficoltà. Il capitale privo d’investimento si procura così una serie di canali di deflusso: all’estero con l’esportazione di capitale, all’interno con la speculazione di borsa. I flussi finanziari internazionali diventano un multiplo sempre più grande dei flussi commerciali: nel 1998 le transazioni finanziarie giornaliere si aggiravano intorno ai duemila miliardi di dollari, di cui solo un centesimo si riferivano a scambi di merci.
Torniamo a Lenin:
«Per il vecchio capitalismo, sotto il regno della libera concorrenza, era caratteristica l’esportazione di merci; per il più recente capitalismo, sotto il dominio dei monopoli, è diventata caratteristica l’esportazione di capitale (...) Alla soglia del XX secolo troviamo la formazione di nuovi tipi di monopolio: in primo luogo associazioni monopolistiche dei capitalisti in tutti i paesi a capitalismo progredito; in secondo luogo la posizione monopolistica dei pochi paesi più ricchi, nei quali l’accumulazione di capitale ha raggiunto dimensioni gigantesche. Si determinò nei paesi più progrediti un’enorme “eccedenza di capitali” (...)
«Finché il capitalismo resta tale, l’eccedenza di capitali non sarà impiegata a elevare il tenore di vita delle masse in un dato paese, perché ciò comporterebbe una diminuzione dei profitti per i capitalisti, ma ad elevare tali profitti mediante l’esportazione dei capitali all’estero, nei paesi meno sviluppati. In questi ultimi i profitti ordinariamente sono assai alti, perché vi è scarsità di capitali, la terra è relativamente a buon mercato, i salari bassi e le materie prime a poco prezzo. La possibilità dell’esportazione di capitali è assicurata dal fatto che una serie di paesi arretrati è già attratta nell’orbita del capitalismo mondiale, che in essi sono già state costruite o sono in via di costruzione delle reti ferroviarie, che sono assicurate le condizioni elementari per lo sviluppo dell’industria, ecc. La necessità dell’esportazione di capitale è dovuta alla “maturità eccessiva” del capitalismo in alcuni paesi e al fatto che al capitale (data l’arretratezza dell’agricoltura e la povertà delle masse) fanno difetto gli investimenti “redditizi”».
Evidentemente queste esportazioni di capitale all’estero avvengono sempre a vantaggio del prestatore:
«In questi affari internazionali tocca sempre qualche cosa ai creditori, o un vantaggio di politica commerciale, o un giacimento di carbone, o la costruzione di un porto, o una pingue concessione, o una commissione di cannoni (...) La cosa più frequente nella concessione di crediti è quella di mettere come condizione che una parte del denaro prestato debba venire impiegato nell’acquisto di prodotti del paese che concede il prestito, specialmente di materiale da guerra, navi, ecc.»
La tedesca Deutsche Bank, in contropartita dei prestiti concessi alla Turchia, ottenne l’esclusiva per la costruzione della linea ferroviaria Berlino-Baghdad, oltre ad importanti concessioni petrolifere. E Lenin conclude:
«I paesi esportatori di capitali si sono spartiti il mondo sulla carta, ma il capitale finanziario ha condotto anche a una spartizione del mondo vera e propria».
9. La spartizione del mondo tra i grandi trust
La spartizione del mondo ad opera di pochi grandi trust ebbe il suo prototipo, all’inizio del XX secolo, nell’industria elettrica, nella quale il processo di concentrazione fu talmente rapido che portò in breve alla formazione di due enormi consorzi, uno americano e l’altro tedesco. Scrive Lenin:
«L’industria elettrica è quella che meglio di ogni altra rappresenta gli ultimi progressi compiuti dalla tecnica e dal capitalismo tra la fine del secolo XIX e l’inizio del XX. Essa si è sviluppata soprattutto nei due nuovi paesi capitalistici più avanzati, gli Stati Uniti e la Germania. In Germania specialmente la crisi del 1900 esercitò una grande influenza sull’incremento della concentrazione in questo campo. Le banche, già abbastanza fuse con l’industria, durante questa crisi accelerarono e approfondirono in altissimo grado la rovina delle imprese relativamente piccole e il loro assorbimento nelle grandi aziende. “Le banche – scrive Jeidels – toglievano i loro aiuti appunto alle imprese più bisognose di capitale, promuovendo così prima uno sviluppo prodigioso, e poi un fallimento disperato delle società non legate ad esse strettamente e durevolmente” (...) Ma naturalmente la divisione del mondo tra due potenti trust non esclude che possa avvenire una nuova spartizione, non appena venga a mutare il rapporto delle forze in conseguenza dell’ineguaglianza nello sviluppo, per effetto di guerre, di crack, ecc.
«Un esempio istruttivo di simile nuova spartizione e delle lotte che essa provoca è offerto dall’industria del petrolio. “Il mercato mondiale del petrolio – scriveva Jeidels nel 1905 – è oggi sostanzialmente ripartito tra due grandi gruppi finanziari: la Standard Oil Co. di Rockefeller, e i padroni del petrolio russo di Baku, Rothschild e Nobel. Questi due gruppi sono strettamente legati, ma da alcuni anni sono minacciati nelle loro posizioni di monopolio da cinque avversari”: 1) l’esaurimento delle fonti petrolifere americane; 2) la concorrenza della ditta Mantascev e Co. di Baku [rappresentante del grande capitale armeno, che ebbe praticamente il monopolio del petrolio di Baku dal 1850 al 1872]; 3) le risorse di petrolio in Austria e 4) in Romania; 5) le fonti petrolifere transoceaniche, specialmente nelle colonie olandesi (le ricchissime ditte Samuel e Shell, legate anche al capitale inglese). Questi tre ultimi gruppi di imprese sono legati alle grandi banche tedesche con alla testa la più grande, la Deutsche Bank. Queste banche hanno promosso in modo sistematico e indipendente l’industria del petrolio, per esempio in Romania, allo scopo di avere i loro “propri” punti di appoggio. Nel 1907 si calcolava a 185 milioni di franchi il capitale straniero impiegato nell’industria petrolifera romena, e di essi 74 milioni erano di provenienza tedesca.
«Iniziò allora una lotta che, nella letteratura economica, verrà definita lotta per la “spartizione del mondo”. Da un lato, il trust petrolifero di Rockefeller, che aspirava ad impadronirsi di tutto, fondò nella stessa Olanda una “società figlia”, allo scopo di accaparrarsi le risorse di petrolio delle Indie olandesi e colpire così a morte il suo principale avversario, il trust anglo-olandese Shell. Dall’altro lato, la Deutsche Bank e le altre grandi banche di Berlino cercarono di “salvaguardare” la Romania e associarla alla Russia contro Rockefeller. Quest’ultimo disponeva di capitali infinitamente superiori e di una eccellente organizzazione di trasporto e di distribuzione. La lotta quindi doveva terminare e terminò, nel 1907, con la completa sconfitta della Deutsche Bank alla quale non rimase altra scelta che o liquidare i suoi “interessi petroliferi” perdendo milioni o sottomettersi. La Deutsche Bank scelse quest’ultima alternativa e concluse con la Standard Oil un accordo assai svantaggioso, con il quale s’impegnava a “non intraprendere nulla a danno degli interessi americani”, con la clausola tuttavia che il trattato avrebbe perduto il suo valore nel caso che la Germania avesse introdotto, per via legislativa, il monopolio di Stato sul petrolio.
«E allora incominciò la “commedia del petrolio”. Uno dei re della finanza germanica, von Gwinner, direttore della Deutsche Bank, a mezzo del suo segretario privato Stauss iniziò un’agitazione a favore del monopolio statale del petrolio. L’intero gigantesco apparato della massima banca di Berlino, tutte le sue infinite “relazioni” furono messe in moto; la stampa, piena d’indignazione “patriottica”, gonfiò le gote contro il “giogo” del trust americano, e il 15 marzo 1911 il Reichstag, quasi all’unanimità, approvò una mozione che invitava il governo a preparare un disegno di legge sul monopolio del petrolio. Il governo afferrò al volo questa idea diventata ormai “popolare” e sembrò che il gioco della Deutsche Bank, che voleva imbrogliare i suoi contraenti americani e migliorare i propri affari con l’aiuto del monopolio di Stato, fosse riuscito. Ai magnati tedeschi del petrolio veniva l’acquolina in bocca nel pregustare i giganteschi profitti che non avrebbero avuto nulla da invidiare a quelli degli industriali russi dello zucchero (...) Ma, sul più bello, le grandi banche tedesche si azzuffarono per la spartizione del bottino e la Disconto-Gesellschaft svelò gli egoistici interessi della Deutsche Bank. A questo punto, il governo non se la sentì di iniziare una lotta contro Rockefeller, perché appariva molto dubbio che, senza di lui, la Germania potesse riuscire a procurarsi il petrolio (la produzione della Romania era modesta). E quando, nel 1913, fu approvato lo stanziamento di un miliardo destinato agli armamenti, il progetto di monopolio venne abbandonato. La Standard Oil di Rockefeller uscì, per allora, vincitrice dalla lotta.
«A questo proposito la rivista berlinese Die Bank scriveva che la Germania avrebbe potuto combattere la Standard Oil soltanto mediante il monopolio della corrente elettrica e la trasformazione della forza idraulica in elettricità a buon mercato. “Ma – aggiungeva l’autore dell’articolo – il monopolio dell’elettricità si avrà nel momento in cui i produttori ne avranno bisogno, cioè allorché sarà imminente un nuovo grande crack dell’industria elettrica, allorquando le grandiose e costose stazioni elettriche, che ora i consorzi privati dell’industria elettrica vanno fondando dappertutto, e a favore delle quali ottengono monopoli parziali dalle città, dagli Stati, ecc., non saranno più in grado di lavorare con profitto. Allora ci si dovrà rivolgere alle forze idrauliche; ma queste non potranno venir trasformate in elettricità a buon mercato direttamente dallo Stato, bensì occorrerà di bel nuovo concederle a un ‘monopolio privato controllato dallo Stato’, perché l’industria privata ha già concluso una serie di affari e si è riservata, contrattualmente, forti indennizzi (...) Così è avvenuto per il monopolio della potassa, così per il monopolio del petrolio, e così avverrà anche per il monopolio dell’elettricità. I nostri socialisti di Stato, che si lasciano accecare dalle belle teorie, dovrebbero finalmente accorgersi che in Germania i monopoli non hanno mai avuto né lo scopo né il risultato di giovare ai consumatori e neppure quello di assicurare allo Stato una parte dei guadagni d’impresa, ma hanno sempre servito soltanto a risanare, a spese dello Stato, le industrie private sull’orlo del fallimento”.
«A quali preziose confessioni si vedono mai costretti gli economisti borghesi della Germania! Da esse emerge nettamente come, nell’età del capitale finanziario, i monopoli statali e privati si compenetrino gli uni con gli altri, e come tanto gli uni quanto gli altri siano semplicemente singoli anelli della catena della lotta imperialistica per la spartizione del mondo (...) L’epoca del capitalismo moderno ci dimostra come tra i gruppi capitalistici si stabiliscano determinati rapporti basati sulla spartizione economica del mondo, e come, di pari passo con tale fenomeno e in connessione con esso, si stabiliscano anche tra i raggruppamenti politici, cioè gli Stati, determinati rapporti basati sulla spartizione territoriale del mondo, sulla lotta per le colonie, sulla “lotta per i territori economici”».
10. La contesa tra le potenze imperiali
Ma la spartizione del mondo tra i monopoli capitalisti, in primo luogo i monopoli finanziari, è strettamente legata agli antagonismi tra le potenze. Il motivo centrale della politica estera dei paesi capitalisti a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento consiste nella conquista dei territori stranieri, chiudendoli alla concorrenza estera, come mercati di prodotti finiti, fonti di materie prime e di manodopera a buon mercato o campi di investimento di capitali da esportare. Lenin prosegue:
«Per l’Inghilterra il periodo delle più grandi conquiste coloniali cade tra il 1860 e il 1880, ed esse sono ancora cospicue negli ultimi vent’anni del secolo XIX. Per la Francia e la Germania sono importanti specialmente questi ultimi venti anni. Abbiamo già veduto che il periodo di massimo sviluppo del capitalismo pre-monopolistico, col predominio della libera concorrenza, cade tra il sesto e il settimo decennio. Ora vediamo che specialmente dopo tale periodo s’inizia un prodigioso “sviluppo” delle conquiste coloniali e si acuisce all’estremo la lotta per la ripartizione territoriale del mondo. È quindi fuori discussione il fatto che il passaggio del capitalismo alla sua fase monopolistica, al capitale finanziario, è collegato con un inasprimento della lotta per la spartizione del mondo (...)
«Alla soglia del XX secolo la spartizione del mondo era ormai “terminata”. I possedimenti coloniali crebbero a dismisura dopo il 1876, passando da 40 a 65 milioni di chilometri quadrati per le sei maggiori potenze. L’aumento di 25 milioni di chilometri quadrati corrisponde a una volta e mezzo la superficie della madrepatria (16 milioni e mezzo). Nel 1876 tre potenze non avevano alcuna colonia, e una quarta, la Francia, quasi nessuna. Nel 1914 questi quattro paesi possedevano colonie per 14,1 milioni di chilometri quadrati, cioè circa una volta e mezzo la superficie dell’Europa, con una popolazione di circa 100 milioni (...)
«Ciò che caratterizza fondamentalmente il modernissimo capitalismo è il dominio dei gruppi monopolistici costituiti dai maggiori imprenditori. Tali monopoli sono soprattutto solidi quando tutte le sorgenti di materie prime vengono concentrate nelle loro mani. Abbiamo visto l’ardore con cui i gruppi capitalistici internazionali si sforzano, con qualsiasi mezzo, di strappare agli avversari ogni possibilità di concorrenza, di accaparrarsi le miniere di ferro e i giacimenti di petrolio, ecc. Soltanto il possesso delle colonie assicura al monopolio complete garanzie di successo contro i rischi della lotta con i rivali, anche nel caso che questi ultimi decidano di trincerarsi dietro qualche legge di monopolio statale. Quanto più il capitalismo è sviluppato, quanto più la scarsità di materie prime è sensibile, quanto più acuta è in tutto il mondo la concorrenza e la caccia alle fonti di materie prime, tanto più feroce è la lotta per la conquista delle colonie (...)
«Per il capitale finanziario sono importanti non solo le sorgenti di materie prime già scoperte, ma anche quelle eventualmente ancora da scoprire, giacché ai nostri giorni la tecnica fa progressi vertiginosi e terreni oggi inutilizzabili possono domani esser messi in valore, appena siano stati trovati nuovi metodi (e a tal fine la grande banca può allestire speciali spedizioni di ingegneri, agronomi, ecc.) e non appena siano stati impiegati più forti capitali. Lo stesso si può dire delle esplorazioni in cerca di nuove ricchezze minerarie, della scoperta di nuovi metodi di lavorazione e di utilizzo di questa o quella materia prima, ecc. Da ciò nasce inevitabilmente la tendenza del capitale finanziario ad allargare il proprio territorio economico, e anche il proprio territorio in generale.
«Nello stesso modo in cui i trust capitalizzano la loro proprietà valutandola due o tre volte al disopra del suo valore, giacché fanno assegnamento sui profitti “possibili” futuri (e non su quelli attuali) e sugli ulteriori risultati del monopolio, così il capitale finanziario, in generale, si sforza di arraffare quanto più territorio è possibile, comunque e dovunque, in cerca soltanto di possibili sorgenti di materie prime, temendo di rimanere indietro nella lotta forsennata per l’ultimo lembo di sfera terrestre non ancora diviso, o per una nuova spartizione dei territori già divisi».
11. Il posto dell’imperialismo nella storia
Lenin richiama i tratti essenziali del monopolio e dell’imperialismo, mettendo in risalto come questo, pur essendo parassitario e putrescente, attua tuttavia un grado molto elevato di socializzazione della produzione:
«In primo luogo, il monopolio è sorto dalla concentrazione della produzione, giunta ad un grado assai elevato di sviluppo. Si sono formati gruppi monopolistici di capitalisti: cartelli, sindacati padronali e trust (...) Al principio del XX secolo hanno acquistato una supremazia assoluta nei paesi progrediti: e se i primi passi sulla via della cartellizzazione furono compiuti da paesi con alti dazi protettivi (Germania, America), poco tempo dopo anche l’Inghilterra, con tutto il suo sistema di libertà del commercio, mostrava lo stesso fenomeno fondamentale, ossia il sorgere dei monopoli dalla concentrazione della produzione.
«In secondo luogo, i monopoli hanno condotto all’accaparramento intensivo delle principali sorgenti di materie prime, specialmente nell’industria più importante e più cartellizzata della società capitalistica, quella siderurgico-mineraria. Il possesso monopolistico delle più importanti sorgenti della materia prima ha aumentato immensamente la potenza del grande capitale e acuito l’antagonismo tra l’industria cartellizzata e l’industria non cartellizzata.
«In terzo luogo, i monopoli sono sorti dalle banche. Queste si trasformarono da modeste imprese di mediazione in detentrici monopolistiche del capitale finanziario. Tre o cinque grandi banche, di uno qualunque tra i paesi più evoluti, hanno attuato la ”unione personale” del capitale bancario e del capitale industriale, e hanno concentrato nelle loro mani miliardi e miliardi che costituiscono la maggior parte dei capitali e delle entrate in denaro di tutto il paese. La manifestazione più eclatante di tale monopolio è l’oligarchia finanziaria che stringe, senza eccezione, nella sua fitta rete di rapporti di dipendenza tutte le istituzioni economiche e politiche della moderna società borghese.
«In quarto luogo, il monopolio è sorto dalla politica coloniale. Ai numerosi “antichi” moventi della politica coloniale, il capitale finanziario ha aggiunto la lotta per le fonti di materie prime, quella per l’esportazione di capitali, quella per le “sfere d’influenza”, cioè per le regioni che offrono vantaggiosi affari, concessioni, profitti monopolistici, ecc., e infine la lotta per il territorio economico in generale. Quando per esempio le potenze europee occupavano con le loro colonie solo una decima parte dell’Africa, come era il caso ancora nel 1876, la politica coloniale poteva allora svolgersi in forma non monopolistica, nella forma, per così dire, di una “libera presa di possesso” di territorio. Ma, accaparrati già nove decimi dell’Africa (verso il 1900) e terminata la divisione del mondo, allora, com’era inevitabile, iniziò l’era del possesso monopolistico delle colonie, e quindi anche di una lotta particolarmente intensa per la partizione e ripartizione del mondo.
«È noto a tutti quanto il capitale monopolistico abbia acuito tutti gli antagonismi del capitalismo. Basta accennare al rincaro dei prezzi e alla pressione dei cartelli. Questo inasprimento degli antagonismi costituisce la più potente forza motrice del periodo storico di transizione, iniziatosi con la definitiva vittoria del capitale finanziario mondiale. Monopoli, oligarchia, tendenza al dominio anziché alla libertà, sfruttamento di un numero sempre maggiore di nazioni piccole e deboli per opera di poche nazioni più ricche o potenti: sono le caratteristiche dell’imperialismo, che ne fanno un capitalismo parassitario e putrescente (...)«Ma sarebbe un errore credere che tale tendenza alla putrescenza escluda il rapido incremento del capitalismo: tutt’altro. Nell’età dell’imperialismo singole branche d’industria, singoli strati della borghesia o singoli paesi palesano, con forza maggiore o minore, ora l’una ora l’altra di quelle tendenze. In complesso il capitalismo cresce assai più rapidamente di prima, sennonché tale incremento non solo diviene in generale più sperequato, ma tale sperequazione si manifesta particolarmente nell’imputridimento dei paesi capitalisticamente più ricchi di capitale (Inghilterra) (...)
«Quando una grande azienda assume dimensioni gigantesche e, sulla base di un’esatta valutazione di dati innumerevoli, organizza sistematicamente la fornitura della materia prima di base nella proporzione di due terzi o di tre quarti dell’intero fabbisogno di una popolazione di più decine di milioni; quando è organizzato sistematicamente il trasporto di questa materia prima nei più opportuni centri di produzione, talora separati l’uno dall’altro da centinaia o migliaia di chilometri; quando un unico centro dirige tutti i successivi stadi di elaborazione della materia prima, fino alla produzione dei più svariati prodotti finiti; quando la ripartizione di tali prodotti, tra le centinaia di milioni di consumatori, avviene secondo un preciso piano (per esempio, la vendita del petrolio in America e Germania da parte della Standard Oil), allora diventa chiaro che si è in presenza di una socializzazione della produzione e non già di un semplice “intreccio”; che i rapporti di economia privata e di proprietà privata formano un involucro non più corrispondente al contenuto, involucro che deve andare inevitabilmente in putrefazione qualora ne venga ostacolata artificialmente l’eliminazione [ed è quello che disgraziatamente accade da oltre un secolo!], e in stato di putrefazione potrà magari durare per un tempo relativamente lungo (nella peggiore delle ipotesi, se il bubbone opportunista tarderà a scoppiare), ma infine sarà fatalmente eliminato».
L’imperialismo è legato all’opportunismo perché:
«Gli elevati profitti che i capitalisti di una certa branca d’industria o di un certo paese traggono dal monopolio dà loro la possibilità economica di corrompere alcuni strati operai (...) conquistati alla causa della borghesia di quella branca o di quel paese, e di contrapporli a tutti gli altri».
La parentesi della Seconda Guerra mondiale rappresenterà per il capitalismo un bagno di giovinezza riportando momentaneamente indietro la composizione organica del capitale. Ma l’accumulazione è poi ripresa infernale fino alla crisi generale di sovrapproduzione del 1973, che non ha ancora trovato il suo scioglimento: in Europa, in America del Nord, in Russia, in Cina la società borghese è oggi un cadavere putrescente.
12. Lo scontro per il petrolio mediorientale
Con il viatico dello straordinario testo di Lenin, riprendiamo ora la storia del petrolio, o meglio, dei moderni monopoli.
Giusta Lenin, alla vigilia della Prima Guerra mondiale le grandi potenze emergenti erano Stati Uniti e Germania. In Europa la Germania si trovava soffocata dai vecchi capitalismi inglese e francese, e ciò rendeva prima o poi ineluttabile una guerra per una nuova spartizione del mondo. Vediamo le cose un po’ più da vicino.
All’inizio del secolo lo smercio del petrolio nel mondo e in Europa era in mano ai cartelli della Shell e della Standard Oil. La Gran Bretagna, ancora la prima potenza mondiale, non disponeva, a differenza degli Stati Uniti e della Russia, di riserve di petrolio sul proprio territorio, ed era perciò obbligata a cercarlo nei luoghi più remoti.
Per gli inglesi l’affare del petrolio fu fin dagli inizi strettamente collegato alla politica diplomatica. Nel 1901 l’iniziativa dell’affarista britannico William D’Arcy, che aveva acquistato dallo Scià di Persia una concessione petrolifera sessantennale per la prospezione e lo sfruttamento dei giacimenti in tre quarti del paese, ben rispondeva alle necessità britanniche in funzione anti-russa. In Persia gli inglesi detenevano solide posizioni, che i russi cercavano di scalzare. Con il nuovo secolo la Russia aveva aumentato le sua pressione sulla Persia e stabilito una sua forza navale nel Golfo Persico, che minacciava l’India e le vie che ad essa conducevano. Proprio per evitare attriti prematuri con la Russia erano stati esclusi dalla concessione di D’Arcy i territori settentrionali, al confine con l’impero zarista.
Finalmente nel 1908 la perseveranza di D’Arcy venne premiata poiché fu trovato il petrolio e scoperto il ricco giacimento di Masjed e Soleyman, uno dei più importanti del paese. Si rese necessaria la creazione di una struttura societaria per sfruttare al meglio la concessione: nacque così l’Anglo-Persian Oil Company (Apoc, la futura British Petroleum). Lord Strathcona, proveniente dal Foreign Office, ne venne nominato presidente e D’Arcy direttore generale.
Nel 1912 Churchill, allora Lord dell’Ammiragliato, decise di modernizzare la flotta da guerra e dotare le navi della Royal Navy di caldaie a nafta in sostituzione di quelle a carbone per renderle più agili, rapide e flessibili rispetto a quelle tedesche e americane. L’incidente di Agadir dell’anno prima, quando una cannoniera tedesca era entrata nel porto marocchino a scopo dimostrativo, era un chiaro messaggio che la Germania perseguiva fini espansionistici e sfidava il dominio inglese sui mari. Inoltre la flotta inglese dipendeva allora dal petrolio americano, e ciò era visto con preoccupazione da un governo geloso dell’indipendenza nazionale e della sua politica marittima nel mondo. Churchill fu uno dei pochi ad individuare allora la stretta relazione tra controllo statale del petrolio e potenza militare. Puntare su una risorsa che si trovava su territori fuori dell’influenza britannica richiedeva infatti un preciso impegno politico e militare.
Così, per proteggere i propri interessi strategici e porre sotto il diretto controllo della marina le ricche riserve mediorientali, il governo britannico aveva proposto la parziale nazionalizzazione della neonata Anglo-Persian, divenendone azionista di maggioranza. La posizione conquistata dalla Compagnia sarà rafforzata dai lavori necessari allo sfruttamento dei giacimenti in cui presto si lanceranno gli inglesi. Per trasportare il petrolio persiano il capitale finanziario che aveva il controllo della società avviò lavori faraonici per la costruzione del porto di Abadan, sul Golfo Persico, oltre che di strade nei territori montagnosi del paese che erano allora infestati dai briganti, e soprattutto di una pipeline lunga diverse centinaia di chilometri per collegare i pozzi di petrolio al porto, sede allora di una delle più grandi raffinerie del mondo. Alla vigilia della guerra i campi petroliferi persiani sfornavano una produzione annua di 89 mila tonnellate di greggio.
In Medio Oriente le rivalità tra le potenze erano in atto da molto prima che iniziasse lo sfruttamento intensivo del petrolio. L’Impero Ottomano, esteso in tre continenti, occupava una posizione strategica nelle relazioni internazionali, ed era un alleato indispensabile soprattutto alla Gran Bretagna per il suo accesso all’India.
Alla fine dell’Ottocento il fatto nuovo fu che anche i tedeschi cominciarono ad infiltrarsi nell’area per diverse vie: esplorazioni archeologiche e scientifiche, missioni commerciali, linee di navigazione, ecc. Il petrolio farà il suo ingresso nel 1903, quando il Kaiser ottenne dal sultano l’autorizzazione per la costruzione della ferrovia Berlino-Baghdad. Il Gran Visir promise alla Deutsche Bank il diritto di sfruttare le risorse petrolifere situate lungo la linea per una fascia di venti chilometri ai lati della strada ferrata.
Le rivalità nel Medio Oriente sono il prolungamento di una generale concorrenza navale e commerciale sempre più aspra tra le potenze europee, soprattutto dopo l’Entente cordiale (1904) con la quale inglesi e francesi si erano spartiti spudoratamente l’egemonia sul Mediterraneo. Nel 1908-1909 la rivoluzione dei Giovani Turchi modificherà ulteriormente la situazione: la notizia della caduta del sultano Abdul Hamid fu accolta con soddisfazione a Londra e a Parigi perché sembrava preludere alla completa defenestrazione della Germania dalla regione.
Gli inglesi non avevano mai nascosto la volontà di fare di Costantinopoli un centro d’influenza finanziaria esclusivamente britannico. L’occasione favorevole si presentò nel 1910 quando, con l’aiuto di Calouste Gulbenkian, consigliere economico e finanziario delle ambasciate turche a Parigi e a Londra, fu fondata la National Bank of Turkey con capitale interamente inglese. Nel gennaio del 1911 lo stesso Gulbenkian, divenuto nel frattempo direttore della banca a Londra, spinse i fondatori a lanciarsi nell’affare petrolifero ottomano con la fondazione della Turkish Petroleum Company Ltd., a cui parteciparono Sir Ernest Cassel, ambasciatore della Gran Bretagna a Costantinopoli (40% del capitale), Gulbenkian (40%) e la National Bank of Turkey (20%). All’epoca, Gulbenkian, armeno di nazionalità ottomana, non era uno sconosciuto nel mondo del petrolio. Figlio e nipote di grossi importatori di petrolio russo, aveva compiuto gli studi a Londra, al King’s College, da dove era uscito con la laurea in ingegneria. Il padre lo aveva mandato allora a farsi le ossa nell’industria petrolifera di Baku, dove aveva avviato importanti rapporti commerciali e stretto legami con il ministro del governo ottomano per il petrolio e con i rappresentanti locali dei Rothschild e della Shell.
Ma sfortunatamente erano ancora i tedeschi a detenere le concessioni minerarie in Mesopotamia, e ciò impose agli inglesi, volens nolens, un riavvicinamento tattico con i tedeschi, tanto più che anche gli americani cercavano di entrare nel gioco, approfittando della rivoluzione dei Giovani Turchi. Per un fenomeno solo apparentemente anomalo gli Stati Uniti, pur essendo assurti a massimi produttori di petrolio e pur regolando di fatto il mercato petrolifero mondiale in quanto possedevano un’organizzazione molto avanzata per tutti gli stadi della produzione e della vendita dei prodotti petroliferi, erano stati finora tagliati fuori dai giochi mediorientali.
In realtà, la politica degli Usa non è quella di puntare al controllo diretto delle colonie: avendo a disposizione un immenso territorio ricco di materie prime e uno sterminato mercato interno, hanno bisogno piuttosto di nuovi mercati di sbocco per le merci e i capitali. La politica imperialista americana punta su pressioni economiche e su interventi militari ad hoc per creare un’area favorevole al dollaro. Quando gli americani fanno mostra di voler difendere l’integrità territoriale di alcuni paesi appellandosi alla politica della “porta aperta” (agli interessi statunitensi!), lo fanno per tenere fuori i concorrenti.
All’inizio del 1910 gli Stati Uniti avevano inviato il contrammiraglio Chester ad offrire ai turchi un vasto programma di lavori pubblici e di sviluppo economico proponendo, tra gli altri progetti, la costruzione di tre ferrovie a patto di ottenere le stesse condizioni dei tedeschi. Nel marzo, uomini d’affari americani avevano creato l’Ottoman American Development Co., depositando presso la Banca di Turchia la somma di 88 mila sterline. I negoziati furono caldeggiati ufficialmente dal sottosegretario di stato Wilson, recatosi a Costantinopoli in occasione dell’incoronazione del nuovo sultano Maometto V.
Ma la controffensiva diplomatica tedesca e inglese contro la penetrazione americana convincerà gli ottomani a lasciar cadere le trattative in corso. Tedeschi e inglesi avevano buone carte da giocare presso il nuovo governo, in quanto godevano di forti disponibilità di capitali e di una consolidata egemonia commerciale e politica nell’area. Dopo due anni di estenuanti trattative, il 19 marzo 1914, venne creato, sotto l’egida dei governi britannico e tedesco, un Consorzio denominato Turkish Petroleum Company (TPC), il cui capitale era posseduto per una metà dall’Anglo-Persian (controllata dal governo britannico) per l’altra metà dalla Deutsche Bank (in rappresentanza del governo tedesco) e dalla Royal Dutch Shell.
Stretto nella morsa di interessi più grandi di lui, Gulbenkian si vedrà riconosciuto a malapena il 5% di partecipazione agli utili senza diritto di voto; l’interesse del 5% gli sarà versato per metà dal gruppo D’Arcy e per metà dalla società di Deterding, detratto dalle rispettive quote. Nelle sue memorie Gulbenkian non nasconderà il suo rancore: «L’ingiustizia di questo accordo è un esempio di ciò che possono fare i gruppi petroliferi per influenzare gli ambienti governativi grazie alle leve di cui dispongono».
Stavano maturando le condizioni favorevoli per quella guerra contro il concorrente tedesco che i governi inglese e francese aspettavano da decenni e che i marxisti avevano predetto fin dalla disfatta francese del 1871.
L’epoca dello sviluppo imperialistico (1875-1914) è caratterizzata all’inizio dall’esistenza di un gran numero di nuovi campi di investimento per i capitali, poi dalla contesa per questi investimenti da parte delle varie potenze. Nella fase monopolistica del capitalismo le economie nazionali sono strettamente legate alle frazioni nazionali del capitale finanziario e si trovano in competizione fra loro sia per difendersi dalla reciproca concorrenza sia per contendersi il mercato mondiale. Ad un certo momento, la lotta fra i capitali monopolistici diventa guerra imperialistica fra gli Stati a cui i capitali fanno riferimento.
Le due fasi sono evidenti negli avvenimenti che precedettero la Prima Guerra mondiale. Dopo una prima fase di espansione relativamente pacifica del capitalismo europeo (pacifica nelle relazioni tra potenze, omicida nelle relazioni con i paesi colonizzati) sancita dalla Conferenza internazionale di Berlino del 1885 che aveva regolamentato la spartizione dell’Africa centrale, in particolare il bacino del Congo ricchissimo di materie prime, si arrivò inevitabilmente allo scontro fra le potenze, in un crescendo impressionante: 1898, conflitto sfiorato tra Gran Bretagna e Francia in Sudan e in Niger e guerra ispano-americana; 1899-1902, guerra anglo-boera e politica della “porta aperta” in Cina; 1904-05, guerra russo-giapponese; 1905 e 1911, crisi marocchina; 1908, contrasti tra Russia e Gran Bretagna per l’Afghanistan, e fra Russia e Austria per i Balcani; 1912-13, guerre balcaniche.
In questa divisione del mondo la Gran Bretagna fa la parte del leone grazie alla sua, ancora per poco, indiscussa superiorità industriale e finanziaria: domina l’India, la Malesia, la Birmania, una serie di capisaldi sulla via verso l’India da Porto Said a Città del Capo, estende il suo impero su metà delle isole del Pacifico e conserva le sue colonie in America, in Australia e in Nuova Zelanda. La Francia si appropria di territori in Africa del Nord e in Africa occidentale ed equatoriale, oltre che del Madagascar, del Vietnam e di alcune isole del Pacifico. Il piccolo Belgio acquista l’immenso impero del Congo. L’Olanda consolida la sua dominazione sull’Indonesia e sulle Indie occidentali. La Germania si accaparra preziose colonie nell’Africa occidentale e orientale, in Asia e in Oceania. La Russia si espande verso est, in Siberia, e verso sud. Il Giappone occupa Formosa e posizioni sul continente asiatico (Port Arthur, Corea). L’Italia ottiene alcune colonie in Africa. Anche gli Usa prendono parte alla spartizione del mondo: essi puntano la loro attenzione sul controllo degli oceani strappando agli spagnoli bocconi del loro antico impero: Cuba, Portorico, Guam, le Hawaii e le Filippine, importanti per la proiezione verso la Cina.
L’entrata in guerra dell’impero Ottomano a fianco della Germania e il suo definitivo smembramento dopo la sconfitta faranno diventare le risorse petrolifere della pianura del Tigri e dell’Eufrate il pomo della discordia tra i grandi imperialismi. Le rivalità derivanti dagli enormi interessi economici e finanziari delle Compagnie, che spesso detteranno l’agenda dei governi, faranno da moltiplicatore per gli antagonismi politici. Gli scontri fra il capitale tedesco, che cercava di creare un mercato unificato nei Balcani e nell’area dell’impero Ottomano (ferrovia Berlino-Baghdad), e il capitale francese e inglese che si opponevano a questo progetto, saranno il preludio alla prima carneficina imperialista del 1914.
La guerra sancirà di fatto la vittoria definitiva del petrolio sul carbone. Nel 1914 gli eserciti che si affrontavano erano ancora quelli del XIX secolo, ma ben presto la meccanizzazione e il largo impiego del motore a scoppio modificheranno l’apparato bellico e la conduzione stessa della guerra, sia sul mare con l’introduzione delle navi con motore a nafta, sia in terra e in cielo con le automobili, i carri armati, gli esplosivi e infine gli aerei. Il generale francese Gallieni requisì tutti i taxi di Parigi per trasportare nel giro di 48 ore settemila uomini e le relative munizioni sul fronte della Marna, bloccando l’avanzata tedesca. Durante la battaglia di Verdun la “strada sacra” che vi porta era un unico serpentone di camion carichi di uomini e di munizioni. L’approvvigionamento di petrolio diventerà il nodo cruciale della guerra. Le riserve inglesi erano alimentate dall’Anglo-Persian mentre la Germania aveva investito masse enormi di capitali per lo sfruttamento dei giacimenti della Romania. Quanto alla Francia, per soddisfare la sua sete di petrolio fu costretta a rivolgersi al presidente americano Wilson e quindi al monopolio Standard Oil.
L’aiuto finanziario e materiale della potenza americana (capitali, energia, materie prime, prodotti alimentari e industriali, come i camion della Ford, ecc.) sarà decisivo per la vittoria degli alleati. Ma quando la guerra sottomarina tedesca metterà a rischio i rifornimenti europei di petrolio, in certi ambienti si farà strada l’idea che non si può parlare di indipendenza politica senza il controllo dell’approvvigionamento delle fonti di energia. Come farà notare nel 1917 il senatore Henry Bérenger, presidente del neo-costituito Comité Général du Pétrole, «la questione del petrolio si avvia a divenire una questione di politica internazionale». Mentre l’ex rivoluzionario ed ora vampiro Clemenceau dirà nel 1918 che «una goccia di petrolio vale una goccia di sangue».
Gli americani scalpitavano per mettere le mani sulla torta petrolifera mediorientale. L’occasione per entrare in guerra dalla porta principale fu loro data proprio dalla guerra sottomarina intrapresa dalla Germania contro le “neutrali” navi statunitensi, oltre che dai tentativi messi in atto sempre dai tedeschi per arruolare il Messico in funzione anti-americana con la promessa della restituzione del Texas. Così, nell’aprile 1917 più di quattro milioni di soldati americani, con i democratici fiori nelle bocche dei fucili, furono spediti sui campi di battaglia per difendere il capitale americano in Europa e nel Medio Oriente.
Qui intanto inglesi, francesi e russi, fedeli alla regola di vendere la pelle dell’orso prima di averlo scuoiato, già intessevano febbrili negoziati per spartirsi le spoglie dell’impero Ottomano, e ciascuno cercava di acquisire posizioni e alleanze vantaggiose da far pesare al tavolo delle future trattative. Nel 1916 l’amministrazione britannica, per indebolire la Turchia, aveva spinto Hussein, lo Sharif hascemita della Mecca, a guidare la rivolta araba contro il sultano, promettendo a lui e alla sua famiglia l’egemonia sulle varie componenti arabe presenti nell’Impero, e pose al suo fianco vari “collaboratori” inglesi, il più celebre dei quali passerà alla storia come Lawrence d’Arabia. Sempre nel 1916 fu siglato l’accordo segreto anglo-francese di Sykes-Picot che delimitava le rispettive zone di influenza da far valere alla fine della guerra.
Venuto
a conoscenza di questi accordi, che lasciavano gli Stati Uniti fuori
dall’area, Rockefeller era stato tentato di chiudere il rubinetto
del petrolio. Ma alla fine prevalse la saggezza dell’antico
proverbio: meglio un uovo oggi che una gallina domani. Così
continuò
a vendere il petrolio ad entrambe le parti belligeranti senza battere
ciglio, anche dopo l’entrata in guerra degli Stati Uniti a fianco
degli Alleati. Dopotutto, gli affari sono affari! Peraltro, la
Standard Oil non fu la sola Compagnia a collaborare con le
autorità
tedesche durante la guerra; così si comportò l’omologa
anglo-olandese, la Renania, che altri non era che la filiale tedesca
della Shell olandese; anche se i Paesi Bassi rimasero neutrali fino
alla fine della guerra. La sedicente “immoralità” dei monopoli,
è pane per denti piccolo-borghesi. Noi sappiamo con Lenin che
gli
interessi dei monopoli tedeschi e americani erano strettamente
intrecciati già prima di questa guerra e, aggiungiamo noi,
continueranno ad esserlo anche durante la Seconda.
Già nell’autunno del 1914 le truppe britanniche erano sbarcate nello Shatt-al-Arab e risalite verso Bassora con l’ordine di garantire la sicurezza dei campi petroliferi, delle raffinerie e dell’oleodotto. Ben presto le sconfitte subite dalle armate zariste, poi la rivoluzione del 1917 distoglieranno i russi dalla regione dove gli inglesi resteranno per un bel pezzo incontrastati padroni.
La rivolta araba guidata da Hussein, con l’appoggio delle truppe britanniche, aveva reso possibile nel 1918 la conquista dei paesi arabi ai danni della Turchia. Ma il sogno degli hascemiti di creare un vasto Stato arabo indipendente urtava contro gli interessi territoriali anglo-francesi, così come erano stati formalizzati negli accordi del 1916. In base ad essi la Francia avrebbe amministrato oltre alla Cilicia, la costa siriana e libanese fino ad Akko, mentre alla Gran Bretagna sarebbero spettati la Mesopotamia meridionale, compresa Baghdad, e in Palestina i porti di Akko e Haifa. Inoltre il 2 novembre 1917 Balfour, a nome del governo inglese, aveva annunciato la fondazione in Palestina di un “focolare nazionale ebraico”. Sfidando il ridicolo, venne escogitata la formula dei mandati: Francia ed Inghilterra ricevevano dalla Società delle Nazioni il mandato di amministrare i territori della Mezzaluna fertile, per portarli alla... completa indipendenza!
Dopo due anni di ipocrite trattative, una convenzione franco-britannica per il petrolio venne firmata nell’aprile del 1920 a San Remo all’interno della Conferenza convocata per concludere il trattato di pace con la Turchia, all’insaputa degli americani. Il trattato attribuiva alla Francia il mandato sulla Siria, Libano compreso, e all’Inghilterra sulla Palestina e l’Iraq. Da notare che il trattato assegnò all’Iraq e non alla Siria il distretto petrolifero di Mosul, che gli accordi del 1916 avevano invece posto nella zona d’influenza francese. La Francia fece buon viso a cattivo gioco perché sperava nel sostegno della Gran Bretagna per l’occupazione della Ruhr. Come contropartita essa ottenne comunque la quota tedesca (23,75%) della Turkish Petroleum, in cambio dell’impegno ad agevolare la costruzione di un oleodotto fino al Mediterraneo attraverso la Siria.
Il governo francese aveva fretta di imbastire una politica del petrolio. Nel 1923, il presidente del Consiglio Poincaré affidava ad alcuni uomini d’affari l’incarico di impostare una politica nazionale del petrolio e di costituire una società avente lo scopo di gestire le azioni della Turkish, ancora sotto sequestro a Londra. Nella primavera del 1924 verrà creata la Compagnie Française des Pétroles (Cfp), nella quale entrerà anche lo Stato con una quota del 25%. L’industria automobilistica francese era allora in pieno sviluppo: il parco veicoli toccava il milione e Citroën era il primo costruttore d’Europa. Il governo francese mise a capo della Compagnia un celebre scienziato del Politecnico, Ernest Mercier, e diede alla società una protezione particolare, costruendo raffinerie per il greggio proveniente dal Medio Oriente. Ma la Cfp non avrà mai una produzione di scala paragonabile a quella delle concorrenti anglo-americane, e il risentimento francese contro il loro dominio coverà sempre sotto la cenere, con periodiche esplosioni.
14. Prove di guerra tra fratelli
La Gran Bretagna aveva ottenuto il pieno controllo dell’Iraq, ma la regione si avviava a diventare teatro di un nuovo scontro tra gli imperialismi. Già nell’estate del 1920 gli inglesi dovettero affrontare un’imponente rivolta nella regione dell’Eufrate, per reprimere la quale usarono gas asfissianti e bombe ad innesco ritardato, che lasciarono sul campo novantamila morti. Nel marzo 1921, una conferenza riunita al Cairo decise di creare un regno ereditario in Iraq e di affidarne la corona al principe hascemita Faysal, che gli inglesi avevano messo sul trono in Siria nel 1919 e che i francesi avevano detronizzato l’anno dopo. Per l’Inghilterra, che aveva bisogno di stabilità per continuare in santa pace le sue ricerche petrolifere, la scelta di un governo arabo di facciata che governasse a loro nome era perfetta.
Che il re fosse un burattino degli inglesi fu dimostrato dalla questione di Mosul. Questo territorio, ricco di petrolio, popolato in maggioranza da curdi, arabi musulmani e arabi cristiani, era rivendicato e dalla Turchia e dall’Iraq. L’Inghilterra naturalmente preferiva vedere le regioni petrolifere in mano agli iracheni piuttosto che ai turchi. Così nel 1924 il colonnello Lawrence “suggerì” a Faysal di rivendicare la sovranità sul territorio curdo. Gli inglesi portarono la controversia davanti alla Società delle Nazioni, che attribuì all’Iraq la maggior parte del vilayet di Mosul. I timidi tentativi di re Faysal di legittimarsi – straniero imposto sul trono dall’esterno – nel nuovo composito Stato andranno a vuoto. Nel 1932 l’Iraq raggiungerà l’indipendenza formale, primo degli Stati nel sistema dei mandati, ma di fatto i britannici conserveranno il pieno utilizzo delle basi militari e un controllo diretto dell’esercito per mezzo di consiglieri militari.
Gli Stati Uniti, deliberatamente esclusi dagli accordi di San Remo col pretesto che non avevano dichiarato guerra alla Turchia, contestarono duramente il trattato: l’ambasciatore americano a Londra consegnò una nota di protesta al Foreign Office in cui implicitamente si accusava l’Inghilterra di voler esercitare una forma di monopolio per la produzione di una materia essenziale come il petrolio, in oltraggio al principio dell’uguaglianza nei rapporti internazionali. Con linguaggio pomposo la nota ricordava il contributo dato dall’America alla vittoria e il suo diritto a partecipare alla divisione del bottino. Era la solita storia del lupo che accusava l’agnello (in questo caso un altro lupo che perdeva il pelo) di intorbidire l’acqua pur bevendo a valle. Il ministro degli esteri inglese lord Curzon rammentò agli americani che il petrolio proveniente dalla Persia rappresentava soltanto il 4,5% della produzione mondiale, mentre gli Stati Uniti ne controllavano il 70%. Era la prima volta che si affrontavano direttamente il Foreign Office e il Dipartimento di Stato di Washington: fino ad allora le Compagnie inglesi ed americane avevano regolato le loro vertenze in via privata, senza far intervenire i rispettivi governi.
Gli inglesi sospettavano che dietro i ribelli iracheni ci fossero i dollari americani.
Ma per il Dipartimento di Stato la politica della “porta aperta” (nel senso di rimuovere gli ostacoli all’entrata degli americani e permettere così alle potentissime società statunitensi di eliminare i concorrenti meno attrezzati) non doveva ancora attentare alla supremazia britannica per non mettere a rischio la stabilità dell’area. Alla fine, l’Anglo-Persian e la Shell si lasciarono persuadere dal governo che la cooptazione degli americani rientrava nell’interesse nazionale britannico e che il capitale e la tecnologia americani avrebbero accelerato il processo di sviluppo petrolifero del paese e rafforzato il governo filo-britannico.
15. Imperialismo e Rivoluzione in Russia
La rivoluzione bolscevica del 1917 aveva posto agli Alleati seri problemi sia riguardo ai rapporti da intrattenere con il nuovo governo sovietico sia riguardo alle frontiere del nuovo Stato. Quando nel novembre del 1918 i bolscevichi denunciarono il trattato di Brest-Litovsk, che aveva sancito la pace con la Germania nel marzo precedente, gli Alleati esitarono fra tre soluzioni: il negoziato, la lotta armata, la politica del “cordone sanitario”. A tutta prima si scelse l’opzione armata: il 1° dicembre 1918 l’ammiraglio Kolciak con l’appoggio inglese si impadronì del governo panrusso della Siberia, mentre il generale Berthelot, a capo delle truppe alleate in Romania, annunciò l’invio di 150 mila uomini e forniture militari a Odessa.
Ma questo atteggiamento mutò dopo la riconquista da parte dei bolscevichi dell’Ucraina, della Russia bianca e dei Paesi baltici e la sconfitta di Kolciak in Siberia. Lloyd George, Wilson e Clemenceau optarono allora per una conferenza di pace, e a questo scopo mandarono in Russia William Bullit per preparare il terreno. Dopo numerosi incontri, il 14 marzo 1919 Bullit e Lenin si accordarono su un progetto di pace che prevedeva che tutti i governi della Russia avrebbero conservato i loro territori, che sarebbero riprese le relazioni commerciali, che le truppe alleate si sarebbero immediatamente ritirate dalla Russia. Ma a Parigi il piano fu bellamente ignorato, probabilmente a causa dei tentativi rivoluzionari scoppiati nel frattempo in Germania con gli spartachisti e in Ungheria con Bela Kun. Né dovette essere particolarmente gradito agli occidentali l’annuncio a Mosca della creazione della Terza internazionale, nel marzo 1919. La nuova politica che si scelse di applicare contro i bolscevichi fu quella del “cordone sanitario”, ossia dell’appoggio alle armate controrivoluzionarie dei russi bianchi senza intervento diretto delle truppe occidentali.
Non ci dilungheremo sugli anni terribili della guerra civile, quando i bolscevichi furono costretti a ricorrere al petroliere americano Hammer per barattare le opere d’arte in cambio di grano e carburanti. Diremo soltanto che il fallimento della politica alleata di appoggio armato ai russi bianchi fu compensata da alcuni successi occidentali riguardo alla delimitazione delle frontiere sovietiche con la Finlandia, con le regioni baltiche, la Polonia e la Siberia.
Quanto al problema delle frontiere meridionali dei Soviet la questione fu abbastanza complessa. La rivoluzione russa aveva dato avvio a movimenti nazionalisti nelle regioni di frontiera del Caucaso. Nell’aprile 1918 si creò una Federazione Transcaucasica che poi si divise nei tre Stati indipendenti dell’Azerbaigian, dell’Armenia e della Georgia.
Distaccamenti inglesi dell’armata del Medio Oriente marciarono immediatamente verso i campi petroliferi di Baku, presto imitati dai tedeschi e dai Giovani Turchi di Mustafà Kemal, che inviarono loro truppe con il pretesto della lotta in corso tra azeri (una popolazione di origine turca che popola la regione) e armeni. Nell’aprile 1920, inseguendo l’esercito di Denikin, l’armata rossa invase l’Azerbaigian, l’Armenia e la Georgia: entrati a Baku, i bolscevichi cacciarono le truppe inglesi, tedesche e turche che erano arrivate fin là per impadronirsi del petrolio e come primo atto nazionalizzarono le quattrocento Compagnie petrolifere presenti nella zona. Ciò arrecò un notevole danno soprattutto alla Shell, che dal Caucaso ricavava la metà dei suoi rifornimenti. Ma anche la Exxon di Walter Teagle si scontrò per la prima volta con lo spettro della nazionalizzazione, che presto avrebbe turbato il sonno dei petrolieri di tutto il mondo.
La rivoluzione d’Ottobre aveva causato un rimescolamento delle carte e molte Compagnie avevano occupato la scena sperando di fare affari approfittando della confusione del momento. I fratelli Nobel offrirono a Teagle l’acquisto di un terzo dei loro interessi a Baku e – incredibile a dirsi – la Exxon continuò le trattative anche dopo che l’armata rossa aveva sequestrato i pozzi: evidentemente puntava sulla prossima caduta dei bolscevichi. L’accordo venne siglato nel giugno 1920 per una cifra di 11,5 milioni di dollari. Anche la Shell e la Bp, concorrenti della Exxon, cercavano di fare affari con i sovietici. Intanto i russi producevano petrolio in grande abbondanza e lo offrivano a basso prezzo, facendo incombere sugli americani la legge del contrappasso: l’incubo dell’inondazione nei mercati europei di petrolio russo a buon mercato. Alla fine Teagle e Deterding si accordarono per creare una società con l’obiettivo di tentare accordi separati con i sovietici «per la ricostruzione dell’intera industria petrolifera russa». Ma l’accordo non andò mai in porto sia per le esose richieste di denaro da parte di Teagle, sia perché un’altra Compagnia americana, la Mobil, lanciò una campagna di bassi prezzi nel mercato indiano per scalzare la Shell. Deterding rispose scatenando una violenta campagna di stampa in cui accusava la Standard Oil di collaborazione con il comunismo. Alla fine, i russi erano riusciti a far emergere le insanabili rivalità che da sempre dilaniavano le Compagnie occidentali.
Il 28 aprile del 1920 fu costituita la Repubblica sovietica dell’Azerbaigian. L’8 maggio, il governo sovietico riconobbe formalmente l’indipendenza della Georgia, ma vi organizzò un movimento rivoluzionario che l’anno seguente portò alla proclamazione della Repubblica socialista sovietica, sotto la protezione dell’Armata Rossa. Quanto all’Armenia, il 18 aprile 1921 le truppe sovietiche entrarono nella capitale Erivan proclamandovi la Repubblica sovietica. Il trattato russo-turco di Kars dell’ottobre 1921 sanciva il definitivo dominio sovietico nella Transcaucasia. Rispetto all’impero degli zar, i sovietici perdevano solo i distretti di Kars e di Ardahan ceduti alla Turchia.
Al II Congresso dell’Internazionale Comunista nell’estate del 1920, Lenin traccia un quadro della situazione post-bellica cui è bene riferirsi per inquadrare il fenomeno dell’erompere, grazie alla carneficina mondiale, dell’imperialismo americano. Lenin già vede, mentre gli avvenimenti sono ancora incandescenti, quello che diventerà chiaro solo in seguito: la fine del primato imperialistico dell’Inghilterra e la retrocessione dell’Europa borghese imprenditoriale e commerciale di fronte all’America banchiera e finanziaria. Alla testa degli Stati che, al lume della critica marxista, appaiono come i veri vincitori del conflitto egli colloca non l’Inghilterra, che nel 1914 era la potenza egemone, ma gli ultimi arrivati nella giungla capitalista, gli Stati Uniti; e al secondo posto il Giappone, il grande profittatore delle guerre provocate in Asia dall’imperialismo europeo. La chiave di questa trasformazione risiede essenzialmente nel fatto che gli Usa erano diventati “l’arsenale delle democrazie”, come dimostrerà definitivamente la replica in grande stile della Seconda Guerra mondiale.
La libera repubblica stellata non si limitava a fabbricare e a vendere armi ai belligeranti, era anche la cambusa degli eserciti in guerra: l’Europa aveva fame di armi, con cui alimentare la carneficina, e di viveri per sostentare le truppe, dal momento che il “fronte interno” non bastava a portare la produzione all’altezza dei bisogni degli stati maggiori. Così l’Europa divenne cliente degli Stati Uniti e chiese la vendita a credito di colossali ordinazioni a chi, fino al 1914, era stato suo debitore.
Mentre la guerra svenava le nazioni europee, l’economia americana faceva un balzo gigantesco. Gli impianti industriali subivano una pronta trasformazione nel campo tecnico e in quello della gestione, mentre le industrie europee segnavano il passo. In agricoltura furono incrementate le colture industriali e grandi estensioni di terra incolta dissodate e messe a coltura. Fiumi di prodotti industriali e di derrate si riversavano dalle coste atlantiche degli Stati Uniti in Europa, dove la fornace della guerra inghiottiva tutte quelle ricchezze acquistate ma non pagate. Il saldo dei debiti si rimandava alla fine delle ostilità.
Ciò che più di ogni altra cosa denuncia la svolta radicale compiuta dal capitalismo è il fatto, del tutto inedito, che la guerra imperialista, e per essa la dominazione del capitale finanziario, riduceva allo stato di colonia non solo paesi semicivili, ma persino le più progredite nazioni del mondo. Il trattato di Versailles imporrà ai popoli progrediti della Germania, dell’Austria-Ungheria, della Bulgaria condizioni che li precipiteranno in una situazione di soggezione coloniale, di miseria, di fame e di rovina, incatenandoli per numerose generazioni. Questo il vero volto del super-colonialismo capitalista sorto dalla Prima Guerra, la pace degli usurai che avrebbe gravato sulle generazioni future, provocando tremende catastrofi. All’indomani della guerra tutti i maggiori Stati sono indebitati; solo gli Stati Uniti si trovano in una situazione assolutamente indipendente. L’Inghilterra, che pure vanta crediti presso la Francia, l’Italia e la Russia, è debitrice nei confronti degli Usa per la cifra astronomica di 21 miliardi di sterline-oro.
Se si considera che le potenze indebitate verso gli Stati Uniti erano i vertici di immensi imperi coloniali e controllavano attraverso le loro banche la maggior parte del mondo abitato, ci si accorge come gli Usa già alla fine della guerra si fossero messi sulla strada della egemonia planetaria, che conquisteranno definitivamente con la Seconda Guerra mondiale. Si può dire che la condanna del vecchio colonialismo è decretata nel momento in cui le banche statunitensi hanno visto le maggiori potenze della vecchia Europa accorrere ai loro sportelli, anche se per vederne gli effetti politici e rivoluzionari bisognerà attendere che il vecchio edificio sociale imputridisca ancora.
17. Una Linea Rossa sul Medioriente
La guerra commerciale tra la Standard Oil e la Turkish Petroleum si trascinerà fino al 1928, quando un gruppo di Compagnie americane, appoggiate dal governo, riuscirà ad ottenere una partecipazione nell’Anglo-Persian. Decisivi furono i massicci ritrovamenti presso Kirkuk, nel 1927, che spinsero le Compagnie al compromesso. Il 31 luglio 1928 fu firmato a Ostenda, in Belgio, un accordo tra i vecchi azionisti della Turkish e i gruppi americani riuniti nella Near East Development Corporation (Nedc). Dopo il nuovo rimescolamento di carte, il pacchetto azionario dell’Iraq Petroleum Company (nuovo nome della Compagnia) apparterrà per il 47,5% a capitali inglesi (23,75% ciascuno alla Royal Dutch-Shell e all’Anglo-Persian), per il 23,75% a capitali americani, per il 23,75% a capitali francesi, e per il restante 5% alla nostra vecchia conoscenza Calouste Gulbenkian, il primo degli imprenditori solitari destinato ad arricchirsi a spese del Medio Oriente.
Contemporaneamente, per evitare attriti all’interno della nuova Compagnia che potessero mettere in pericolo l’equilibrio del Medio Oriente, furono stabilite alcune semplici regole comuni a tutti i contraenti, sulla base dell’antico postulato: lupo non mangia lupo. L’intesa passò alla storia come Accordo della Linea Rossa, perché Gulbenkian ebbe l’onore di segnare su una cartina con una matita rossa l’area geografica entro la quale i soci si impegnavano a non effettuare attività di ricerca se non congiuntamente, nonché a fare fronte comune per impedire qualsiasi intrusione di concorrenti. La Linea Rossa contornava gli attuali territori di Turchia, Siria, Libano, Israele, Giordania, Iraq e dell’intera penisola arabica, lasciando fuori il Kuwait e la Persia.
Ma l’accordo fu firmato alla vigilia della crisi economica mondiale e dopo un deciso crollo dei prezzi, che nel 1928 erano scesi del 60% rispetto a qualche anno prima. Infatti la guerra dei prezzi che Deterding aveva scatenato in India era ben presto dilagata in tutto il mondo e quella che era iniziata come una disputa intorno al petrolio russo finì per diventare una crisi generale dell’industria petrolifera, mettendo fuori mercato le società minori e diminuendo i profitti di tutti. Ma nessuno era sicuro di vincere perché ci si trovava di fronte ad una situazione di sovrapproduzione la quale, oltre che dalla contrazione dei consumi automobilistici, era determinata dalle nuove quote di produzioni di paesi come l’Iraq, il Venezuela e il Messico.
18. La dittatura delle Sette Sorelle
A combattersi con una concorrenza spietata erano alcune Compagnie internazionali che avevano in mano tutta la catena del ciclo del petrolio, dai pozzi di estrazione alle industrie che lo raffinavano, alle società che distribuivano il prodotto finito alle pompe di benzina, ricavando profitti giganteschi. Si trattava di veri e propri mostri economici-finanziari, sui cui territori non tramontava mai il sole, che facevano e disfacevano governi, compravano capi di Stato e ministri. Erano, e sono tutt’ora, poche. Cinque americane (la Standard Oil of New Jersey, più nota come Exxon o Esso; la Texas Oil Company, più nota come Texaco; la Gulf; la Mobil e la Standard Oil of California o Socal). Una era inglese, l’Anglo-Persian Oil Company (che diventerà British Petroleum o Bp). L’ultima, la Shell, era, come abbiamo visto, metà inglese e metà olandese. A queste sette grandi Compagnie, che Enrico Mattei negli anni Cinquanta battezzerà le Sette Sorelle, va aggiunta la francese Cfp (la futura Total), che era un’industria di Stato ed aspirerà invano a diventare l’ottava sorella.
Per mettere fine alla guerra dei prezzi urgeva un’intesa. Così, meno di due mesi dopo l’accordo della Linea Rossa, nell’agosto 1928, fu perfezionato un altro accordo, che si rivelerà determinante per i destini del mondo. Questa volta il luogo scelto per l’incontro fu il castello scozzese di Achnacarry, preso in affitto dal neo barone Henry Deterding, patron della Shell. Motivo ufficiale della riunione era la pesca della trota. Tra cavalcate e banchetti che durarono due settimane i grandi del petrolio (oltre al citato Deterding c’erano John Cadman della Bp, Walter Teagle della Exxon, William Mellon della Gulf, e i rappresentanti della Mobil, della Texaco e della Jersey) siglarono una dichiarazione di principi, detta Pool Association, che divenne nota con il nome di “As-is”, cioè “Così com’è”, e che rimase segreta fino al 1952. In sintesi fu convenuto che, constatati gli effetti distruttivi dell’eccessiva concorrenza tra le Compagnie, che aveva portato alla attuale tremenda sovrapproduzione, era meglio lasciare i rapporti di forza così com’erano: nessuno avrebbe cercato di espandersi, nessuno avrebbe aumentato unilateralmente la produzione. Anzi, l’accordo stabiliva l’uso in comune degli impianti per evitare la costruzione di nuove raffinerie, e lo scambio di petrolio tra le Compagnie per rifornire i mercati più vicini.
Ma la decisione più importante fu che da allora in poi ci sarebbe stato un solo prezzo del petrolio, valido per tutto il mondo, calcolato con un sistema molto semplice: il prezzo ufficiale sarebbe stato quello del petrolio americano proveniente dal golfo del Messico aumentato dei costi di trasporto e nolo dai porti del golfo del Messico ai paesi destinatari. Nel calcolo non si teneva in nessuna considerazione la provenienza del greggio: qualunque fosse stata, esso sarebbe costato come se venisse dal golfo del Messico. I prezzi americani diventavano i prezzi mondiali.
Dopo la scoperta degli enormi giacimenti in Medio Oriente negli anni Trenta, dove l’estrazione del petrolio costava cinque volte di meno rispetto al Texas (venti centesimi contro circa un dollaro), le Compagnie del cartello petrolifero lucrarono enormi sovrapprofitti. Il prezzo di mercato di un minerale non è quello che realizza il profitto medio, ma è tale da consentire all’impresa che lavora con la più bassa produttività di percepire il tasso medio del profitto. La differenza tra il costo di produzione singolo e quello del produttore meno produttivo costituisce la rendita differenziale. Così le forniture di petrolio sia agli Stati Uniti sia all’Europa occidentale, pagate non sulla base del prezzo di produzione del petrolio del Medio Oriente ma su quello del golfo del Messico, maggiorato delle spese di trasporto “virtuali”, faranno incamerare miliardi di dollari di rendita differenziale alle società sindacate.
Tuttavia il prezzo del petrolio per un quarto di secolo non supererà il dollaro a barile, favorendo la crescita dell’economia occidentale.
L’accordo supererà indenne la crisi del ’29 e la Seconda Guerra mondiale, e durerà nella sostanza fino agli anni Sessanta, assicurando alle Compagnie del cartello un predominio assoluto nel mercato. Una volta stabilito il prezzo sulla carta (il famoso Posted Price), l’unico problema per le Compagnie consisteva nel tenere sotto controllo i fattori che avrebbero potuto determinare una caduta del prezzo reale rispetto al prezzo fissato, facendo in modo che la produzione non eccedesse la domanda. Questo controllo fu possibile grazie alla capacità delle Compagnie di padroneggiare tutta la filiera e al dominio delle concessioni attraverso l’intreccio delle partecipazioni. Una conferma grandiosa della tesi di Lenin, secondo cui la trasformazione della concorrenza in monopolio è uno dei fenomeni più importanti – se non il più importante – dell’economia del capitalismo moderno.
Due fattori concorsero al successo dell’accordo di Achnacarry nell’arrestare il crollo dei prezzi: il maggiore consumo industriale russo e il contingentamento della produzione petrolifera americana. Questo nel 1930 si era reso necessario dopo la scoperta di nuovi giacimenti in Texas: per evitare nuove trivellazioni e la sovrapproduzione, i governatori dell’Oklahoma e del Texas proclamarono la legge marziale e fecero occupare i pozzi dalla Guardia nazionale. L’arrivo alla presidenza di Roosevelt fece della deflazione petrolifera uno dei punti della lotta contro la Grande Depressione, fissando per legge un tetto alla produzione. I monopoli avevano vinto: tra il 1934 e il ’39 il prezzo del petrolio si attestò stabilmente intorno a un dollaro per barile.
Il fascino esercitato dal petrolio mediorientale era irresistibile e non risparmiava nessuno, perché l’economia di nessun paese poteva fare a meno di quella linfa vitale, di quel liquido maleodorante di cui il capitalismo ha bisogno per mantenere in vita la sua macchina insaziabile. Nel 1932 era stato scoperto il petrolio nel Bahrein, una catena di isole al largo della costa saudita, che era allora un protettorato britannico e un’appendice dell’impero Indiano (la sua moneta legale era infatti la rupia). Gli inglesi erano dunque ben piazzati. Ma l’Anglo-Persian in quel momento di petrolio ne aveva a sazietà in Persia e in Iraq e non era troppo interessata al Bahrein. Altrettanto disinteressate si mostrarono la Exxon e la Gulf, quest’ultima soprattutto perché, quale membro dell’IPC, si era impegnata a non fare esplorazioni nell’area della Linea Rossa.
Toccò ad un outsider, la Standard Oil of California (Socal), approfittare delle indecisioni delle sorelle maggiori. Per superare le difficoltà frapposte dal governo britannico il Dipartimento di Stato americano invocò ancora una volta il principio della “porta aperta”. L’anno successivo la Compagnia iniziò il corteggiamento anche all’Arabia Saudita, e la cosa andò in porto grazie ad Harry Philby, un ex funzionario inglese convertito alla religione musulmana e diventato intimo del re Ibn Saud. Il re saudita aveva bisogno di oro sonante e, dopo la scoperta del petrolio nel vicino Bahrein, non fu difficile convincerlo ad aprire le frontiere ai capitali stranieri. Philby divenne consulente della Socal e le fece ottenere la prima concessione saudita della storia, lasciando fuori gli inglesi.
Lo stabilirsi nell’Arabia Saudita di una Compagnia esclusivamente americana era destinato a mutare l’intero equilibrio politico in tutto il Medio Oriente. Quando le trivellazioni cominciarono a dare i loro frutti nel Bahrein, la Socal, dalla sua posizione isolata, si rese conto di essere a corto sia di capitali sia di mercati di sbocco, saldamente in mano alla Exxon. Così fu costretta a rivolgersi all’unica delle Sette Sorelle che non era vincolata alla Linea Rossa, la Texaco, la quale disponeva di una rete commerciale in Asia e nella Spagna di Franco, e che fu ben contenta di trovare una nuova fonte di greggio. Nel 1935 dalla loro unione nacque l’Aramco (Arabian American Oil Company) e tre anni dopo dai favolosi campi petroliferi arabi cominciò a sgorgare il primo petrolio. La concessione messa a disposizione dal re saudita aveva una superficie come quella del Texas, della Louisiana, dell’Oklahoma e del Nuovo Messico messi insieme.
Nello stesso periodo, anche il Kuwait fece il suo ingresso sul palco della commedia del petrolio: la battaglia tra gli interessi britannici e americani fu combattuta principalmente dietro le quinte, tra i rispettivi governi. Gli inglesi dell’Anglo-Persian fecero tesoro dello smacco subito nell’Arabia Saudita e nella gara per le concessioni kuwaitiane costituirono una società paritaria con la Gulf, la Kuwait Oil Company. Nel 1938, dopo due anni di perforazioni nei posti sbagliati, la Compagnia mista scoprì finalmente un ricco giacimento, che però rimase non sfruttato per diversi anni sia a causa dello scoppio della Seconda Guerra mondiale sia per la resistenza degli inglesi, i quali non volevano far concorrenza al loro petrolio iracheno e persiano.
20. Immoralità o rendita fondiaria ?
Nel 1952 il governo americano rivelò che una clausola nell’accordo di Achnacarry ne escludeva l’applicazione al mercato interno americano e alle esportazioni provenienti dagli Usa. L’intenzione era di obbligare i petrolieri ad abbassare i prezzi ed impedire che i crediti del piano Marshall finissero soprattutto nelle loro tasche. Ma certo non si trattava di una dichiarazione di guerra alla lobby petrolifera. Quando gli “onesti” democratici denunciano, in nome della loro “morale”, l’aspetto “scandaloso” dei sovrapprofitti dei petrolieri, dimenticano che i sovrapprofitti e le rendite dei monopoli provengono solo dal plusvalore prodotto dalle classi lavoratrici. Marx da oltre un secolo ha dimostrato che questa “malversazione” è una legge economica inesorabile del sistema capitalista e porta il nome di rendita fondiaria. Il prezzo del petrolio non è dovuto all’immoralità e alla rapacità dei petrolieri ma alla legge della rendita fondiaria, che pesa come un macigno sulle spalle della forza lavoro del proletariato.
Scrivemmo in “Il Programma Comunista”, n. 8, 1955, “Il cartello del petrolio e le basi della conservazione capitalistica”:
«Il problema non si imposta in termini di nazioni ma in termini di classi. Ciò si comprende appena ci si accorge che una diversa politica del Consorzio è cosa impossibile perché segnerebbe la rovina, ferme restando le leggi dell’economia mercantile e monetaria, della industria del petrolio, da cui conseguirebbe una minaccia di morte per la stessa conservazione della classe borghese (...) Il petrolio, come altri articoli di monopolio, finché resterà merce scambiabile con denaro, cioè finché resterà il capitalismo, sarà venduto nelle condizioni capestro imposte dal cartello internazionale. Le leggi del mercato vietano che lo stesso articolo di monopolio possa essere venduto a prezzi diversi, anche se determinate condizioni economiche permettano di produrre a costi differenziati. Il petrolio, per il diverso grado di efficienza dei pozzi a seconda della configurazione geologica del giacimento e dell’età del suo sfruttamento, viene prodotto a costi diversi. Certi pozzi in via di esaurimento hanno un bassissimo rendimento e quindi producono ad alti costi (...) Stando così le cose, si comprende agevolmente che, se il prezzo di vendita del petrolio fosse equiparato al prezzo di produzione del greggio estratto dai pozzi ad alto rendimento, una sicura condanna a morte peserebbe sui pozzi a bassa produzione (...) Di conseguenza il cartello internazionale viene a realizzare oltre al profitto normale enormi sovrapprofitti (la rendita differenziale di Marx) che sono dati appunto dalla differenza tra i costi di produzione (...) e il prezzo di mercato (...)
«Non è l’Europa, termine che socialmente dice nulla, ma sono le masse lavoratrici dell’Europa che, in ultima analisi, pagano gli smisurati sovrapprofitti del cartello del petrolio (...) Le borghesie europee sono esse stesse parti contraenti del Consorzio internazionale o alla politica di questo legano indirettamente (produzione e vendite dei raffinati, trasporti del greggio, ecc.) immensi interessi. Se dunque il capitalismo europeo partecipa al pantagruelico banchetto dei sovrapprofitti petroliferi, è chiaro che questi debbano uscire dal lavoro e dal sangue di masse lavoratrici europee. Perciò noi diciamo che il principale oggetto dello sfruttamento e la più ricca colonia del trust del petrolio sono, molto più che il sottile strato salariato indigeno che lavora nei pozzi del Medio Oriente, le masse salariate dell’Europa occidentale (...) Il capitale maneggiato dal trust del petrolio non è, a rigore, né americano, né inglese, né francese, né olandese; è, al contrario, una potenza senza nome e internazionale».
E ancora da ”Vulcano della produzione o palude del mercato?” del 1954:
«Non è quindi la concorrenza libera il carattere di base dell’economia borghese, ma il sistema dei monopoli, che permette di vendere tutta una gamma di prodotti, tra cui quelli preminenti della terra agraria e dell’industria estrattiva, a prezzi superiori al valore ossia alla somma di sforzo sociale che essi costano, dopo aver anche pagato il normale profitto dell’industria “libera”. La teoria quantitativa della questione agraria e della rendita è quindi la completa ed esauriente teoria di ogni monopolio e di ogni sopraprofitto di monopolio, per ogni fenomeno che stabilisca i prezzi correnti al di sopra del valore sociale. E ciò avviene quando lo Stato monopolizza le sigarette, come quando un potente trust o sindacato monopolizza, poniamo, i pozzi di petrolio di tutta una regione del globo, come quando si forma un pool internazionale capitalistico del carbone o dell’acciaio o, come sarà domani, dell’uranio. Quindi il senso generale del capitalismo è questo: storicamente comincia con l’abbassare quello che si potrebbe dire l’indice del lavoro sociale per una data quantità di prodotto manifatturato, il che condurrebbe la società a consumare gli stessi prodotti, ed anche prodotti aumentati, con un minore impiego di lavoro, e quindi diminuendo le ore di lavoro della giornata solare (...)
«Non potendosi fermare il ritmo di inferno della accumulazione, questa umanità, parassita di se stessa, brucia e distrugge sopraprofitti e sopravalori in un girone di follia, e rende sempre più disagiate e insensate le sue condizioni di esistenza. L’accumulazione che la fece sapiente e potente la rende ora straziata e istupidita, fino a che non sarà dialetticamente capovolto il rapporto, la funzione storica che essa ha avuto (...)
«Non a caso un analogo ciclo del capitalismo ha condotto alla presente situazione di mostruoso volume di una produzione per nove decimi inutile alla sana vita della specie umana, e ha determinato una sovrastruttura dottrinale che richiama la posizione di Malthus, invocando, a costo di chiederli alle forze infernali, consumatori che inghiottano senza posa quanto l’accumulazione erutta. La scuola del benessere, con la sua pretesa che l’assorbimento individuale di consumo possa salire oltre ogni limite, gonfiando le poche ore, che il lavoro obbligato e il riposo lasciano a ciascuno, di fasti e riti e morbose follie parimenti obbligate, esprime in realtà il malessere di una società in rovina, e volendo scrivere le leggi della sua sopravvivenza non fa che confermare il decorso, forse ineguale, ma inesorabile, della sua orribile agonia».
In Francia, al tempo del Fronte Popolare, l’automobile si “democratizzava”: la Germania nazista aveva inventato la “Volkswagen”, Citroën la “Due cavalli”. La benzina era allora abbondante e a buon mercato grazie alla partecipazione francese nell’Iraq Petroleum, con le quote strappate alla Deutsche Bank.
Lo stesso non si poteva dire dell’Italia che, estromessa totalmente dal ricco pascolo petrolifero del Medio Oriente, era costretta a rifornirsi di carburante in Romania. La società Agip (Azienda Generale Italiana Petroli) era stata creata con un regio decreto del 3 aprile 1926 per lo svolgimento dell’attività relativa all’industria e al commercio dei prodotti petroliferi. L’azienda nasceva nella forma di società per azioni, ma di fatto era un ente pubblico: il capitale sociale era conferito per il 60% dal ministero del Tesoro, per un 20% dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (Ina) e per il restante 20% dalle Assicurazioni Sociali. Nel 1927 fu emanata la cosiddetta “legge mineraria”, che attribuiva la proprietà del sottosuolo al demanio dello Stato ed imponeva pertanto che qualunque attività petrolifera fosse soggetta ad autorizzazione o concessione governativa. La società attraversò difficoltà dopo la crisi del 1929, ma riprese a svilupparsi negli anni Trenta. Nel 1933 fu emanata una norma protezionistica in materia di raffinerie e l’Agip poté operare con maggior agio anche in questo settore.
Alcuni anni prima l’Agip era riuscita ad entrare in una cordata finanziaria inglese, estranea all’Iraq Petroleum, che aveva costituito la British Oil Development (Bod) con lo scopo di perseguire la politica della “porta aperta” in Mesopotamia ed entrare nell’affare del petrolio iracheno. Il capitale era così ripartito: 51% al gruppo inglese, 25% all’Agip, il resto ad un gruppo tedesco di cui facevano parte i Krupp. Nel 1932, aggiudicatasi una importante concessione nella zona di Mosul, la società prese il nome di Mosul Oilfields: in essa l’azienda di Stato italiana, acquisendo ulteriori quote, era riuscita a diventare socio di maggioranza.
Per un attimo sembrò invertirsi la miope tendenza della politica estera italiana, che dopo lo smacco degli accordi di San Remo, quando l’Italia fu esclusa dalla spartizione del Medio Oriente, era portata più a mere rivendicazioni territoriali che al dominio economico assicurato dal controllo del petrolio. Ma nell’agosto del 1936, proprio quando la produzione petrolifera irachena si avviava a toccare i cinque milioni di barili, su direttiva del governo italiano l’intera quota di capitale fu incomprensibilmente ceduta alle Compagnie anglo-americane dell’Iraq Petroleum. Non si capirebbe il voltafaccia italiano senza accennare ai coevi avvenimenti africani.
Nel 1935 Mussolini, approfittando di un incidente verificatosi alla frontiera eritrea dove trenta soldati italiani erano stati uccisi in uno scontro con gli abissini, aveva rotto il patto di solidarietà anglo-franco-italiano di Stresa, facendo chiaramente capire di volersi impadronire dell’Etiopia, un paese membro della Società delle Nazioni. I governi francese e inglese si trovarono in imbarazzo: era meglio far finta di niente per assicurarsi l’aiuto italiano contro la Germania o conveniva appoggiare l’Etiopia? Preoccupata era soprattutto l’Inghilterra: la conquista italiana era una minaccia per l’irrigazione dell’Egitto, che essa occupava, oltre che per l’avvenire del Sudan anglo-egiziano, che separava l’Etiopia dalla Libia. Inoltre una grande Africa Orientale italiana rischiava di minacciare la strada delle Indie. Tutti i tentativi diplomatici per appianare la faccenda fallirono, come pure lo sfoggio di muscoli da parte della flotta inglese che concentrò nel Mediterraneo navi da guerra per un tonnellaggio doppio rispetto a quello italiano. Ma Mussolini, vista l’indecisione della Società delle Nazioni, contava evidentemente sul fatto che l’Inghilterra difficilmente si sarebbe imbarcata in una guerra in cui si fosse trovata da sola.
Così, il 3 ottobre 1935 iniziarono le operazioni militari italiane che si conclusero il 5 maggio 1936, quando le truppe entrarono in Addis Abeba. L’Etiopia non aveva speranza contro un esercito di 200 mila uomini dotato di armi moderne, compresi i gas asfissianti. Cominciò la farsa delle sanzioni. Fu rifiutata l’idea di applicare sanzioni militari, tanto è vero che la Gran Bretagna spinse i suoi scrupoli al punto di rifiutare di chiudere il canale di Suez per impedire alle truppe italiane di raggiungere l’Etiopia, appellandosi alla convenzione del 1888 che prevedeva la libertà di navigazione nel canale anche in tempo di guerra. Contro l’Italia furono adottate sanzioni finanziarie ed economiche, che però non comprendevano ferro, acciaio, rame, piombo, zinco, cotone, lana e... petrolio! Forse la cessione della quota dell’Agip, oltre a portare denaro fresco nelle casse statali che la guerra di Spagna e la campagna d’Etiopia avevano prosciugato, aveva evitato quell’embargo petrolifero integrale che sarebbe stato esiziale per i sogni imperiali della borghesia italica.
La lotta per il controllo delle fonti energetiche non risparmiò il Sud America, anzi fu proprio in questa parte del mondo che il nazionalismo si scontrò per la prima volta con le Compagnie petrolifere.
Nel Messico il petrolio era stato scoperto nel 1903 e subito le Compagnie inglesi e americane si erano accomodate sotto l’ala protettrice del dittatore di turno. Inutile dire che la sicurezza degli impianti era inesistente e le condizioni di lavoro terribili. La prima grande catastrofe della storia del petrolio data al 1908, quando esplose un pozzo nei pressi del porto messicano di Tampico, lanciando una colonna di fuoco alta 500 metri che continuò a bruciare per 59 giorni e fece un numero imprecisato di morti.
Durante la guerra mondiale il Messico fu una fonte essenziale per i rifornimenti americani, fino a quando un nuovo presidente non aumentò le tasse delle Compagnie e nazionalizzò i pozzi. La risposta delle Società statunitensi fu classica: riduzione della produzione e assassinio del presidente. Questo andrà a vantaggio del Venezuela il cui regime, per attrarre i capitali dall’estero, affiderà alla stessa Standard Oil (e alla Shell) l’incarico di scrivere la Legge petrolifera, prima di consegnare direttamente alle due Compagnie le chiavi della produzione. Negli anni Venti il Messico e il Venezuela diventeranno rispettivamente il secondo e il terzo produttore mondiale. Il Messico petrolifero fu sconvolto nel 1937 da un’ondata di scioperi generali per l’aumento dei salari, che coinvolgeva soprattutto gli impianti della Shell.
Ma nei precedenti dieci anni la quota di produzione petrolifera messicana era crollata dall’11 al 2,5% mondiale. Nel 1938, per cercare di arrestare questo declino, il governo messicano espropriò le Compagnie straniere e nazionalizzò il petrolio, rischiando per un pelo la guerra con la Gran Bretagna. Ma le Compagnie, con l’aiuto dei servizi segreti britannici, preferirono la strada del putsch, mettendo non poco in allarme il governo statunitense. Sottoposto all’embargo, il petrolio messicano non trovò più compratori. La produzione si dimezzò e lo Stato avrebbe rischiato il fallimento se non fossero intervenute le commesse tedesche, italiane e giapponesi. La Compagnia nazionale Pemex poté così sopravvivere fino allo scoppio della guerra, quando le si spalancò il mercato americano.
Di nuovo dalle vicende messicane trarrà vantaggio il Venezuela. Questo paese, con una superficie superiore a quella del Texas e una popolazione di soli sei milioni di abitanti, diventerà durante la guerra il principale esportatore di greggio al mondo ed una risorsa vitale per le tre Compagnie che vi dettavano legge, Exxon, Shell e Gulf. La guerra in Europa, sebbene l’opinione pubblica non se ne renderà conto, dipenderà proprio dal petrolio del Venezuela. Grazie al petrolio il Venezuela era diventato la nazione più ricca dell’America Latina e la sua capitale Caracas in vent’anni si era riempita di automobili e la popolazione raddoppiata.
Come già in Messico, i rapporti tra le Compagnie e i vari governi non furono mai semplici, a causa degli esorbitanti profitti intascati dalle Società statunitensi e delle miserabili condizioni in cui vivevano i lavoratori dei campi petroliferi. Nel 1938 i venezuelani, dopo la caduta del dittatore Gomez, chiesero, in cambio del rinnovo delle concessioni, una revisione dei contratti, maggiori royalty e tasse. L’alternativa era la nazionalizzazione. Nonostante l’iniziale malumore delle Compagnie, su pressioni del Dipartimento di Stato americano, fu introdotta una nuova legge che, in cambio di più alte royalty, accordava alle Compagnie nuove concessioni e contratti di durata quarantennale. In breve tempo la produzione petrolifera raddoppiò.
Nel 1945 il partito radicale Acción Democratica prese il potere in Venezuela e nuovo ministro del petrolio diventò Pérez Alfonzo, un nazionalista cosmopolita che conosceva a fondo l’economia del settore essendosi formato negli Stati Uniti e che era destinato a divenire il futuro architetto dell’Opec. Nel 1948, approfittando dei durissimi scioperi scoppiati tra i lavoratori petroliferi, fece approvare una nuova legge che concedeva al governo venezuelano una partecipazione del 50% negli utili derivanti dal petrolio, ma soprattutto che le royalty fossero pagate in petrolio, che il governo avrebbe venduto direttamente, togliendo in questo modo alle Compagnie l’esclusiva “per diritto divino” della commercializzazione. Era nata la formula del fifty-fifty. Presto diventerà un’esigenza generale e attraverserà l’Atlantico.
La Germania era vogliosa di rivincita dopo che alla fine della prima carneficina mondiale gli alleati, Gran Bretagna, Francia e Usa, per liberarsi di un pericoloso concorrente, le avevano strappato tutte le concessioni petrolifere e imposto durissime riparazioni di guerra. Le avevano cioè imposto di “riparare” i vincitori dei danni patiti in una guerra la cui responsabilità venne attribuita, dai vari Wilson, Lloyd George, Clemenceau, Orlando, esclusivamente alla Germania. L’articolo 231 del trattato di Versailles stabiliva che «la Germania riconosce di essere responsabile, per averli causati, di tutti i danni subiti dai governi Alleati ed Associati e dai loro cittadini in conseguenza di una guerra, che è stata loro imposta dalla sua aggressione». La Germania fu anche costretta ad una dichiarazione di “colpevolezza morale”!
Ma lo stesso trattato, che metteva a sacco la sua economia a vantaggio dei vincitori, poneva la Germania nell’impossibilità di rimettere in sesto la sua macchina produttiva sconquassata dalla guerra e quindi di far fronte agli impegni. Allora intervenne, deus ex-machina, il genio finanziario dei banchieri americani, che partorì l’idea che le riparazioni di guerra tedesche sarebbero state rimborsate grazie ai crediti concessi dalle stesse banche americane! Tu mi devi rimborsare un debito e non guadagni abbastanza per pagarmi? Niente paura: io ti anticipo una somma supplementare che ti servirà a sfruttare un maggior numero di operai e quindi ti permetterà di rimborsarmi col profitto ricavato il prestito antico e quello nuovo, oltre gli interessi su entrambi. In fondo, il grande banchiere attorniato da uno stuolo di scienziati dell’economia borghese non si comporta in modo molto diverso dal classico strozzino caro alla letteratura mondiale.
Così nel 1924 fu elaborato il Piano Dawes, dal nome del generale americano Charles P. Dawes, uomo di fiducia della finanza americana e abile speculatore egli stesso. La Commissione per le riparazioni, come nella migliore tradizione del capitalismo monopolista, era infarcita di banchieri che erano contemporaneamente industriali, non esclusi i rappresentanti tedeschi delle banche e del cartello dell’acciaio. Evidentemente, la grande finanza considerava le macerie del vecchio continente terreno ideale per incrementare i propri affari. La Commissione non fu infatti una riunione di benefattori: il capitale americano, in cambio del prestito di 800 milioni di marchi-oro per la ricostruzione economica del paese, mise un’ipoteca sui beni e sulle fabbriche tedesche.
Il piano Dawes riduceva drasticamente la sovranità dello Stato e metteva nelle mani degli uomini di Wall Street la direzione economica del paese. I prestiti più cospicui furono concessi dalle banche internazionali per aiutare i maggiori cartelli tedesco-americani (Aeg/General Electric, Vereinigte Stahlwerke/United Steel, IG Farben/American IG Chemical), nei cui consigli di amministrazione sedevano banchieri americani e rappresentanti della Standard Oil. Quasi colonia della Borsa di New York, la Germania divenne il paradiso della finanza internazionale: nel 1928 era indebitata sull’estero per 25 miliardi! Di fatto i prestiti destinati alla ricostruzione della Germania più che a ristabilire la pace, ebbero il compito di gettare le basi della futura guerra mondiale!
Il piano Young, che prese il nome da un altro banchiere americano, fu varato poco prima che scoppiasse la crisi a Wall Street, nella primavera del 1929. Sostituiva il piano Dawes e si dava due obiettivi: arrivare ad una stima del debito dovuto dalla Germania per le riparazioni, rimasto fino ad allora indeterminato, e rimuovere i controlli stranieri sull’economia tedesca. L’intera somma fu ripartita in cinquantadue annualità, con una media di due miliardi di marchi l’anno. Parve che la Germania tornasse padrona di sé: le ferrovie e la Reichsbank tornarono nelle mani dello Stato, l’Intesa evacuò la Renania. In realtà era più schiava che mai, essendo obbligata a versare le rate fino al 1988 (anno della futura, lontana riunificazione!) e non potendosi sottrarre alla spoliazione perché la sua economia dipendeva totalmente dai prestiti anglosassoni.
Tanto è vero che, quando i finanziatori americani, colpiti dalla crisi, richiamarono i loro capitali, una tremenda catastrofe si abbatté sulla Germania. Le industrie si fermarono. Moltitudini di disoccupati riempirono le strade: tre milioni e mezzo nel 1929-30, sei milioni nel 1931.
Quali circostanze avevano provocata la crisi negli Stati Uniti? Le stesse che avevano favorito il crescere abnorme della produzione americana, cioè gli stretti legami finanziari e commerciali stabilitisi tra l’Europa e l’America. Dopo la guerra, il capitalismo americano non si era arrestato nella sua folle corsa: in crescente aumento erano la produzione industriale, la produzione agricola, i profitti, gli investimenti, le vendite. Il paese rigurgitava di capitali che si offrivano in prestito. Nel 1928 la bilancia commerciale americana registrava un attivo straordinario: le esportazioni superavano le importazioni per un valore di 800 milioni di dollari. Nel 1929 la produzione annua dell’acciaio aveva toccato la quota di 50 milioni di tonnellate. Per le strade dell’Unione scorrazzavano 5 milioni di automobili. I prestiti all’estero raggiunsero la cifra straordinaria di 1,26 miliardi di dollari. Dollari 1928!
Fu proprio questa enorme massa di denaro a provocare la crisi. Mentre in America l’orgia delle vendite a rate, delle aperture di credito, della speculazione manteneva alti i costi di produzione provocando fenomeni inflazionistici, in Europa, grazie alla pioggia di dollari, le economie si riprendevano, la produzione superava i livelli d’anteguerra, il commercio estero riannodava i suoi fili. Senza però dimenticare che bisognava pagare gli interessi sui prestiti. Di qui la tendenza a ridurre le importazioni dall’America per non far crescere troppo il montante del debito. Inoltre contro le importazioni americane, che avrebbero finito alla lunga per danneggiare l’agricoltura e l’industria dei paesi europei, si lavorava ad erigere sbarramenti sul commercio estero. La grande fiumana delle esportazioni americane cominciava a rifluire. I prodotti agricoli furono i primi ad ammucchiarsi nei magazzini. Dalle campagne, tradizionalmente l’anello debole dell’economia capitalistica, la crisi si estese all’industria. Chiudevano le fabbriche di automobili, le acciaierie, i cantieri edili, le officine. La catastrofe esplose quando il morbo attaccò il cuore dell’economia americana: la finanza, le grandi banche private, gli enti di credito pubblico, la Borsa. Quando queste istituzioni decisero di coprirsi esigendo, all’interno del paese e all’estero, il rimborso dei crediti, la crisi si allargò al mondo intero.
Nel generale rifugiarsi dei governi dietro le trincee del protezionismo, due sono gli avvenimenti di estrema importanza che vengono a derivare dalla crisi economica mondiale e che plasmeranno la storia futura. Il primo è l’occupazione nell’estate del 1931 della Manciuria da parte del Giappone. Se il capitalismo nipponico si decise al gran passo, pur sapendo di attirarsi addosso l’ostilità delle potenze anglosassoni, ciò accadde perché la crisi aveva preso alla gola il commercio estero giapponese restringendo i mercati di sbocco. Il secondo avvenimento fu l’ascesa al potere del regime nazista in Germania dovuto a due condizioni obiettive: la disperazione delle moltitudini che la paralisi delle industrie gettava nella miseria e nella fame, e il tradimento dello stalinismo internazionale che rifiutò di chiamare le masse operaie all’azione rivoluzionaria.
La politica europea negli anni Venti e Trenta era dettata dalle grandi banche di Londra e di New York e l’ascesa al potere di Hitler fu appoggiata dai grandi cartelli tedeschi, che vedevano in lui una carta su cui puntare per difendere i loro profitti.
Per la Germania, che alla fine della guerra era stata spogliata di tutte le concessioni petrolifere, la necessità di produrre petrolio autonomamente diventava una questione di vita o di morte. Dipendere da altri per il petrolio col rischio di trovarsi sotto il ricatto di un embargo non poteva non turbare i sogni di chi aveva in mano le sorti del paese. Anche se era stato sottoscritto con l’Unione Sovietica un accordo segreto per la fornitura di petrolio, si cercavano altre fonti di energia.
Presto si puntò sulla tecnologia chimica per la produzione di carburanti sintetici, di cui un brevetto era di proprietà della IG Farben (International Gesellschaft Farben Industrie). Questo cartello era nato nel 1925 dalla fusione di sei industrie chimiche tedesche e l’operazione era andata in porto grazie all’intervento di capitali americani, in particolare della Standard Oil-Exxon. Quest’ultima acquistò i diritti del brevetto di idrogenazione del carbone fuori della Germania in cambio della cessione alla IG Farben del 2% del suo capitale, concordando un piano di collaborazione che andrà avanti fino al 1941 e che costerà alla Standard l’accusa di tradimento da parte del presidente Truman.
Ma, a parte la solita ipocrisia puritana, la reindustrializzazione tedesca, come già era accaduto durante la guerra mondiale, non sarebbe stata possibile senza l’aiuto delle grandi aziende statunitensi, favorevoli, nonostante i nazisti, ai buoni affari. I due monopoli tedesco e americano creeranno una filiale comune negli Stati Uniti specializzata in ricerche petrolchimiche: il settore sviluppato dalla IG Farben, su brevetto americano, sarà quello della gomma sintetica, un prodotto importante per l’industria bellica. Hitler si era impegnato a sostenere il progetto di idrogenazione del carbone della IG Farben fin dal 1932 e divenuto cancelliere lanciò la motorizzazione e la costruzione della rete autostradale tedesca. Il regime nazista impegnò lo Stato nella costruzione delle strutture necessarie al progetto dell’autonomia energetica, dal cui raggiungimento sarebbero dipese le sorti del futuro ineluttabile conflitto.
La Germania aveva bisogno di piombo tetraetile per produrre benzina ad alto indice di ottano per far volare gli aerei e aumentare l’efficacia dei motori a terra. La Standard e la General Motors crearono la società Ethyl Gasoline Corporation per commercializzare questo prodotto di cui detenevano il brevetto (en passant: il piombo tetraetile nella benzina verrà proibito, a causa della sua tossicità, nel 1985 negli Usa e solo nel 2001 in Europa). Nel 1935 questa tecnologia fu trasferita in Germania dove furono costruite fabbriche apposite, che permetteranno ai tedeschi di produrre piombo tetraetile durante la guerra. Senza l’etile la Luftwaffe non avrebbe mai potuto decollare. Alla vigilia dell’invasione della Polonia, nel settembre 1939, erano in funzione nel territorio tedesco quattordici impianti di idrogenazione e altri sei erano in costruzione.
Tra il 1937 e il 1938, per la sua importanza strategica, la IG Farben passò sotto il controllo dello Stato. Vantava quote di partecipazione in 380 altre industrie tedesche e in 500 imprese estere più oltre duemila accordi di cartello con la Standard Oil, con la Dupont de Nemours, con la General Motors, ecc. L’impero IG Farben possedeva proprie miniere di carbone, centrali elettriche, altiforni, banche, centri di ricerca, una propria rete commerciale. Oltre alla gomma e al petrolio sintetici, produceva gas mortali, tra cui il tristemente celebre Zyklon B. Inoltre, grazie al sistema di interdipendenza tecnica e finanziaria con l’industria americana, la IG Farben e il cartello dell’acciaio fabbricavano il 95% degli esplosivi tedeschi. I due grandi produttori di carri d’assalto tedeschi furono la Opel, di proprietà della General Motors (anch’essa controllata da una delle banche americane creditrici della Germania), e la Ford AG, succursale tedesca della fabbrica di Detroit (Henry Ford verrà decorato dai nazisti per i servizi resi alla Germania).
Ma, nonostante i grandi passi compiuti nella produzione dei carburanti sintetici, il petrolio era sempre in cima alle preoccupazioni di Hitler. Il 23 agosto 1939 la Germania sottoscrisse un piano di non aggressione con l’Urss: Mosca, oltre a mettere a disposizione le proprie fabbriche per la produzione di armamenti, nel biennio 1939-41 rifornì la Germania di 65 milioni di barili di petrolio, che andarono ad aggiungersi agli enormi stock già accumulati. Senza i rifornimenti russi e americani (questi ultimi arrivavano segretamente in Germania attraverso paesi “neutrali” quali la Svezia e la Spagna) i panzer tedeschi non avrebbero potuto invadere l’Europa.
Alla formulazione del concetto strategico di “guerra lampo” non fu sicuramente estranea la mancanza di produzione petrolifera interna. Si rendevano necessarie battaglie di breve durata, con l’uso concentrato di forze motorizzate e vittorie decisive prima che potessero sorgere problemi di carburante. All’inizio la strategia funzionò: nel 1939 con la Polonia e nel 1940 con l’invasione della Norvegia, dei Paesi Bassi e della Francia. L’aviazione tedesca rase al suolo gli impianti petroliferi del porto di Rotterdam e le installazioni francesi a nord della Loira, compresa la raffineria di Port Jerome, la più grande d’Europa. Molti impianti furono smantellati e trasportati in Germania, mentre il sequestro dei depositi di petrolio migliorò temporaneamente la situazione energetica tedesca.
Quali che fossero i piani strategici generali della Germania, la cui analisi esula dagli scopi di questo lavoro, per i tedeschi era di vitale importanza proiettarsi verso il petrolio dei paesi dell’Est e del Medio Oriente. In particolare il controllo dei giacimenti petroliferi del Caucaso, tra i più importanti al mondo, era una motivazione prioritaria non tanto per il mantenimento dello status quo, ma in vista di una lunga durata del conflitto e di un suo probabile imminente allargamento.
Il fatto che nel giugno 1940 Stalin avesse occupato gran parte della Romania nord-orientale e spinto le truppe a ridosso dei giacimenti petroliferi di Ploiesti, aveva allarmato non poco i borghesi tedeschi, dal momento che il petrolio rumeno copriva oltre la metà del loro fabbisogno. Il 22 gennaio 1941 Hitler, nonostante il patto di amicizia stretto con Stalin, iniziò la preparazione della invasione della Russia. Il piano prevedeva un attacco a tenaglia per impadronirsi contemporaneamente del petrolio del Caucaso e di quello del Medio Oriente: una prima offensiva si sarebbe dispiegata sull’asse Rostov-Stalingrado-Baku, mentre l’Afrikakorp guidato da Rommel, partendo dalla Libia, avrebbe invaso l’Egitto e attraverso la Palestina, l’Iraq e l’Iran si sarebbe ricongiunto alle truppe tedesche che combattevano nel Caucaso. In questo modo, l’Inghilterra sarebbe stata tagliata fuori dai rifornimenti di petrolio.
I tedeschi pensavano che sarebbe stata una ripetizione delle altre offensive-lampo già viste in Europa. Ma non sarà così. L’attacco alla Russia ebbe inizio il 22 giugno 1941, il giorno prima dell’anniversario dell’inizio dell’invasione napoleonica del 1812. Il passo si dimostrerà altrettanto fatale per Hitler quanto lo era stato per il celebre predecessore, anche se la fine non sarà altrettanto rapida: Napoleone si ritirò dalla Russia prima della fine dell’anno, Hitler resistette fino all’inizio del 1943, quando le truppe tedesche furono costrette a ritirarsi dal Caucaso e l’armata di Von Paulus, ridotta allo stremo, si arrese a Stalingrado. Un’altra disfatta, altrettanto decisiva, i tedeschi la subirono in Africa settentrionale, al confine tra la Libia e l’Egitto. L’andamento della guerra dipendeva ormai dalle forze meccanizzate, e per l’esercito germanico, sconfitto ad El Alamein, fu drammaticamente determinante la penuria di petrolio.
25. Iran crocevia dello scontro tra imperialismi
Già prima della guerra, l’Iran si era aperto all’influenza tedesca: Reza Pahlavi la rafforzò per emancipare il paese dal dominio economico e politico dei russi e soprattutto degli inglesi. La quota della Germania nel commercio estero iraniano era passata dall’8% nel 1932 al 45% nel 1941. Imprese tedesche avevano costruito ferrovie e fabbriche, comprese quelle di armamenti, e l’80% del macchinario importato proveniva dalla Germania. Più di tremila tedeschi risiedevano in Iran con una quinta colonna molto attiva. Gli inglesi temevano per le loro linee di comunicazione e per lo sfruttamento petrolifero dell’Anglo-Persian. Il problema di assicurare la sicurezza delle vie di accesso si acuì per gli alleati dopo l’attacco della Germania alla Russia, perché per l’Iran passavano i rifornimenti all’armata rossa nel Caucaso.
Nell’agosto del 1941 i governi russo e inglese, di comune accordo, reclamarono dallo Scià l’espulsione dei tedeschi. Al suo rifiuto, motivato dalla neutralità dell’Iran, entrarono nel paese affermando, con notevole spudoratezza, di non voler attentare alla sua integrità territoriale né indipendenza. Inglesi e russi pretesero dal governo facilitazioni per il trasporto del materiale bellico attraverso il paese e la consegna dei cittadini tedeschi alle autorità militari alleate. Reza Scià pensava di poter mantenere il trono, a dispetto dei suoi sentimenti filo-tedeschi, ingannato in questo dalla risposta amichevole di Roosevelt a cui aveva chiesto i buoni uffici nei negoziati tra l’Iran e gli occupanti. Ma il 16 settembre, in seguito a una violenta propaganda inglese e russa diretta contro di lui, fu costretto ad abdicare in favore del figlio. L’indomani stesso le truppe britanniche e russe entrarono a Teheran. L’ex sovrano fu deportato prima nelle isole Mauritius e poi in Sudafrica, dove morirà tre anni dopo.
Il nuovo governo accettò, obtorto collo, di divenire alleato delle potenze occupanti e fu costretto a barcamenarsi di fronte alla nuova situazione di sovranità ridotta, in cui il ruolo delle sue truppe sarebbe stato “limitato al mantenimento della sicurezza interna” (accordo del 29 gennaio 1942). Nel settembre 1943 lo Scià dovette umiliarsi fino a dichiarare, sebbene solo nominalmente, guerra alla Germania. Nel novembre 1943 i “tre Grandi”, Churchill, Roosevelt e Stalin, scelsero proprio Teheran come sede del loro primo incontro, nel corso del quale ribadirono l’impegno dell’assistenza all’Iran contro il nemico comune e riaffermarono il desiderio di mantenere l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale del paese. Ma ben presto il problema del petrolio farà venire a galla gli interessi contrastanti delle grandi potenze, perché la geografia collocava l’Iran all’incrocio delle loro zone d’influenza.
La Prima Guerra mondiale dipese dal petrolio ma molto più dal carbone, le cui fonti erano abbastanza equamente distribuite fra i contendenti. Nella Seconda il petrolio ebbe un ruolo decisivo, rendendo drammatica la situazione di quei paesi, come il Giappone, privi di risorse energetiche sul territorio nazionale. Da quando il Giappone aveva sconfitto la flotta russa a Tsushima, lo scontro con gli Stati Uniti per il dominio del Pacifico era solo questione di tempo. Ciò che era sempre interessato agli Stati Uniti era il mantenimento della politica della “porta aperta” in Cina. In funzione di questa politica gli Usa avevano occupato una serie di isole del Pacifico: le Hawaii, Wake, Guam, le Filippine dovevano costituire un sistema di scali, di basi di rifornimento, di stazioni telegrafiche sulla rotta della penetrazione e del dominio del favoloso mercato cinese.
Nel 1931 il Giappone invase la Manciuria e nel 1935 attaccò la Cina mettendosi in diretto contrasto con gli Usa. Lo sforzo militare giapponese richiedeva petrolio, e questo arrivava per la maggior parte dall’Indocina, che era sotto controllo occidentale. Senza addentrarci nei più complessi problemi politici si può dire che sotto molti aspetti la guerra contro l’occidente non fu che un prolungamento della guerra che i giapponesi stavano già combattendo in Cina, in gran parte l’attacco giapponese a Pearl Harbour e l’invasione dell’Asia sud-orientale furono il naturale sviluppo della penetrazione militare in Cina. Anche gli Stati Uniti entreranno in guerra per la Cina, oltre che per emarginare il Giappone.
Benché gran parte del Sud-Est asiatico si trovasse sotto il controllo delle potenze europee, per il Giappone l’interlocutore privilegiato, con cui intavolare i principali negoziati, furono gli Usa a causa del ruolo chiave che questi avevano nel commercio giapponese, soprattutto nel settore delle materie prime strategiche. Mentre l’Inghilterra, accogliendo le richieste di Tokyo, per isolare il regime nazionalista cinese aveva chiuso la strada dalla Birmania alla Cina, d’importanza vitale per il Kuomintang, e la Francia permesso alle truppe giapponesi di stazionare nel Nord dell’Indocina, furono gli Stati Uniti a creare gravi difficoltà ai giapponesi nel luglio 1940, introducendo un blocco delle esportazioni di alcuni prodotti di uso comune in Giappone. Nel settembre 1940, in coincidenza con l’occupazione giapponese dell’Indocina settentrionale, alla lista furono aggiunti due prodotti fondamentali, il petrolio e i rottami di ferro. Il 26 luglio 1941 il presidente Roosevelt firmò l’embargo totale, subito appoggiato dai governi inglese e olandese che bloccarono del tutto le esportazioni di petrolio dall’Indocina verso il Giappone.
Il petrolio del Sud-Est asiatico rappresentava per i giapponesi quello che per i tedeschi era il petrolio del Caucaso: la possibilità dell’autonomia energetica come base della proiezione di potenza, che per la Germania era la Russia e per il Giappone la Cina. L’embargo fu vissuto dai giapponesi come una calamità che metteva in pericolo la vita stessa dell’Impero, un incubo che influenzerà tutte le decisioni, soprattutto quelle belliche, spingendo il generale Hideki Tojo, capo del governo durante la guerra, a sostenere che il destino dell’Impero giapponese dipendeva dal petrolio.
Il Giappone offrì un accordo per porre fine ad ogni discriminazione nei rapporti commerciali nell’area del Pacifico, compresa la Cina, ma l’America nell’autunno del 1941 respinse la proposta di un incontro al vertice tra il primo ministro giapponese e Roosevelt, spingendo il Giappone a recitare la parte dell’aggressore. All’alba del 7 dicembre 1941, per rompere l’embargo petrolifero, il Giappone attaccò la base americana di Pearl Harbour, nelle Hawaii, dando l’occasione per l’entrata in guerra degli Stati Uniti. L’operazione contro Pearl Harbour aveva lo scopo di rendere inutilizzabile la flotta americana che non prendesse di fianco le truppe giapponesi durante l’invasione del Sud-Est asiatico e dei giacimenti petroliferi delle Indie Olandesi. Inspiegabilmente i giapponesi lasciarono intatti i serbatoi di carburante a Pearl Harbour che contenevano riserve sufficienti per rifornire la flotta americana per due anni.
Durante la guerra gli Usa riforniranno di ingenti quantità di carburante la Cina nazionalista attraverso il Tibet, con grande impiego di uomini e mezzi.
27. Il grande affare della Seconda Guerra
Con l’entrata in guerra degli Usa la fame di petrolio subì una decisa impennata, con grave danno soprattutto per la Germania, che fino ad allora era stata rifornita sottobanco dalla Texaco attraverso la Spagna. Le risorse tedesche rischiavano di prosciugarsi perché i soli pozzi della Romania non erano sufficienti per le necessità dell’industria e dell’esercito. Giocoforza l’Europa nazista si riempì di fabbriche per la idrogenazione del carbone, proveniente oltre che dalle miniere della Germania da quelle della Francia e del Belgio. La distruzione delle riserve tedesche di carburante diventò quindi per gli alleati una priorità. A loro volta, gli oltre mille sommergibili tedeschi fecero del loro meglio per affondare le petroliere che attraversavano l’Atlantico, ma nulla poterono contro l’immensa capacità dei cantieri navali statunitensi, che riuscivano a sfornare più navi di quante i tedeschi ne colassero a fondo.
A partire dal 1943 i bombardieri della Raf e dell’Us Air Force iniziarono a colpire i pozzi rumeni riducendone di tre quarti la capacità. Nella primavera del 1944, in previsione dello sbarco in Normandia, migliaia di aerei alleati martellarono per due mesi i depositi di carburante e le linee di comunicazione della Wehrmacht in Francia, mentre nelle retrovie i “resistenti” sabotavano ponti e linee ferroviarie. Nonostante i massicci bombardamenti alleati, le fabbriche di carburante sintetico continueranno a funzionare in Germania fino all’ultimo, riuscendo miracolosamente a far fronte al 57% del fabbisogno nazionale di energia e producendo il 92% della benzina per l’aviazione. Ma ormai la sconfitta della Germania era solo questione di tempo, scritta anche nella sua carenza drammatica di petrolio.
Il secondo conflitto mondiale permetterà un arricchimento senza precedenti per i grandi gruppi monopolistici. Gli Stati nazionali diventeranno i maggiori committenti delle industrie del settore bellico, della siderurgia, della chimica e della meccanica, garantendo loro la fornitura di materie prime e prezzi di monopolio. Il petrolio delle raffinerie di Abadan costerà molto caro alle borghesie alleate ceduto, in base agli accordi di Achnacarry, ad un prezzo superiore di cinque volte il suo costo, e i governi inglese e americano si guarderanno bene dal chiedere sconti ai petrolieri dei loro paesi!
Ma la guerra fu un affare colossale non solo per i petrolieri. Già prima della loro entrata in guerra, gli Stati Uniti avevano avviato una produzione intensiva di materiale bellico. In pochi mesi diventeranno, insieme al Canada, “l’arsenale delle democrazie” arrivando a produrre il 50% degli armamenti complessivi. Le industrie di punta convertirono la loro produzione e applicarono sistematicamente la standardizzazione dei processi lavorativi: Ford e Chrysler interruppero la fabbricazione di automobili per dedicarsi all’assemblaggio di aerei e carri armati, mentre si allestivano i cantieri navali. La standardizzazione permise di fabbricare una nave da guerra in 15 settimane (contro le 35 settimane del 1939) e una petroliera in 45 giorni (contro i 244 giorni di tre anni prima).
Per rifornire di benzina l’enorme quantità di mezzi che il 6 giugno 1944 sbarcarono sulle spiagge della Normandia furono posate sotto la Manica qualcosa come ventidue condutture di acciaio flessibile che permisero un flusso ininterrotto di carburante dalla Gran Bretagna verso Cherbourg e Boulogne. Le pipe-line si allungheranno secondo le esigenze dell’offensiva nei territori man mano conquistati, raggiungendo il Belgio, l’Olanda e la Germania. Questo sistema evitò l’impiego di migliaia di camion-cisterna.
Nel dicembre 1944 i tedeschi, approfittando della nebbia che costringeva al suolo l’aviazione nemica, tentarono una controffensiva disperata nelle Ardenne. Il vero obiettivo erano i depositi di benzina del porto belga di Anversa ma, per ironia della sorte, i panzer furono bloccati sulla Mosa proprio dalla mancanza di carburante, a pochi chilometri da un enorme deposito di benzina americano. Anche le divisioni corazzate sovietiche, che da est si lanciarono attraverso la Germania, recavano al seguito un’enorme quantità di vagoni ferroviari pieni di carburante proveniente dai pozzi russi, iraniani e perfino americani.
Le bombe atomiche americane sganciate su Hiroshima e Nagasaki il 6 e il 9 agosto 1945 più che determinare la fine della guerra suoneranno a morte per le velleità russe nell’area asiatica e affermeranno la supremazia economica mondiale del capitale a base statunitense. La politica rooseveltiana, accantonato l’isolazionismo, aveva permesso agli Stati Uniti di assurgere al rango di prima potenza imperialistica, dando alle forze armate americane il controllo dell’Europa occidentale e l’assoluta egemonia marittima.
Tuttavia, la contesa che ha visto il campo imperialista economicamente più forte uscire vittorioso dall’immane massacro, non è spiegabile, né tanto meno risolvibile, nei moduli delle libertà nazioni, né della vittoria della democrazia sulla barbarie, come sarebbe piaciuto a vinti e a vincitori. Sono interpretabili soltanto nei moduli della lotta mortale fra le classi, nella quale il proletariato mondiale aveva dovuto pagare il prezzo più alto, immolato alla controrivoluzione democratica-staliniana e per soddisfare la sete di profitto del capitale finanziario internazionale. Il piano di divisione del mondo foggiato a Yalta e Potsdam pretendeva costringere il magma sociale nei confini della contesa interimperialista.
Ma, mentre l’Europa veniva chiusa nella morsa dell’occupazione militare, gli altri continenti sarebbero presto entrati in ebollizione per l’incontenibile moto di rivolta delle popolazioni più povere, più oppresse, più affamate del mondo. In particolare falliranno i piani neo-coloniali giapponese ed americano di espansione nell’immenso e popoloso spazio cinese.
Si era così addivenuti ad una nuova spartizione del mondo fra potenze imperiali in funzione della forza economica e militare di ciascuno, sempre in rapporti di rivalità e di conflitto tra i loro Stati nazionali, gendarmi a difesa di macchine produttive fondate sulla sottomissione della classe operaia.
Le armate americana e russa, incontratesi nel cuore della Germania, avevano messo fine al primato imperialistico dell’Europa borghese.
Nei paesi europei “liberati” l’industria petrolifera era praticamente annientata dopo gli smantellamenti operati dai tedeschi e i bombardamenti alleati, per cui i petrolieri anglo-americani si trovarono in una posizione di forza.
Un accordo per un “nuovo ordine mondiale” finanziario e monetario venne negoziato fra inglesi e americani e firmato a Bretton Woods nel luglio 1944. Nella cittadina americana quarantaquattro capi di Stato, uomini di governo ed economisti di tutto il mondo, fra cui Lord Maynard Keynes, fecero da maggiordomi alla potenza che poteva vantare il controllo della maggior parte dei capitali mondiali e l’economia più produttiva, gli Stati Uniti. Non c’è da stupirsi se il dollaro fu promosso allora a perno dell’economia mondiale. All’epoca gli americani possedevano i due terzi di tutto l’oro del mondo capitalista ed era quindi nel loro interesse stabilire un nuovo sistema monetario internazionale basato sull’oro.
Per l’Europa, distrutta dalla guerra e pressoché priva di mezzi internazionali di pagamento, un sistema basato sull’oro sarebbe stato attraente se quest’oro fosse stato in qualche modo ridistribuito; ma gli americani preferirono distribuire dollari sotto forma di doni o prestiti a basso tasso di interesse (Piano Marshall), imponendo che la loro moneta venisse considerata un mezzo di pagamento internazionale alla pari dell’oro, prendendo l’impegno di cambiare i dollari in oro al prezzo fisso di 35 dollari l’oncia. La supremazia del dollaro rispetto alle altre monete trae dunque la sua origine dalla posizione speciale che il dollaro assunse nel sistema monetario internazionale nel secondo dopoguerra.
Gli Usa acquisteranno all’estero merci, servizi e capitali, pagando i debiti con la moneta nazionale; gli altri paesi dovranno accettare i dollari in pagamento e metterli nelle proprie riserve accanto all’oro.
Le cose fileranno lisce fino a quando ci sarà una proporzione ragionevole tra la somma di dollari accumulatisi fuori dagli Usa e la loro riserva aurea. Ma all’inizio degli anni Sessanta le cose cambiarono perché questa proporzione si squilibrò a svantaggio della riserva aurea e le banche centrali non americane cominciarono a esigere dalla banca centrale americana il cambio in oro dei dollari in loro possesso. La morte del sistema del Gold Exchange Standard sarà certificata il 15 agosto del 1971 quando Nixon dichiarerà l’inconvertibilità del dollaro in oro.
L’architettura finanziaria costruita a Bretton Woods, e che aveva consentito agli Usa di gestire a proprio vantaggio per almeno un ventennio le ricorrenti crisi del debito, i rapporti di cambio e la politica petrolifera mondiale, si basava sul Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, il Gatt e altre istituzioni internazionali. Originariamente, gli scopi del Fmi erano di assicurare la stabilità monetaria in una economia mondiale aperta, facendo le veci della parità aurea che aveva assolto il compito fino al 1914. Esso avrebbe dovuto assicurare ai paesi che si fossero trovati in situazioni di eccesso o di deficit nella bilancia dei pagamenti la liquidità necessaria ad attuare misure correttive. Ma dopo l’introduzione del sistema di fluttuazione delle monete, alla fine degli anni Sessanta, la funzione del Fondo diventò tecnicamente superflua, ed esso è sopravvissuto come semplice esecutore delle strategie dei Grandi (G4, G5, G7, ecc.) sia riguardo alla gestione degli aggiustamenti strutturali imposti unilateralmente ai paesi del Sud, sia riguardo all’integrazione nel sistema monetario internazionale dei paesi dell’Est.
Quanto alla Banca Mondiale, essa fu pensata come ente complementare al Fmi per concedere credito a lungo termine in vista del progetto di “sviluppo” del Terzo Mondo, mentre la ricostruzione economica europea fu affare privato di Washington attraverso il piano Marshall. A grandi linee possiamo dire che la Banca, più che essere una istituzione pubblica in concorrenza con il capitale privato delle multinazionali, è stata piuttosto un agente incaricato di sostenerne la penetrazione nei mercati del Terzo Mondo, adoperandosi per distruggere le economie di sussistenza attraverso l’erogazione di crediti ad hoc e fungendo da assicuratore politico contro il rischio di nazionalizzazioni.
Inoltre furono gettate le basi per un accordo generale su dazi e commercio, volto a sostenere il “libero mercato”, in modo da scardinare tutte le resistenze doganali, tariffarie, protezionistiche dei paesi dominati, che impedivano alle merci e ai capitali di fare del mondo un unico mercato. Accanto alle istituzioni finanziarie, l’Organizzazione Mondiale del Commercio rivestiva un ruolo fondamentale perché il capitale potesse trovare nuovi spazi di valorizzazione. Nella loro apparente onnipotenza, i tre Grandi vittoriosi tennero dunque un vertice a Yalta, in Crimea, dal 4 all’11 febbraio 1945, allo scopo di spartirsi il pianeta e le sue fonti di energia.
Già la fornace della guerra, con le sue immani distruzioni e l’espansione dell’industria dovuta alle commesse statali e alla fame di approvvigionamenti, aveva dato all’economia una decisiva accelerazione. D’ora in avanti, il consumo di petrolio non poteva che aumentare, in considerazione del prevedibile sviluppo dell’industria automobilistica, della meccanizzazione delle aziende capitalistiche nell’agricoltura, della fabbricazione di tessuti sintetici, dell’impiego delle materie plastiche su grande scala. Per l’industria petrolifera americana era essenziale poter sostenere l’esplosione della domanda di greggio.
In questa prospettiva divenne irrinunciabile una più forte presenza in Medio Oriente. Di ritorno da Yalta, il presidente Roosevelt farà scalo in Arabia Saudita (dove già operava la Compagnia petrolifera americana Aramco) per suggellare i legami con i paesi maggiori produttori di petrolio e assicurare così la supremazia del capitale finanziario a base americana, in cambio della protezione politica e militare degli Stati Uniti.
Cominciò la solita commedia, su probabile sceneggiatura del governo di Washington, per eliminare gli ostacoli che intralciavano il libero movimento alle Compagnie americane. La Standard of New Jersey e la Mobil volevano entrare nella vecchia Aramco, una joint-venture operante tra la Socal e la Texaco, alla quale occorrevano capitali freschi per sfruttare gli immensi giacimenti sauditi che aveva in concessione. Ma c’era l’ostacolo dell’accordo della Linea Rossa che legava le mani ai soci dell’Iraq Petroleum (cui appartenevano sia la Jersey sia la Mobil), impedendo loro di agire autonomamente. Di portarsi dietro gli altri soci, tra i quali l’Anglo-Persian, la Shell e la francese Cfp, neanche a parlarne. Meglio tentare di far decadere l’accordo del 1928. Il cavillo trovato dagli americani fu questo: durante la guerra la Compagnia francese Cfp si era venuta a trovare in territorio sotto controllo tedesco, quindi era da considerarsi “nemica” e perciò motivo di sopravvenuta illegalità dell’accordo.
Le quattro Compagnie americane dell’Aramco avviarono la costruzione della famosa Tap-Line (Trans-Arabian Pipeline), che oltre a costituire il più grande oleodotto del momento era anche il progetto privato più costoso al mondo. La sua costruzione fu portata a termine in due anni (fu terminata nel 1950) e richiese l’impiego delle tecniche più moderne per assemblare i 1700 chilometri di tubi che collegavano i pozzi sauditi al porto libanese di Saida. Si andava delineando la futura strategia petrolifera statunitense, che avrebbe fatto perno su tre paesi: l’Arabia Saudita, il Venezuela e l’Iran.
29. Usa-Urss collaborazione e contenimento
Verso la fine della guerra la corsa all’accaparramento dei territori ricchi di riserve energetiche subì un’accelerazione.
L’Azerbaigian, con capitale Baku, che per secoli era stato teatro di lotte accanite tra la Russia, la Persia e l’Impero Ottomano, dall’inizio del XIX secolo era controllato in parte dalla Russia, che faceva leva sulla minoranza armena contro la maggioranza azera turcofona, e in parte dall’Iran.
Come abbiamo visto, nel 1941 i sovietici, in accordo con gli inglesi che avevano occupato il Sud dell’Iran, erano penetrati nella parte iraniana dell’Azerbaigian: i patti erano che avrebbero entrambi lasciato il paese entro sei mesi dalla fine della guerra. Il 19 maggio 1945, su richiesta del governo iraniano, i britannici accettarono di evacuare il paese, ad eccezione della zona petrolifera meridionale, mentre i sovietici fecero per non inteso e mantennero le loro forze: la regione era un troppo importante nodo strategico e oltretutto ricca di petrolio.
In agosto, mentre le bombe atomiche cadevano su Hiroshima e Nagasaki, in Azerbaigian il partito filo-comunista Tudeh, divenuto poco dopo Partito Democratico dell’Azerbaigian, organizzò una rivolta a carattere nazionale appoggiata dall’armata russa, che portò nel dicembre alla proclamazione della Repubblica autonoma con a capo Piscevari, veterano del Comintern.
Nella conferenza di Mosca del 15 dicembre 1945 Molotov rifiutò la proposta inglese di istituire una commissione dei tre Grandi sull’Iran, così come rifiutò la proposta anglo-americana di evacuare il paese, prendendo a pretesto il Trattato del 1921. Di fatto i russi restarono in tutti i territori iraniani che occupavano fin dal 1941 ed inviarono anche dei rinforzi. Questo fece nascere il sospetto che Stalin volesse fare dell’avamposto iraniano un trampolino verso la mecca petrolifera del golfo Persico. Il 19 gennaio 1946 il Consiglio di Sicurezza investito della questione decise di affidarne la soluzione a negoziati diretti russo-iraniani, ciò che rappresentava una confessione di impotenza. Il 4 aprile fu concluso l’accordo russo-iraniano che stipulava: a) l’evacuazione dell’armata russa; b) la creazione di una Compagnia petrolifera iraniano-sovietica, con la maggioranza del capitale al governo russo, il cui statuto avrebbe dovuto essere ratificato dal Parlamento iraniano (Majlis); c) negoziati diretti tra l’Iran e l’Azerbaigian.
Per ottenere la ratifica dal Majlis, la Russia favorì un accordo fra Iran e Azerbaigian, firmato a Tabriz il 14 giugno, in base al quale l’Azerbaigian sarebbe diventato una provincia autonoma dell’Iran obbligata a versargli un quarto delle imposte. Il 2 agosto il primo ministro iraniano Ghavam Sultaneh introduceva tre membri del partito Tudeh nel governo. L’Iran sembrava sempre più attratto verso la Russia, o forse stava soltanto cercando di alzare il prezzo.
Ma a partire dal 3 agosto gli inglesi reagirono inviando truppe a Bassora, dove era scoppiato un sanguinoso sciopero generale nella zona dell’Anglo-Iranian. Molte tribù del Sud, sobillate dagli inglesi e dai capi religiosi musulmani, si sollevarono contro il Tudeh e minacciarono di porsi sotto la sovranità dell’Iraq. Il risultato fu che il 17 ottobre Ghavam licenziò i tre ministri del Tudeh e costituì un governo senza comunisti. Inoltre dichiarò che l’Azerbaigian doveva essere assoggettato al governo centrale. Forte del sostegno inglese e americano, il primo ministro abbandonava il suo atteggiamento filo-sovietico: il 24 novembre, su suggerimento del nuovo ambasciatore americano Allen, ordinò alle truppe di marciare su Tabriz, dove la popolazione dell’Azerbaigian accolse con entusiasmo l’esercito iraniano. Il 14 dicembre in Azerbaigian il governo comunista fu rovesciato e diversi ministri arrestati e fucilati. L’inerzia dei russi in questa occasione forse si spiega con la volontà di facilitare la ratifica dell’accordo petrolifero o forse col fatto che Stalin aveva altri piani per l’Europa orientale.
Il Majlis, sotto i buoni auspici dell’ambasciatore americano Allen e contro la violenta opposizione all’accordo capeggiata da Mossadeq, rifiutò la ratifica con 102 voti contro 2. La porta persiana questa volta era definitivamente spalancata per gli Usa, che in base al trattato del 20 giugno 1947 invieranno in Iran i primi osservatori e una ingente fornitura di materiale militare.
Nello stesso periodo c’erano state anche le prime prese di posizione concrete degli Stati Uniti contro la pressione espansionista sovietica verso il Mediterraneo (Grecia e Turchia). Il 20 marzo 1945 la Russia aveva denunciato il Trattato di neutralità e di amicizia firmato con la Turchia nel 1935, chiedendo la restituzione di territori ex russi di Kars e di Ardahan e la revisione degli accordi di Montreux sugli Stretti del 1936. In poche parole Stalin voleva che la difesa degli Stretti fosse assicurata in comune dalla Turchia e dalla Russia. Naturalmente gli anglosassoni e i turchi rifiutarono questo principio che avrebbe permesso ai sovietici di realizzare l’antico sogno degli zar.
Il braccio di ferro continuò, con scaramucce più o meno dissimulate, fino all’inizio del 1947, quando gli Usa decisero di gettare la maschera e non nascondere più la situazione reale dietro formule ottimistiche. Nel gennaio il segretario di Stato Byrnes era stato sostituito dal generale Marshall, la cui nomina corrispondeva alla volontà del presidente Truman di attuare una politica più energica. Gli ispiratori di questo cambio di passo furono il diplomatico George Kennan, specialista di questioni sovietiche, futuro ambasciatore a Mosca, e il sottosegretario di Stato Acheson. Il 12 marzo 1947 Truman illustrò al Congresso la gravità della situazione internazionale e chiese di votare un aiuto di 400 milioni di dollari per far fronte alla guerra civile in Grecia e alla minaccia dei comunisti in Turchia: in fondo non si trattava che della millesima parte della somma di 341 miliardi di dollari che la Seconda Guerra mondiale era costata agli Stati Uniti. L’obiettivo era di impedire che si ripetesse in altre aree ciò che era successo in Polonia, in Bulgaria e in Romania.
Questa iniziativa americana rappresentò l’inaugurazione ufficiale della rivalità post-bellica tra America e Russia che prenderà il nome di “guerra fredda”, e che niente avrà a che vedere con una fantomatica lotta di classe fra capitalismo e comunismo: non fu una lotta per cambiare il mondo, ma per spartirselo! Le due superpotenze non rappresentavano due mondi diversi e opposti, il capitalismo e il socialismo, uno Stato imperialista borghese e quello della classe operaia. Era assurdo anche solo immaginare che lo stalinismo, sotterratore della sinistra rivoluzionaria della Terza Internazionale, potesse riprendere la guerra di classe contro le potenze capitalistiche con cui aveva stretto alleanza nel corso della guerra. Fu proprio l’alleanza col regime russo, accompagnata da una adeguata esaltazione propagandistica, a permettere a Londra e Washington di portare a termine la guerra senza che il proletariato si rendesse conto che il suo sacrificio andava a totale vantaggio dei suoi sfruttatori. Dopo, senza lo stalinismo il capitalismo americano ed europeo non sarebbe riuscito a far sopportare alle forze del lavoro tutte le spese della ricostruzione dell’apparato economico, politico e militare uscito sconquassato dal conflitto. Washington si oppose a Mosca rimproverandola non di capitanare la rivoluzione mondiale, ma di intralciare l’espansionismo del dollaro.
A partire dagli anni Cinquanta cominciò a manifestarsi apertamente la divaricazione degli interessi fra paesi arabi produttori e nazioni industrializzate occidentali, perché un aumento del prezzo del barile era una condizione sine qua non per lo sviluppo economico e sociale dei paesi arabi più popolosi. Fino ad allora erano state le Compagnie a detenere il diritto assoluto di ricercare, trivellare, estrarre, costruire oleodotti, commercializzare il greggio in base alle proprie esigenze e non a quelle dei paesi produttori. I profitti lucrati dalle Compagnie del cartello sui bassi costi del petrolio mediorientale rispetto al petrolio prodotto nell’emisfero occidentale risultavano enormemente sproporzionati rispetto ai compensi previsti per i paesi produttori, royalty fissate in percentuale sui bassi costi di produzione. Le sette Compagnie private che regnavano sovrane sul mondo del petrolio non ridistribuivano che il 30% dei loro profitti ai paesi produttori. La perdita del controllo diretto delle fonti petrolifere avrebbe aperto nuovi scenari che implicavano l’intervento militare delle grandi potenze che dirigevano il gioco nel campo imperialista.
Una prima rottura del sistema che regolava gli accordi petroliferi si ebbe, come abbiamo visto, nel 1948 in Venezuela, dove il ministro del petrolio Pérez Alfonzo era riuscito a strappare alle Compagnie una partecipazione paritaria agli utili. Nel 1950, lo spirito del fifty-fifty, metà per uno, sbarcò in Arabia Saudita dove i dirigenti americani dell’Aramco, pressati dalla concorrenza dei petrolieri indipendenti e dalle Compagnie giapponesi e temendo di perdere le concessioni, cedettero alle rivendicazioni saudite per una più equa ripartizione delle rendite. All’accordo non fu estraneo il Dipartimento di Stato Usa che fece pressione sulle Compagnie per conto della monarchia saudita in vista degli interessi di lungo termine degli Stati Uniti.
La politica prevalse allora sulle considerazioni economiche a breve termine delle Compagnie perché, nonostante tutto, l’imperialismo non dormiva sonni tranquilli. Le allarmate invocazioni al “pericolo rosso” e il romanzo delle infiltrazioni russe in Medio Oriente servivano a nascondere il vero timore delle borghesie europee, e con esse dell’imperialismo americano, ossia un effettivo progresso del movimento di unificazione araba.
Ad ogni modo l’impegno delle Compagnie statunitensi fu adeguatamente ricompensato dal governo con il varo di una legge che assimilava a tasse pagate all’estero quanto pagato ai paesi produttori, il che comportava un notevole beneficio fiscale sugli utili complessivi: quanto destinato a Riad si sarebbe dedotto dalla cartella delle tasse. Il marchingegno portava via al Tesoro americano cifre ingenti trasferite pari pari al re saudita: un buon sistema per finanziare “al nero” un paese strategicamente importante senza dover passare per l’approvazione del Congresso. Ma anche le altre Compagnie preferirono investire all’estero piuttosto che in America per pagare meno tasse: nel 1973 le cinque Sorelle Usa realizzeranno due terzi dei loro utili all’estero.
L’adozione del fifty-fifty scatenò la prima crisi petrolifera postbellica. Mentre altri paesi mediorientali ne ottenevano l’applicazione, l’Iran si vide rifiutare lo stesso trattamento dall’Anglo-Iranian, che peraltro era l’unica Compagnia titolare di concessioni nel paese. Essendo il governo britannico azionista di maggioranza dell’Aioc fin dal 1914, la questione investì il problema più generale dei rapporti tra Iran e Gran Bretagna. La trattativa giunse in un momento in cui l’Iran era agitato da manifestazioni popolari antioccidentali, perché le attuali difficoltà economiche erano attribuite all’occupazione alleata subita nel corso della guerra mondiale. La polemica sulle pretese dell’Anglo-Iranian si trasformò ben presto in una accesa battaglia contro la rapina imperialista, battaglia di cui era vessillifero Mohammed Mossadeq, capo del fronte nazionalista e presidente della commissione petroli al Majlis. Mossadeq, fra lo sgomento dei petrolieri internazionali, avanzò la proposta di nazionalizzazione del petrolio. L’offerta di un accordo basato sulla base del fifty-fifty non bastava più ai nazionalisti iraniani: “il petrolio alla patria”. Sotto la pressione delle masse popolari il 15 marzo 1951 il Majlis prese all’unanimità la decisione di nazionalizzare l’industria petrolifera e in particolare i beni dell’Anglo-Iranian. Lo Scià non poté far altro che ratificare la legge e l’onda dell’entusiasmo popolare il 2 maggio portò Mossadeq alla guida del governo.
L’iniziativa costituiva un colpo mortale per il traballante prestigio inglese in Medio Oriente, ma ancor più per le sue riserve petrolifere: più della metà della sua produzione era concentrata in Iran e perderla significava sparire dal palcoscenico mondiale del petrolio. Il governo britannico fece fuoco e fiamme: minacciò di invadere l’Iran, fece arrivare tre navi da guerra nel golfo Persico, chiese la solidarietà delle Compagnie petrolifere di tutto il mondo. Ma l’Impero coloniale della Corona si stava ormai sgretolando e l’intervento militare avrebbe solo rischiato di accelerare questo processo. Inoltre l’intervento britannico avrebbe potuto provocare un’invasione sovietica da nord in virtù del trattato del 1921. Gli inglesi restarono a lungo incerti se far uso delle cannoniere o della diplomazia. Gli americani, con la scusa del loro impegno in Corea, negarono loro qualsiasi appoggio militare e li convinsero a soprassedere.
Fu scelta allora una strategia di lungo respiro che prevedeva l’embargo totale del greggio iraniano e il rimpatrio della maggior parte dei tecnici, oltre alla chiusura delle raffinerie di Abadan. Tutte le maggiori Compagnie petrolifere aderirono al blocco con entusiasmo, visto che in quel momento c’era sovrabbondanza di petrolio sul mercato. Ma la chiusura delle raffinerie creò non pochi problemi agli americani perché Abadan serviva allora da base di rifornimento per l’aviazione statunitense verso la Corea. Per venti mesi non uscì dall’Iran una goccia di petrolio. Nel 1952 l’Iran era sull’orlo del disastro: i pozzi, per mancanza di manutenzione, prendevano fuoco e per spegnerli si dovette ricorrere a tecnici texani, pagandoli a peso d’oro.
Quando il governo Mossadeq, di fronte al prosciugarsi delle finanze statali orfane delle royalty, diede segno di appoggiarsi al Tudeh (il Partito comunista iraniano di stretta osservanza staliniana), agli Stati Uniti non sembrò vero di poter intervenire. Agli americani, che fino a quel momento erano rimasti ai margini del petrolio iraniano, si presentava l’occasione per spalancare una volta per tutte la famosa “porta persiana”, approfittando della debolezza britannica nel paese. Un accordo segreto anglo-americano fu raggiunto sulla base della creazione di un Consorzio internazionale denominato Iranian Oil Company, più noto come “Consortium” o “Consorzio di Abadan”, che avrebbe dovuto garantire lo sviluppo e la commercializzazione del petrolio iraniano, e a cui parteciparono per la prima volta nella storia tutte le Sette Sorelle. Infatti il Consorzio era controllato dall’ex Anglo-Iranian, trasformatasi in British Petroleum, dalla Shell, da due gruppi americani l’uno formato dalle cinque principali Compagnie petrolifere statunitensi (Esso, Socal, Mobil, Gulf, Texaco) e l’altro da nove piccole Compagnie “indipendenti”, e infine dalla Compagnia Francese dei Petroli. L’egemonia britannica fu per il momento sostanzialmente mantenuta perché la Bp e la Shell ebbero insieme il 54% delle azioni.
A questo punto non restava che sbarazzarsi di Mossadeq con il pretesto della lotta al comunismo. Come hanno dimostrato i documenti della Cia pubblicati vent’anni dopo, il Dipartimento di Stato mise in piedi quella che si chiamò in codice “operazione Aiax”. L’intervento occulto fu affidato dalla Cia a Kermit Roosevelt, nipote del defunto presidente, che alla fine dell’operazione darà le dimissioni dalla Cia e diventerà vicepresidente della Gulf. Nell’aprile 1953 lo Scià tentò di fare arrestare Mossadeq, sostenuto dal Partito comunista, ma il primo ministro con un colpo di Stato assunse i pieni poteri costringendo lo Scià a fuggire a Roma. Ma le vacanze romane del giovane re durarono poco. Quando anche le masse cominciarono a muoversi, la borghesia iraniana, spaventata dalla radicalizzazione del proletariato, consentì all’esercito di arrestare Mossadeq, gettandosi così nelle braccia dell’imperialismo americano. Dopo il ritorno dello Scià il 24 agosto 1953 la repressione fu feroce: 5.000 oppositori furono passati per le armi. Mosca si guardò bene dall’intervenire, dati anche i rapporti di forza, e mise la museruola al Tudeh. Gli Usa ringraziarono la docile borghesia iraniana e il suo Scià estendendo il loro aiuto finanziario e riempiendo di nuovi armamenti il paese! Da allora la borghesia iraniana ha esaurito ogni suo carattere progressista.
L’affare Mossadeq, se da una parte sancì la sconfitta inappellabile della Gran Bretagna, ormai incapace di controllare da sola il Medio Oriente, e se accelerò la penetrazione americana nell’area, dall’altra dimostrò che il vento stava cambiando nel mondo del petrolio e che lo strapotere delle Compagnie doveva cominciare a fare i conti con le nuove coscienze nazionali. I grandi monopoli privati anglo-americani saranno destinati a svolgere in parte un ruolo di supplenza del governo nel perseguimento degli obiettivi di politica estera, quali furono definiti dal massimo organo di sicurezza degli Usa, il “National Security Council”: «Poiché il Medio Oriente e il Venezuela sono le uniche fonti in grado di soddisfare il fabbisogno di petrolio del mondo libero, queste fonti sono necessarie per continuare gli sforzi militari ed economici del mondo libero. Da ciò consegue che a nessuno può essere permesso di interferire in modo sostanziale con la disponibilità di petrolio da queste fonti». Il Dipartimento di Stato statunitense punterà proprio su Arabia Saudita, Iraq, Iran e Israele per estendere la sua influenza su tutto il Medio Oriente, che occuperà un posto sempre più decisivo nello scacchiere diplomatico.
Per quanto riguarda Israele, è noto che il 15 maggio 1948, finito il mandato inglese, lo Stato di Israele si autoproclamò indipendente e fu immediatamente riconosciuto dalla Russia e dagli Stati Uniti. Alla sua fondazione parteciparono tutti gli imperialismi, per farne, al loro servizio in generale e delle Compagnie petrolifere in particolare, un ostacolo alla unità araba. Lo Stato di Israele è una base americana incuneata nel cuore del Medio Oriente, con le testate nucleari puntate verso i paesi arabi e verso l’Iran. Quattro guerre israeliano-arabe, tutte perse dagli eserciti arabi, scandiranno nel secondo dopoguerra la storia del Medio Oriente e del suo petrolio. La controversia tra i due blocchi est-ovest si sviluppava per Stati interposti e attraverso queste guerre per procura: la guerra del 1948 per la creazione dello Stato israeliano, la guerra del 1956 per il canale di Suez, la guerra del 1967 detta dei Sei Giorni, la guerra del 1973 detta del Kippur, che farà da detonatore al primo choc petrolifero globale.
31. La chimera del panarabismo
Legato mani e piedi al carro del vincitore, l’Iran aderirà nell’ottobre 1955 al patto di Baghdad che già comprendeva l’Iraq, la Turchia, il Pakistan e l’Inghilterra. Usa e Inghilterra sortirono due risultati: impossessarsi dei pozzi petroliferi e includere la Persia nello schieramento atlantico. Il passaggio non era scontato perché la Russia di fronte alla mossa occidentale avrebbe potuto invocare le clausole del trattato russo-persiano del 1921, che autorizzava il governo russo ad occupare la parte settentrionale della Persia qualora si fosse profilato il pericolo di un intervento di una terza potenza nel paese. Ma la collaudata tecnica anglosassone di costringere l’avversario a colpire per primo per addossargli l’accusa di aggressore funzionò anche questa volta: il 2 ottobre Nasser confermava alla radio le notizie sulle forniture di armi ceche e russe – il 12 lo Scià annunciò al parlamento l’adesione al patto di Baghdad. Mosca si limitò a protestare violentemente, ma si adattò volente o nolente al fatto compiuto.
Il Patto, firmato nella capitale irachena il 24 febbraio 1955, fu in origine un trattato bilaterale tra Turchia e Iraq congegnato e voluto dalla diplomazia anglo-americana, che in tal modo riusciva a gettare discordia e scissione nella Lega araba, i cui membri si erano impegnati col patto di sicurezza inter-arabo del settembre 1950 a non aderire a coalizioni militari estranee. Pertanto era un primo colpo portato al rinato panarabismo, e soprattutto all’Egitto che si atteggiava a potenza-guida del mondo arabo. L’Egitto di Nasser rifiutò infatti di aderire al patto, considerandolo una espressione degli interessi imperialistici dell’Occidente. Anche la Siria non aderì perché temeva l’espansionismo dell’Iraq, dove regnava la dinastia hascemita, la stessa cui apparteneva la casa reale della Giordania.
L’opposizione della Russia al patto si spiega facilmente tenendo presente che esso sanciva un’alleanza militare ostile alle sue frontiere meridionali, per di più collegata, tramite la Turchia, al patto Atlantico. Con l’adesione l’Inghilterra dimostrava di mantenere una qualche influenza in Medio Oriente. In settembre entrò a farne parte il Pakistan, che negli anni precedenti aveva stipulato accordi con la Turchia e gli Stati Uniti.
Pezzo su pezzo, le potenze occidentali venivano completando un poderoso sbarramento sulle vie di accesso russo al Medio Oriente. La cessione delle armi all’Egitto era il tentativo della Russia di rompere l’accerchiamento e di attestarsi alle spalle del nemico. Di qui il contrattacco anglo-americano in Persia, l’unica potenza confinante con la Russia che ancora si teneva fuori dal patto anglo-turco-iracheno-pakistano.
Mentre in Europa la linea di demarcazione fra i due blocchi era chiaramente tracciata e stabilita non si può dire lo stesso per l’area mediorientale dove gli Stati arabi per la loro posizione strategica e le immense riserve di petrolio costituivano la posta delle rivalità tra i blocchi. Gli Stati Uniti tenteranno, almeno all’inizio, di prevalere con l’aiuto economico e con le alleanze militari indirette, mentre la Russia appoggerà la Siria e l’Egitto soprattutto con la fornitura di armi.
Nel mondo arabo, nonostante l’unità etnica e linguistica, la centralizzazione del potere politico era tutt’altro che una realtà. Gli arabi erano racchiusi entro Stati prefabbricati, cioè fabbricati dall’imperialismo e dai suoi agenti, divisi da ignobili questioni dinastiche, pidocchiosamente attaccati ai loro interessi particolari, divorati vivi dai manigoldi dei monopoli capitalistici stranieri, invischiati nelle mortifere alleanze militari dell’imperialismo. Gli Stati arabi non solo non incuteranno timore agli imperialisti, ma si faranno pedine dei loro giochi.
L’elevazione della “nazione araba” in uno Stato unitario steso dall’Iraq al Marocco sarebbe stato certamente – nel quadro borghese – una aspirazione rivoluzionaria. Ma l’ideologia e la politica del panarabismo di tipo nasseriano era lungi dal rappresentare un movimento rivoluzionario di massa: non si accompagnò ad alcun rivolgimento sociale, limitandosi ad innestare nella stessa struttura sociale su cui poggiava la monarchia, un regime politico che differiva da quello antico solo negli orientamenti di politica estera, a loro volta resi possibili unicamente dall’urgere di nuovi rapporti di forza tra le grandi potenze mondiali. La pretesa rivoluzione del 1952 neppure sfiorò gli strati profondi della società egiziana, che continuarono a vivere nella gabbia di rapporti produttivi arretratissimi, e non espresse nemmeno la prepotente volontà di ascesa di una borghesia degna di questo nome.
È incontrovertibile che contro la dominazione dell’aristocrazia latifondista, i cui rappresentanti vivevano nel lusso al Cairo e ad Alessandria, il regime non alzò un dito. La redenzione dei fellah nei miserrimi villaggi nilotici, dove trascinavano un’esistenza atroce insidiata dalla fame e dalle malattie, fu affidata ad un problematico piano di colossali opere di irrigazione che avrebbe dovuto aumentare in un incerto avvenire la terra coltivabile. Una rivoluzione borghese “fino in fondo” all’epoca dell’imperialismo è ancora più irrealizzabile che in passato se i nuovi poteri subentrati ai vecchi non nascono sull’onda di grandiosi movimenti di masse sfruttate e non poggiano sulla loro forza armata. In realtà, nei paesi mediorientali molte monarchie feudali si trasformeranno senza grandi scosse in monarchie borghesi continuando a governare sotto nuove spoglie. E anche dove la monarchia è stata sostituita dalla repubblica l’avvenimento è da considerare il frutto di rivolte militari ristrette piuttosto che di movimenti politici di massa.
Seguendo il filo degli avvenimenti degli anni Cinquanta, che videro numerosi scioperi operai in Libano, Iraq, Giordania, il fatto più importante è del luglio 1952 quando in Egitto, dopo diversi mesi di grandi dimostrazioni popolari e importanti scioperi operai culminati nello sciopero generale del gennaio, re Faruk è costretto ad abdicare dalla sollevazione dell’esercito guidato dal gruppo dei Liberi Ufficiali. Sempre nel 1952 in Libano va al potere Camille Chamoun, personaggio legato a doppio filo all’occidente e amicissimo del re Abdullah di Giordania, assassinato un anno prima da un arabo palestinese.
Con la salita al potere di Nasser la politica di nazionalizzazione della repubblica egiziana riprende la bandiera del panarabismo, della grande patria araba unita, cerca di ridare vigore alla Lega Araba costituitasi fin dal 1945 fra Egitto, Arabia Saudita, Yemen, Transgiordania, Iraq, Libano e Siria, che aveva mostrato tutta la sua impotenza, inefficacia, i limiti del federalismo nella guerra del 1948 contro Israele.
Il primo colpo al rinato panarabismo lo darà, come abbiamo visto, l’Iraq quando nel 1954 si alleò alla Turchia, entrata due anni prima nella Nato, per poi aderire, nel 1955, al patto di Baghdad. Nel febbraio del 1954 una rivolta rovescia in Siria la dittatura di Shishakli, aprendo un periodo di instabilità politica. In Giordania nel 1955 vi furono vasti movimenti popolari contro l’adesione al patto di Baghdad e le elezioni del 1956 diedero origine ad un governo filo-nasseriano.
Non meno spinose controversie dinastiche e territoriali oppongono l’Arabia Saudita alla Giordania, la pupilla degli inglesi, che occupa i territori di Maan e Aqaba, dei quali la prima si considera defraudata. Un cenno a parte merita la questione dell’oasi di Buraimi rivendicata sia dall’Arabia Saudita sia dall’Emirato di Abu Dhabi. Mentre il petrolio dell’Arabia Saudita era nelle mani delle Compagnie americane, gli inglesi avevano sotto la loro protezione l’Emirato. Nel 1952, l’oasi, che si supponeva ricca di petrolio e che vi verrà effettivamente scoperto nel 1958, fu occupata dalle truppe saudite. La Gran Bretagna portò la questione davanti a una corte arbitrale e alla fine dell’anno formazioni militari di Abu Dhabi, guidate da ufficiali inglesi, cacciarono le truppe saudite da Buraimi. L’occupazione militare britannica ottenne il duplice scopo di dare una risposta intimidatoria all’Arabia Saudita, che in quei giorni stipulava il trattato di alleanza con l’Egitto, e di mettere le mani su una zona di interesse petrolifero.
Il 26 luglio 1956 Nasser nazionalizzò il canale di Suez gettando le premesse per la seconda guerra arabo-israeliana. L’Egitto era stretto nella morsa dei grandi imperialismi. L’antefatto fu il rifiuto, il 19 luglio 1956, da parte degli Usa del finanziamento per la costruzione di una grande diga ad Assuan. Il vero motivo era senza dubbio l’arrivo di moderne armi russe e cecoslovacche in Egitto e l’annuncio di una conferenza “neutralista” che riunì nell’isola jugoslava di Brioni (18-20 luglio) Nasser, Tito e Nehru. Il rifiuto americano era un colpo grave al prestigio di Nasser, e in ogni caso il fallimento di un’opera in grado di irrigare un milione di ettari ed accrescere il livello di vita di centinaia di migliaia di famiglie. Così Nasser il 26 luglio nazionalizzò la Compagnia del canale di Suez, proibendo il passaggio alle navi israeliane e a quelle che trasportavano merci verso Israele.
Lo schieramento delle potenze fu immediato. Pressioni per far ritirare la nazionalizzazione vennero subito dai governi francese, cosciente del ruolo di Nasser nella guerra d’Algeria e per il fatto che la Francia deteneva numerose azioni della Compagnia, e britannico, contrariato nel veder prendere questa decisione meno di due mesi dopo la partenza dell’ultimo soldato di Sua Maestà dall’Egitto e per l’importanza del canale per la Gran Bretagna. Gli Stati Uniti stettero un po’ alla finestra, essendo più interessati al mantenimento di buone relazioni con i paesi arabi produttori di petrolio che al transito per il canale. La Russia al contrario appoggiò subito la nazionalizzazione.
Mentre in campo internazionale fervevano incontri e conferenze per risolvere il problema, alla fine di settembre si verificarono degli incidenti alla frontiera giordano-israeliana. La Giordania, esitante fra Nasser e gli Stati hascemiti, era molto agitata e truppe irachene stazionavano nel Nord del paese, con grande disappunto di Israele. Il 24 ottobre, subito dopo le elezioni, che avevano visto il trionfo degli anti-occidentali, la Giordania firmò un accordo con la Siria e l’Egitto che prevedeva la creazione di un comando militare comune. Ancora più grave era per Israele la presenza sul territorio egiziano del Sinai di depositi di armi di provenienza sovietica. A questo punto prese corpo la logica della guerra per il petrolio insieme all’estremo tentativo di Francia ed Inghilterra di rientrare dalla finestra nella loro vecchia area storica.
Il 24 ottobre diplomatici ed alti ufficiali britannici e francesi si incontrarono vicino Parigi con esponenti del governo israeliano, di cui facevano parte Ben Gurion, Moshe Dayan e Shimon Peres, per concordare una strategia comune. Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, forte della sua superiorità militare, il governo di Ben Gurion decise d’invadere il Sinai. La spedizione israeliana rivelò subito l’estrema debolezza militare dell’Egitto. Il 30 ottobre la Francia e l’Inghilterra, prendendo a pretesto la paralisi del Consiglio di Sicurezza, lanciarono un ultimatum ai due belligeranti di cessare le ostilità e di ritirare le loro truppe a 16 chilometri dal canale. Israele accettò subito l’ultimatum che l’Egitto invece respinse. Francesi e inglesi speravano di forzare la mano a Nasser, contando sull’astensione degli Stati Uniti – che non erano stati consultati – e della Russia, in preda alle serie difficoltà causate dalla rivolta ungherese.
Il 5 novembre Israele aveva raggiunto tutti i suoi obiettivi militari nel Sinai. Fin dal 1° novembre il Cairo aveva chiesto alla Siria di far saltare gli oleodotti, il che fu immediatamente fatto. Gli egiziani affondarono numerose navi nel canale, ma dopo una settimana di bombardamenti degli aeroporti egiziani, che non opposero alcuna resistenza (una nave da guerra egiziana si arrese persino, senza combattere, agli israeliani), il 5 novembre i paracadutisti franco-britannici occuparono Porto Said, poi sbarcarono le truppe.
A questo punto il presidente Usa Eisenhower cominciò a suonare la grancassa: l’intervento franco-britannico significava la rottura del fronte atlantico, era “un colpo fatale inferto alle Nazioni Unite”, una slealtà nei confronti di Washington, una manifestazione di colonialismo verso i paesi arabi ed asiatici. A sua volta la Russia, dopo aver invano proposto agli Stati Uniti un intervento militare congiunto, il 5 novembre alle ore 23,30 lanciò un ultimatum alla Francia, alla Gran Bretagna e ad Israele. Il maresciallo Bulganin denunciò l’aggressione e ventilò la possibilità di usare le più moderne armi offensive, soprattutto missili, contro i tre paesi. Il 7 novembre l’Assemblea generale dell’Onu votò con 64 voti e 12 astensioni la creazione di una forza internazionale incaricata di sostituire i franco-britannici. Questi ultimi avevano dunque fallito, dimostrando che l’autonomia di intervento delle potenze medie era ormai quasi nulla. L’intervento anglo-francese, invece di assicurare il controllo internazionale del canale, si concluse con la sua temporanea chiusura a causa dell’affondamento di parecchie navi e alla interruzione degli oleodotti. Per la prima volta l’Europa occidentale assaggiò le restrizioni e fu costretta ad importare carburante dal Texas. Il risultato principale della guerra per Suez fu l’eliminazione quasi totale dell’influenza francese e britannica in quella regione-chiave.
All’inizio del 1957 gli Stati Uniti si fanno nuovamente avanti per consolidare la loro influenza sull’area. Il 5 gennaio Eisenhower presenta al Congresso un piano per la politica americana in Medio Oriente che si articolava in 3 punti: intervenire con massicci aiuti in appoggio dei governi amici; fornire, ad arbitrio del presidente stesso, un sostegno militare a Stati o gruppi di Stati che lo richiedessero; approntare forze militari americane per intervenire direttamente al fianco degli Stati mediorientali minacciati dal “comunismo internazionale”.
Questa politica si concretizzerà nei mesi successivi in Giordania e in Libano. In Giordania un colpo di Stato dell’esercito appoggiato dal re liquidò il governo filo-nasseriano di Nabulsi, mentre la Sesta Flotta americana, di stanza nel Mediterraneo, si dichiarava pronta ad intervenire per salvare “l’integrità e l’indipendenza” della Giordania. Dieci milioni di dollari furono il premio concesso da Washington al sovrano hascemita in cambio della fedeltà all’occidente. In Libano nel maggio del ‘58, come reazione al governo dittatoriale di Chamoun scoppiava uno sciopero generale che si trasformò in una vera e propria insurrezione che incendiò l’intero paese.
In Iraq, all’alba del 14 luglio 1958, due brigate dell’esercito iracheno comandate dal colonnello Abdel el-Kassem, sorrette dall’appoggio popolare e dai partiti clandestini, si impadronirono dei punti strategici della capitale mentre la radio trasmetteva le note della Marsigliese. La famiglia reale fu fucilata e il ministro Nuri al-Said, catturato dalla folla, linciato. La proclamazione della Repubblica metteva fine, insieme alla monarchia, al progetto inglese di una federazione di monarchie arabe. Kassem ritirò l’Iraq dal Patto di Baghdad e denunciò i preesistenti accordi petroliferi, limitando le concessioni alle Compagnie straniere. Inoltre si accostò alla Russia e ai comunisti iracheni.
Per circoscrivere il contagio, le potenze occidentali decisero di procedere ad una operazione militare di vaste proporzioni. Il 15 luglio una flotta di una cinquantina di navi americane, tra cui due portaerei, sbarcano in Libano 10 mila soldati, mentre forti contingenti di paracadutisti inglesi arrivano ad Amman, chiamati da re Hussein di Giordania alle prese con grandi sollevazioni popolari, soprattutto dei profughi palestinesi che costituivano la grande maggioranza della popolazione giordana. Tuttavia inglesi e americani non osarono attaccare direttamente la nuova repubblica irachena temendo una guerra lunga e logorante.
Kassem governerà per cinque anni prendendo qualche provvedimento populista a favore delle classi meno abbienti, ma senza alcun reale mutamento della situazione sociale. Era soprattutto un nazionalista iracheno e perciò la sua politica estera fu ostile all’Egitto, che proprio nel 1958 aveva costituito la Repubblica Araba Unita con la Siria. Anche per Kassem, come per Nasser, valeva il principio della politique d’abord, ossia utilizzare la politica estera solo come spettacolo contro l’opposizione interna e per nascondere i fallimenti delle riforme sociali. Ostile ad una unione con la RAU, Kassem combatté il Baath e i nazionalisti filo-egiziani che si organizzavano all’interno. Nel 1959 il presidente riaprì una controversia di frontiera con l’Iran per il controllo del golfo Persico e nel 1961 tentò invano sia di annettere il Kuwait sia di venire a capo dell’insurrezione curda, anticipando quella che sarà la politica di Saddam Hussein negli anni Ottanta. Il colonnello finanziò generosamente l’Fln algerino con i fondi provenienti dall’Iraq Petroleum, di cui nazionalizzò il 90% dei giacimenti che la Compagnia aveva in concessione. Kassem ricevette l’assistenza dei tecnici russi, ma il boicottaggio del petrolio iracheno da parte del fronte unito delle Sette Sorelle fece piombare il paese in una crisi spaventosa. Nel 1963 presero il potere i militari del Baath e fu posto a capo dello Stato Abd al-Salam Arif, un altro protagonista della rivoluzione del 14 luglio, che subentrava a Kassem, ucciso nel corso del putsch.
32. Lo scontro per il petrolio algerino
Il nuovo ordine petrolifero post-bellico era incentrato sul Medio Oriente e al suo interno le Compagnie anglo-americane si erano autoinvestite del compito di soddisfare la crescente richiesta mondiale di petrolio. Già nel 1949 le Sette Sorelle controllavano l’82% della produzione e il 76% della raffinazione di tutto l’emisfero occidentale esclusi gli Stati Uniti. Chi non aveva sangue puritano nelle vene trovava enormi difficoltà a sviluppare un’industria petrolifera minimamente indipendente.
Subito dopo la guerra la Francia del generale De Gaulle aveva creato il Bureau des Recherches Pétrolières (Brp) con l’obiettivo di ricostruire l’industria del petrolio distrutta e soddisfare il fabbisogno nazionale attraverso le ricerche petrolifere all’interno dell’impero coloniale francese in Africa. Non potendo contare sulla storica Compagnie française des pétroles (dal 1985 Total) impegnata allora a difendere le sue posizioni nell’Iraq Petroleum Company e nel Medio Oriente, il governo affidò l’incarico ad altre Compagnie statali, fra cui la Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine (Snpa), che dopo qualche anno fecero modesti ritrovamenti di petrolio nel Gabon.
Ma la notizia che infiammò la Francia fu la scoperta, nel 1956, in concomitanza con lo scoppio della ribellione algerina, di un consistente strato di rocce impregnate di petrolio nel Sahara orientale francese, nella zona di Hassi Messaoud. I francesi scorsero la possibilità concreta di emanciparsi dal petrolio mediorientale e dall’influenza anglo-americana. La Francia, nonostante le grandi difficoltà ambientali, aveva iniziato la costruzione di alcuni oleodotti per collegare i pozzi di Hassi Messaoud ai porti algerini e tunisini, da dove il petrolio, caricato sulle petroliere, potesse raggiungere Marsiglia. Lo sforzo francese per arrivare all’indipendenza energetica fu premiato: nel 1961 il petrolio prodotto in varie parti del mondo dalle Compagnie francesi private o sotto il controllo statale copriva oltre il 90% del fabbisogno nazionale. Nell’idea di De Gaulle il raggiungimento di questo obiettivo era legato a un rilancio della grandeur francese, che si concretizzò in una storica apertura verso la Germania e nella firma di un’intesa fra i due Stati a Rambouillet.
Ma, contrariamente ai desideri francesi, gli algerini consideravano il Sahara parte integrante del loro territorio. La guerra di indipendenza dell’Algeria e gli schieramenti che la finanziavano furono fin dall’inizio intrecciati con gli interessi petroliferi. Le Compagnie americane avevano cominciato a finanziare il Fronte Nazionale di Liberazione subito dopo la scoperta dei nuovi giacimenti: l’allora senatore John Kennedy, importante azionista della Standard Oil, aveva chiesto pubblicamente che gli Stati Uniti andassero incontro «all’ansia di libertà e di indipendenza dei patrioti algerini soffocati dalla Francia colonialista». De Gaulle dovette minacciare di uscire dalla Nato per far cessare i finanziamenti americani. Ma a rendere incerto il futuro del petrolio sahariano c’erano anche le manovre portate avanti dall’Eni per aprirsi un canale preferenziale verso il gas e il petrolio algerini.
In Italia, nel dopoguerra, i vincitori avevano incaricato Enrico Mattei, proveniente dalla resistenza cattolica, di smantellare l’Agip, la Compagnia petrolifera nazionale creatura del regime fascista. Nella nuova logica di potere postbellica, le Compagnie anglo-americane si opposero con ogni mezzo perché si sviluppasse in Europa una industria petrolifera autonoma. Un chiaro esempio di questa politica fu proprio l’esclusione dell’Agip dai finanziamenti previsti dal piano Marshall che, non ci dimentichiamo, verrà rimborsato dagli acquisti di petrolio fornito dalle Compagnie americane. In Italia c’era poco petrolio, ma in compenso in val Padana c’era abbondanza di gas e Mattei, sfruttando la rete di vendita messa a sua disposizione dalla Bp, diede vita a quella industria estrattiva moltiplicando le trivellazioni e costruendo gasdotti con l’ausilio delle più moderne tecnologie. In soli due anni l’Italia settentrionale si coprì di una rete di seimila chilometri di gasdotti. Nel 1953 l’Agip si trasformò in una holding, l’Eni (Ente Nazionale Idrocarburi), a cui fecero capo tutte le attività nazionali e internazionali legate al petrolio.
Per alimentare l’enorme complesso petrolifero di cui l’Italia si era dotata Mattei finì per pestare i calli al cartello delle grandi Compagnie. Le prime avvisaglie si ebbero in Iran nel 1954, quando la Exxon rifiutò categoricamente l’entrata dell’Eni nel Consorzio internazionale per lo sfruttamento del petrolio iraniano, nonostante Mattei non avesse fatto nulla che si discostasse dalla linea anglo-americana nei giorni dell’embargo petrolifero nei confronti dell’Iran, non aveva cercato contatti con gli agenti di Mossadeq né preso in considerazione le offerte di petrolio a bassissimo prezzo.
Il veto delle grandi Compagnie all’entrata dello Stato italiano nel Consorzio venne considerato da Mattei un “insultante rifiuto”, che spingerà l’Eni a una politica di punture di spillo contro le multinazionali che governavano il mondo del petrolio. Di questi atteggiamenti si inebriarono i nazional-stalinisti nostrani dell’epoca i quali, poco curandosi che a beneficiare delle attività dell’Eni erano principalmente branche industriali gestite da imprenditori privati, si schierarono contro le Compagnie italo-americane che godevano di concessioni in Italia, tirando fuori le non nuove formule della nazionalizzazione e della lotta “nazionale” contro l’imperialismo! Fumo negli occhi a fini elettoraleschi. Che lo Stato incameri una parte o anche tutti gli utili non autorizza a considerare l’ente di Stato su un piano sociale diverso da quello in cui si muovono le imprese private. I rapporti di produzione entro i quali l’Eni svolgeva la sua attività si concretizzavano nel fatto di gestire le forze produttive secondo leggi economiche prettamente capitalistiche, pagando la manodopera con salario, producendo per il mercato e perseguendo il profitto. Considerati su questo terreno comune la Gulf Oil valeva l’Eni.
Per farsi spazio tra i giganti anglo-americani, il tentativo di concorrenza messo in atto dal capitalismo monopolistico di Stato dell’Eni dovette inventarsi una politica innovativa nei confronti dei paesi esportatori. Nel 1957, approfittando del vuoto di iniziative seguito alla crisi di Suez, Mattei perfezionò con il governo iraniano un accordo basato non più sul fifty-fifty, ma su una formula che prevedeva l’anticipo di tutte le spese per la ricerca a carico dell’Eni e, una volta trovato il giacimento, la possibilità per lo Stato produttore di diventare socio paritario versando metà delle spese. Inoltre, sui profitti divisi a metà l’Eni avrebbe aggiunto un altro 50% in tasse, arrivando così ad una percentuale complessiva 75/25 a favore dell’Iran. L’accordo fece infuriare americani e inglesi i quali protestarono presso il governo italiano denunciando che la destabilizzazione della formula del fifty-fifty rischiava di mettere in pericolo la stabilità del Medio Oriente e gli stessi rifornimenti all’Europa.
Mattei, o perlomeno certi ambienti a lui vicini, era consapevole che non può esserci indipendenza politica senza indipendenza economica, ma questo significava rompere gli equilibri del mercato petrolifero e svincolarsi dall’imperialismo americano, che aveva lasciato l’Italia fuori dal gioco. Lo scontro tra l’Eni e le Sette Sorelle proseguì a tutto campo, dal Nord Africa alla Russia. Nel 1960, in piena guerra fredda, Mattei ruppe l’embargo commerciale ed economico nei confronti dei russi, firmando un accordo in base al quale l’Urss offriva all’Eni 12 milioni di tonnellate di greggio in quattro anni ad un prezzo di poco superiore al dollaro per barile. In cambio l’Italia avrebbe esportato in Russia 50 mila tonnellate di gomma sintetica, 240 mila tonnellate di tubi della Finsider e apparecchiature della Nuovo Pignone. Il tipo di contratto, basato sullo scambio di merci, costituiva una novità introdotta da Mattei nel mondo del petrolio. I tubi Finsider e le pompe Pignone dovevano servire alla Russia per la costruzione di un oleodotto verso l’Europa centrale.
Mattei fu accusato di aver gettato l’Italia nelle mani dei comunisti. Cominciarono campagne di stampa e dispute legali messe in piedi dal cartello delle Sette Sorelle in combutta con gli avversari italiani di Mattei, che di nemici se ne era fatti tanti, e che si trovavano sia nel campo della politica sia in quello degli interessi privati industriali e finanziari, impersonati principalmente dalle società Montecatini ed Edison, attive nei settori della chimica, gas ed elettricità.
Ma la goccia che fece traboccare il vaso fu il fronte algerino. A partire dal 1959 Mattei aveva iniziato, nell’ambito della sua strategia di penetrazione in Africa settentrionale, a inviare aiuti, soprattutto in natura, al Fronte Nazionale di Liberazione (en passant, la sede per l’Europa del Fronte stava proprio a Roma in locali messi a disposizione dall’Eni), nonché a facilitare i passaggi diplomatici degli algerini verso l’Europa e formare i loro tecnici petroliferi. Il sostegno più importante fornito da Mattei fu quello di elaborare insieme all’Fln le strategie petrolifere societarie e normative da far valere nei confronti della Francia. La strategia dell’Eni non escludeva pregiudizialmente la presenza francese, ma prospettava una titolarità diretta algerina del sottosuolo e la costituzione di un’azienda di Stato in cui potessero collaborare francesi e italiani.
Questa politica disturbava le Compagnie americane e quella francese, allora alla ricerca di un accordo per lo sfruttamento dell’intero Sahara francese. Per De Gaulle il Sahara algerino era “una finzione giuridica e nazionalistica senza fondamento storico”. Niente di più facile che i servizi segreti americani e francesi sapessero che i dossier algerini erano stati preparati dall’Eni. Nel giugno del 1961 americani e francesi offrirono all’Eni di entrare a far parte del pool, ma Mattei rifiutò, contando sulla sua posizione di forza presso il Fronte da far pesare alla fine della guerra. Risalgono a questo periodo le minacce di morte ricevute da Mattei da parte dell’OAS francese. Egli si affrettò a rilasciare un’intervista al settimanale Nouvel Observateur significativamente intitolata “Sono io un nemico della Francia?”, nella quale ribadiva di aver rifiutato le offerte delle Compagnie francesi e americane per non compromettere la posizione non colonialista dell’Italia verso i paesi produttori di petrolio.
Dopo che De Gaulle, nel marzo 1962, decise di porre termine al conflitto e ci fu la proclamazione della Repubblica algerina, Mattei aprì le trattative per un accordo petrolifero con il nuovo governo indipendente che comprendeva il solito “pacchetto” (75/25 a favore dell’Algeria) e prevedeva la creazione di una società mista e la costruzione di una raffineria in Algeria. Alle trattative partecipò anche un alto funzionario francese, Claude Cheysson, futuro ministro degli Esteri di Mitterrand. Oltre alla partecipazione a tre nei giacimenti petroliferi e di metano, l’accordo prevedeva di realizzare un gasdotto intercontinentale che dal Sahara, attraverso lo Stretto di Gibilterra e la Spagna, arrivasse fino alla Francia e all’Italia. Un progetto da estendere in seguito ad altri paesi del terzo mondo.
Ma l’accordo, che doveva essere ratificato nell’incontro con Ben Bella del 6 novembre 1962, non sarà mai firmato: Mattei morirà nel suo aereo, precipitato per un attentato nell’ottobre di quell’anno!
Nel febbraio 1963 il vicepresidente dell’Eni Eugenio Cefis firmò con l’americana Esso un accordo per l’acquisto del gas dalla Libia e tutto il delicato lavoro di collaborazione intessuto con i francesi e gli algerini andò perduto. I giornali algerini e di tutto il terzo mondo accusarono Cefis di tradimento e di filo-americanismo. Enrico Mattei riporterà una vittoria postuma quindici anni dopo la sua morte quando l’Eni firmerà un accordo con la Compagnia di Stato algerina Sonatrach per l’importazione di gas in Italia.
33. Sovrapproduzione e nascita dell’Opec
Alla fine degli anni Cinquanta la sovrapproduzione petrolifera apparve come un fatto strutturale. In tutto il mondo si praticavano riduzioni nei prezzi mentre la Russia inondava i mercati a buon mercato. In Italia Mattei aveva appena concluso coi russi un accordo per l’acquisto di greggio a sessanta centesimi meno del prezzo praticato in Medio Oriente. In Giappone il petrolio veniva svenduto. Il petrolio russo stava invadendo l’India, come era accaduto nella guerra dei prezzi scatenata da Deterding negli anni Venti: quando il governo indiano annunciò alle raffinerie di tre delle Sette Sorelle che gli era stato offerto greggio russo più a buon mercato queste furono obbligate ad abbassare i prezzi. Alla situazione di sovrapproduzione mondiale di greggio concorse la scoperta di nuovi grandi giacimenti in Libia, la cui produzione passò da 180 mila b/g del 1962 a 3,3 milioni del 1970, facendo del paese il terzo produttore Opec.
Per tutti gli anni Sessanta i prezzi di listino rimasero pressoché fermi, mentre i prezzi effettivi ai quali il greggio veniva venduto alle industrie di raffinazione tendeva ad abbassarsi. La Exxon e le altre Sorelle si trovarono in mezzo al guado: da una parte erano costrette a praticare sul mercato prezzi competitivi, dall’altra essendo legate al posted price, che costituiva la base di calcolo per le tasse, finivano per pagare ai paesi produttori più del fifty-fifty concordato. Grazie ai bassi prezzi, nel ventennio 1950-1970 la domanda globale quintuplicò e il petrolio diventò la prima fonte energetica consumata a livello mondiale.
Nel 1959 Eisenhower decise di imporre un programma di limitazione alle importazioni di petrolio mediorientale, cedendo alle pressioni delle piccole e medie Compagnie statunitensi che dipendevano dalla più costosa produzione nazionale e che rischiavano di essere messe fuori mercato. Esse fecero balenare il pericolo che una ridotta autonomia produttiva avrebbe esposto gli Usa al ricatto di paesi lontani e instabili. A questo punto le grandi Compagnie, vistosi chiudere il più grande mercato di consumo in un mondo in cui c’era già un eccesso di offerta, risposero con l’abbassamento di 18 centesimi del prezzo del barile per poter pagare meno tasse ai paesi produttori. Ciò significava però tagliare le rendite a Stati che dipendevano mediamente per l’80% dagli introiti petroliferi.
Ciò che non poté la politica, poté il petrolio: tra i produttori la riduzione dei prezzi generò un sussulto di solidarietà fra regni feudali, paesi antimonarchici e Stati estranei al mondo arabo. Nel 1960 i rappresentanti di Arabia Saudita, Iraq, Iran, Kuwait e Venezuela si incontrarono a Baghdad in un’atmosfera di rinnovata fiducia dando vita all’Opec (Organizzazione dei paesi produttori ed esportatori di petrolio), ossia ad un nuovo cartello per contrastare quello delle Sette Sorelle. La decisione unilaterale della potente Exxon (che era socia contemporaneamente dell’Aramco, del Consorzio iraniano ed anche dell’Iraq Petroleum) aveva spinto i paesi del petrolio a rispondere allo stesso modo: probabilmente l’Opec non sarebbe mai nata senza il cartello delle Sette Sorelle.
La prima risoluzione votata individuava il principale nemico nelle Compagnie e stabiliva che i membri non potevano restare indifferenti alla politica dei prezzi adottata dalle società petrolifere e che tutti dovevano attivarsi per riportare i prezzi ai livelli precedenti. L’Opec raggiunse subito l’obiettivo di prevenire altre riduzioni dei prezzi ufficiali, ma non riuscirà mai a ripristinare i prezzi originari; non solo, i suoi membri non possedevano gli strumenti per fissare i prezzi o per diminuire la produzione, che erano nelle mani di chi controllava il mercato. Di fatto, la ritrovata unità dei paesi produttori annegò ben presto nell’abbondanza di petrolio russo e del nuovo petrolio nigeriano e libico che impedirono ogni sostegno artificioso dei prezzi, mentre le Compagnie continuavano a trattare separatamente con ciascun governo per tentare di metterli l’uno contro l’altro. Paradossalmente, a fronte delle Compagnie che cercavano di frenare la produzione per impedire il crollo dei prezzi, ciascun paese Opec aspirava ad aumentare la propria per assicurarsi maggiori introiti.
Lo Scià era il più intollerante ad ogni restrizione, impegnato nel suo ambizioso quarto piano quinquennale e nelle crescenti spese militari. Era convinto che l’accordo del Consorzio iraniano era più restrittivo di quello dell’Aramco e minacciò le Compagnie di ritiro delle concessioni. In effetti le clausole segrete intervenute tra le Sette Sorelle prevedevano per l’Iran, in caso di eccedenza produttiva, penalità maggiori di quelle per l’Arabia Saudita. Per altro il meccanismo per cui ogni società non poteva ritirare proporzionalmente più della propria quota senza pagare una penale, rendeva insoddisfatte anche società come la Mobil o la Cfp che avevano una compartecipazione più bassa rispetto ad Exxon, Socal o Texaco. Alla lunga questi accordi restrittivi si ritorceranno contro i paesi produttori, la crescita economica dei quali doveva essere oggetto di trattativa nei corridoi delle Compagnie private.
In quello stesso tempo la crescente tensione tra lo Stato di Israele e gli Stati arabi minacciava di far da detonatore allo scoppio di tutta l’area. La seconda guerra arabo-israeliana del 1956 aveva mantenuto le linee di confine stabilite alla fine della prima guerra del 1948. La sorveglianza delle frontiere era stata affidata alle truppe Onu. Nessuna soluzione era mai stata apportata al problema dei profughi che avevano abbandonato la Palestina ebraica nel 1948 e vivevano da allora soprattutto in Giordania e in Egitto in campi di raccolta in condizioni di vita miserabili. Il canale di Suez restava chiuso ad Israele, che però poteva comunicare con il Mar Rosso attraverso il porto di Eilat situato in fondo al golfo di Aqaba: l’ingresso del golfo era controllato dall’Egitto, ma i caschi blu dell’Onu assicuravano il passaggio delle navi israeliane.
Una iniziativa di Nasser, probabilmente su pressione della Russia, pose fine a questa situazione, mettendo in pericolo l’economia di Israele: il 18 maggio 1967, su richiesta di Nasser, il segretario dell’Onu U-Thant ritirò i caschi blu, permettendogli di sbarrare l’accesso nel golfo di Aqaba non solo alle navi israeliane ma anche a quelle che trasportavano prodotti strategici per Israele, compreso il petrolio.
Il 5 giugno 1967 Israele invase l’Egitto dando inizio alla guerra detta dei Sei Giorni. Il suo esercito, lo Tsahal, attaccò il grosso dell’esercito egiziano concentrato a nord del Sinai, mentre l’aviazione distruggeva a terra gran parte dell’aviazione egiziana di fabbricazione sovietica. La sorpresa fu totale: il 6 giugno lo stato maggiore israeliano annunciò la conquista di Gaza; il 7 di Sharm el Sheikh, che controllava l’ingresso del golfo di Aqaba all’estremità meridionale del Sinai. Inoltre gli israeliani occuparono la penisola desertica del Sinai, ciò che permise loro di impadronirsi di tutta la riva orientale del canale di Suez, molto oltre le linee del 1956. L’esercito israeliano occupò la città vecchia di Gerusalemme, che apparteneva alla Giordania, e proseguì l’offensiva occupando tutta la riva occidentale del Giordano. Infine le forze israeliane si impadronirono di importanti posizioni strategiche in Siria. In sei giorni quella che avrebbe dovuto essere la riscossa degli Stati arabi si era trasformata nella loro totale disfatta: la Siria aveva perso le alture del Golan, oltre a gran parte della sua aviazione; la Giordania aveva dovuto rinunciare a tutta la Cisgiordania, alla sua aviazione e a gran parte del suo equipaggiamento militare. Chi aveva subito però il colpo letale era stato l’Egitto: il suo esercito aveva subito quasi 15 mila caduti, enormi perdite di armi e munizioni, la sua aviazione era stata quasi totalmente distrutta, e soprattutto Israele gli aveva strappato l’intero Sinai. Nasser, travolto dalla disfatta, rassegnò le dimissioni la sera del 9 giugno.
Da tempo i paesi arabi minacciavano di usare l’arma del petrolio contro l’Occidente e l’occasione fu loro fornita proprio dalla guerra. Il 6 giugno, il giorno successivo all’attacco israeliano, l’Opec decise di attuare l’embargo petrolifero verso i paesi che appoggiavano Israele, andando ad aggravare la crisi provocata dalla chiusura del canale di Suez e degli oleodotti. Il blocco colpì soprattutto l’Europa, che dal Medio Oriente e dal Nord Africa dipendeva per i tre quarti delle sue importazioni. Verso la fine di giugno anche la Nigeria, alle prese all’epoca con la rivolta del Biafra, cessò le sue esportazioni, sottraendo ad un mercato già in condizioni critiche altri 500 mila barili al giorno.
Ma il boicottaggio si dimostrò un fuoco di paglia, dato che l’Iran e la Libia continuarono tranquillamente a vendere il loro petrolio, non solo ai paesi occidentali ma anche ad Israele, mentre il Venezuela aumentò addirittura la produzione. Re Faysal, che si trovava di fronte ad una imminente crisi finanziaria, su consiglio del ministro del petrolio Yamani, limitò l’embargo a Stati Uniti e Inghilterra, considerati paesi aggressori (peraltro nessuna delle due potenze ritirava allora molto petrolio dall’Arabia Saudita). Di fatto, per l’assenza di un fronte comune dei paesi arabi produttori, l’embargo non ottenne gli effetti voluti. Già dopo un mese, i paesi che lo avevano decretato cominciarono a dare segni di irrequietezza per la diminuzione delle entrate, Arabia Saudita ed Egitto in testa. Ai primi di settembre l’embargo venne annullato, a scorno completo del mondo arabo, che all’umiliazione militare aggiungeva l’impotenza politica.
Ma la situazione era destinata a cambiare all’inizio degli anni Settanta quando gli avvenimenti libici fornirono l’occasione per dare slancio all’ascesa dell’Opec (che ora comprendeva dodici paesi membri: ai cinque originari si erano aggiunti Qatar, Emirati Arabi, Libia, Algeria, Indonesia, Nigeria, Gabon) e dettare alle Compagnie nuove condizioni contrattuali.
Nel 1955 un petrolio di alta qualità – il cosiddetto light – era zampillato in Libia. Per la verità già negli anni Venti il geologo francese Conrad Kilian aveva scoperto il petrolio nella regione del Fezzan, nel sud della Libia, nella totale indifferenza da parte della Francia, ma non dei servizi segreti britannici e del generale gollista Leclerc. Quest’ultimo nel 1942, abbandonando la Libia, aveva lasciato una guarnigione a difesa dei giacimenti cartografati da Kilian, nella prospettiva di annettere il Fezzan al Sahara francese. Nel novembre del 1947, mentre Leclerc stava ispezionando i confini libici, l’aereo sul quale viaggiava precipitò (come accadrà a Mattei) in circostanze rimaste misteriose. Nel 1951 le mire francesi vennero definitivamente frustrate dalla decisione dell’Onu, su pressione degli inglesi, di decretare l’indipendenza della Libia mettendo sul trono Idris al Senussi, il cui primo provvedimento fu la concessione agli Usa di una base militare e il rilascio alle Compagnie anglo-americane dei permessi per effettuare ricerche petrolifere sul territorio libico. Sei delle Sette Sorelle e altre otto Compagnie indipendenti si accaparrarono le concessioni, e finalmente nel 1955 il nuovo petrolio libico iniziò a navigare verso gli Usa sulle petroliere Exxon. Graziosamente, le Compagnie americane lasciarono alcune briciole all’italiana Eni e alla francese Cfp.
Finché restò al potere il corrotto regime di re Idris le Compagnie petrolifere non furono seriamente minacciate. Il re si lamentava del basso prezzo del petrolio, ma a tenerlo buono bastava l’esempio di Mossadeq. Tutto cambiò nel momento in cui, il 1° settembre 1969, Idris venne deposto da un gruppo di giovani ufficiali dell’esercito guidati dal colonnello Muammar Gheddafi. Il gruppo, deciso ad usare il petrolio come arma contro Israele e l’Occidente, entrerà inevitabilmente in rotta di collisione con l’imperialismo americano e le Sette Sorelle. Il primo provvedimento messo in atto dai giovani colonnelli fu di ordinare agli americani di evacuare la loro più grande base militare del Nord Africa e di lasciare il paese.
All’inizio il nuovo governo più che verso la nazionalizzazione delle Compagnie si orientò verso un aumento del prezzo del barile: il 20 gennaio 1970 Gheddafi diede il via ai negoziati con ciascuna delle ventuno società operanti in Libia, annunciando che se non avessero accettato di aumentare i prezzi di 40 centesimi di dollaro al barile avrebbe agito unilateralmente. Affermò con boria che «il popolo libico aveva vissuto senza petrolio per cinquemila anni e poteva continuare a farne a meno ancora per qualche anno pur di vedere riconosciuti i propri diritti». In fondo la richiesta era ragionevole, in considerazione dell’alta qualità del greggio (a bassa gradazione di zolfo e quindi particolarmente adatto alla trasformazione in carburante per auto e aerei) e della vicinanza della Libia ai mercati europei. Questo fatto diventerà ancora più importante dopo il maggio 1970, quando un sabotaggio interromperà in Siria la Tap-line proveniente dall’Arabia Saudita. I governanti libici ricevettero un aiuto inatteso dall’esperto di petrolio del Dipartimento di Stato James Akins il quale, preoccupato dalle prospettive di una crisi energetica, sollecitò le Compagnie a scendere a patti con Gheddafi.
La richiesta fu respinta al mittente dalle grandi Società, con alla testa la Exxon, ma in Libia l’anello debole della catena era costituito dalle Compagnie indipendenti che non potevano permettersi di perdere le loro concessioni come minacciato da Gheddafi in caso di mancato accordo. La prima a cedere fu la Occidental Petroleum del miliardario statunitense Hammer, in quel momento sotto i riflettori perché accusato di aver corrotto alcuni funzionari del vecchio regime libico. Negoziando separatamente anche la Continental aveva rotto il fronte degli operatori. Le Sette Sorelle, dopo aver chiesto invano l’intervento del Dipartimento di Stato e del Foreign Office, capitolarono in ottobre, accettando le condizioni imposte alla Occidental.
Ben presto le richieste di aumento di prezzo si diffusero oltre i confini della Libia: l’Iraq, l’Algeria, il Kuwait, l’Iran chiesero tutti un aumento dell’aliquota fiscale dal 50 al 55%. Nella conferenza di Caracas del 12 dicembre 1970 l’Opec sancì il principio che i 30 centesimi di aumento ottenuti dalla Libia divenivano il prezzo ufficiale di riferimento per tutti i paesi membri. All’inizio del 1971 la Libia di Gheddafi si trovava in una posizione di assoluto vantaggio nei confronti delle Compagnie che di fatto avevano perso il controllo sui volumi di produzione ed erano soggette al gioco al rialzo dei prezzi ed esposte alla minaccia di nazionalizzazioni.
Le Major sotto la guida della Bp formarono un fronte comune di “difesa”: i rappresentanti di ventitré Compagnie sottoscrissero a New York, nel quartiere generale della Mobil, una lettera all’Opec nella quale si sollecitava un accordo generale tra le Compagnie e l’insieme degli Stati, allo scopo di evitare negoziati separati. Niente male, se si pensa che soltanto dieci anni prima le Compagnie si erano rifiutate di riconoscere l’esistenza stessa dell’Opec. Inoltre, fu siglato un documento, rimasto segreto per tre anni, con cui ciascun firmatario prometteva di non concludere alcun accordo con il governo libico senza il consenso di tutti gli altri e si impegnava ad uno scambio di aiuto reciproco. Per l’occasione il Dipartimento di Giustizia, preposto all’anti-trust, girò la testa dall’altra parte.
In risposta alla lettera delle Compagnie, lo Scià convocò una conferenza dell’Opec a Teheran al termine della quale, nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio 1971, fu firmato un accordo che riconosceva un extra di 30 centesimi sul prezzo ufficiale del barile, da elevare a 50 a partire dal 1975. Ma solo gli Stati del Golfo furono totalmente favorevoli: l’accordo escludeva specificamente ogni impegno per i prezzi del petrolio nel Mediterraneo. La Libia, il Venezuela e altri Stati “radicali” si dichiararono contrari perché ritenevano che l’accordo limitasse il margine di azione dei singoli Stati membri nei confronti delle Compagnie.
A soli quattro giorni dalla riunione di Teheran il governo di Tripoli, con l’appoggio dell’Algeria, dell’Iraq e dell’Arabia Saudita, iniziò nuove trattative separate con le Compagnie presenti nel paese e riuscì a strappare un aumento di 76 centesimi portando il prezzo base a 3,30 dollari al barile, oltre al rincaro delle imposte governative al 60%. L’accordo di Tripoli scavò un fossato tra la Libia e gli Stati del Golfo favorevoli a Teheran.
36. La crisi economica mondiale - 1973: il primo choc petrolifero
Nel dicembre 1972, nell’ambito del G-10, si arrivò ad un accordo, che il presidente americano Nixon enfatizzò come “il più importante nella storia del mondo”, in base al quale i tassi di cambio delle valute potevano avere una banda di oscillazione del 2,25% rispetto alla parità. Ma questo non impedì una seconda svalutazione del dollaro nel febbraio 1973.
Grave fu il disappunto soprattutto dei paesi produttori di petrolio, visto che tasse e royalty erano calcolate in dollari. La dipendenza di questi paesi dal dollaro era accentuata dal fatto che il surplus accumulato poteva essere assorbito solo dal mercato finanziario americano e che la gran parte dei titoli finanziari detenuti al di fuori degli Usa erano anch’essi denominati in dollari.
Questa dipendenza assoluta dalla divisa americana e la necessità di proteggere i propri investimenti aveva spinto l’Opec, dopo lo smantellamento del sistema di Bretton Woods, a concentrare i suoi sforzi sulla ricontrattazione del prezzo del petrolio. L’aumento che ci fu nell’ottobre 1973, per quanto elevato in termini assoluti, fu in realtà contenuto se riferito al valore dell’oro. Fino al 1971 infatti il valore dell’oro in petrolio non era mai uscito dall’intervallo di 10-15 barili per oncia, mentre alla vigilia dello choc dell’ottobre 1973 il rapporto era arrivato a 34 barili di petrolio per un’oncia d’oro.
Ma andiamo con ordine. Il 6 ottobre 1973, giorno della festività ebraica dello Yom Kippur, Egitto e Siria, forti degli armamenti loro forniti dall’Urss e probabilmente su ispirazione dei consiglieri sovietici presenti nei due paesi, aprirono le ostilità contro Israele pensando di cogliere impreparato il nemico. Ma anche questo conflitto, dal punto di vista militare si risolverà con una sconfitta degli arabi: gli israeliani, equipaggiati dalle armi americane, alla fine della guerra avevano sottratto territorio strategico sia alla Siria sulle alture del Golan sia all’Egitto sulla sponda occidentale del canale di Suez.
Gli avvenimenti bellici furono strettamente intrecciati con la Conferenza dei paesi Opec che in quegli stessi primi giorni di ottobre si teneva a Vienna per discutere con le Major una revisione generale dei prezzi del greggio. Il giorno 9, all’offerta delle Compagnie di un aumento del 15% del posted price (il prezzo formale di listino) e di un aggiustamento verso l’alto dell’indicizzazione sull’inflazione, il Cartello aveva rilanciato chiedendo un aumento del 100% e un aggancio all’inflazione basato sull’indice generale dei prezzi.
Il 10 ottobre gli Stati Uniti proposero il cessate il fuoco su tutte le linee di combattimento: ma sia Israele sia l’Egitto opposero il loro rifiuto. Da quel momento, l’Unione sovietica prese una più decisa posizione nel conflitto organizzando un ponte aereo per rifornire e soccorrere soprattutto la Siria che era in difficoltà contro le forze israeliane. Anche Washington decise per un ponte aereo di sostegno ad Israele.
L’arrivo in Israele dei primi cargo americani carichi di armi provocò l’interruzione delle trattative viennesi. Il 16 ottobre i delegati dei paesi del Golfo (cinque arabi e un iraniano) riuniti a Kuwait City annunciarono unilateralmente la decisione di un aumento del 70% del prezzo del greggio (da 2,90 dollari a 5,12), allineandolo ai prezzi del mercato libero. La proposta irachena di nazionalizzare le Compagnie americane, ritirare i capitali dalle banche Usa e istituire l’embargo contro gli Stati Uniti e gli altri amici di Israele non trovò l’appoggio dell’Arabia Saudita, contraria ad una aperta dichiarazione di guerra economica agli americani.
Il 17 ottobre, mentre le forze israeliane avanzavano verso la Siria, venne deciso dai ministri arabi riuniti in Kuwait di usare il petrolio come arma politica procedendo ad un taglio della produzione nella misura del 5% al mese. Due giorni dopo, il 19 ottobre, in risposta ad un pacchetto di aiuti militari forniti dagli Usa ad Israele del valore di 2,2 miliardi di dollari, la Libia stabilì l’embargo totale del trasporto di petrolio verso gli Stati Uniti (esteso poi a Olanda, Portogallo, Danimarca, Sudafrica e Zaire in quanto alleati di Israele) e la riduzione del trasporto verso altri paesi “non amici”, da mantenere fino a quando lo Stato ebraico non si fosse ritirato dai territori occupati nella guerra del 1967. Il giorno 20, un analogo provvedimento fu preso dall’Arabia Saudita e dagli altri Stati arabi.
Il 21 ottobre il Consiglio di sicurezza approvò la Risoluzione n. 338 che imponeva il cessate il fuoco sulle linee raggiunte in quel momento dai due eserciti. Ma non fu sufficiente a fermare i combattimenti perché gli israeliani proseguirono la loro offensiva sul fronte del Sinai, decisi a chiudere in trappola la terza armata egiziana e a non mollare il vantaggio ottenuto sul campo. Ci vollero altre due Risoluzioni (la 339 del 23 ottobre e la 340 del 25) per arrivare finalmente a bloccare le operazioni militari, anche per la minaccia di un possibile intervento sovietico a fianco degli arabi.
Questi avvenimenti concitati furono l’occasione tanto attesa dai paesi produttori per girare la bilancia a loro favore e dare una risposta concreta alla svalutazione della moneta americana. La pretesa delle Compagnie di negoziare i prezzi direttamente con i paesi produttori era ormai un ricordo del passato. Questo sconvolgimento è passato alla storia con il termine di primo choc petrolifero, primo di una serie dunque: il secondo seguirà nel 1979 in concomitanza con la guerra Iran-Iraq, il terzo nel 2008 quando il prezzo del petrolio raggiungerà il picco di 145 dollari/barile, in parte per motivi di pura speculazione. Nel periodo 2001-2007, infatti, mentre la domanda mondiale di petrolio aumenterà di nove milioni di barili/giorno, il cartello dei paesi produttori non attuerà nessun intervento di sostegno alla domanda e i paesi non-Opec aumenteranno l’estrazione di greggio per meno del 50% del fabbisogno.
Quella prima, improvvisa impennata dei prezzi provocò il panico generalizzato: ogni paese cercò di accumulare riserve negoziando separatamente con i paesi arabi produttori. Il 24 ottobre 1973 la Comunità europea e il Giappone approvarono, in disaccordo con gli Usa, la risoluzione 242 dell’Onu che condannava Israele e ne esigeva il ritiro dai territori occupati. I paesi europei, fortemente dipendenti dal petrolio mediorientale, erano pronti a dissociarsi dalle posizioni americane per sposare la causa dei paesi arabi, con Inghilterra e Francia vogliose di prendersi la rivincita per lo smacco subito dagli americani durante la crisi di Suez di vent’anni prima.
Di fronte ai prezzi crescenti e alle pessimistiche previsioni del Club di Roma sui limiti dello sviluppo basato sulle fonti di energie fossili non rinnovabili, i paesi industrializzati cominciarono ad imporre politiche di risparmio energetico e di sviluppo di fonti alternative di energia. La Francia introdusse misure draconiane di restrizione, soprattutto in materia di energia elettrica, benché l’Algeria continuasse i rifornimenti; anzi, cogliendo l’occasione, si lanciò ben presto in un massiccio programma di costruzione di centrali nucleari attingendo all’uranio della Nigeria e del Kazakistan. In Italia tutto si ridusse alle famose “domeniche a piedi”. Anche l’Olanda si esercitò nel razionamento dei combustibili, nonostante che Rotterdam possedesse le più grandi riserve petrolifere del mondo!
In realtà, in nessun momento vi fu una vera penuria di petrolio. Gli analisti sono concordi nel ritenere che l’effettiva carenza non fu superiore al 5-7% rispetto al periodo precedente la crisi, e in parte fu compensata dal fatto che le Compagnie ripartirono le loro scorte accumulate più o meno verso tutti i mercati, senza ovviamente tener conto dell’embargo voluto dall’Opec. Peraltro l’embargo fu troppo breve per avere serie ripercussioni sulle economie dei paesi colpiti, soprattutto di quei paesi come Francia e Inghilterra che, grazie alle proprie Compagnie nazionali, avevano accesso diretto alla produzione mediorientale e potevano così rifornire i rispettivi mercati. Per le Compagnie americane invece le direttive ufficiali furono quelle di mantenere una politica di neutralità e distribuire il greggio “nel modo più equo possibile” (che significava portare verso gli Stati Uniti quanto più petrolio possibile). Tra i paesi Opec, l’Iran addirittura non solo non rispettò l’embargo, ma aumentò la sua produzione, mentre il prezzo del barile continuava a salire! La commedia finì a marzo del 1974, quando l’embargo fu ufficialmente annullato, dopo che alla fine di gennaio Israele ed Egitto, con la mediazione del Segretario di stato americano Kissinger, avevano cominciato a negoziare i termini per il ritiro delle truppe israeliane dal Sinai.
Gli alti prezzi del petrolio furono una manna per le Compagnie, e resero vantaggiosi gli investimenti in aree e campi altrimenti antieconomici a causa delle difficoltà tecniche e degli elevati costi di produzione. Le multinazionali del petrolio iniziarono a sfruttare in modo intensivo soprattutto i pozzi del golfo del Messico (Texas), del mare del Nord e dell’Alaska. Il greggio dell’Alaska, scoperto negli anni Sessanta dalla Exxon e dalla Bp, convogliato attraverso un oleodotto lungo 1.280 km entrato in funzione nel 1977, con i suoi 2 milioni di barili/giorno arriverà a coprire un quarto della produzione complessiva di petrolio degli Stati Uniti.
Dal mare del Nord il primo carico di greggio, proveniente dai grandi giacimenti di Forties e di Brent (che da allora darà il nome al greggio di riferimento dei mercati), giunse in una raffineria britannica nel giugno 1975. All’inizio degli anni Ottanta la produzione superò i due milioni di barili/giorno. Il mare del Nord diventò la nuova frontiera petrolifera fuori dal controllo Opec oltre che luogo di sperimentazione di nuovi sistemi di ricerca e di estrazione degli idrocarburi. Tra il 1990 e il 1995 quest’area coprirà oltre il 50% dell’incremento nella domanda mondiale di petrolio ma, nonostante questo exploit, il mare del Nord ha riserve per appena 16 miliardi di barili (pari all’1,5 delle riserve mondiali).
Quanto al Messico, dopo la nazionalizzazione del petrolio avvenuta negli anni Trenta, esso era rimasto ai margini del sistema petrolifero mondiale. L’inversione di rotta si ebbe nel 1974 con la scoperta di enormi campi petroliferi offshore nella baia di Campeche: l’afflusso di ingenti investimenti e prestiti internazionali porteranno la produzione messicana a quasi due milioni di barili/giorno.
La guerra arabo-israeliana era stata il classico specchietto per le allodole, perché alla base degli avvenimenti di allora c’era la crisi di sovrapproduzione venuta a maturazione in tutto il mondo capitalista (e a tutt’oggi ancora irrisolta) che provocò un rallentamento nel consumo di petrolio, dopo i vertiginosi aumenti dei decenni precedenti. Sotto i colpi della recessione che faceva il giro del mondo la stampa occidentale si interrogava sul ruolo effettivamente svolto dalle Compagnie petrolifere nell’esplosione della crisi, mentre gli Stati Uniti venivano additati quali principali responsabili dell’aumento dei prezzi perché in quei mesi importarono oltre il doppio del loro fabbisogno interno, mettendo fine ad anni di contingentamento.
In conseguenza di questa decisione, la domanda Usa di greggio mediorientale crebbe rapidamente, ben più di quanto diminuivano le esportazioni arabe e più che controbilanciando la caduta delle importazioni europee e giapponesi. Probabilmente, con una diversa politica americana, la crisi petrolifera del 1973 si sarebbe risolta in breve tempo e con aumenti di prezzo irrisori. Alla fine, dopo molto clamore, le Compagnie uscirono indenni da un’indagine promossa dal Senato americano per accertare eventuali loro responsabilità nello scoppio della crisi. Ma il vento era cambiato, e le Compagnie dovettero dire addio alle grandi concessioni petrolifere mediorientali che erano state alla base della loro espansione mondiale, e anche a quella sorta di regime extraterritoriale che avevano messo in piedi in quelle regioni.
L’aumento dei prezzi consentì un passaggio di della proprietà dei giacimenti dalle Compagnie ai governi arabi, i quali in cambio dell’esproprio concessero alle società straniere compensazioni e accordi di cooperazione nella gestione dei giacimenti stessi. In altri termini il dominio dell’Opec nel periodo dal 1973 al 1985 è stato reso possibile dalle scelte strategiche del maggior paese consumatore, gli Stati Uniti, e dalla continua cooperazione di Washington con le grandi Compagnie.
Dopo le concessioni irachene e libiche, nel 1974 cadde quella della Kuwait Oil Company, partecipata da Bp e Gulf: il governo kuwaitiano acquisì dietro indennizzo prima il 60% della compagnia e poi nel marzo del 1975 il restante 40%. Poi fu la volta della concessione più ricca, quella della Aramco in Arabia Saudita: fondata nel 1947 per volere dell’amministrazione statunitense dalle quattro maggiori Compagnie petrolifere americane, Exxon, Texaco, Mobil, Chevron, possedeva da sola oltre un quarto delle riserve petrolifere allora esistenti. Nel giugno 1974, dopo ripetute pressioni del governo di Riyadh che pretendeva una più equa ripartizione dei profitti, la quota di capitale saudita passò dal 25 al 60%. Nel dicembre dello stesso anno l’Arabia Saudita manifestò l’intenzione di operare una completa nazionalizzazione della società, concedendo alle quattro Compagnie ex-proprietarie condizioni molto vantaggiose: la possibilità di continuare a fornire assistenza tecnica per l’estrazione del greggio ricevendo ventuno centesimi di dollaro per barile estratto e l’opportunità di commercializzare l’80% del petrolio prodotto acquistandolo a prezzo di favore.
Tuttavia, questa politica di esclusione delle Compagnie occidentali dalle riserve mediorientali e di chiusura della maggior parte dei paesi Opec agli investimenti stranieri spingerà l’industria petrolifera a concentrare le ricerche in altre parti del mondo, facendo diminuire drasticamente la fetta di mercato controllata dall’Opec. Anche le guerre mediorientali, soprattutto quella fra Iran e Iraq, contribuiranno a creare un mercato di esportatori esterni al Cartello di Vienna (oggi circa il 60% del petrolio venduto nel mondo proviene da aree non-Opec).
Tuttavia l’Opec, nonostante la messa fuori gioco delle Compagnie occidentali, non aveva la coesione interna necessaria a gestire la questione dei prezzi. A partire dal 1976, con la ripresa della domanda mondiale, i paesi produttori che avevano accumulato eccedenze negli anni di bassi consumi, cominciarono a vendere petrolio sottobanco per fare cassa, alimentando così i cosiddetti mercati “liberi” (o “spot”), alternativi e in concorrenza con il mercato gestito dall’Opec. Il più importante tra questi mercati era senza dubbio quello centrato sul porto di Rotterdam, attivo fin dagli anni Trenta ma che fino alla nascita dell’Opec aveva sempre rivestito un ruolo secondario nella pianificazione dei rifornimenti di prodotti raffinati da parte delle Compagnie. Agli inizi degli anni Settanta, il mercato spot copriva circa l’1% del commercio mondiale di greggio, con carichi trasportati via nave soprattutto da operatori indipendenti che lucravano sui differenziali di prezzo. Con l’entrata in campo di nuovi attori – Compagnie petrolifere nazionali dei paesi arabi, Compagnie pubbliche e private dei paesi consumatori, società di trading e di mediazione, mercati finanziari – Rotterdam diventerà in breve tempo il mercato petrolifero di riferimento a livello mondiale e funzionerà come una vera e propria Borsa del petrolio, per quanto modeste fossero le quantità scambiate (arriverà a gestire il 5% del volume mondiale degli scambi).
La formazione del prezzo del petrolio è cosa alquanto complessa in cui entrano molti fattori, non ultimi la consistenza delle riserve e la speculazione. I produttori manipolano il prezzo attraverso la gestione delle riserve e la disponibilità del bene. Il prezzo viene determinato nei mercati spot e nei mercati finanziari. Nei mercati spot, come quello di Rotterdam, sono acquistati volumi fisici di greggio al di fuori da ogni accordo di fornitura. Nei mercati finanziari invece si scambiano barili di carta: quel che viene scambiato in una serie più o meno lunga di compravendite non è una data quantità di greggio, ma un impegno all’acquisto futuro di un dato volume di greggio. I titoli scambiati sono futures, swap e opzioni. Nel mercato futures viene computato il rischio sulle oscillazioni di prezzo.
Tutte le multinazionali del petrolio possiedono proprie raffinerie a Rotterdam, facendo sì che questo mercato costituisca un barometro per le quotazioni mondiali del greggio e un luogo privilegiato di osservazione per le situazioni di surplus o di penuria della materia prima. Conoscere in anticipo, prima degli altri, le aree dove il petrolio scarseggia mette le ali alla speculazione: i compratori si disputano il prodotto e i prezzi salgono. In caso di penuria, i paesi produttori preferiscono vendere a prezzo più caro nei mercati spot piuttosto che ai loro clienti abituali al prezzo fissato. Senza dimenticare che molti paesi Opec utilizzano questi mercati proprio per superare la loro quota di produzione assegnata dal cartello.
Nel 1973-74 l’aumento dei prezzi, più che alla penuria di petrolio, fu dovuto a questo genere di speculazione, dal momento che ciascun paese consumatore agiva in ordine sparso e ricorreva al mercato di Rotterdam per accumulare riserve. Questo farà la fortuna dei commercianti indipendenti, broker o intermediari che li si voglia chiamare, i quali diventeranno i padroni incontrastati del mercato petrolifero mondiale. Ad esempio, riforniranno i paesi colpiti da embargo (Israele, Sudafrica, ecc.) noleggiando i cargo di armatori indipendenti. Uno di questi era il greco Aristotele Onassis, in attività dal 1938, che nel dopoguerra non esiterà ad entrare in contrasto con le Compagnie americane dotandosi di una flotta di superpetroliere.
Data la diversa qualità dei greggi, ogni area geografica ha il suo prezzo di riferimento. Attualmente i più importanti prezzi sono quelli del Brent del Mare del Nord, molto pregiato, di riferimento per l’Europa, l’Africa e il Mediterraneo, ed è anche il principale riferimento a livello mondiale, e il Wti del Texas, greggio di riferimento per il nord America nel circuito delle quotazioni della borsa-merci Nymex. Questi due petroli, al contrario del greggio del paniere Opec, hanno il vantaggio di essere “leggeri”, cioè poveri di zolfo e a bassa viscosità, il che ne facilita il trasporto e nella fase di raffinazione consente di ottenere una resa maggiore in prodotti finiti, per esempio, benzina e kerosene.
Il 1979 è l’anno dei clamorosi rovesciamenti di fronte nel campo delle alleanze politiche nella regione del Golfo. L’anno si aprì con la fuga dello scià Reza Palhevi, il 16 gennaio, e l’arrivo al potere dell’ayatollah Khomeini, determinando un vero e proprio rovescio strategico per gli Usa e gli arabi sunniti.
Il 26 marzo ci fu la firma ufficiale, apposta a Washington, del trattato di pace fra Egitto e Israele, che coronò la lunga marcia di avvicinamento del presidente egiziano Sadat agli Stati Uniti. Le tappe precedenti erano state la guerra del Kippur del 1973, la visita a Washington dell’ottobre 1975 per chiedere aiuti economici e militari, il viaggio a Gerusalemme del novembre 1977 conclusosi con il famoso discorso alla knesset, pieno di richiami alle comuni radici religiose di ebraismo e islam, e infine gli accordi di Camp David del settembre 1978, fortemente voluti dagli Usa, che prevedevano la restituzione del Sinai all’Egitto (non però della Striscia di Gaza) in cambio della pace e della libertà di navigazione per le navi israeliane nel mar Rosso. I mesi intercorsi fra i colloqui e la firma ufficiale del trattato furono teatro di furiose polemiche sia in Israele sia nei paesi arabi e fra i palestinesi. Basti dire che tutti gli Stati arabi ruppero le relazioni diplomatiche con l’Egitto, la Lega Araba trasferì la propria sede dal Cairo a Tunisi e la Conferenza Islamica, la massima autorità in campo musulmano, espulse l’Egitto.
Il 16 luglio il presidente iracheno Hassan al-Bakr si ritirò lasciando il posto al cugino Saddam Hussein.
Il turbolento 1979 si chiuse con l’invasione sovietica dell’Afghanistan iniziata alla vigilia di Natale. Il governo Usa, intervenendo attivamente nel conflitto in aiuto alla jihad afgana, getterà le basi per la nascita della futura Al-Qaeda di Bin Laden.
Nel settembre 1980 Saddam Hussein, sostenuto militarmente dagli Stati Uniti e dalla Francia, attaccò l’Iran, che pensava sprofondato nel caos, inseguendo un disegno di potenza regionale in cui entrava anche il petrolio: il greggio iracheno e quello iraniano avrebbero insieme trasformato l’Iraq nel più grande produttore mondiale. Iniziò così una tragedia destinata a durare otto anni con un bilancio terrificante in termini di vittime (un milione di morti) e di danni alle infrastrutture. A finire sotto le bombe furono, in Iraq, la grande raffineria di Bassora, il terminale di Fao, gli impianti petroliferi di Kirkuk e gli oleodotti che attraverso la Siria e la Turchia portavano il petrolio fino al Mediterraneo; in Iran, i terminali dell’isola di Kharg e di Bandar Khomeini, oltre al grande complesso di Abadan.
A causa della guerra venne a mancare sul mercato il 10% del fabbisogno mondiale di petrolio e ciò provocò naturalmente il panico generalizzato e un aumento dei prezzi. Tutti volevano accumulare scorte rivolgendosi principalmente al mercato libero di Rotterdam. Ma anche questa volta la penuria fu soltanto momentanea perché le Compagnie avevano enormi partite di greggio immagazzinate, che naturalmente aumentarono di valore e furono cedute ai migliori offerenti. E anche questa volta non mancò chi si scandalizzò per quei sovrapprofitti: negli Stati Uniti, parlamentari del calibro di un Ted Kennedy imbastirono inutili inchieste per la violazione delle leggi antitrust, mentre in Francia il tentativo di perseguire le Compagnie che si rifiutavano di mettere il petrolio sul mercato o che attuarono accordi illeciti a sfavore delle minori si arenò in cavilli legali.
Nel 1983, sempre in Francia, lo scandalo degli aerei “ricognitori”, “sniffatori” in un giornale satirico, pose di nuovo all’ordine del giorno il problema del potere delle Compagnie petrolifere: negli anni precedenti somme enormi di denaro pubblico erano state versate a Elf-Aquitaine per la sperimentazione degli aerei in grado di localizzare i giacimenti di petrolio. Naturalmente si trattava di una truffa. La destinazione delle somme versate non venne mai chiarita, anche se si ha ragione di pensare che una buona parte sia finito nei fondi neri della destra francese. Ma le Compagnie non agivano forse per il bene dello Stato?
In Italia, già in occasione del primo choc del 1973, mentre le scuole stavano al freddo, saltò fuori che il gasolio per il riscaldamento era stato accaparrato per creare una falsa penuria e far alzare i prezzi. Dietro l’operazione c’erano le mazzette versate a politici democristiani e socialisti da parte di Compagnie americane. Nel 1978 la Guardia di Finanza, che avrebbe proprio l’incarico istituzionale di vigilare sulle tasse e accise petrolifere, era stata coinvolta nell’inchiesta aperta dai giudici di Treviso contro la condotta fraudolenta di petrolieri e grossisti di Torino, Venezia e Milano. Venne a galla una frode fiscale di enormi proporzioni che coinvolgeva alti funzionari delle Fiamme gialle e, guarda caso, politici della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista. L’indagine giudiziaria mise in luce per la prima volta anche i legami tra mondo della politica, mondo degli affari, servizi segreti e loggia massonica P2. Nel 1979 fu l’Eni a finire in un nuovo scandalo politico-finanziario: la società aveva concluso un accordo con l’Arabia Saudita grazie ai servigi della loggia P2 e dietro il pagamento di una tangente del 7% ad uno dei principi di casa Saud e di varie mazzette ai soliti politici italiani.
A partire dall’inverno del 1981, a causa della nuova recessione globale, i mercati furono sommersi da una enorme eccedenza di materia prima. In due anni il consumo mondiale di petrolio calò di un quarto: l’Europa consumò meno, mentre gli Stati Uniti ridussero le proprie importazioni dal 50 al 30%, incrementando la produzione interna. Paesi come l’Iran, la Nigeria, la Libia, il Messico, il Venezuela superarono le loro quote di produzione e puntarono al ribasso dei prezzi in controtendenza con le indicazioni dell’Opec. Per tutta risposta, inglesi, norvegesi e russi, questi ultimi primi produttori mondiali a caccia di divise forti, proposero un prezzo ancora più basso! Mondialmente, la capacità di raffinazione era allora di 80 milioni di barili/giorno contro un consumo stimato in 60 milioni: un terzo di troppo rispetto al fabbisogno. Il blocco della produzione iraniana e irachena in quegli anni non venne dunque per nuocere. Nel 1984, in ambito Opec, il Kuwait dichiarò riserve pari a 65 miliardi di barili, che l’anno successivo lievitarono del 50%: niente di strano se si pensa che le quote di produzione imposte dal Cartello sono proporzionali alle riserve dichiarate. Ma tutti hanno interesse a gonfiare certe stime fatte circolare sui mercati, e dichiarare l’esistenza di riserve e capacità estrattive superiori a quelle reali. I dati forniti sono per lo più arbitrari e sono volti ad attrarre investimenti, ottenere prestiti, aumentare le esportazioni. Così le esatte quantità di greggio estratte da ogni giacimento, le condizioni dei giacimenti stessi e i metodi usati restano un segreto gelosamente custodito. Tanto più che le riserve essendo una parte determinante per la formazione del prezzo, la segretezza dei dati è un ulteriore meccanismo di manipolazione del prezzo.
Altri fattori, oltre alla recessione, hanno concorso al rallentamento della domanda globale di petrolio: il progressivo ridimensionamento dell’uso del gasolio da riscaldamento, che in Francia, per esempio, è stato sostituito dall’energia nucleare, e l’utilizzo sempre più massiccio di gas naturale (oggi un quarto delle forniture di gas all’Europa è garantito dal gigante russo Gazprom attraverso il gasdotto North Stream che collega i giacimenti della Siberia occidentale alla Germania).
Ma, nonostante gli alti e bassi del mercato, il giro di affari attorno a questa materia prima strategica rimane colossale, con fatturati da capogiro: le imposte petrolifere nei paesi consumatori superano i mille miliardi di dollari e le rendite i 500 miliardi.
All’inizio degli anni Ottanta subentrò una fase nella quale il crollo dei prezzi e l’ascesa delle Compagnie nazionali nei paesi produttori impose alle Società petrolifere una ristrutturazione e diversificazione, tagliando costi e progetti di investimento, riducendo il personale per concentrarsi sulle attività strategiche, il famoso core business. La riorganizzazione industriale e finanziaria delle Compagnie è stata il risultato di una vera propria guerra a colpi di fusioni, di scalate e di acquisizioni che non risparmiò niente e nessuno. All’epoca fecero rumore l’acquisizione della Conoco – una delle grandi Compagnie indipendenti americane – da parte del gruppo chimico DuPont e della Gulf – una delle Sette Sorelle storiche – da parte della Chevron.
All’epoca, mentre le aree con grandi riserve di idrocarburi si facevano rare a fronte degli aumentati costi di esplorazione e di produzione, divennero assai appetibili i giacimenti vergini ricchi di petrolio e di gas situati nella zona del Caspio. Nel 1989, dopo la caduta del muro di Berlino e lo smantellamento dell’impero sovietico attanagliato da una profonda crisi economica, i paesi della regione, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, divennero oggetto di desiderio dei maggiori Stati imperialisti, sempre più assetati delle materie prime indispensabili alla vita dell’economia. La politica di sciacallaggio delle Compagnie e delle varie diplomazie, non disdegnando nessun mezzo d’azione per quanto perfido, punta ad impadronirsi dei pozzi e degli oleodotti.
La “liberalizzazione” dell’economia russa, iniziata sotto Gorbaciov già a partire dal 1987 grazie all’arrivo dei capitali esteri (Usa, Banca mondiale, Banca europea), subì un’accelerazione sotto Eltsin che diede il via a una vasta ondata di privatizzazioni nei settori dell’energia, dei metalli e delle telecomunicazioni (al 1994 oltre il 60% del Pil proveniva dal settore privato). Su questo terreno di “libera concorrenza” sono germogliati i monopoli bancari ed industriali dei famigerati “oligarchi” russi, che nel 2000 Putin ebbe buon gioco a mettere nel mirino additandoli all’opinione pubblica quali responsabili dell’aggravamento delle già disastrose condizioni di vita del proletariato russo. Il clan di Putin riuscì così sia a sbarazzarsi di qualche compagnia straniera troppo intraprendente sia ad incamerare al suo clan la rendita del petrolio e del gas russi, ricompattando il controllo politico e la gestione finanziaria delle immense risorse energetiche del paese.
Dal 1994 la città di Baku, capitale dell’Azerbaigian, è diventata la Dubai ultramoderna sul Caspio, dove tutte le grandi Compagnie hanno aperto uffici e avviato promettenti prospezioni offshore.
L’Orso russo non fa mancare il suo appoggio, contro Baku, alla vicina Armenia, da dove il petrolio del Caspio è a portata di cannone.
L’euforia delle grandi Compagnie per l’Azerbaigian presto si è rivolto anche al Kazakistan, sulla riva asiatica del Caspio, e alle sue miniere di uranio e di potassio. Nel 2000 è stato scoperto a Kashagan, nel Nord del Caspio, uno dei più grandi giacimenti petroliferi offshore esistenti al mondo ad opera di un Consorzio di otto società (tra cui le solite Shell, Exxon, Total, Eni). Non è ancora chiaro quanto di questo petrolio sarà recuperabile, date le notevoli difficoltà tecniche, di costi degli impianti e di rischi ambientali (in caso di incidenti l’emissione di gas solforato sarebbe mortale per i lavoratori e per la popolazione). I costi medi di produzione dell’area si aggirano sui 6-8 dollari/barile contro i 3 del Golfo Persico, senza contare i maggiori costi di trasporto e di diritti di transito. Intanto una cosa è certa: ci vorranno decenni per risanare i debiti che il paese ha contratto. Dal 2005, una parte del petrolio kazako scorre verso la Cina attraverso l’oleodotto che collega i giacimenti di Atasu alla provincia cinese dello Xinjiang, regione turcofona musulmana in rivolta contro Pechino. Ormai nel Caucaso, come altrove, la partita dell’energia è giocata da tre imperialismi: americano, russo e cinese.
Nel 1971 il presidente Boumédiène nazionalizzò il petrolio algerino, costringendo le Compagnie francesi Total ed Elf ad interessarsi ad altre aree petrolifere, soprattutto mare del Nord e golfo di Guinea. In Gabon, la Total insediò un dittatore di comodo per meglio gestire i propri affari, mentre Elf si concentrò sulla Nigeria, che era ricca di giacimenti off-shore.
Il petrolio era stato scoperto in Nigeria nel 1956, nel delta del fiume Niger nell’estremo Sud del paese, dalla Shell-Bp, multinazionale anglo-olandese che al tempo era l’unica concessionaria dei diritti di estrazione. Da allora la storia della Nigeria è pesantemente condizionata dal petrolio. Quando nel 1967 il Biafra proclamò l’indipendenza dalla Nigeria fu subito sostenuto dalla Francia e dall’Elf: il conflitto che ne seguì, sobillato dalle potenze occidentali per saccheggiare le ricchezze del paese, fu disastroso e causò la morte di oltre due milioni di uomini, la maggior parte dei quali per fame. Dopo l’indipendenza dalla Gran Bretagna del 1960 il paese è stato quasi sempre sotto regime militare, ma il vero potere è stato esercitato di fatto dalle Compagnie del petrolio (su tutte la Shell, detentrice del 40% delle quote del Consorzio petrolifero, e poi Exxon, Chevron, Eni e Total), che hanno loro uomini a libro paga in ogni ministero e in ogni struttura.
La produzione di petrolio ammonta oggi in Nigeria, che dal 1971 è membro Opec, a 2,3 milioni di barili/giorno (dodicesimo produttore mondiale, primo in Africa). I pozzi sulla terraferma hanno una produzione decrescente fin dai primi anni Ottanta, mentre acquistano sempre più importanza i giacimenti situati in acque profonde. La Nigeria è al secondo posto in Africa dopo la Libia per riserve provate (37 miliardi di barili) ed è al primo posto per riserve di gas naturale (5.000 miliardi di metri cubi). La Nigeria riveste grande interesse per il capitale internazionale, non solo in campo petrolifero ma anche in quello delle infrastrutture. Il paese è il più popoloso dell’Africa con 173 milioni di abitanti nel 2014 e la prima economia del continente, quindi un potenziale enorme mercato. Secondo previsioni la Nigeria nei prossimi dieci anni assorbirà il 40% di tutte le spese per infrastrutture che si investiranno nell’Africa sub-sahariana.
Non è quindi strano il crescente protagonismo mostrato verso il paese dai grandi imperialismi. Nel 2003, il presidente americano venne a proporre aiuti finanziari in cambio di petrolio, seguendo il criterio della differenziazione degli approvvigionamenti per non dipendere troppo da alcune aree, vedi Medio Oriente, tanto più che a separare gli Stati Uniti dall’Africa non c’è che l’Atlantico. Bisogna dire tuttavia che se gli Stati Uniti sono sempre stati in passato il principale acquirente del petrolio nigeriano, negli ultimi anni, in seguito al massiccio piano nazionale di estrazione di petrolio da scisti argillosi, le importazioni dalla Nigeria si sono sempre più ridotte fino ad azzerarsi nel 2014.
Ma in prima fila c’è sicuramente il capitale cinese, che mostra un forte interesse strategico verso tutto il continente africano, e che ha stretto legami commerciali con la Nigeria, l’Angola, l’Etiopia, il Sudan. Da 15 anni esiste a livello istituzionale un forum per la cooperazione Cina-Africa. Nel Ciad l’imperialismo cinese non ha esitato ad appoggiare una ribellione locale, mentre in Niger già operano direttamente Compagnie petrolifere cinesi. La Cina è il primo esportatore in Nigeria, soprattutto per prodotti elettronici, macchinari e beni di consumo: in conseguenza dei forti legami commerciali fra i due paesi recentemente la Banca centrale nigeriana ha convertito parte delle sue riserve da dollari Usa a yuan cinesi. Anche il mancato introito nigeriano per la chiusura del mercato Usa è stato prontamente sostituito dall’impegno cinese ad aumentare le importazioni petrolifere dalla Nigeria, anche per attenuare da parte della Cina la dipendenza dal petrolio angolano, che da solo rappresenta la metà del suo import petrolifero. Complessivamente la domanda cinese di prodotti energetici nel giro dell’ultimo decennio è pressoché raddoppiata, ed è ormai un sesto di quella mondiale.
La storia dell’Iraq degli ultimi decenni evidenzia in modo esemplare le dinamiche geopolitiche legate al petrolio. Nel 1988, alla fine della guerra contro l’Iran, il paese era materialmente e finanziariamente a terra e pesantemente indebitato con le petro-monarchie “amiche”, Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, che vantavano crediti superiori ai 60 miliardi di dollari. L’Iraq, che sosteneva di essersi sacrificato “in nome di tutti gli arabi”, reclamò la cancellazione del debito, oltre ad un risarcimento consistente nel diritto di trivellazione nei giacimenti situati a nord del Kuwait. Inoltre, come spiegò il vice-presidente iracheno Tareq Aziz, questi paesi dal 1980 avevano estratto 2,1 milioni di barili/giorno anziché i previsti 1,5, facendo perdere all’Iraq 89 miliardi di dollari in dieci anni a causa del prezzo mantenuto basso dalla sovrapproduzione. In particolare proprio il Kuwait aveva approfittato della guerra per aumentare la sua produzione del 20% facendo precipitare il prezzo del petrolio e creando ulteriori problemi al già martoriato Iraq.
Va ricordato che il Kuwait era riserva di caccia personale dei Bush, che avevano fatto fortuna grazie alla Zapata Petroleum Company, la società di famiglia che aveva sfruttato prima il petrolio off-shore texano negli anni Cinquanta e successivamente quello kuwaitiano.
Il Kuwait, i cui investimenti all’estero nel 1986 avevano superato le entrate petrolifere, e che pertanto non era interessato ad agire sul prezzo del greggio attraverso un calo della produzione, rimase quindi sordo alle rivendicazioni irachene. Saddam vide nel rifiuto opposto dall’emiro del Kuwait una dichiarazione di guerra, e il 2 agosto 1990, in seguito al fallimento delle trattative di Gedda, diede l’ordine alle sue truppe di invadere il paese. All’arrischiata iniziativa non fu estraneo l’atteggiamento dall’ambasciatrice statunitense a Baghdad, April Glaspie, che fece intendere che gli Stati Uniti non si sarebbero immischiati in dispute tra arabi.
L’invasione allarmò la comunità internazionale perché occupando il Kuwait l’Iraq avrebbe controllato il 20% delle riserve mondiali di greggio. Su iniziativa statunitense scattò l’operazione Desert Shield (Scudo nel deserto), ufficialmente a protezione dell’Arabia Saudita, e cominciarono ad affluire nel regno 200.000 militari. Contemporaneamente venne orchestrata la commedia delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu con le quali si condannava l’invasione e si intimava all’Iraq il ritiro immediato. Il 6 agosto lo stesso Consiglio votò contro Baghdad l’embargo economico più esteso mai imposto ad un paese, impegnando tutti gli Stati membri dell’Onu a sospendere qualsiasi tipo di scambio commerciale con l’Iraq, e nominò un’apposita commissione per controllare l’applicazione delle sanzioni. L’embargo comprendeva i medicinali, i fertilizzanti e moltissimi prodotti alimentari.
In risposta, l’8 agosto, il Consiglio della Rivoluzione iracheno approvò l’annessione del Kuwait all’Iraq come diciannovesima provincia: storicamente l’emirato, prima di divenire un protettorato britannico nel 1899, aveva fatto parte della provincia irachena di Bassora all’interno dell’Impero Ottomano.
Il 10 agosto, nel corso della Conferenza al vertice svoltasi al Cairo, dodici paesi arabi aderirono all’alleanza anti-irachena capeggiata dalla casa Saud, tutti gli altri, ad eccezione della Libia, si astennero.
L’amministrazione Bush senior coinvolse nell’operazione la Gran Bretagna, la Francia, l’Italia, l’Olanda, il Canada e l’Urss. Dalla propaganda orchestrata per mesi dagli Usa sullo stile del marketing commerciale, che tendeva a presentare Saddam Hussein come un dittatore spietato e sanguinario e gli Usa con il nobile obiettivo di riportare la pace e la libertà nel Medio Oriente, si passò nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 1991 ai bombardamenti aerei di Baghdad da parte della coalizione, dando inizio alla guerra che passerà alla storia col nome di Desert Storm (Tempesta nel deserto). Dopo sei settimane di bombardamenti e pochi giorni di operazioni di terra, che portarono gli alleati a 240 chilometri da Baghdad, terminò quella che venne chiamata la Prima Guerra del Golfo.
Il Kuwait fu “liberato”, ma il regime di Saddam rimase in piedi in un paese pressoché distrutto: far cadere allora il Baath avrebbe rischiato di destabilizzare tutto il Medio Oriente, con pesanti ripercussioni sul fronte del petrolio. La guerra fu il primo tentativo da parte degli Stati Uniti di imporre il Nuovo Ordine Mondiale sull’area del Golfo dopo la fine della Guerra fredda.
L’Iraq diventò un boccone da azzannare da tutte le parti: le rivolte tribali, ribattezzate intifada, sciita a sud e curda a nord, fomentate dagli americani, le sanzioni mantenute integralmente anche dopo la liberazione del Kuwait, le condizioni capestro imposte dall’Onu, fra cui l’istituzione di una no-fly zone, cioè di un’area interdetta all’aviazione irachena nel Kurdistan iracheno e nel sud sciita, che di fatto sottrasse quei territori al controllo del governo centrale, il risarcimento dei danni di guerra, l’imposizione delle ispezioni Onu sugli arsenali iracheni. Queste misure finirono per affossare definitivamente l’idealità e la possibilità di Nazioni indipendenti faticosamente propagandate nel Ventesimo secolo.
Gli Usa impressero una nuova accelerazione dopo l’elezione a presidente di George Bush junior, i cui legami col mondo dei petrolieri erano ben noti. Il 28 gennaio 2000, appena eletto, Bush fece mettere in agenda dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il problema mediorientale, in previsione di una deregolamentazione dell’energia. Una Commissione creata ad hoc sotto la direzione del fedele Dick Cheney (anch’egli legato all’ambiente del petrolio) e formata da membri del gruppo Enron, allora uno dei grandi mondiali dell’energia, fu incaricata della fattibilità del progetto. Quando nel 2003 la Corte Suprema metterà le mani sui documenti prodotti dalla Commissione (nel frattempo la Enron era stata al centro di un clamoroso fallimento), scoprirà una cartina dell’Iraq risalente al marzo 2001 in cui si evidenziava una zona alla frontiera con l’Arabia Saudita, estesa per circa un terzo dell’intero paese, frazionata in otto lotti ai fini dello sfruttamento petrolifero. Niente di strano che l’Iraq fosse visto come una fonte petrolifera ausiliaria alle riserve dell’alleato saudita, oltre che come una fonte di facili sovrapprofitti per le Compagnie americane.
Ma non erano solo gli americani a puntare sull’Iraq. Il 19 aprile 2011, il giornale britannico The Indipendent rivelerà i disegni “segreti” alla base dell’intervento militare del governo Blair in Iraq nel 2003: la Shell e la Bp incontrarono a più riprese i responsabili del governo inglese per accaparrarsi in anticipo la partecipazione alla spartizione del petrolio iracheno. Il ministero degli Affari Esteri aveva redatto un memorandum di questo tenore: «L’Iraq è un grosso fornitore potenziale di petrolio. Bp vuole assolutamente essere della partita e teme che accordi politici sfavorevoli le facciano perdere questa enorme opportunità».
Così, il 20 marzo 2003, fu sferrata una nuova guerra contro lo sventurato Iraq, questa volta con il pretesto delle “armi di distruzione di massa” possedute da Saddam Hussein, che non saranno mai trovate. I tempi erano maturi per gli anglo-americani di sbarazzarsi del “dittatore”. Come prima cosa allungarono le mani sul Ministero del Petrolio e sui giacimenti. Il paese fu consegnato al caos, teatro di una serie interminabile di attentati, di guerre civili, di scontri religiosi, di lotte fra clan, mentre la vita per la popolazione diventava un inferno, spesso priva anche dei conforti primari come acqua ed elettricità.
I campi petroliferi furono messi progressivamente all’incanto da parte di un governo iracheno più o meno legittimo: i pretendenti erano molti e di tutte le nazionalità, ma i contratti più consistenti furono assegnati a Exxon, Shell e Mobil. I contratti siglati a seguito dell’invasione avevano una durata ventennale e interessavano la metà delle riserve irachene.
Nel marzo 2006 fu istituita su iniziativa del Congresso americano e del presidente Bush una commissione denominata Gruppo di Studio sull’Iraq, composta da dieci membri, democratici e repubblicani, e presieduta dall’avvocato ed ex-Segretario di Stato James Baker, il cui scopo era quello di ridefinire la politica statunitense in Iraq. Baker era tutt’altro che estraneo all’ambiente dell’industria petrolifera, anzi il suo studio legale era tra i maggiori consulenti delle Compagnie americane. Il rapporto partorito da Baker prevedeva la privatizzazione totale della Compagnia Petrolifera Irachena a favore – naturalmente sotto protezione delle forze armate statunitensi – delle Compagnie private americane, le quali ottenevano così quello che era stato loro rifiutato prima della guerra: mettere le mani sul petrolio iracheno ancora nel sottosuolo. Molto democraticamente, il rapporto raccomandava di sospendere ogni aiuto militare, economico e politico al governo iracheno nel caso che le proposte avanzate non avessero avuto seguito.
Non bisogna dimenticare che le fluttuazioni dei prezzi della materia prima vanno ad agire sulla composizione organica del capitale ed hanno sempre un’incidenza diretta sul saggio di profitto, anche quando non esercitano alcuna azione sul salario, quindi neanche sul saggio e sulla massa del plusvalore. Come scriveva Marx, la materia prima costituisce un elemento essenziale del capitale costante, e supposto che le altre circostanze (macchinario, numero degli operai, saggio del plusvalore, ecc.) rimangano invariate, il saggio del profitto decresce o aumenta in ragione inversa del prezzo della materia prima. Infatti, «se il prezzo della materia prima decresce di un importo d, il saggio del profitto che è uguale a pv/C, ossia a pv/c+v, si trasforma in pv/C-d oppure, che è lo stesso, pv/(c-d)+v. Di conseguenza il saggio di profitto aumenta. Viceversa, se il prezzo della materia prima sale, pv/C diviene pv/C+d ovvero pv/(c+d)+v; di conseguenza il saggio di profitto diminuisce» (Il Capitale, III). Ne risulta l’importanza fondamentale della materia prima petrolio per i suoi molteplici impieghi industriali nell’economia capitalistica, e di conseguenza il peso politico da esso esercitato all’interno dei rapporti imperialistici fra le grandi potenze.
Le variazioni del prezzo del petrolio dipendono, prima che dalla speculazione, dalla rendita, a sua volta dipendente dall’andamento della crisi di sovrapproduzione industriale.
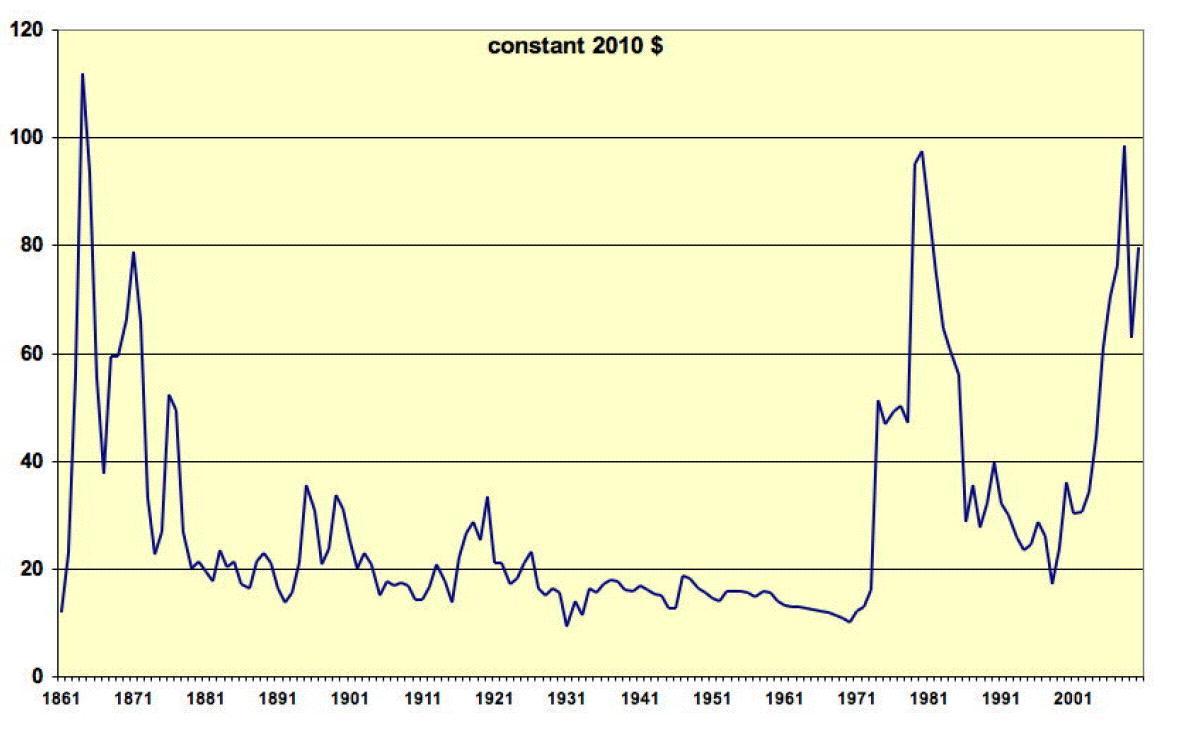 |
Seguendo la curva dei prezzi del petrolio in dollari correnti e in dollari costanti (cioè depurati delle variazioni dovute all’inflazione), si nota che il prezzo medio del greggio dal 1900 al 1970 è rimasto stabile. Dopo il 1973 aumenta l’ampiezza delle oscillazioni e il prezzo sembra più difficile da controllare: abbiamo due impennate nel 1973-1974 e nel 1979-1980, un crollo nel 1986, una stagnazione nel periodo 1975-1978, un’erosione tra il 1982 e il 1985, una volatilità a partire dal 1987, ma un aumento regolare dopo il 1999 ad eccezione del picco vertiginoso ma effimero nel 2008.
Tuttavia la media annuale del periodo non è mai scesa al di sotto dei 14/15 dollari correnti al barile (18/20 dollari del 2010). L’oscillazione si mantiene sempre al di sopra di un prezzo minimo. Per un valido motivo: considerato che nel 1978 il costo di un barile di petrolio estratto negli Usa era 69 volte più elevato di quello estratto in Arabia Saudita (8,06 dollari/barile contro 0,13), e sapendo che un petrolio a basso costo sarebbe destinato ad espellere dal mercato il petrolio di costo più elevato, si capisce che il prezzo minimo è necessario per scongiurare il blocco della produzione statunitense. Ovviamente, gli Usa non escludono il ricorso alla forza militare per proteggere la sicurezza dei loro rifornimenti petroliferi “ad un prezzo ragionevole”. Nel 1986, la guerra dei prezzi sfondò il prezzo minimo, costringendo l’allora vice-presidente americano Bush senior a precipitarsi in Arabia Saudita per mettere le cose a posto.
Mentre i paesi Opec con meno riserve o con fabbisogni finanziari elevati (come l’Iran e l’Iraq dopo la guerra del 1980) puntano a massimizzare i prezzi, l’Arabia Saudita, con il suo 40% di riserve provate, ha sempre giocato un ruolo importante di stabilizzazione a vantaggio degli Stati Uniti, in cambio di protezione e aiuti militari.
42. Produttori, produzioni, consumi
Il petrolio è un olio, originato da processi biologici o abiotici, imprigionato in giacimenti sotterranei (Stati Uniti, Canada, Russia, Medio Oriente, Venezuela, ecc.) o in fondo al mare (Caspio, Golfo del Messico, Mare del Nord, Golfo di Guinea, coste del Brasile). Nonostante le misure di risparmio energetico e il crescente utilizzo del gas naturale e del nucleare, ma soprattutto nonostante la cronica crisi generale di sovrapproduzione, il mondo consuma annualmente circa tre miliardi di tonnellate di prodotti petroliferi.
Secondo i dati forniti dall’Agenzia Internazionale per l’Energia nel 2007 il consumo energetico mondiale è stato di 8,2 miliardi di Tep, contro i 4,7 del 1973. Il Tep, tonnellata di petrolio equivalente, è l’unità di misura del potere calorico ed equivale a 1,43 tonnellate di carbone di alta qualità. La produzione di energia primaria fu di 12 miliardi di Tep, provenienti per l’80,4% dalla combustione di energia fossile (petrolio, carbone, gas) e per il resto dal nucleare.
La maggior parte del petrolio è fornita da solo otto Compagnie. Quella del petrolio (carburanti, plastiche, tessuti sintetici, ecc.) è la maggiore industria mondiale. Tra le prime dieci società industriali ben otto sono petrolifere, e di queste quattro sono americane. Nel 2011, a conclusione di un incessante processo di ristrutturazione e di concentrazione, a svettare nel mondo del petrolio sono rimaste cinque grandi multinazionali con attività in tutti i settori (banche, servizi, trasporti, ecc.): al primo posto, con base a Dallas, troviamo la Exxon Mobil Corporation, diretta discendente della Standard Oil di Rockefeller, con le sue 45 raffinerie in 25 paesi diversi e 42.000 stazioni di servizio; in California c’è la Chevron, che nel 2005 si è fusa con la Texaco ed l’Unocal; poi c’è la francese Total (sorta dalla fusione di Total, Fina ed Elf), che nel 2011 ha acquisito il gigante del gas Gdf Suez con partecipazioni nei giacimenti del Mare del Nord; ci sono poi l’anglo-olandese Shell e la Bp (la ex Anglo-Persian Oil Company), che nel 2004 ha acquisito il 50% della compagnia petrolifera russa Tnk, ora Tnk-Bp, titolare di concessioni nell’Artico.
Secondo Wikipedia Fortune Global 500, queste multinazionali sono nel novero delle società industriali più ricche del globo quanto a fatturato: la Shell è in seconda posizione dietro Wal-Mart, leader americana della grande distribuzione; subito dopo seguono Exxon al terzo posto e la Bp al quarto; al quinto e al sesto posto ci sono le Compagnie cinesi Sinopec e China National Petroleum; in decima posizione troviamo la Chevron e in undicesima la Total. Se invece guardiamo ai profitti realizzati, cambia l’ordine: 1° Exxon, 2° Shell, 3° Chevron, 4° Wal-Mart, 5° China Petroleum Corporation, 6° Total.
Nel periodo 2003-2007, i principali paesi importatori di petrolio sono stati gli Usa con il 23,5% della percentuale mondiale, l’Europa occidentale con il 26,8%, il Giappone per il 9,6%. La maggior parte degli scambi origina dal Medio Oriente con destinazione Europa, America settentrionale e Giappone. L’Africa esporta soprattutto verso gli Usa e l’Europa occidentale, mentre la Russia soprattutto verso l’Europa dell’Est. La produzione del Mare del Nord è destinata all’Europa. Il consumo di petrolio è quasi sestuplicato nel periodo dal 1950 al 1973, mentre tra il 1973 e il 2002 è aumentato soltanto di 1,25 volte.
Si è anche assistito a un radicale mutamento delle gerarchie nell’ambito delle diverse fonti energetiche: se nel 1950, il petrolio rappresentava il 27% del totale dei consumi energetici, contro il 62% del carbone e il 10% del gas naturale, già nel 1970 esso copriva il 48% della domanda di energia mondiale, contro il 31% del carbone e il 18% del gas. La produzione energetica mondiale commercializzata nel 2008 è derivata per il 34% dal petrolio, per il 24% dal gas naturale, per il 29% dal carbone, per il 6% dall’idroelettrico, per il 5% dal nucleare, per l’1% dall’eolico e per lo 0,04% dal fotovoltaico (Bp Statistical Review of World Energy, 2009). Si prevede che nel 2020, il petrolio sarà sempre la prima fonte di energia (40%), contro il 24% del carbone, sempre più rimpiazzato dal gas naturale (24%).
Secondo uno studio del gennaio 2011 pubblicato dalla Documentation Française e riferito all’anno 2010, i principali paesi produttori di petrolio, sugli oltre 90 esistenti, sono: Russia (12,9% della produzione mondiale), Arabia Saudita (12%), Usa (8,5%), Iran (5,3%), e Venezuela, Cina, Messico, Norvegia, Iraq, Nigeria, Brasile, Regno Unito (dal 3 al 5% ciascuno). L’offerta è praticamente stabile da diversi anni e si aggira attorno agli 85-87 milioni di barili/giorno.
Nel 2009, i principali consumatori in ordine decrescente sono stati: Usa (21,7%), Cina (10,4%), Giappone (5,1%), India (3,8%), Russia (3,2%), Arabia Saudita (3,1%), Germania (2,9%), Brasile (2,7%). La percentuale della Cina potrebbe arrivare nel 2030 al 20% del totale mondiale (contro il 5% del 2002). Nel gruppo del G20, che rappresentano l’85% del commercio mondiale e i 2/3 della popolazione, queste le quote dei consumi energetici: Cina 25%, Usa 22%, Unione Europea 16%, Russia 7%, India 7%, Giappone 5%, Brasile 3%. In alcuni paesi come Francia e Giappone, il gas e l’energia nucleare hanno sostituito il petrolio, soprattutto per la produzione di elettricità. Nei paesi industrializzati, il 54% del petrolio è consumato nei trasporti.
Nel 2010, il consumo mondiale di petrolio ha toccato il record di 87,4 milioni di barili/giorno (52,7% nei paesi OCSE, 47,4% nei paesi non-OCSE). Rispetto agli anni precedenti, l’aumento più consistente ha riguardato Usa, Brasile, Russia, Medio Oriente e Cina.
Nel 2010, il consumo di energia (non solo petrolifera) a livello mondiale è aumentato del 5,5%, dopo il declino dell’1% dell’anno precedente. I paesi emergenti hanno contribuito per i 2/3 di questo aumento (la Cina da sola ha coperto un quarto della crescita energetica totale).
L’estrazione del petrolio mediante frantumazione idraulica si è sviluppata soprattutto in Nord America, dove ha provocato l’inquinamento delle falde freatiche.
Quanto all’energia prodotta dal vento e dal sole, bisognerà forse aspettare il comunismo, che sarà incurante di alti costi di produzione, perché possa svilupparsi.
Secondo i dati dell’Aie, nel 2006 l’energia è stata utilizzata per il 28% dall’industria, per il 27% dai trasporti, per il 24% dalle utenze domestiche e soltanto per il 2% dall’agricoltura.
Nel 2009 le riserve accertate mondiali, cioè le quantità estraibili in un momento dato, superiori ai mille miliardi di barili, sono concentrate in limitate aree geografiche: il Medio Oriente ne possiede il 60% (il 19,8% l’Arabia Saudita, l’8,6% l’Iraq, il 7,3% gli Emirati Arabi Uniti, il 7,6% il Kuwait, il 10,3% l’Iran), il Venezuela il 12,9%, la Russia il 5,6%, la Libia il 3,3%, il Kazakistan il 3%, la Nigeria il 2,8%, il Canada il 2,5%, gli Usa il 2,1%, e meno del 2% tutti gli altri.
Conoscere lo stato reale delle riserve è faccenda assai complicata, non solo perché le informazioni provengono sostanzialmente da chi è interessato a non scoprire le carte, cioè le Compagnie e i paesi produttori, che gonfiano la consistenza delle loro riserve. Le condizioni geologiche del sottosuolo, la posizione geografica, la tipologia del greggio, lo sviluppo delle tecniche, l’andamento dei prezzi sono tutti elementi che concorrono a rendere rilevante o meno un giacimento in termini economico-industriali. Nonostante che dagli anni Sessanta non siano stati più scoperti giacimenti di grandi dimensioni, pure è cresciuta la consistenza delle riserve grazie alle nuove tecniche di estrazione che hanno reso appetibili campi prima antieconomici.
Le previsioni delle cassandre che vedono dietro l’angolo la “fine del petrolio” sono da valutare in queste dinamiche. Così, secondo alcuni geologi americani, che hanno rivisto al ribasso le cifre fornite dall’Opec, le riserve residue dell’Arabia Saudita, il maggiore esportatore mondiale di petrolio, ammonterebbero soltanto a 50-60 miliardi di barili, una quantità equivalente a soli due anni di consumo mondiale!
Il vero problema è semmai che l’80% degli 85 milioni di barili consumati giornalmente provengono da un nucleo ristretto di paesi, che così acquisiscono un’importanza enorme. L’Agenzia Internazionale per l’Energia, che raggruppa i principali paesi consumatori ma è sotto influenza americana, a questo proposito è decisamente catastrofista: in un rapporto del 2009 sosteneva che bisognerebbe moltiplicare per quattro le riserve dell’Arabia Saudita per poter soddisfare il fabbisogno mondiale.
Infatti la domanda globale di energia tende a salire per l’entrata sul mercato di nuovi grandi consumatori come Cina e India. Inoltre il petrolio resta la materia prima fondamentale per la fabbricazione di una infinità di prodotti, dai tessuti sintetici alle materie plastiche. Per altro l’impiego di tecniche sofisticate di perforazione del suolo (anche fino a 12 chilometri di profondità) fanno aumentare enormemente i costi di produzione rendendo gli investimenti sempre meno redditizi.
44. Una sola alternativa: la rivoluzione
L’Opec è ormai un cartello dilaniato tra i paesi incatenati agli interessi dell’imperialismo americano, come Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi (che per mantenere bassi i prezzi, soprattutto in funzione antirussa, hanno aumentato la produzione durante il conflitto libico del 2011 e in occasione della crisi ucraina del 2014), e i “falchi” come Iran e Venezuela, legati piuttosto agli imperi russo e cinese. Il timore di una recessione mondiale, e quindi di una diminuzione drastica del consumo di petrolio, addensa nubi all’orizzonte.
L’unica soluzione sensata, ossia fermare la corsa al profitto, e quindi ridurre sia la produzione sia il consumo di energia, implica la distruzione del potere politico delle borghesie mondiali.
Scriveva Henri Kissinger nel giugno 2005: «La domanda e la competizione per l’accesso all’energia potrebbero diventare ragione di vita e di morte per molte nazioni». La Russia e gli Stati Uniti, che possiedono sul proprio territorio notevoli riserve energetiche, controllano militarmente sia le zone di produzione sia le rotte di rifornimento verso l’Occidente. I russi presidiano l’area del Caspio, ma con il loro enorme potenziale di risorse puntano apertamente al mercato europeo: Gazprom è ormai una multinazionale a tutti gli effetti, che è entrata nella corte dei Grandi.
Notiamo che è oggi un lontano ricordo lo scudo americano costruito nel 1955 per contenere l’espansionismo dell’Urss nella regione del Golfo, il Patto di Baghdad che univa Turchia, Iraq, Iran e Pakistan in un trattato di mutua difesa antisovietica. La questione siriana rende l’area ancora più esplosiva: un intervento internazionale occidentale in Siria dovrebbe fare i conti con l’opposizione della Russia, che ha firmato con Assad un accordo per la costruzione di una base di sottomarini nucleari sul Mediterraneo, e anche della Cina, del Brasile e dell’India.
Gli Usa, approfittando dei ricorrenti conflitti che attraversano il Medio Oriente, hanno impiantato nell’area dove sono ubicate oltre il 60% delle riserve mondiali di greggio un numero impressionante di basi militari, sulla terraferma e sul mare. Dopo aver fornito appoggio ai peggiori regimi della regione e contribuito al sorgere del terrorismo islamico, oggi gli Stati Uniti vogliono far credere di voler cambiare strategia e di voler aprire alla democrazia nell’area del Medio Oriente e del Maghreb lacerata da profonde trasformazioni sociali e politiche. In realtà si tratta dell’ennesima giravolta che dietro la finzione democratica nasconde il cinico obiettivo di realizzare, attraverso le guerre, un grande supermercato per i bisogni strategici ed energetici americani.
Intanto il dragone cinese, sempre più energivoro, stringe alleanze con tutti i paesi ricchi di risorse (Russia, Venezuela, paesi africani), le sue Compagnie petrolifere cercano di strappare le condizioni migliori, attraverso le sue potenti banche che erogano finanziamenti a mezzo mondo, e con la partecipazione diretta e indiretta ai conflitti locali. Lo scontro con gli altri imperialismi è alla lunga inevitabile, dal momento che quello cinese è un capitalismo in piena espansione e protende i suoi tentacoli verso i quattro angoli del mondo, dall’Indonesia al Medio Oriente all’Africa nera.
In Niger per esempio, che è già una delle sue roccheforti petrolifere, la Cina punta a mettere le mani sull’uranio di cui il paese è ricchissimo, che però è indispensabile anche per l’industria nucleare francese. Forse si capisce il fervore dei francesi nel voler liberare a tutti i costi la Libia dal “dittatore” Gheddafi, vista l’importanza strategica del paese nord-africano per il controllo dell’Africa centrale.
Dietro i monopoli economici ci sono dunque le grandi potenze vecchie e nuove che puntano a spartirsi il pianeta. Scrive Lenin ne “L’Imperialismo”:
«Più il capitalismo è sviluppato, più la mancanza di materie prime si fa sentire, più la concorrenza e la ricerca delle fonti di materie prime in tutto il mondo è accanita, e più è brutale la lotta per il possesso delle colonie».
Se si sostituisce il
termine
colonie con semi-colonie – lasciando agli sprovveduti l’illusione
che esistano paesi “indipendenti” – il passo di Lenin illumina
anche la situazione di oggi.
«Non potendosi fermare il ritmo di inferno della accumulazione, questa umanità, parassita di se stessa, brucia e distrugge sopraprofitti e sopravalori in un girone di follia, e rende sempre più disagiate e insensate le sue condizioni di esistenza. L’accumulazione che la fece sapiente e potente la rende ora straziata e istupidita, fino a che non sarà dialetticamente capovolto il rapporto, la funzione storica che essa ha avuto» (“Vulcano della produzione o palude del mercato?”).
Da questa lotta infernale, da questo consumo ad oltranza di energia che distrugge il mondo dei viventi, da questa spirale incontrollabile di disperazione nella quale è precipitato il sistema capitalista con tutti i suoi mercenari, il proletariato non ha nulla da sperare se non massacri fratricidi, distruzioni, miseria, sofferenze e guerre interimperialiste senza fine.
Il capitalismo ha ormai compiuto il giro del mondo: la contrapposizione Est-Ovest, la questione coloniale e la questione nazionale non sono più un motore di rivoluzioni e motivo di mobilitazione per i lavoratori e per le masse diseredate. All’ordine del giorno c’è soltanto la lotta radicale del proletariato internazionale contro la borghesia internazionale. Rinascano in tutti i paesi le organizzazioni di classe strette al loro unico partito comunista per affrontare e finalmente abbattere il vampiro capitalista e tutti i suoi traffici mercantili.
È necessario uccidere il capitalismo affinché l’umanità possa vivere.