|
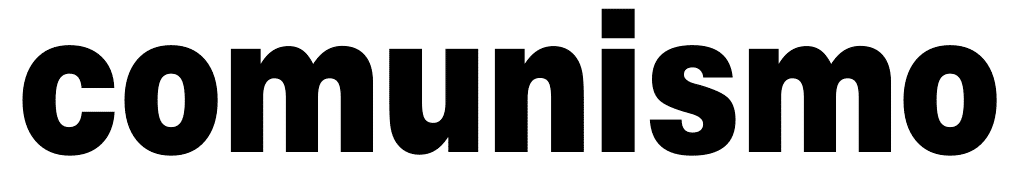 |
n.100 - dicembre 2025 - Anno XLVII aggiornato al 19 dicembre 2025 |
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Guerre sempre più distruttive nel modo di produzione capitalistico sono ineluttabili.
Le guerre sono sempre esistite, indotte da moventi di natura economica. Anche l’impero di Sargon di Akkad, intorno al 2.350 a.C., considerato il primo impero della storia, tra le altre motivazioni economiche del suo espandersi aveva bisogno dello stagno, di cui era privo, per fonderlo con il rame ad ottenere il bronzo.
Anche nell’imperialismo, fase terminale del capitalismo, valgono molto poco le volontà dei capi di Stato, marionette nelle mani del capitale: è la necessità di sopravvivenza della classe borghese che decide per la guerra, quando la sua esistenza è minacciata da crisi di sovrapproduzione non più contenibili. Le varie borghesie nazionali sono costrette a cercare di schiacciare i capitalismi concorrenti per non esserne schiacciate.
La martellante propaganda di tutti gli Stati annuncia che la guerra è santa perché contro un aggressore – sia “terrorista” o “ibrido” – e che i proletari devono andare a uccidere e a morire, meglio se con gioia, in nome della Patria, di Dio, della Democrazia, della Libertà, o altro imbroglio.
Tali “nobili principi” che sembrano scolpiti nel granito spesso presto si dissolvono, data l’estrema mobilità delle alleanze inter-imperialistiche, e accade che uno Stato si trovi poi alleato con quello dipinto fino a poco prima come “il male assoluto”. L’Italia ne è un esempio. Nel primo conflitto mondiale entrò in guerra contro gli Stati con cui fino all’ultimo era alleata, nel secondo ha cambiato fronte in corso d’opera.
Anche gli imperialismi più forti come quello statunitense non fanno eccezione: è recente la correzione di rotta degli U.S.A., che dopo aver imposto la guerra ai suoi riluttanti vassalli europei, li ha poi abbandonati per cercare migliori rapporti con la Russia, in funzione anticinese. I servili Stati europei sono ora indecisi tra mollare l’osso o continuare a fomentare la guerra per guadagnarci almeno le briciole, comunque sostanziose, costituite dalla ricostruzione dell’Ucraina e dello sfruttamento delle sue risorse. Ma non possono scegliere: la guerra si impone ai capitalisti per l’avanzare della crisi economica.
I borghesi per la difesa dei profitti sono sempre pronti ad abbandonare ogni loro pacifismo. Subito accompagnati dai partiti “di sinistra”. È eloquente l’esempio del socialista Turati: dopo Caporetto sostenne l’abbandono della già traditrice parola d’ordine “non aderire né sabotare”, per passare all’aperto difesismo: “La patria è sul Grappa”!
I comunisti sanno che l’unica alternativa alla guerra imperialista è la guerra di classe, la guerra alla guerra, spinta fino alla rivoluzione comunista. La nostra parola d’ordine è stata formulata da Lenin: “Trasformare la guerra imperialista in guerra civile”.
Per tale prospettiva è necessaria la presenza di un forte sindacato di classe diretto dal Partito Comunista rivoluzionario marxista. Il Partito dirige la classe tramite le sue organizzazioni, la “cinghia di trasmissione”, queste indispensabili come il primo.
Per questo non ha significato opporre nel Partito il “lavoro sindacale” al “lavoro politico”, o alternarlo secondo le situazioni. L’intreccio tra l’attività del partito in campo sindacale e l’azione di indirizzo programmatico rivoluzionario comunista non può mai essere inteso, qualunque sia la situazione, come un qualcosa di separato.
Risponde Lenin al compagno Natsia il 13 ottobre 1905: «”Ponendosi il compito dell’insurrezione armata il compito di dirigere la lotta sindacale del proletariato passa inevitabilmente in secondo piano”. Questo, a mio parere, teoricamente non è giusto e dal punto di vista della tattica è errato. L’insurrezione armata è il metodo supremo della lotta politica. Perché abbia successo dal punto di vista del proletariato è necessario sviluppare ampiamente tutti gli aspetti del movimento operaio. Perciò è arci-errata l’idea di contrapporre il compito dell’insurrezione al compito della direzione della lotta sindacale».
Se il Partito è lo stato maggiore della rivoluzione, il Sindacato di classe, composto da proletari, ne costituisce gran parte dell’esercito. Dato che l’unica alternativa alla guerra imperialista è la vittoriosa guerra di classe, a questa occorre quell’esercito e quello stato maggiore. Questi occorrono per sabotare la guerra e praticare il disfattismo rivoluzionario, ostacolare l’afflusso dei soldati e delle armi verso il fronte, bloccare il proprio Paese in guerra con lo sciopero generale, fino ad abbattere in alcuni grandi Stati il potere della classe borghese.
Il proletariato, diretto dal suo partito comunista internazionale, non userà
allora più le armi contro i propri fratelli di classe sotto un’altra divisa, ma
le volgerà contro i veri nemici, la propria borghesia, decretando la fine
dell’infame regime del Capitale.
La guerra civile in Russia
Nel Donbass
Capitoli esposti alla riunione generale del maggio 2024
Anche se non influenzò in modo determinante e direttamente l’andamento della guerra civile in Russia, non passò senza conseguenze la grave crisi sociale interna della Germania. Il 15 gennaio 1919 erano stati assassinati Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg.
Ma già dal 1918 in quasi tutti i paesi europei, specialmente in quelli direttamente coinvolti nel conflitto, si erano avuti scioperi e manifestazioni contro la guerra per la profonda crisi economica che aveva generato, che si aggravava e colpiva il proletariato sia dei paesi vincitori sia dei vinti. Anche lontano dai fronti, negli Stati Uniti ebbe luogo a Seattle un esteso sciopero generale e in Canada violente agitazioni costrinsero il governatore a insistere con Londra a rinunciare all’utilizzo di truppe canadesi nella guerra civile in Russia.
Il “nemico interno”, il proletariato, sull’esempio del vittorioso proletariato russo, avanzava risoluto rivendicazioni economiche, nonostante la repressione dei movimenti operaio e rivoluzionario, che tendeva a “fare come in Russia”.
Le lotte operaie durante il Biennio Rosso in Europa, 1919-20, ebbero sviluppi diversi nei vari paesi ma non raggiunsero i successi sperati e attesi dai comunisti nel senso di una rivoluzione politica. Ebbe nefasta influenza nel raffrenare e deviare quelle lotte l’appoggio alle rispettive borghesie nazionali fornito dai partiti socialdemocratici, che dal 1914 avevano approvato i crediti per finanziare le spese del conflitto, determinando di fatto la fine nel tradimento della II Internazionale Socialista.
Lenin nell’articolo: “La situazione e i compiti dell’Internazionale Socialista” pubblicato il 1° novembre 1914, fornisce l’indirizzo per i compiti futuri: «Nell’ultimo terzo del secolo XIX e all’inizio del XX la Seconda Internazionale ha compiuto la sua parte di utile lavoro preparatorio, di organizzazione delle masse proletarie nel lungo periodo “pacifico” della più crudele schiavitù capitalistica e del più rapido progresso capitalistico. Alla Terza Internazionale spetta il compito di organizzare le forze del proletariato per l’assalto rivoluzionario contro i governi capitalistici, per la guerra civile contro la borghesia di tutti i paesi, per il potere politico, per la vittoria del socialismo».
Allo scopo quindi di dare forma e sostanza a quelle indicazioni, per coordinare tutte le iniziative di lotte proletarie, favorire la formazione di genuini partiti comunisti in tutto il mondo, per poter dirigere la rivoluzione comunista a livello internazionale, a Mosca dal 2-7 marzo 1919 si tenne il Primo Congresso della Internazionale Comunista. Poterono parteciparvi 51 delegati di 30 paesi, quelli che riuscirono a superare i fronti militari e le persecuzioni delle polizie.
Situazione generale nei confini europei
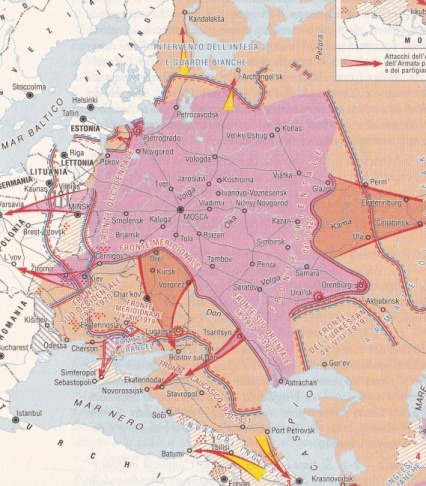
Il Donbass: baricentro del fronte Sud
Anton Denikin, il comandante in capo delle forze controrivoluzionarie, dopo i ben tre recenti insuccessi volti a conquistare stabilmente Caricyn, accantona al momento le offensive contro la strategica città sul Volga per una nuova sceltacruciale: privilegiare nel Sud la campagna per il controllo del ricco bacino minerario e industrializzato del Donbass. Stabilisce quindi una nuova disposizione e assetto del fronte che tiene conto del mutato impegno nella guerra civile russa delle forze dell’Intesa, principalmente franco-britanniche, a seguito dell’uscita della Germania dalla guerra e del conseguente ritiro delle truppe tedesche dall’Ucraina, che aveva agevolato l’esercito rosso nell’occupazione di Kiev il 6 febbraio 1919.
Le forze rivoluzionarie erano così posizionate: il fianco occidentale sul Mar d’Azov era tenuto dalla II Armata ucraina; le si aggiunsero le formazioni dell’Esercito Rivoluzionario Insurrezionale dell’Ucraina comandate dall’anarchico Machno, che insieme costituirono la XIV Armata Rossa.
In Ucraina le prime bande insurrezionaliste erano sorte come risposta armata all’attribuzione di una parte dell’Ucraina agli Imperi Centrali sancita dal trattato di Brest-Litovsk del 3 marzo 1918. Si radunarono in una formazione più strutturata sotto la guida dell’anarchico Machno, la cosiddetta Armata Nera. Questa, secondo un calcolo del loro stato maggiore, all’inizio del 1919 contava 15.000 uomini, tutti volontari, organizzati in cavalleria, fanteria e artiglieria, per arrivare poi a disporre nel dicembre dello stesso anno di 83.000 fanti, 20.135 cavalieri, 1.435 mitragliatrici, 118 cannoni, 7 treni corazzati e alcune macchine blindate. Furono necessariamente riorganizzate in conformità a quelle dell’Armata Rossa per operare congiuntamente.
Ma complesso e tumultuoso fu il rapporto con questa armata, che combatteva indistintamente contro qualunque forza volesse sottomettere e impossessarsi dell’Ucraina, stringendo mutevoli alleanze temporanee. Per la loro concezione anarchica tendevano all’auto-amministrazione economica e politica delle varie comunità, autonome e federate secondo il principio egualitario e antiautoritario, che non si conciliava con le necessità militari del momento e con l’universalismo comunista. Dopo aspri contrasti e non semplici scontri dovemmo sconfiggerli militarmente nel 1921 con una spedizione bolscevica guidata da M. Frunze.
Lo spiegamento delle forze sovietiche a nord-est era posizionato con il gruppo di Koženikov di 20.000 uomini, la futura XIII Armata, che si agganciava a nord di Millerovo al fianco destro della VIII Armata di 27.000 uomini, comandata da Tuchačevskij, appena trasferito dal fronte orientale. Questa armata controllava un esteso fronte da Millerovo fino a Vesenskaja. Qui la IX Armata di 28mila uomini era posizionata verso est dove con la X Armata di Egorov con 23.000 uomini controllavano tutta l’area fino al Volga a nord di Caricyn.
Il settore del Donbass
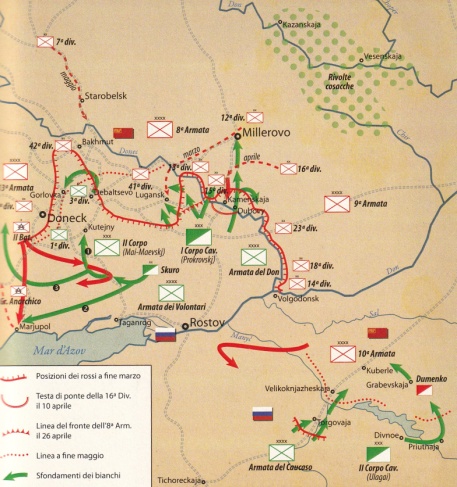 Il fronte bianco era così disposto: da ovest la penisola di Crimea era difesa
dall’omonimo Corpo di Crimea; il bacino del Donec disponeva delle ridotte forze
di Maj-Maevskij tra Donec e Lugansk, conquistata poi dai bolscevichi; nella
parte centrale del fronte vi era l’Armata del Don con 15.000 uomini a ridosso
del Don; infine sul fianco orientale la cavalleria di Mamontov era in seria
difficoltà a sostenere la crescente pressione della X Armata Rossa stanziata a
protezione di Caricyn.
Il fronte bianco era così disposto: da ovest la penisola di Crimea era difesa
dall’omonimo Corpo di Crimea; il bacino del Donec disponeva delle ridotte forze
di Maj-Maevskij tra Donec e Lugansk, conquistata poi dai bolscevichi; nella
parte centrale del fronte vi era l’Armata del Don con 15.000 uomini a ridosso
del Don; infine sul fianco orientale la cavalleria di Mamontov era in seria
difficoltà a sostenere la crescente pressione della X Armata Rossa stanziata a
protezione di Caricyn.
Occorreva ora sfruttare subito il fallimento dei tre tentativi dei cosacchi bianchi di assumere il controllo dello snodo di Caricyn, e in particolare dello sfaldamento delle loro formazioni che in buona parte si erano arrese anche senza combattere, indebolite e mancanti di ogni tipo di rifornimento.
Vācietis, a capo del Consiglio Militare Rivoluzionario (RVSR), intravide ormai prossima la vittoria finale sul fronte meridionale e la conquista del Donbass, dell’intera regione del Don e del Caucaso settentrionale, fino allora escluse dalle direttrici principali dei piani militari. La precedente impostazione intendeva ottenere risultati decisivi aggirando i bianchi più a nord, presso lo snodo di Millerovo, senza inoltrarsi nell’industrializzato Donbass, però escludendo così l’aiuto che avrebbe dato all’esercito rosso l’insurrezione alle spalle dei bianchi di quel consistente numero di proletari.
Il nuovo assetto dei bianchi volto a difesa del Donbass, ritenuto ormai l’epicentro di tutto il fronte sud, costrinse Vācietis a rettificare i piani militari concentrando velocemente le forze disponibili a occidente, verso il Donbass, per un’offensiva su larga scala. Conscio della situazione così esortava i suoi generali: «Il nostro successo in questo settore è importante perché il nemico minaccia la nostra avanzata su Novočerkassk e Rostov sul Don. Le forze del nemico qui sono aumentate di due o tre volte».
Il cambio di direzione non fu affatto semplice per le esauste divisioni sovietiche, in assenza di linee ferroviarie utilizzabili: nella regione si sviluppavano lungo la direttrice nord-sud, e non est-ovest, e i cosacchi in ritirata le avevano in gran parte distrutte.
Per la manovra sovietica fu richiesto un maggior coinvolgimento delle truppe di Antonov-Ovseenko e del Gruppo anarchico di Machno operanti in Ucraina. Gittis, il comandante del fronte rosso di quel settore, approntò il nuovo dispiegamento generale che avvenne sostenendo diversi scontri, con alterne fortune, dovute anche a un anticipato scioglimento del ghiaccio del Donec e dei maggiori affluenti, che interpose una barriera di fango tra le opposte linee.
Dopo vari posizionamenti, a metà marzo la linea di partenza per l’offensiva per il possesso del Donbass seguiva all’incirca il corso del Donec, sul quale erano confluiti circa 130-150.000 truppe sovietiche contro circa 45-55.000 controrivoluzionarie. Poiché Vācietis insisteva per un immediato assalto frontale, nonostante fossero ancora necessarie due settimane per il completo riassestamento del fronte, e il Donec ancora in piena, fu deciso per il 17 marzo un attacco delle unità che potevano operare senza l’impedimento del fiume. Questo permise di occupare importanti centri intorno al fiume, ma che non furono consolidati per il terreno acquitrinoso e la spossatezza delle truppe che ormai combattevano ininterrottamente da mesi in difficili condizioni. Con l’arrivo dei nuovi reparti l’iniziale inferiorità numerica rossa in quel particolare settore delle operazioni si trasformò in una leggera superiorità superando di poco i 40.000 bianchi.
Le forze di Antonov-Ovseenko avanzarono dall’Ucraina fino al Mar d’Azov costringendo il Corpo di Crimea a ritirarsi nella penisola, lasciando senza protezione il fianco sinistro delle forze bianche di Maj-Maevskij lungo la costa presso Mariupol, che fu occupata dagli anarchici di Machno.
Gittis, cercando di sfruttare al meglio la situazione e la precaria superiorità numerica del momento, concepì un nuovo piano, non privo di rischi, per portare, dopo un rapido spostamento di consistenti truppe, comprendente anche la brigata anarchica di Machno, un poderoso attacco al fianco delle truppe di Maj-Maevskij, mentre una esigua formazione rossa avrebbe dovuto attaccare i bianchi stanziati a Lugansk.
Inizialmente il piano funzionò e le formazioni di Maj-Maevskij furono costrette a ritirarsi dalle loro posizioni. Ma quando il comando bianco capì che davanti a Lugansk i rossi erano in evidente inferiorità numerica, Denikin ordinò un’immediata controffensiva in forze nel settore producendo tra il 27 e 28 marzo uno sfondamento nelle linee rosse. Il vigoroso e vincente attacco bianco sulla debole e secondaria posizione nemica disarticolò il piano di Gittis che fu quindi obbligato a riposizionare velocemente le truppe per arginare l’estesa falla che si era creata presso Lugansk. Da questa la Cavalleria del Caucaso di Škuro era penetrata attaccando alle spalle le retrovie del gruppo d’attacco sovietico obbligando Gittis addirittura a sguarnire la prima linea d’attacco per contrastarli. Nelle loro scorribande i cosacchi di Škuro seminarono terrore e distruzione nei villaggi e si procurarono un discreto bottino militare e 5.000 prigionieri.
A seguito di questi eventi negativi le forze rosse furono costrette a lasciare parte del terreno guadagnato. Altri attacchi dei Lupi di Škuro costrinsero l’Armata Nera a lasciare Mariupol. Si ristabilì la situazione di partenza.
Il fallimento del piano di Gittis fu anche determinato dalle ribellioni che si svilupparono nelle retrovie delle forze rosse: numerose comunità dei villaggi cosacchi attorno a Vesenskaja e Kazanskaja, che già si erano ribellate contro le truppe di Krasnov, ora si rivoltavano contro i bolscevichi, soprattutto per le requisizioni di derrate. Si dovettero distaccare 14.000 uomini della VIII e IX Armata per contrastare gli insorti, valutati in circa 30.000. Quel tentativo bolscevico di riprendere il controllo della situazione provocò in poche settimane migliaia di uccisioni. Lo stesso Trotzki in “Ribellione nelle retrovie”, del 12 maggio 1919, riferiva: «La ribellione di una parte dei cosacchi dura già da alcune settimane. È stata provocata dagli ufficiali controrivoluzionari, agenti di Denikin, ed è sostenuta dai kulaki cosacchi. I kulaki hanno trascinato un numeroso gruppo di contadini cosacchi medi. È molto probabile che in certi casi i cosacchi abbiano dovuto sopportare ingiustizie da parte di certe unità militari di passaggio o da parte di certi rappresentanti delle autorità sovietiche. Gli agenti di Denikin hanno saputo servirsene per attizzare la fiamma della rivolta (...) Una ribellione nelle retrovie è per il soldato come un ascesso al braccio per l’operaio (...) Per questo il nostro compito più urgente è quello di ripulire il Don dai sobillatori e di reprimere le sommosse» (Scritti militari, I - La rivoluzione armata).
Ad aprile Gittis organizzò un nuovo attacco al Donbass principalmente muovendo da est la IX Armata Rossa. L’articolata manovra, approfittando della ritirata delle acque del Donec, prevedeva che alcune divisioni rosse, appena riposizionate a ridosso di Millerovo, dovevano colpire il fianco destro dei bianchi, già impegnati al contrasto della VIII Armata, permettendo così alla IX Armata di avanzare in profondità sul Donec. Purtroppo la IX Armata si mosse con incredibile lentezza e confusione; invece di cooperare con la VIII Armata secondo i piani, avanzò disordinatamente, attraversò il fiume Donec accontentandosi di piccoli risultati tattici, per altro nemmeno ben sfruttati.
In questo modo le altre divisioni rosse della complessa manovra, trovandosi oltre il Donec con i fianchi scoperti e sotto i contrattacchi dei bianchi, furono costrette a ritornare sulle posizioni di partenza. Solo la 16a divisione rossa riuscì a trincerarsi sulle posizioni previste. Anche i minimi successi nel settore ovest della VIII Armata non riequilibrarono la situazione perché, dopo una breve avanzata, fu costretta a ripiegare dai contrattacchi della cavalleria di Škuro. I bianchi approfittarono di questa favorevole situazione per rigettare i rossi al di là del Donec, occupare Lugansk e da lì cercare di controllare il passaggio a nord del fiume. Furono però fermati dalla testa di ponte della VIII Armata che li colpiva ai fianchi da Kamenskaja.
Questa fu la prima pesante sconfitta, non solamente sul piano militare, dopo mesi di onerose offensive rosse nel Donbass. Trotzki impose a Gittis di organizzare il prima possibile un altro vasto attacco per riprendere Lugansk e penetrare a fondo nel Donbass.
La nuova offensiva prevedeva una manovra concentrica su Lugansk portata mediante un attacco frontale della VIII Armata, mentre la XIII, comprendente la consistente formazione anarchica di Macho, avrebbe attaccato il fianco dell’Armata dei Volontari da sud.
L’offensiva rossa il 15 maggio 1919 cacciò i bianchi da Lugansk e la XIII Armata in forze penetrò in profondità nel bacino del Donec fino alla stazione ferroviaria di Kutejny, a soli 40 chilometri a sud di Doneck.
Intanto più a sud una formazione di Machno con 10.000 uomini e 12 cannoni avanzò fino a soli 40 chilometri da Taganrog, al punto che Maj-Maevskij, comandante il fronte sud dei bianchi, considerando i vari sfondamenti subiti, fece accorciare la linea del fronte ripiegando verso Rostov. Questo anche perché doveva contrastare l’attacco dei rossi lanciati alla conquista di Odessa e dei porti ucraini sul Mar Nero. Erano comandati dal generale Nikifor Grigor’ev (Hryhoriv), infido, portato a cambiare bandiera allo scopo di creare un proprio potentato nel sud dell’Ucraina fuori dall’autorità bolscevica.
Il 6 aprile la sua formazione entrò in Odessa, abbandonata il giorno prima dalle truppe d’intervento francesi, esibendosi in saccheggi e violenze di ogni genere: per l’Armata Rossa quell’Atamano cosacco fu più un nemico che un alleato.
Sul Mar Nero ora la situazione era favorevole ai sovietici perché, dopo Odessa, altre truppe rosse il 10 aprile occupavano la penisola di Crimea.
I bianchi avevano combattuto in inferiorità numerica, patito ingenti perdite e non potevano contare su nuove forze di riserva prelevate da altri settori della controrivoluzione. Il celebre Reggimento d’assalto Kornilov, giunto all’inizio dell’anno sul bacino del Donec con 1.500 esperti combattenti, che in circa 6 mesi aveva sostenuto 57 battaglie e perso 3.303 uomini, più del doppio dei suoi effettivi originari.
Ma la potente e decisiva offensiva rossa, necessaria per completare lo sfondamento generale, non poté essere effettuata per la mancanza di adeguate riserve e per nuove criticità sopraggiunte.
Sul fronte orientale, contro l’offensiva di Kolčak alla massima intensità, si rese necessario incrementare le locali forze sovietiche con adeguate unità distolte dal fronte meridionale.
Lenin in un telegramma dell’8 maggio così raccomanda: «Dopo aver discusso della situazione critica, quasi catastrofica, nel bacino del Donec e sul Manyč, si sollecita insistentemente il Consiglio di difesa di Kiev ad accelerare e intensificare con ogni mezzo l’aiuto militare al bacino del Donec, a designare alcuni dei migliori compagni perché sorveglino giorno per giorno, ora per ora, l’attuazione delle misure di aiuto (...) infine a rendere Podvoiski e Antonov personalmente responsabili del gruppo di Machno. Rendetevi conto che se non si prende rapidamente Rostov la rivoluzione è ineluttabilmente perduta».
Denikin e il suo Stato maggiore percepirono che le operazioni sovietiche avevano subito un blocco e predisposero una controffensiva, iniziata il 19 maggio, quando la Cavalleria del Caucaso di Škuro riuscì a penetrare tra le Divisioni del fianco occidentale della XIII Armata riuscendo a ricacciare la brigata anarchica di Machno sulle precedenti posizioni.
Dopo l’incursione di Škuro, il generale controrivoluzionario Maj-Maevskij concentrò le sue unità contro il fianco destro sovietico riuscendo in una settimana ad avanzare prima su Doneck, poi prendere per la seconda volta Lugansk e giungere il 28 maggio fino a Bachmut. Durante questa offensiva per la prima volta nel conflitto 6 carri armati inglesi Mark V furono impiegati contro le linee della XIII Armata.
Questa, dopo gli ultimi eventi non rappresentò più una seria minaccia perché molto provata, fisicamente e nel morale, come anche le altre unità, perché dopo mesi di continue offensive non erano riuscite ad avere ragione dei bianchi, a occupare il Donbass e addirittura erano state ricacciate oltre il Donec.
La situazione peggiorava anche nel settore della IX Armata Rossa perché i bianchi dell’Armata del Don, dopo aver ripristinato i loro ranghi, attaccarono le difese sovietiche presso Dubovy sul Donec, riuscendo ad aprirsi un varco da cui, in assenza di un’efficace controffensiva, il 29 maggio, proseguendo verso nord raggiunsero e occuparono Millerovo. Da questa falla la Cavalleria del Don proseguì in direzione di Vešenskaja per portare sostegno ai locali cosacchi che si ribellavano all’autorità sovietica. Alla fine di maggio la IX Armata Rossa, spaccata in due tronconi e compromessa nelle retrovie dai cosacchi in rivolta, fu costretta a ritirarsi dall’intero fronte.
A controbilanciare, soprattutto nel morale, lo schieramento rosso va ricordata l’imprevista avanzata della X Armata Rossa nel settore orientale del fronte, posizionata in un settore periferico considerato stabile. Questa formazione era separata dalle altre armate e destinata a un eventuale contrasto all’Armata del Caucaso di Vrangel, stanziata oltre il fiume Manyč. Anche Denikin aveva concentrato le sue truppe più esperte sull’obiettivo principale sul Donec lasciando in quel settore le truppe di riserva di Vrangel.
Al comando della X Armata Rossa era stato recentemente assegnato A.I. Egorov. Di semplici origini contadine si era arruolato da giovane nell’esercito zarista in cui nel 1901 era divenuto ufficiale. Nel 1914 aderì al Partito Socialista Rivoluzionario e dalla presa del potere sovietico entrò nell’Armata Rossa, dove per le sue brillanti capacità raggiunse il più alto grado militare nel 1935 come Maresciallo dell’Unione Sovietica. I suoi uomini vedevano in Egorov l’esempio del comandante di semplici origini passato a difendere la rivoluzione proletaria. Fu uno dei tanti rivoluzionari della vecchia guardia fucilato durante le purghe staliniane.
Egorov, nonostante la carenza di munizioni e scarse possibilità di rifornimenti, aveva organizzato un’avanzata verso il sud di Rostov allo scopo di interporsi e tagliare in due il fronte bianco nel settore, separando i cosacchi del Don, a nord di Rostov, da quelli a sud, nel Kuban. Nonostante gli scarsi mezzi le sue formazioni riuscirono senza grandi intoppi a superare il fiume Manyč e le sue avanguardie a giungere a 40 chilometri da Rostov, dove era insediato il comando dello Stato Maggiore bianco.
Denikin fu costretto a spostare rapidamente dal Donbass il 1° Corpo di cavalleria del Kuban per difendere Rostov da est, dove erano ridotte forze di riserva e limitate formazioni di cavalleria per organizzare una valida controffensiva.
Questa situazione fece riemergere i continui e mai sopiti contrasti politici e di impostazione strategica del fronte sud tra Denikin, Comandante in capo, e Vrangel, Comandante dell’Armata dei Volontari. Quest’ultimo riteneva che la sua armata, spostata in massa in direzione della lontana Caricyn, senza consistenti trasferimenti di truppe dal Donbass, sarebbe stata respinta oltre il Don, esposta agli attacchi ai fianchi e sulle retrovie da ben quattro armate sovietiche. Vrangel, che cercava sostenitori tra i conservatori e i monarchici, considerava Denikin troppo liberale e disponibile verso le richieste dell’autonomia cosacca.
Il piano organizzato e guidato da Denikin invece prevedeva l’attacco frontale della sopraggiunta Cavalleria del Kuban, con il sostegno delle riserve locali, per ricacciare le truppe di Egorov oltre il Manič. Per colpire alle spalle i sovietici un distaccamento di cavalleria cosacca avrebbe guadato il fiume più a sud, anche per tagliare loro la via di fuga. L’azione cosacca riuscì e le truppe rosse furono costrette a ripiegare su Velikoknjazheskja (oggi Proletarsk) dove comunque riuscirono a concentrare la loro artiglieria.
Le successive fasi della controffensiva bianca furono poi dirette da Vrangel che riuscì a completare l’accerchiamento della X Armata Rossa, la quale si difese con onore in tre giorni di duri combattimenti, in cui fu anche ferito Egorov. Le sue truppe, che avevano vinto le battaglie di Caricyn, furono infine costrette ad abbandonare in fretta le loro posizioni sul Manič lasciando al nemico 55 cannoni, 100 mitragliatrici e 15.000 prigionieri.
Denikin, sull’onda di questa vittoria, progettò di riprendere subito l’offensiva per Caricyn. Vrangel stimò in tre settimane il tempo necessario alla sua cavalleria per giungere sull’obiettivo. Ma senza adeguata fanteria e artiglieria, che Denikin avrebbe dovuto fornire, era assolutamente impossibile organizzare un valido attacco.
A complicare la situazione per i rossi in quella delicata situazione, si riaccese la rivolta dell’atamano Grigor’ev, che aveva ben oltrepassato il limite dell’insubordinazione: con le sue truppe aveva disertato il fronte sovietico per unirsi ai Socialisti Rivoluzionari, creando grosse criticità politiche e militari nel Sud dell’Ucraina.
Questi i fatti. Il comando sovietico aveva ordinato all’Atamano ucraino di spostare le sue unità sul fronte rumeno. Durante il trasferimento Grigor’ev diffuse un articolato manifesto-proclama “Universale” con cui denunciava le promesse sovietiche non attuate sulla distribuzione delle terre, la requisizione forzate per l’esercito, la libertà negata dai soviet alla secolare tradizione religiosa ortodossa, il tutto intriso di acceso antisemitismo. Chiamava quindi gli ucraini alla rivolta con la promessa di convocare un soviet ucraino liberamente eletto.
Dopo vani tentativi di Antonov-Ovseenko di chiarimento con Grigor’ev, il quale invece millantava una inesistente presenza di delegati di Machno per una possibile alleanza nella rivolta, il cosacco fu denunciato pericoloso traditore. Antonov-Ovseenko, in quella critica situazione generale del fronte, dovette sganciare parte della II Armata per contrastare la formazione cosacca ribelle.
Trotzki il 16 maggio 1919 scrisse in “Le lezioni ucraine” sulla guerriglia e sul suo utilizzo nelle varie fasi della lotta rivoluzionaria: «In primo luogo bisogna stroncare l’assurda sommossa di Grigor’ev (...) Sarà tanto più dolorosa liquidarla in quanto è sopravvissuta troppo a lungo, vale a dire l’abbiamo lasciata vivere (...) È chiaro che, anche in queste circostanze, la guerriglia non è un principio, e nemmeno un vantaggio. Al contrario il proletariato rivoluzionario si sforza di strutturare al massimo la sua organizzazione militare superando nella misura del possibile il dilettantismo (...) L’armata della classe rivoluzionaria vittoriosa deve raggrupparsi attorno all’apparato di Stato per salvaguardarlo. Se conserva le caratteristiche della guerriglia finisce inevitabilmente per opporsi al governo. E una opposizione di franchi tiratori è sinonimo di sommossa armata (...) Il periodo della guerriglia è durato anche troppo in Ucraina. Perciò la sua liquidazione assume una svolta così drammatica. Adesso siamo costretti ad impiegare la forza. È indispensabile portare a termine questo compito. Bisogna farla finita con gli avventurieri, non soltanto a parole ma anche con i fatti; e cosa ancor più importante, bisogna soprattutto farla finita con l’avventurismo».
Ma i contadini cosacchi non insorsero e non si unirono alla rivolta di Grigor’ev, che fu militarmente sconfitto dalle truppe rosse in poche settimane. La falsa affermazione dell’Atamano sulla presenza dalla sua parte di delegati di Machno dette l’opportunità al comando sovietico di richiedere un chiarimento all’Armata Nera sulla sua fedeltà alla rivoluzione sovietica, che fu tempestivamente fornita dichiarando Grigor’ev traditore della rivoluzione. Per dileguare ogni dubbio sulla loro fedeltà verso il governo sovietico, gli anarchici, durante un loro congresso, presente Grigor’ev, denunciarono i suoi contatti con Denikin. Reagendo alle sue pesanti provocazioni lo uccisero insieme ai suoi fedeli accompagnatori.
Ciò nonostante, le contraddizioni col sistema sovietico centralizzatore riesplosero violentemente rompendo definitivamente la temporanea alleanza militare con l’Armata Nera. L’Armata Rossa, dopo aver sconfitto l’Armata Bianca, nel giugno 1920 riuscì a cacciare da Kiev i polacchi e i nazionalisti ucraini di Petljura, dipoi la II Armata ucraina di Antonov-Ovseenko fu inviata contro la loro base principale di Guljaj Pole. Dopo mesi di duri combattimenti, nell’agosto 1921, l’Armata Nera fu sconfitta e Machno, gravemente ferito, fuggì dall’Ucraina attraverso il confine rumeno. Dopo incredibili e dure vicissitudini fu esiliato in Francia, dove visse in povertà, con i postumi delle ferite subite nei combattimenti, malattie e tubercolosi. Morì in ospedale a Parigi nel 1934.
Come tutti i gruppi anarchici anche quello di Machno si era posto al di fuori e contro la dittatura del partito comunista in Russia, il quale, per garantirsi sicurezza politica e militare, vi aveva inserito numerosi commissari bolscevichi. Inoltre il comando sovietico, causa anche la generale carenza di armi e munizioni, aveva dotato gli anarchici di fucili italiani che usavano cartucce di non facile disponibilità, in modo che, in caso di ribellione, sarebbe stato semplice disarmarli.
Trotzki in “Le bande di Machno” del 2 giugno 1919 articolò una dura critica degli anarchici e del loro modo di operare, che considerava più pericolosi dei ribelli di Grigor’ev. «Al posto di un’economia organizzata in tutto il paese, in funzione di un’idea e di un piano comuni, e al posto di una sistematica ripartizione socialista dei beni indispensabili, gli accoliti di Machno tentano di stabilire il regno delle bande e dei clan: il bottino appartiene a colui che se ne è impossessato e può essere scambiato con ogni altra merce che gli manchi. Questo non è nemmeno uno scambio di merci, è un saccheggio organizzato. Gli accoliti di Machno gridano: “Abbasso il partito, abbasso i comunisti, viva i soviet senza-partito” (...) L’armata di Machno è il peggiore aspetto della guerriglia, anche se in essa vi sono numerosi buoni soldati. È impossibile trovare la minima traccia di disciplina o di ordine in questa “armata”. Le razioni alimentari, le uniformi, le riserve militari si accaparrano dove è possibile e si saccheggiano dove capita».
Il tentativo dell’Armata Rossa di ottenere con un assalto in forze la stabile conquista del bacino del Donec era dolorosamente fallito per una serie di concause. Determinante fu il considerevole aumento dell’esercito bianco, che nel marzo-aprile crebbe da 40.000 a 73.000 uomini, al comando dell’esperto generale Maj-Maevskij, che riuscirono a tenere testa alle nuove Armate rosse XIII e XIV, composte in gran parte dagli anarchici di Machno e dai comunisti ucraini. Questi, pur superiori di numero, non furono in grado di reagire efficacemente alle più esperte unità bianche.
Altro fattore fu il disgelo e l’espandersi delle aree inondate, che trasformarono strade e pianure in fango e acquitrini: frenavano gli attacchi dei reggimenti rossi mentre favorirono i bianchi attestati sulla difesa, che riuscirono così a respingere ben tre offensive. I controrivoluzionari nel maggio vennero a disporre di ulteriori rinforzi dovuti all’arruolamento forzato di nuove leve, frettolosamente addestrate.
Ma la causa principale del fallimento dell’offensiva rossa va individuata nelle rivolte cosacche di Grigor’ev nelle retrovie, che obbligarono il comando sovietico a distogliere truppe dal fronte.
Le forze di Denikin nel settore meridionale avevano recuperato territori su tutta la nuova linea: alla sinistra le unità, ulteriormente rinforzate, di Maj-Maevskij si erano attestate sulla linea Mariupol-Donec-Lugansk, controllando anche alcune teste di ponte oltre il Donec. Al centro l’Armata del Don di Sidorin aveva oltrepassato il Donec e giunta a Millerovo era entrata in contatto con i cosacchi ribelli dell’alto Don. Sulla destra Vrangel, con l’Armata dei Volontari del Caucaso, attraversando le steppe oltre il fiume Sal, risaliva verso Caricyn.
Questa situazione di netto vantaggio strategico, con i rossi in forte crisi, indusse Denikin e tutto il comando delle forze bianche a ritenere fosse giunto il momento per mettere in atto la “Direttiva Mosca” per l’assalto finale al centro del potere sovietico, mentre erano ancora aperti altri fronti presenti, dai Paesi Baltici alla Siberia.
Per fare una concessione all’attualità: siamo nel Donbass, le stesse terre oggi di nuovo contese fra Russia e imperialismi occidentali. Solo che allora combattevamo per la difesa del primo Stato proletario dall’assalto dei capitalismi, oggi per una spartizione delle ricchezze ucraine fra entrambi ladroni borghesi.
(continua al prossimo numero)
Le “fonti del reddito” esprimono i rapporti della produzione capitalistica nella sua forma più feticistica. La terra diventa così la fonte della rendita fondiaria, il capitale la fonte del profitto e il lavoro la fonte del salario. La distorsione reale si trova riprodotta nelle rappresentazioni degli agenti di questo modo di produzione. Gli economisti volgari traducono le rappresentazioni di coloro su cui poggia la produzione capitalistica in un linguaggio dottrinario, dal punto di vista della classe dominante, in modo apologetico.
Ma di queste forme il feticcio più completo è il capitale produttivo d’interesse. Qui abbiamo il punto di partenza originario del capitale – il denaro – la formula D-M-D’ ridotta ai suoi due estremi D-D’, denaro che crea più denaro.
La natura come fonte della rendita fondiaria è già abbastanza feticistica. Ma, per una amena confusione fra valore d’uso e valore di scambio, l’opinione comune ha ancora la scappatoia della forza produttiva della natura, che con un abracadabra si incarna nel proprietario fondiario.
Il lavoro come fonte del salario, partecipazione dell’operaio al suo prodotto determinata dalla forma specificamente sociale del lavoro, il lavoro come fonte del fatto che l’operaio, con il suo lavoro, compra il permesso di produrre. Su un punto, però, l’opinione comune concorda: pur confondendo il lavoro col lavoro salariato, perciò il prodotto del lavoro salariato – il salario – con il prodotto del lavoro, il buon senso tuttavia riconosce ancora che il lavoro stesso crea il suo salario.
Del capitale, considerato nel processo di produzione, resta sempre più o meno l’idea che sia uno strumento per pescare lavoro altrui. Nella misura in cui il capitale si manifesta nel processo di circolazione, e questo per la concezione ordinaria avviene soprattutto nel capitale commerciale, come una sorta di capitale incaricato di questa sola operazione, il profitto vi è accompagnato da un’oscura sensazione di truffa generale. Il profitto è qui spiegato in base allo scambio, un rapporto sociale, non in base a una cosa.
Invece nel capitale produttivo d’interesse il feticcio è completo. È il capitale concluso – unità del processo di produzione e circolazione – che in un determinato periodo di tempo frutta un determinato profitto. Nella forma del capitale produttivo d’interesse resta quest’unica determinazione, senza la mediazione del processo di produzione e circolazione. Nel capitale e nel profitto permane ancora il ricordo del loro passato, benché la diversità del profitto dal plusvalore e il profitto uniforme di tutti i capitali – il saggio generale del profitto – oscurino già molto il capitale. Nel capitale produttivo d’interesse questo feticcio è completo, è il valore che valorizza sé stesso, e in questa forma non porta più i segni della sua origine. Il rapporto sociale è rapporto della cosa con sé stessa.
Poiché, in base alla produzione capitalistica, una determinata somma di valore conferisce il potere di estrarre gratuitamente dagli operai una determinata quantità di lavoro, è chiaro che il denaro stesso può esser venduto come capitale, ma come una merce sui generis. Può essere venduto come fonte del profitto. Col denaro io permetto a un altro di appropriarsi di plusvalore. È quindi giustificato che io riceva una parte di tale plusvalore. Poiché nel processo capitalistico di produzione il valore del capitale si perpetua, è logico che, se si vende il denaro come capitale, esso dopo un certo periodo di tempo ritorni al venditore e che egli non lo alieni mai come fa con la merce, ma ne conservi la proprietà.
Il movimento caratteristico del capitale, tanto nel processo di produzione quanto nel processo di circolazione, è il ritorno del denaro o della merce al suo punto di partenza, al capitalista. Ciò esprime da un lato la metamorfosi reale, il fatto che la merce si trasforma nelle condizioni della sua produzione e le condizioni di produzione a loro volta tornano nella forma di merce: riproduzione. Dall’altro, la metamorfosi formale, il fatto che la merce si trasforma in denaro e il denaro a sua volta in merce. Infine la moltiplicazione del valore, D-M-D’. Il valore originario resta sempre nelle mani del medesimo capitalista, ma intanto nel processo si accresce.
Questo ritorno del capitale al suo punto di partenza riceve nel capitale produttivo d’interesse una figura del tutto esteriore, separata dal movimento reale di cui è forma. A spende il suo denaro non come denaro ma come capitale. Qui il denaro cambia solo di mano. La sua reale trasformazione in capitale si compie solo quando è nelle mani di B. Ma per A è diventato capitale col passaggio del denaro dalle mani di A in quelle di B. Il vero ritorno del capitale dai processi di produzione e di circolazione ha luogo per B. Ma per A il ritorno avviene allo stesso modo dell’alienazione. Dalle mani di B ritorna in quelle di A. Egli presta il denaro, invece di spenderlo. Lo spostamento del denaro, quando è prestato come capitale e quindi non viene trasformato in capitale ma entra come capitale nella circolazione, non esprime altro che trasferimento del medesimo denaro da una mano all’altra. Il titolo di proprietà resta nelle mani del prestatore, ma il possesso passa nelle mani del capitalista industriale. Per il prestatore la trasformazione del denaro in capitale inizia nel momento in cui, invece di spenderlo come denaro, lo spende come capitale, lo consegna nelle mani del capitalista industriale. È vero che l’altro lo trasforma in capitale, ma è una operazione che sta al di là di quella che si svolge fra colui che presta e colui che prende in prestito. Questa mediazione è cancellata. Invece della trasformazione reale del denaro in capitale qui appare solo la forma priva di contenuto di tale trasformazione. Come per la capacità lavorativa, il valore d’uso del denaro qui diventa quello di creare valore di scambio, un valore di scambio maggiore di quello in esso contenuto.
Nel profitto come tale è già offuscato e mistificato il plusvalore e, quindi, la sua fonte reale: 1) in quanto, dal punto di vista formale, il profitto è il plusvalore calcolato sull’intero capitale anticipato, costante e variabile, per cui ogni parte del capitale dà un profitto di uguale grandezza; 2) in quanto con la determinazione del saggio generale del profitto ogni capitale, in qualunque sfera operi, comunque si suddivida in capitale costante e capitale variabile, qualunque sia il suo periodo di rotazione ecc., dà nel medesimo periodo di tempo il medesimo profitto medio, come qualsiasi altro capitale di condizioni organiche completamente differenti. È su questa figura già esteriorizzata del plusvalore, distinta dalla sua prima forma semplice in cui mostra ancora il cordone ombelicale della nascita che si basa l’interesse. Esso presuppone immediatamente il profitto, non il plusvalore. Nell’interesse, quindi, il plusvalore è molto più irriconoscibile che nel profitto, poiché è solo sotto forma di profitto che esso si riferisce direttamente al plusvalore.
Il periodo di rotazione dipende dal processo reale di produzione. Nel capitale produttivo d’interesse il suo ritorno come capitale pare dipendere unicamente dalla convenzione fra colui che presta e colui che prende in prestito, di modo che, per effetto di questa transazione, il ritorno del capitale non appare più come un risultato determinato dal processo di produzione, ma è come se il capitale non perdesse neppure per un istante la forma di denaro. L’interesse, in quanto distinto dal profitto, rappresenta il valore della mera proprietà di capitale. È vero che le condizioni del lavoro sono capitale solo in quanto fungono, rispetto all’operaio, come sua non-proprietà, in contrapposizione al lavoro. L’esistenza antitetica di queste condizioni rispetto al lavoro fa del loro proprietario un capitalista e di queste condizioni da lui possedute un capitale. Il capitalista monetario A non si contrappone affatto all’operaio, ma solo ad un altro capitalista B. Ciò che egli vende, è effettivamente l’”uso” del denaro. Ma di fatto non è l’uso ciò che egli vende direttamente: egli cede la proprietà del denaro per un determinato periodo di tempo. Il suo denaro si manifesta quindi come capitale prima di essere alienato.
Mentre l’interesse non è che una parte del profitto classificata sotto un nome a sé, l’interesse appare qui come ciò che è inerente al capitale come tale, indipendentemente dal processo di produzione, e quindi alla mera proprietà di capitale, indipendentemente dai rapporti che danno a questa proprietà il carattere della proprietà capitalistica, perché la contrappongono al lavoro; l’interesse appare come una creazione di plusvalore inerente alla mera proprietà del capitale, e quindi il profitto industriale appare come una mera aggiunta che colui che prende in prestito il capitale realizza con l’impiego produttivo che ne fa. È l’interesse e non il profitto che appare come la creazione di valore del capitale che scaturisce dal capitale come tale, quindi come il reddito particolare creato dal capitale. È in questa forma, perciò, che lo concepiscono anche gli economisti volgari. In questa forma è cancellata ogni mediazione, e la figura di feticcio è compiuta. Per l’economista volgare, che vuole rappresentare il capitale come fonte autonoma del valore, la fonte del profitto non è più riconoscibile e in cui il risultato del processo capitalistico riceve un’esistenza autonoma. In D-M-D’ è ancora contenuta una mediazione. In D-D’ abbiamo la forma a-concettuale del capitale, la distorsione e reificazione del rapporto di produzione alla massima potenza.
Al saggio generale del profitto corrisponde un saggio generale dell’interesse. Il saggio generale del profitto appare come un fatto incomparabilmente meno solido che il saggio dell’interesse. Per alcuni anni il saggio del profitto in determinate sfere è più alto, negli anni seguenti è più basso. Considerando gli anni nel loro insieme ne risulterà un saggio del profitto medio. In questo modo, però, esso non si manifesta mai come un dato immediato, ma solo come la risultante di oscillazioni casuali.
Per il tasso d’interesse le cose stanno diversamente. Nella sua generalità è un fatto fissato quotidianamente, che al capitalista industriale serve perfino come un elemento di calcolo. Del tasso d’interesse sono piuttosto le deviazioni che appaiono come eccezioni motivate da circostanze particolari.
Le oscillazioni del saggio del profitto all’interno di ogni sfera dipendono dal livello di volta in volta dato dai prezzi di mercato e dalle loro oscillazioni intorno ai prezzi di costo. Se, in una sfera particolare, la caduta del saggio del profitto al di sotto della media ideale si prolunga, ciò è sufficiente per sottrarre capitale a questa sfera o a escludere l’offerta di nuovo capitale alla scala media. Infatti a compensare la ripartizione del capitale nelle singole sfere, più ancora che la distribuzione del capitale investito, contribuisce l’offerta del nuovo capitale aggiuntivo. Il sovrapprofitto delle singole sfere può esser riconosciuto solo confrontando i prezzi di mercato con i prezzi di costo. Appena la differenza si manifesta nell’uno o l’altro modo, si ha un’emigrazione e immigrazione dei capitali da e verso le sfere particolari. L’insieme è un movimento molto complicato, in cui bisogna tener conto tanto dei prezzi di mercato in ogni sfera particolare, dei prezzi di costo comparati delle differenti merci, dello stato della domanda e dell’offerta all’interno di ogni sfera, quanto della concorrenza dei capitalisti delle differenti sfere; e in cui la maggiore o minore rapidità della perequazione dipende dalla particolare composizione organica dei capitali e dalla natura particolare delle loro merci, a seconda che la loro natura di valori d’uso permetta un ritiro più o meno rapido dal mercato, una diminuzione o un aumento dell’offerta, secondo il livello dei prezzi di mercato.
Per il capitale monetario invece si contrappongono solo due specie di compratori e venditori. Da un lato la classe di capitalisti che prestano, dall’altro quella dei capitalisti che prendono a prestito. La merce ha la medesima forma: denaro. Tutte le forme particolari che il capitale assume a seconda della particolare sfera di produzione o di circolazione in cui è investito sono qui cancellate. La concorrenza delle sfere particolari qui cessa: sono tutte raggruppate in quanto tutte prendono a prestito, e il capitale si contrappone ad esse nella forma in cui è ancora indifferente alle forme del suo impiego.
Quell’aspetto del capitale produttivo che si manifesta solo nel movimento e nella concorrenza fra le sfere particolari, di essere cioè il capitale comune della classe dei capitalisti, qui si presenta realmente, con tutto il suo peso, nella domanda di capitale. A ciò si aggiunge il fatto che con lo sviluppo della grande industria il capitale monetario, in quanto si presenti sul mercato, è sempre meno rappresentato dal singolo capitalista, ma si concentra e, in un modo del tutto diverso della produzione reale, si presenta come il controllo dei banchieri che rappresentano il capitale. Di modo che la domanda corrisponde al peso di una classe; l’offerta si rappresenta come massa del capitale prestabile.
Il denaro come forma modificata della merce era ciò da cui siamo partiti; il denaro come forma modificata del capitale è ciò a cui perveniamo; come merce è il presupposto e il risultato del processo di produzione del capitale.
In questa sua figura, più strana e nello stesso tempo la più vicina all’immagine più diffusa, il capitale è tanto la “forma fondamentale” degli economisti volgari quanto il primo punto d’attacco di una critica superficiale.
La polemica degli economisti borghesi del XVIII secolo contro l’interesse come forma autonoma del plusvalore è la lotta della nascente borghesia industriale contro gli usurai di vecchio stampo. Il capitale produttivo d’interesse qui è ancora una forma antidiluviana del capitale, che dev’essere ancora subordinata al capitale industriale e riceverne quella posizione dipendente che è destinata ad occupare teoricamente e praticamente sulla base della produzione capitalistica.
Il socialismo rivolto contro il capitale produttivo d’interesse come “forma
fondamentale” del capitale è quindi non solo del tutto chiuso nell’orizzonte
borghese, ma, nella misura in cui la sua polemica non è un attacco e una critica
al processo di produzione capitalistico, non è altro che una pressione in favore
dello sviluppo del credito borghese, e quindi esprime unicamente la situazione
di sottosviluppo dei rapporti nel Paese in cui tale polemica si atteggia a
socialismo.
5.2. - Il capitale produttivo d’interesse e il capitale commerciale
nel loro rapporto col capitale industriale
Benché la forma commerciale e quella dell’interesse siano anteriori a quella della produzione capitalistica, di fronte al capitale industriale, forma fondamentale del rapporto capitalistico che regge la società borghese, le altre forme appaiono solo come derivate o secondarie. Derivate, come il capitale produttivo d’interesse; secondarie, cioè di capitale in una funzione particolare, come quello commerciale. Il capitale industriale deve prima sottomettersi queste forme e trasformarle in funzioni derivate o particolari di sé stesso. Quando nasce e si forma, trova queste forme più antiche. Le trova come presupposti. Come in origine trova la merce, ma non come suo prodotto, e come trova la circolazione monetaria, ma non come un momento della sua propria riproduzione.
Quando la produzione capitalistica si è sviluppata nell’ampiezza delle sue forme ed è il modo di produzione dominante, il capitale produttivo d’interesse è dominato dal capitale industriale, e il capitale commerciale non è che una figura, derivata dal processo di circolazione, del capitale industriale stesso.
Storicamente contro il capitale produttivo d’interesse si è impiegata la violenza dello Stato, per una forzata riduzione del tasso d’interesse, di modo che non potesse più dettare i termini al capitale industriale. Questa, però, è una forma che appartiene agli stadi meno sviluppati della produzione capitalistica. La vera maniera del capitale industriale di sottometterselo è la creazione di una forma che gli è peculiare: il sistema creditizio.
Diverse sono le forme in cui il capitale commerciale venne subordinato al capitale industriale. Il mercante, invece di comprare la merce, iniziò a comprare lavoro salariato, con cui produceva la merce destinata ad essere venduta. È in questo modo che la manifattura lottò contro le corporazioni medievali e che delimitò l’ambito dell’artigianato. Questa trasformazione del mercante in capitalista industriale è nello stesso tempo trasformazione del capitale commerciale in mera forma di quello industriale. In origine il commercio è il presupposto della trasformazione del lavoro corporativo, del lavoro a domicilio delle campagne e del lavoro agricolo feudale in produzione capitalistica. Trasforma il prodotto in merce, sia creando un mercato, sia offrendo alla produzione nuovi equivalenti di merci e nuovi materiali e inaugurando così modi di produzione che si basano fin da principio sul commercio, tanto sulla produzione per il mercato quanto su elementi della produzione che provengono dal mercato mondiale. Appena la manifattura si è sufficientemente rafforzata, e più ancora come grande industria, crea il mercato, lo conquista e si apre, in parte con la violenza, nuovi mercati che poi però conquista con le sue stesse merci. D’ora in poi, il commercio è soltanto il servo della produzione industriale, per la quale il costante allargamento del mercato è diventato una condizione vitale, in quanto la produzione di massa sempre più ampia, che non è limitata dalla dimensione del commercio ma soltanto dalla grandezza del capitale e dallo sviluppo della forza produttiva del lavoro, inonda costantemente il mercato e quindi agisce costantemente nel senso di un allargamento e spostamento dei suoi confini.
La formazione del capitale produttivo d’interesse, la sua separazione dal capitale industriale, è un prodotto necessario dello sviluppo del capitale industriale. Il denaro – o le condizioni della produzione nelle quali può essere trasformato e di cui non è che la forma modificata, impiegata come capitale – comanda una determinata quantità di lavoro, lavoro necessario pagato più pluslavoro. Nello scambio con il lavoro non solo riceve il suo valore ma lo accresce. Sulla base della produzione capitalistica è solo il diverso impiego del denaro che fa sì che venga speso come denaro o come capitale. Sulla base della produzione capitalistica, il denaro è in sé capitale (proprio come la capacità lavorativa è in sé lavoro) perché 1) può essere trasformato nelle condizioni della produzione e, così com’è, è soltanto la loro espressione astratta, la loro esistenza come valore, e 2) gli elementi oggettivi della ricchezza posseggono in sé la proprietà di essere capitale, poiché la loro antitesi, il lavoro salariato, ciò che li rende capitale, è presente come base della produzione sociale.
Anche la rendita è solo un nome per una parte del plusvalore che il capitalista industriale deve cedere, come l’interesse è un’altra parte del plusvalore che egli, sì, intasca, come la rendita, ma ha da pagare a una terza persona. Ma qui sta la differenza: attraverso la proprietà fondiaria il proprietario fondiario impedisce al capitale di adeguare i valori dei prodotti agricoli ai loro prezzi di costo. Il monopolio della proprietà fondiaria glielo permette. Nella misura in cui si tratta della rendita differenziale gli permette di incassare l’eccedenza del valore di mercato sul valore individuale del prodotto di un determinato terreno; e così questa differenza non finisce invece, come nei settori non agricoli, come plusprofitto nelle tasche di quei capitalisti che lavorano in condizioni più favorevoli. La proprietà fondiaria è un mezzo per sottrarre parte del plusvalore prodotto dal capitale industriale.
L’eliminazione della proprietà fondiaria nel senso di Ricardo, la sua
trasformazione in proprietà statale cosicché la rendita venga pagata allo Stato
invece che al proprietario del fondo, è l’ideale intimo che scaturisce
dall’essenza più profonda del capitale. Il capitale non può eliminare la
proprietà fondiaria; ma, tramite la sua trasformazione in rendita pagata allo
Stato, se ne impadronisce come classe. L’eliminazione dell’interesse e del
capitale produttivo d’interesse sarebbe invece eliminazione del capitale e della
produzione capitalistica. Il capitale che produce interesse e quello che produce
profitto non sono due capitali differenti, ma il medesimo che funge come
capitale nel processo, produce un profitto che si distribuisce fra due
capitalisti differenti: quello che sta al di fuori del processo e che, come
proprietario, rappresenta il capitale in sé, e quello che rappresenta il
capitale in funzione, il capitale che si trova nel processo.
5.3. - Rapporto fra interesse e profitto industriale
L’ulteriore autonomizzazione della divisione del profitto si rivela nel sintomo che il profitto di ogni capitale si scompone in due componenti reciprocamente indipendenti: l’interesse e il profitto industriale. Se il saggio del profitto è uguale al 15%, e il saggio d’interesse al 5%, il capitalista – anche quando è il proprietario del capitale – fa sempre come se di questi 15%, 5% rappresentassero l’interesse del suo capitale e invece il profitto realizzato con l’impiego produttivo del capitale fosse solo del 10%. L’”interesse” è il frutto del capitale in quanto non “lavora”, e il profitto è il frutto del capitale che “lavora”. Che un capitalista produca con capitale proprio o altrui, o quale sia la proporzione fra il capitale proprio e il capitale altrui è indifferente.
Come mai allora questa divisione del profitto in profitto industriale e interesse non appare come una divisione accidentale? Alla base qui sta un momento reale. Il denaro si appropria di un plusvalore solo perché è già presupposto come capitale prima del processo di produzione. Nel processo si conserva, e si riproduce come capitale, e su scala sempre più larga. Ma già prima del processo – una volta dato il modo di produzione capitalistico, quando si lavora su questa base ed entro i rapporti sociali che vi corrispondono – esiste come capitale in sé, dal punto di vista delle caratteristiche, che però si realizzano solo nel processo.
È come col denaro. La moneta è un pezzo di metallo. È denaro solo per la sua funzione nel processo di circolazione. Ma una volta presupposto il processo di circolazione delle merci, la moneta non funge soltanto come denaro, ma è presupposta come tale in ogni singolo caso del processo di circolazione, prima che vi entri. Il capitale non è soltanto il risultato, ma il presupposto della produzione capitalistica. Il denaro e le merci sono in sé capitale latente: tutte le merci, in quanto sono convertibili in denaro, il denaro, in quanto è convertibile in quelle merci che costituiscono gli elementi del processo capitalistico di produzione. L’interesse appare quindi come il plusvalore dovuto al capitale in quanto capitale, alla sua mera proprietà; mentre il profitto industriale, parte del plusvalore, spetta al capitalista come possessore del capitale in funzione. Come ogni cosa in questo modo di produzione si rappresenta in modo distorto, così abbiamo l’ultima distorsione nel rapporto fra interesse e profitto, per cui la parte del profitto accantonata sotto una rubrica speciale (interesse) si rappresenta come il prodotto più proprio del capitale, e il profitto industriale come mera aggiunta innestata su questo.
Poiché il capitalista monetario ottiene la sua parte di plusvalore solo in quanto è il proprietario del capitale, mentre rimane al di fuori del processo di produzione; poiché il prezzo del capitale, del mero titolo di proprietà, è quotato sul mercato monetario nel saggio d’interesse, come il prezzo di mercato di ogni altra merce; poiché la quota di plusvalore, a cui dà diritto il capitale in sé è una grandezza data, mentre il saggio del profitto varia in ogni istante nelle diverse sfere e in ogni sfera varia fra i singoli capitalisti sia perché producono in condizioni diversamente favorevoli sia perché sfruttano il lavoro capitalisticamente con un diverso grado di accortezza e di energia sia perché truffano i compratori o venditori di merci con un diverso grado di fortuna e scaltrezza, agli industriali, siano o no proprietari del capitale che si trova nel processo, l’interesse appare come dovuto al capitale come tale; mentre il profitto industriale appare come il prodotto del loro lavoro.
Mentre il capitale produttivo d’interesse esprime l’antitesi fra la ricchezza oggettiva e il lavoro, e quindi con la sua esistenza come capitale, nella rappresentazione si ha l’esatto capovolgimento, che il capitalista monetario non ha alcun rapporto con l’operaio salariato, ma solo con altri capitalisti.
A ciò si aggiunge il fatto che il singolo capitalista industriale può prestare il denaro per valorizzarlo egli stesso come capitale. Nella misura in cui ne ritrae un interesse, non fa che riceverne il prezzo, pur non funzionando come industriale. Di qui la bella frase di alcuni economisti volgari: se il capitalista industriale, oltre all’interesse, non ricavasse un profitto, presterebbe a interesse il suo capitale e vivrebbe di rendita. Cosicché tutti i capitalisti cesserebbero di produrre e tutto il capitale cesserebbe di fungere come capitale e tuttavia si potrebbe vivere dei suoi interessi!
Potrebbe sembrare che nella trinità terra-rendita, capitale-profitto (interesse),
lavoro-salario, l’ultimo membro sia quello più razionale. È almeno espressa la
fonte da cui scaturisce il salario. Ma è piuttosto la più irrazionale. Il lavoro
è lavoro salariato solo quando le sue condizioni gli si contrappongono in questa
forma. Il lavoro salariato presuppone la terra come proprietà fondiaria e il
prodotto come capitale. Poiché il salario qui appare come il prodotto specifico
del lavoro, come l’unico suo prodotto, appare altrettanto necessario che le
altre parti del valore – la rendita, il profitto (l’interesse) – scaturiscano da
altre fonti specifiche. Proprio come la parte del valore del prodotto che si
risolve in salario dev’essere concepita come prodotto specifico del lavoro, le
parti del valore che si risolvono in rendita e profitto devono essere concepite
come risultati specifici degli agenti per cui sono rampollo rispettivamente
della terra e del capitale.
5.4. - Crescente distacco delle forme modificate del plusvalore
dalla sua essenza: il pluslavoro
Analizziamo il cammino che il capitale percorre prima di manifestarsi nella forma di capitale produttivo d’interesse. Nel processo di produzione la cosa è semplice. Il plusvalore non ha ancora assunto alcuna forma particolare. Come il valore in generale si risolve in lavoro, così il plusvalore è misurato unicamente da quella parte del capitale che modifica realmente il proprio valore, il capitale variabile. In questo stato embrionale il rapporto è ancora comprensibile. L’unica difficoltà consiste nello scoprire in che modo questa appropriazione di lavoro senza equivalente derivi dalla legge dello scambio delle merci – dal fatto che le merci si scambiano in rapporto al tempo di lavoro in esse contenuto – e in un primo momento non contraddica questa legge.
Il processo di circolazione già cancella l’equivalenza. Poiché la massa del plusvalore si realizza anche col tempo di circolazione, sembra che s’introduca un elemento estraneo al tempo di lavoro. Nel capitale compiuto – unità del processo di circolazione e produzione, come una determinata somma di valore che, in un determinato spazio di tempo, in un determinato segmento di circolazione, produce un determinato profitto – il processo di produzione e circolazione esistono solo come momenti che realizzano entrambi il plusvalore, velando la sua natura semplice. Il plusvalore adesso appare come profitto: 1) è riferito a una rotazione del capitale, che è differente dal tempo di lavoro; 2) il plusvalore è calcolato e riferito non alla parte del capitale da cui immediatamente deriva (variabile), ma indistintamente all’intero capitale; 3) benché in questa prima forma del profitto la sua massa sia ancora quantitativamente identica alla massa del plusvalore prodotto dal singolo capitale, il saggio del profitto è differente dal saggio del plusvalore, essendo il saggio del plusvalore = p / v e il saggio del profitto = p / (c + v); 4) presupponendo come dato il saggio del plusvalore, il saggio del profitto può salire o scendere, perfino in senso contrario al saggio del plusvalore.
Con la trasformazione del profitto in profitto medio, con la formazione del saggio generale del profitto e la trasformazione dei valori in prezzi di costo, il profitto del singolo capitale viene a differenziarsi – non solo nell’espressione, come differenza del saggio del profitto dal saggio del plusvalore, ma anche nella quantità – dal plusvalore che il singolo capitale ha prodotto nella sua particolare sfera. Se si considera il capitale complessivo di una sfera particolare, il profitto non solo sembra ma è differente dal plusvalore. Capitali di ugual grandezza forniscono profitti uguali. Il profitto è determinato dal valore del capitale anticipato.
In tutte queste espressioni, il rapporto fra il profitto e la composizione organica del capitale è cancellato. In questa forma estraniata del profitto, e nella misura in cui la figura del profitto ne nasconde il nocciolo interno, il capitale assume una figura sempre più materiale, da un rapporto si trasforma sempre più in una cosa, ma in una cosa che ha incorporato il rapporto sociale, una cosa che si rapporta a sé stessa con una vita e un’autonomia fittizie, un essere sensibilmente sovrasensibile; e in questa forma di capitale e di profitto appare alla superficie come un compiuto presupposto. Ed è la forma in cui vive nella coscienza dei suoi portatori, i capitalisti.
Questa forma metamorfizzata del profitto è ulteriormente rafforzata nel suo aspetto esteriore dal fatto che lo stesso processo di perequazione del capitale, che dà al profitto questa forma di profitto medio, ne stacca una parte sotto forma di rendita, come se fosse indipendente e cresciuta su un altro suolo, la terra. È vero che in origine la rendita si presenta come una parte del profitto che il capitalista agricolo paga al proprietario fondiario. Ma poiché il primo non intasca questo plusprofitto e poiché il capitale che egli impiega non si differenzia come capitale da un altro capitale, la terra appare come la fonte di questa parte del valore della merce e il proprietario fondiario sembra solo rappresentare la terra come personalità giuridica.
Se la rendita è calcolata in base al capitale anticipato, resta un filo che ne ricorda l’origine, come una parte separata del profitto, quindi del plusvalore. Ma la rendita vien pagata per una determinata quantità di terreno; è capitalizzata nel valore del terreno; questo valore sale o scende in rapporto alla superficie che resta invariata (mentre il capitale che opera su di essa è una grandezza variabile); la rendita, come ogni figura creata dalla produzione capitalistica, appare nello stesso tempo come un presupposto fisso per il singolo. Il fatto di calcolare la rendita in base al capitale industriale è ancora una formula critica dell’economia politica, che mantiene l’intima connessione della rendita con il profitto come suo fondamento. Ma nella realtà questa connessione non si manifesta, la rendita si misura sul terreno effettivo: tanti metri quadri di terreno danno tanto di rendita. In quest’espressione, in cui una parte del plusvalore – la rendita – si rappresenta in rapporto a un particolare elemento naturale, indipendentemente dal lavoro umano, non solo la natura del plusvalore è cancellata, perché vi è cancellata quella del valore, ma adesso il profitto appare dovuto al capitale come a un particolare elemento oggettivo della produzione, come la rendita appare dovuta alla terra.
La rendita fondiaria, e il rapporto terra-rendita, possono apparire come una forma più misteriosa che quella dell’interesse. Ma nella forma della rendita fondiaria, l’irrazionale non è espresso in rapporto del capitale stesso: poiché la terra è produttiva di valori d’uso si può confondere il valore d’uso e il valore di scambio, la cosa con una forma specificamente sociale del lavoro contenuto nel prodotto; e allora l’irrazionale trova un fondamento in sé stessa, assumendo che la rendita non abbia niente a che fare con il processo capitalistico.
Nel caso del capitale produttivo d’interesse le cose stanno diversamente. Qui non si tratta di un rapporto estraneo al capitale, ma di un rapporto che scaturisce dalla produzione capitalistica e le è specifico. Il profitto implica un riferimento al capitale in processo, al processo in cui vien generato il plusvalore. Nell’interesse la sua forma estraniata è espressamente posta, presente ed enunciata come essenziale. È resa autonoma e fissata nella sua contrapposizione alla vera natura del plusvalore. L’interesse spetta al capitale in quanto capitale. Il capitale non tira fuori l’interesse dal processo di produzione, ma ve lo introduce. L’eccedenza del profitto sull’interesse – la quantità di plusvalore che il capitale deve unicamente al processo di produzione – ottiene, nei confronti dell’interesse come creazione di valore inerente al capitale in sé, una figura particolare come profitto industriale.
In tal modo la forma del plusvalore viene isolata e concepita in una forma
estraniata e con ciò la natura del capitale e del plusvalore, come della
produzione capitalistica, viene mistificata. Il profitto industriale, in
antitesi all’interesse, rappresenta il capitale nel processo in antitesi al
capitale al di fuori del processo, e quindi il capitalista come capitalista in
funzione, come rappresentante del capitale attivo, in antitesi al capitalista
come mera personificazione del capitale. Egli così appare come capitalista
attivo contrapposto a sé stesso come capitalista, e quindi come lavoratore
contrapposto a sé stesso come mero proprietario. Il profitto industriale è
risolto in lavoro, ma non in lavoro non pagato altrui, bensì in lavoro salariato,
in salario per il capitale, che viene accomunato all’operaio salariato, con
l’unica differenza che è una specie meglio pagata di salariato.
5.5. - Differenza essenziale fra l’economia classica e l’economia volgare
L’economia classica vuol comprendere il nesso interiore nella molteplicità delle forme di manifestazione. Perciò riduce la rendita a sovrapprofitto, e così quella cessa di esistere come fonte particolare e vien separata dalla sua fonte apparente, il suolo. Allo stesso modo spoglia l’interesse della sua forma autonoma e rivela che è una parte del profitto. In questo modo ha ridotto tutte le forme di reddito e tutte le figure autonome, tutti i titoli con cui il non lavoratore partecipa al valore della merce, all’unica forma del profitto. Questo si risolve in plusvalore, poiché il valore dell’intera merce si risolve in lavoro; la quantità pagata del lavoro in essa contenuto si risolve in salario, e quindi l’eccedenza si risolve in lavoro non pagato.
L’economia classica occasionalmente si contraddice; cerca spesso di intraprendere la riduzione e di dimostrare immediatamente l’identità della sorgente delle differenti forme, senza gli anelli intermedi. Ma questo deriva dal suo metodo analitico col quale devono cominciare la critica e la comprensione. L’economia classica ha infine il difetto di concepire la forma fondamentale del capitale, la produzione rivolta all’appropriazione di lavoro altrui, non come forma storica, ma naturale della produzione sociale, concezione alla cui eliminazione essa apre la strada con la sua stessa analisi.
Diversamente stanno le cose per l’economia volgare la quale si fa largo solo quando l’economia con la sua analisi ha già dissolto i propri presupposti, e quindi l’opposizione all’economia esiste già. Infatti lo sviluppo dell’economia politica e dell’opposizione da essa stessa creata va di pari passo con lo sviluppo reale degli antagonismi sociali e delle lotte di classe presenti nella produzione capitalistica. Solo quando l’economia politica ha raggiunto una certa ampiezza di sviluppo e si è data forme stabili, quella sua componente, che non è altro che la rappresentazione dell’apparenza, la sua componente volgare, se ne stacca come esposizione particolare dell’economia. Così in Say la separazione delle concezioni volgari che si incontrano in Smith è fissata come cristallizzazione a sé stante. Anche da Ricardo e dallo sviluppo da lui consolidato dell’economia, l’economista volgare riceve nuovo alimento e quanto più l’economia giunge a compimento, e quindi penetra in profondità e si sviluppa come un sistema dell’opposizione, tanto più autonomamente le si contrappone la sua propria componente volgare, arricchita di materiale che accomoda a modo suo, finché trova la sua migliore espressione in una compilazione di un sincretismo erudito e un eclettismo senza carattere.
L’ultima forma è la forma professorale, che procede “storicamente” e, con saggia moderazione, raccoglie qua e là “il meglio”, senza badare a contraddizioni. Il calore dell’apologetica è temperato qui dall’erudizione che osserva con superiorità le esagerazioni dei pensatori economici e le tollera solo come curiosità che galleggiano nella sua mediocre poltiglia. Poiché lavori di questo genere appaiono solo quando si chiude il cerchio dell’economia politica come scienza, sono nello stesso tempo le tombe di questa scienza.
Mentre la forma dell’estraniazione dà da fare agli economisti classici, ed essi tentano di disfarsene con l’analisi, l’economia volgare si sente invece a suo agio soltanto nell’estraneità in cui si contrappongono le differenti partecipazioni al valore; come uno scolastico si trova a suo agio in Dio-Padre, Dio-Figlio e Dio-Spirito Santo, così l’economista volgare in terra-rendita, capitale-interesse e lavoro-salario. È questa la forma in cui tali rapporti sembrano immediatamente connessi, ed è in questa forma che vivono nelle idee degli agenti della produzione capitalistica. L’economia volgare ritiene di essere tanto più semplice quanto più si limita a tradurre le idee ordinarie in un linguaggio dottrinario. Quindi, quanto più estraniata è la forma in cui concepisce le configurazioni della produzione capitalistica, tanto più si avvicina all’elemento della rappresentazione comune, tanto più si muove nel suo elemento naturale.
Nel processo capitalistico ogni elemento, perfino il più semplice, come per esempio la merce, costituisce già un rovesciamento e fa già apparire i rapporti fra uomini come proprietà di cose, e come rapporti fra uomini le proprietà sociali di queste cose.
L’interesse non è che una parte del profitto, pagata dal capitalista industriale in funzione al proprietario del capitale. Poiché egli può appropriarsi di pluslavoro solo mediante capitale, ne cede una parte a colui che gli procura questo mezzo. E quest’ultimo, che vuole godere del denaro come capitale senza lasciarlo funzionare come capitale, può farlo unicamente accontentandosi di una parte del profitto. Non c’è niente di misterioso nel fatto che il valore della merce si risolva in parte nel valore del lavoro, in parte in lavoro non pagato, e che la parte del suo valore che consta di lavoro non pagato si risolva in interesse, profitto industriale e rendita, che l’immediato accaparratore di questo plusvalore complessivo ne debba cedere delle parti e tenga così per sé la terza parte, sotto un nome distinto. L’analisi del plusvalore, cioè di una parte del valore delle merci, in queste rubriche non contraddice la legge stessa del valore.
Il tutto viene però mistificato dalla forma autonoma raggiunta da queste differenti parti del plusvalore, dalla diversità delle persone a cui affluiscono, dalla diversità degli elementi su cui si fonda il loro titolo di proprietà, e infine dall’autonomia con cui alcune di queste parti si contrappongono e condizionano il processo di produzione. Da parti in cui si può scomporre il valore, si trasformano in elementi autonomi che lo costituiscono. Essi lo sono per il prezzo di mercato; diventano realmente gli elementi costitutivi di esso. Il modo in cui questa loro apparente indipendenza come condizione del processo sia a sua volta regolata dalla legge intrinseca e come siano solo apparentemente indipendenti, non giunge a manifestarsi in alcun istante del processo di produzione né opera come motivo determinante.
È quanto avviene con l’interesse e la rendita. Essi fanno parte delle anticipazioni del capitalista industriale e agricolo. Qui non appaiono più come espressione di un pluslavoro non pagato, ma di un pluslavoro pagato, per il quale è stato pagato un equivalente nel processo di produzione, non all’operaio di cui è il pluslavoro, ma ad altre persone. Non appaiono quindi come surplus e tanto meno come pluslavoro, bensì come prezzi della merce “capitale” e della merce “terra”. La parte del valore della merce che si risolve in interesse appare quindi come riproduzione del prezzo pagato per il capitale, e la parte che si risolve in rendita come riproduzione del prezzo pagato per la terra. Questi prezzi formano quindi le parti costitutive del prezzo complessivo.
Ciò non soltanto pare così al capitalista industriale; per lui questi prezzi costituiscono effettivamente una parte delle sue anticipazioni, e se da un lato sono determinati dal prezzo di mercato della sua merce, il prezzo di mercato, è, d’altro canto, determinato da essi. Poiché parti del plusvalore, l’interesse e la rendita, entrano nel processo di produzione come prezzi di merci, esistono in una forma che non solo vela ma rinnega la loro vera origine. Il fatto che il pluslavoro entra nel processo capitalistico di produzione come parte altrettanto essenziale quanto il lavoro pagato, qui appare come se elementi produttivi distinti dal lavoro – la terra e il capitale – dovessero esser pagati o come se nel prezzo entrassero costi distinti dal prezzo delle merci anticipate e dal salario. Parti del plusvalore appaiono qui come anticipazioni del capitalista.
Gli agenti della produzione capitalistica vivono in un mondo stregato, e le loro relazioni appaiono loro come proprietà delle cose. Ma è nelle forme estreme, le più mediate – in cui non solo è diventata invisibile la mediazione, ma è espresso il suo diretto contrario – che le figure del capitale appaiono come veri agenti e portatori immediati della produzione. Il capitale produttivo d’interesse è personificato nel capitalista monetario, quello industriale nel capitalista industriale, il capitale produttivo di rendita nel capitalista fondiario e il lavoro nell’operaio salariato. Con quest’aspetto, come figure fisse, personificate in personalità autonome, che appaiono come meri rappresentanti di oggetti personificati, entrano nella concorrenza e nel reale processo di produzione. La concorrenza presuppone questa esteriorizzazione. Sono le forme che le sono consone, naturali e storiche, e nella sua manifestazione superficiale è il movimento di questo mondo capovolto.
Smith risolve dapprima il valore in salario, profitto (interesse) e rendita, poi, al contrario, rappresenta questi come elementi costitutivi autonomi dei prezzi delle merci. Nella prima versione egli esprime il nesso recondito, nella seconda il fenomeno. Ricardo è contrario al fatto che Smith consideri il valore come costituito dalle sue parti. Ma non è coerente. Altrimenti non potrebbe discutere con Smith sulla questione se il profitto, il salario e la rendita o come afferma lui, soltanto il profitto e il salario entrino nel prezzo come elementi costitutivi. Vi entrano analiticamente, non appena sono pagati. Dovrebbe dire: il prezzo di ogni merce può essere risolto in profitto e salario; il prezzo di alcune merci può esser risolto in profitto, rendita e salario. Ma essi non costituiscono il prezzo di nessuna merce, poiché non compongono il valore delle merci come potenze autonome di determinata grandezza, bensì, se il valore è dato, esso può essere scomposto in quelle parti secondo proporzioni molto differenti. Il profitto, il salario e la rendita non sono potenze date la cui addizione determini la grandezza del valore, ma è la stessa grandezza di valore, una data grandezza del valore, che si risolve in salario, profitto e rendita e, a seconda delle circostanze, si distribuisce in maniera diversa fra queste 3 categorie.
Poniamo che il processo di produzione si ripeta costantemente nelle medesime condizioni, che la riproduzione avvenga nelle medesime condizioni che la produzione, il che presuppone che la produttività del lavoro rimanga uguale o che le variazioni nella produttività non alterino i rapporti degli agenti della produzione; teoricamente non sarebbe esatto dire che le differenti parti del valore determinano il valore complessivo, ma sarebbe pratico e giusto dire che esse lo costituiscono, se si intende la formazione dell’intero mediante l’addizione delle parti. Il valore si distribuirebbe uniformemente, costantemente, in valore del capitale anticipato e plusvalore; e il nuovo valore creato si risolverebbe uniformemente in salario e profitto; il profitto si scomporrebbe uniformemente in interesse, profitto industriale e rendita.
Questa uniformità della riproduzione non ha luogo. La produttività si modifica e modifica le condizioni. Le condizioni modificano la produttività. Ma le deviazioni si rivelano in parte in oscillazioni superficiali che si compensano in breve termine, in parte in un graduale accumularsi di deviazioni che conducono a una crisi, a una violenta e apparente riduzione ai vecchi rapporti, oppure vengono riconosciute e si impongono solo molto gradualmente come una modificazione delle condizioni.
Nella forma di interesse e di rendita, in cui il plusvalore si ripartisce, si presuppone che il carattere generale della riproduzione resti lo stesso. E questo avviene finché dura il modo capitalistico di produzione. In secondo luogo si presuppone che per un determinato periodo di tempo i determinati rapporti di questo modo di produzione restino gli stessi. Così il risultato della produzione si fissa come condizione stabile, e quindi presupposta, della produzione, e in particolare come qualità stabile delle condizioni oggettive di produzione. Sono le crisi che pongono termine a questa parvenza di autonomia dei differenti elementi in cui il processo di produzione costantemente si risolve e che costantemente riproduce.
Il capitale produttivo d’interesse riceve nel credito la forma peculiare della produzione capitalistica e ad essa corrispondente. È una forma creata dal modo capitalistico di produzione. La perequazione dei valori a prezzi di costo avviene in quanto il singolo capitale funge come parte aliquota del capitale complessivo della classe e, d’altra parte, il capitale complessivo della classe si distribuisce fra le differenti singole sfere a seconda delle esigenze della produzione. Ciò avviene per mezzo del credito. Esso non solo rende possibile e facilita questa perequazione, ma grazie ad esso una parte del capitale – sotto forma di capitale monetario – appare di fatto come il materiale comune con cui opera l’intera classe. E questo è il primo senso del credito. L’altro è il costante tentativo del capitale di abbreviare le metamorfosi che deve subire nel processo di circolazione; di accorciare il periodo di circolazione, e di controbilanciare così la sua propria limitatezza.
La funzione di accumulare, nella misura in cui non è trasformazione di reddito in capitale, ma afflusso di plusvalore sotto forma di capitale, viene così in parte affidata a una classe particolare, tutte le accumulazioni della società in questo senso diventano accumulazioni di capitale e vengono messe a disposizione dei capitalisti industriali. Questa operazione che si svolge isolatamente in innumerevoli punti della società vien concentrata e raccolta in determinati serbatoi. Il denaro, in quanto è un arrestarsi della metamorfosi della merce, in quanto giace inoperoso, vien così trasformato in capitale.
Terra-rendita, capitale-interesse sono espressioni irrazionali nella misura in cui la rendita si fissa come prezzo annuo della terra e l’interesse come prezzo del capitale. Nella forma di capitale che produce un interesse, che produce una rendita, che produce un profitto, è ancora riconoscibile la comune origine, in quanto il capitale include l’appropriazione del pluslavoro, e queste diverse forme esprimono soltanto il fatto che nel capitale in generale questo pluslavoro prodotto dal capitale si ripartisce fra due specie di capitalisti e, nel capitale investito nell’agricoltura, fra il capitalista industriale e agricolo. La rendita come prezzo della terra concepisce la terra come merce, come valore d’uso che ha un valore la cui espressione monetaria è il prezzo. Ma un valore d’uso che non è il prodotto del lavoro non può avere valore, affinché un valore d’uso si rappresenti come valore di scambio deve essere il prodotto di un lavoro concreto. La terra e il prezzo sono grandezze incommensurabili che dovrebbero tuttavia avere un rapporto. Qui una cosa che non ha un valore ha un prezzo.
L’interesse come prezzo del capitale esprime l’irrazionalità opposta. Qui una merce ha un doppio valore, prima un valore, e poi un prezzo distinto da questo valore, senza avere un valore d’uso. Il capitale in un primo tempo non è altro che una somma di denaro o una quantità di merci. Se la merce è data in prestito come capitale, non è altro che la forma travestita di una somma di denaro. Ciò che è dato in prestito come capitale, non sono tante libbre di cotone, ma tanto denaro il cui valore esiste sotto forma di cotone.
Come può una somma di valore avere un prezzo oltre a quello espresso nella sua propria forma di denaro? Il prezzo è il valore della merce, a differenza dal suo valore d’uso. Il prezzo come differenza dal suo valore, il prezzo come valore di una somma di denaro è una contraddizione in termini. Quest’irrazionalità di espressione è così ben avvertita dall’economista volgare che egli falsa entrambe le espressioni per renderle irrazionali. Egli fa che si paghi l’interesse per il capitale in quanto è un valore d’uso, e parla quindi dell’utilità che i prodotti o i mezzi di produzione hanno per la riproduzione come tale e che il capitale ha materialmente come elemento del processo lavorativo. Il suo valore d’uso è già presente nella sua forma di merce, e senza essa non sarebbe merce e non avrebbe valore. Come denaro, è l’espressione del valore delle merci ed è trasformabile in esse in rapporto al suo proprio valore. Se trasformo del denaro in una macchina, lo trasformo in valori d’uso dello stesso valore. Come denaro, ha il valore d’uso di esser trasformabile nella forma di ogni merce, ma in una merce dello stesso valore. Questo cambiamento di forma non modifica il valore del denaro come non modifica quello della merce quando è trasformata in denaro. Il valore d’uso delle merci, in cui posso trasformare il denaro, non gli dà oltre al suo valore un prezzo da esso distinto. Il modo in cui vien consumato il valore d’uso di una merce non modifica il suo valore di scambio. Modifica soltanto la circostanza che la acquisti il capitalista industriale o il consumatore immediato.
L’economista volgare non vuole dire che il capitale è un mezzo per appropriarsi del pluslavoro. Dice: ha più valore del suo valore perché è una merce ordinaria come ogni altra, perché ha un valore d’uso. Qui si identifica il capitale con la merce, mentre bisogna spiegare proprio perché la merce possa presentarsi come capitale. La difficoltà vien sempre superata astraendo da essa e sostituendo alla differenza specifica che dev’essere spiegata un rapporto che nega questa differenza.
* * *
La teoria economica di Marx si erge sulle rovine della economia classica
borghese a condanna dei meccanismi profondi dei rapporti di produzione
capitalistici e ad anticipazione della loro felice negazione nella società
comunistica, post mercantile e post classista.
L’orientamento del Quarto Congresso dell’Internazionale Comunista (novembre-dicembre 1922) sulla questione cinese, favorevole alla cooperazione del Partito Comunista di Cina con il Kuomintang, che iniziava ad assumere la forma della presenza dei comunisti nel partito nazionalista, venne formalizzato con una risoluzione dell’Esecutivo dell’Internazionale del 12 gennaio 1923:
«1 La sola seria organizzazione nazional-rivoluzionaria in Cina è il Kuomintang, che ha la sua base, in parte nella borghesia e nella piccola-borghesia democratico-liberale, in parte nell’intelligenza e nei lavoratori.
«2 Poiché nel paese il movimento operaio indipendente è ancora debole, poiché il compito centrale per la Cina è la rivoluzione nazionale contro gli imperialisti e i loro agenti feudali all’interno del Paese, poiché inoltre la classe operaia è direttamente interessata alla soluzione di questo problema rivoluzionario-nazionale, pur restando ancora differenziata in misura insufficiente in quanto forza sociale pienamente autonoma, il CEIC ritiene che il KMT e il giovane PCC debbano coordinare la loro azione.
«3 di conseguenza, nelle condizioni presenti è opportuno che i membri del PCC rimangano nel Kuomintang».
In tal modo, l’Internazionale recepiva la proposta caldeggiata da Maring, che già nella prima metà del 1922 aveva provato a spingere i comunisti cinesi a lavorare all’interno del Kuomintang. L’indicazione che la risoluzione dava al PCdC, quindi, andava oltre la necessità di coordinare l’azione del partito con quella che era considerata l’unica vera organizzazione nazional-rivoluzionaria, formalizzando quanto nei fatti era messo in pratica in Cina, con i primi comunisti cinesi che dalla seconda metà del 1922 avevano iniziato a entrare individualmente nel Kuomintang.
Tale tattica, come indica il primo punto della risoluzione, partiva da un fraintendimento circa la natura del Kuomintang, che, nonostante la provenienza sociale dei suoi membri, borghesia, piccola-borghesia democratico-liberale, intellettuali e lavoratori, era un partito nazionalista che si informava a una politica, non solo certamente borghese, ma tendente al compromesso sia con le classi possidenti cinesi sia con gli imperialisti stranieri. Svanivano, quindi, quelle critiche che solo un anno prima, al Congresso dei Toilers di inizio di quello stesso 1922, Zinoviev e anche Safarov avevano mosso nei confronti del Kuomintang.
Questo orientamento dell’Internazionale iniziava a colpire l’indipendenza politica e organizzativa del partito comunista, sottomesso alla disciplina di un partito borghese quale era il Kuomintang, una pratica del tutto anormale che ne metteva in discussione la unità e continuità. La risoluzione infrangeva apertamente le Tesi del Secondo Congresso, del 1920, che avevano indicato: «L’I.C. deve entrare in rapporti temporanei e formare anche unioni con i movimenti rivoluzionari nelle colonie e i paesi arretrati, senza tuttavia mai fondersi con essi, e conservando sempre il carattere indipendente del movimento proletario anche nella sua forma embrionale», della difesa del partito e della sua autonomia programmatica ed organizzativa.
È vero che la risoluzione raccomandava che la nuova tattica non obliterasse le specifiche caratteristiche politiche del PCdC, che il partito conservasse la sua organizzazione indipendente, un apparato strettamente centralizzato, contribuendo ad organizzare i lavoratori e formare dei sindacati, al fine di creare un potente partito comunista di massa. Ma confondendo la organizzazione del partito con quella del Kuomintang si rendeva impossibile proprio quanto si diceva di voler realizzare, cioè presentarsi il PCdC «sotto i suoi propri colori, distinto da ogni altro gruppo politico». Si affermava che «pur dando appoggio al Kuomintang in tutte le campagne sul fronte rivoluzionario-nazionale, nella misura in cui esso condurrà una politica oggettivamente corretta, il PCC non dovrà fondersi con esso e, in queste campagne, non dovrà ammainare la propria bandiera», ma nella pratica avverrà proprio questo, il Partito Comunista cederà al Kuomintang la bandiera della rivoluzione in Cina, con i comunisti ridotti a fare “il lavoro dei coolies” (secondo una successiva pittoresca affermazione di Borodin) per il Kuomintang.
Ma la sottomissione del PCdC al Kuomintang derivava anche dai rapporti della Cina con lo Stato sovietico sul piano militare. Il Kuomintang era nelle condizioni di poter ambire ad esercitare un potere effettivo su una parte del territorio cinese. La diplomazia sovietica era stata quindi fin dal principio interessata a intraprendere un dialogo con Sun Yat-sen, che aveva la sua base di potere nel Guangdong.
Dal settembre 1917 Sun Yat-sen fu capo del governo militare di Canton, sostenuto dai Signori della Guerra del Sud. Nel maggio del 1918 il governo di Sun andò in pezzi quando i Signori della Guerra ritirarono il loro sostegno e Sun lasciò Canton, fino a quando, nell’ottobre 1920, non lo restaurò il Signore della Guerra del Guangdong, Chen Jiongming. La Spedizione del Nord di Sun Yat-sen alla fine portò allo scontro con Chen Jiongming, che pretendeva la sospensione del conflitto militare e la costituzione del Guangdong come provincia autonoma. Lo scontro si risolse con il colpo di Stato del 16 giugno 1922 di Chen Jiongming che costrinse Sun a fuggire a Shanghai.
Qui, verso la fine di gennaio 1923, mentre significativi mutamenti erano in corso a Canton, che avrebbero portato il mese successivo Sun Yat-sen a formare un nuovo governo nella città per la terza volta, Sun Yat-sen incontrò Adol’f Yoffe, capo della diplomazia sovietica in Cina a partire dall’agosto del 1922. Sun Yat-sen, che attribuiva la sua cacciata da Canton ad elementi reazionari dello stesso Kuomintang e agli intrighi dell’imperialismo britannico, ostili per la posizione assunta durante lo sciopero di Hong Kong, si dimostrò ben disposto a spostare il suo partito “a sinistra” e a ricevere l’aiuto sovietico contro i rivali interni e stranieri.
Da parte sovietica, dopo che negli anni passati erano state tentate, senza successo, trattative con il governo di Pechino, e si era mostrata anche una certa apertura verso il Signore della Guerra Wu Peifu, che si era imposto nella Cina centrale, il cui iniziale atteggiamento anti-giapponese si era risolto in un avvicinamento agli imperialisti anglosassoni, si iniziò a puntare sempre con maggiore convinzione su Sun Yat-sen quale potenziale aspirante al potere in Cina. Per arrivare a un accordo con Sun Yat-sen la diplomazia sovietica fece intravedere al capo del nazionalismo cinese il vantaggio di un’alleanza non col debole PCdC ma con la forza dello Stato sovietico. Anche al prezzo di una momentanea rinuncia agli obiettivi comunisti e rivoluzionari in Cina.
Il 23 gennaio 1923 Yoffe e Sun Yat-sen stilarono la seguente dichiarazione: «Il dottor Sun Yat-sen sostiene che né l’ordine comunistico, né il sistema sovietico possono attualmente essere introdotti in Cina, perché non esistono quivi le condizioni necessarie per una riuscita istituzione del comunismo o del sovietismo. Questa opinione è interamente condivisa dal signor Yoffe, il quale pensa inoltre che il supremo e più urgente problema della Cina sia realizzare l’unificazione nazionale e raggiungere la piena indipendenza nazionale. In relazione con questo grande compito, egli ha assicurato il signor Sun Yat-sen che la Cina ha la più calda simpatia del popolo russo e può contare sull’appoggio della Russia».
Gli iniziali rapporti tra lo Stato proletario russo e quelli che erano i governi cinesi, in un contesto politico caratterizzato dalla divisione politica del Paese, divennero a partire dal 1923 una esplicita alleanza con la borghesia cinese. Partendo dal pretesto che la Cina non era matura per il comunismo e il sistema dei soviet, cioè per la dittatura del proletariato, si arrivava a circoscrivere i compiti della rivoluzione in Cina all’interno dell’ordine borghese, di cui Sun Yat-sen era il rappresentante.
Si veniva così a confermare nei fatti una politica schiettamente menscevica. Dal punto di vista economico la Cina di allora non era troppo diversa dalla Russia del 1917, dove i bolscevichi si erano battuti per la rivoluzione diretta dal proletariato. Capovolgendo gli insegnamenti di Lenin sulla tattica nelle cosiddette rivoluzioni doppie e le indicazioni dell’Internazionale per il proletariato delle colonie e semicolonie, la nuova rotta che veniva tracciata riconosceva alla borghesia un ruolo rivoluzionario nella rivoluzione nazionale e si portava il proletariato a sottomettersi alla sua direzione.
I rapporti tra la Russia sovietica e Sun Yat-sen si svilupparono ulteriormente non appena nel febbraio 1923 Sun riprese le redini del governo di Canton.
In quel mese lo sciopero dei ferrovieri della linea Pechino-Hankow, ultima importante lotta dell’ondata iniziata nel 1919 e che aveva avuto l’apice nel 1922, venne a rafforzare la convinzione della debolezza del Partito Comunista e della necessità di stringere i legami con il Kuomintang.
La causa dello sciopero fu la fondazione del Sindacato generale della ferrovia Pechino-Hankow.
Già dal 1921 in tutte le stazioni della linea Pechino-Hankow i ferrovieri avevano cominciato ad organizzarsi costituendo sezioni sindacali, allora chiamate club operai. Senza distinzione le sezioni riunivano le differenti categorie (meccanici, macchinisti, addetti ai binari ecc.); il 45% della quota era destinato alla cassa di resistenza. Ad aprile del 1922 i delegati iniziarono ad incontrarsi per unificare le sezioni sindacali; ad inizio gennaio del 1923 il processo di unificazione si era concluso, fu abbozzato lo statuto del sindacato e si decise di convocare il Congresso di fondazione il primo febbraio a Zhengzhou, al centro della linea ferroviaria.
La fondazione del sindacato dei ferrovieri mise in allerta Wu Peifu, il Signore della Guerra che controllava la provincia. Arrivato al potere Wu Peifu aveva cercato di attirare la simpatia degli operai con un programma politico che tra l’altro parlava di “protezione del lavoro” e prometteva una adeguata legislazione. Verso Wu Peifu c’era stato anche un atteggiamento di neutralità reciproca, se non cooperazione, di alcuni comunisti cinesi, tra cui Li Dazhao, nell’illusione di utilizzare queste aperture e le rivalità tra fazioni conservatrici per estendere le organizzazioni dei lavoratori, in particolare tra i ferrovieri. Lo storico Chesneaux, “maoista francese”, quando scrisse sul movimento operaio cinese agli inizi degli anni Venti, riporta un accordo con Wu Peifu con elementi comunisti per eliminare i suoi avversari sulla rete del Nord: furono nominati dalle autorità di Pechino sei membri del Partito Comunista come "Ispettori segreti" delle ferrovie autorizzati a circolare liberamente su tutta la rete. Lo stesso Radek, al Quarto Congresso dell’Internazionale, fece intendere la possibilità di utilizzare, in una situazione come quella cinese, delle forze reazionarie come quella di Wu Peifu.
Se inizialmente i comunisti cinesi avevano potuto estendere l’organizzazione dei ferrovieri utilizzando la possibilità di presentarsi come commissari sulla rete, presto questo vantaggio fu loro revocato. Wu Peifu contava anche sui proventi della ferrovia Pechino-Hankow, per cui si mosse a spezzare il sindacato e a reprimerlo nel sangue. Ne vietò il Congresso di fondazione, convocato per il primo di febbraio. Nonostante il divieto, i delegati decisero di riunirsi. La mattina del primo febbraio i ferrovieri e i loro delegati si trovarono i soldati armati in città, dove era stata promulgata la legge marziale. All’apertura del Congresso, con le truppe che circondavano il teatro in cui si svolgeva, fu dichiarato costituito il Sindacato Generale della Ferrovia Pechino-Hankow. Subito dopo consistenti reparti militari misero sotto sorveglianza le abitazioni in cui erano alloggiati i delegati e occuparono la sede del sindacato.
La stessa notte una riunione segreta del sindacato approvò una risoluzione che proclamava per il 4 febbraio lo sciopero generale della linea Pechino-Hankow. La mattina del 4 febbraio i ferrovieri entrarono in sciopero.
Lo sciopero generale su tutta la rete Pechino-Hankow preoccupava non solo la cricca di Wu Peifu, ma mise in allerta le potenze straniere che sentivano minacciati i propri interessi. Su iniziativa del console britannico di Hankow, il 6 febbraio, si riunirono segretamente i consoli stranieri, i rappresentanti della polizia e dell’esercito cinesi, gli industriali occidentali e la direzione della rete ferroviaria, con l’obiettivo di mettere fine allo sciopero. Il 7 febbraio, a Jiangnan, uno dei principali centri dello sciopero, le truppe circondarono la sede del sindacato e aprirono il fuoco, facendo oltre 30 morti. La repressione continuò con perquisizioni, arresti di operai ed esecuzioni sommarie, come quella di Lin Xiangqian, uno dei capi operai, che arrestato si rifiutò di ordinare la ripresa del lavoro e fu decapitato davanti ai suoi compagni. La carneficina fu ripetuta in tutte le altre stazioni in sciopero.
Di fronte alla brutale repressione, la Federazione Provinciale dei Gruppi Operai dell’Hubei chiamò allo sciopero generale. A Wuhan, principale centro della regione, scesero in sciopero lavoratori di diverse categorie. Ma contemporaneamente furono fatte sbarcare le truppe degli imperialisti occidentali che diedero sostegno ai soldati cinesi. Il terrore piombò sulla città e lo sciopero fu spezzato col sangue. Il 9 febbraio il Sindacato Generale della Ferrovia Pechino-Hankow e la Federazione Provinciale dei Gruppi Operai dell’Hubei ordinarono la ripresa del lavoro. I morti furono decine e centinaia i feriti, diverse decine gli arresti, oltre mille operai furono licenziati per rappresaglia ed espulsi dalla regione. Il movimento operaio cinese aveva perduto una sua prima battaglia.
Analizzando le ragioni della sconfitta dei ferrovieri Deng Zhongxia, militante comunista e organizzatore sindacale, scrisse: «Allora il Partito Comunista era giovane e non aveva ancora salde radici nella classe operaia (...) Ma una cosa possiamo dire con certezza: anche un forte partito comunista, con ben strutturate organizzazioni sindacali, non avrebbe avuto la forza sufficiente per contrastare le truppe con le armi spianate, solo avrebbe saputo evitare una sconfitta di tali proporzioni». Deng Zhongxia individuava tre principali cause della sconfitta dello sciopero: prima, lo sciopero di solidarietà non fu sufficientemente preparato ed iniziò in ritardo, quando il nemico aveva già concentrato le truppe e iniziava lo scoraggiamento in gruppi di lavoratori; seconda, non fu svolta una propaganda rivoluzionaria tra i soldati, i militanti comunisti non avevano ancora esperienza di lavoro rivoluzionario tra i soldati e la maggior parte degli operai aveva un atteggiamento ostile verso i soldati, per cui ai comandi fu possibile impiegare le truppe per sparare sugli scioperanti; infine, non si occuparono le stazioni telegrafiche e telefoniche, mentre le comunicazioni tra i lavoratori delle diverse località furono interrotte all’inizio dello sciopero: il comando militare poté servirsi del telegrafo e dei telefoni per muovere le truppe.
Queste considerazioni danno una idea di cosa significava uno sciopero in Cina negli anni Venti, una vera guerra di classe, la cui vittoria può essere assicurata solo se la classe operaia ha una direzione salda e decisa, capace di guidare il proprio esercito in tutte le fasi della lotta, anche quando si rende necessaria una ritirata per prepararsi al prossimo assalto.
La sconfitta provocò un arretramento delle lotte della classe operaia, ma mise in chiaro di cosa aveva bisogno il proletariato cinese per vincere la sua guerra di classe. In seguito alla repressione del 7 febbraio 1923, il Segretariato Nazionale dei Sindacati, un organismo creato dal PCdC per propagandare la necessità della coalizione operaia e per lavorare all’organizzazione dei lavoratori in sindacati, elaborò un manifesto in cui si affermava:
«La nostra è una guerra di lunga durata, e questa sconfitta è soltanto un iniziale fallimento; continuando la nostra guerra senza esitazioni la vittoria finale sarà nostra! Il compito di oggi è organizzare nuovi sindacati, di ripristinare quelli sciolti, creando gruppi potenti e solidi. Ma tutto ciò non è sufficiente. Accanto ai sindacati gli operai hanno bisogno di un’altra organizzazione: il partito politico. La classe operaia combatte la guerra di classe per la propria emancipazione; per vincere deve organizzare solidamente il suo esercito, cioè il sindacato. L’organizzazione della massa dei fanti è necessaria, ma insufficiente per rispondere alle necessità della guerra. Gli operai d’avanguardia devono organizzare lo stato maggiore per preparare e dirigere la lotta nell’interesse di tutta la classe operaia. Questo stato maggiore è il partito politico.
«Il partito di cui abbiamo bisogno è il Partito Comunista, che ci ha diretti fin dall’inizio per organizzare i sindacati, ci ha aiutati a ottenere con la lotta gli aumenti di salario, ci ha fatto comprendere che “l’unità è la forza degli operai”. Senza temere le difficoltà e risparmiare gli sforzi, il partito ci dirige sulla via dell’emancipazione, nella lotta per le libertà (...)
«Tutti i rivoluzionari d’avanguardia della classe operaia devono entrare nel Partito Comunista della Cina. Accanto ai sindacati occorre l’organizzazione del partito. È questo l’insegnamento da trarre dalla recente sconfitta. Se i compagni faranno del loro meglio per assolvere a questo compito; se si prodigheranno per sviluppare le forze del Partito Comunista, le nostre perdite saranno allora vendicate. Viva il Partito Comunista della Cina!».
Come ben si vede, all’interno del Partito Comunista di Cina erano presenti delle sane forze rivoluzionarie che, strette attorno a un chiaro programma e a una solida organizzazione, avrebbero tratto i corretti insegnamenti dalla sconfitta per prepararsi ai nuovi assalti, che sarebbero arrivati in una ingigantita vampata di lotta operaia a partire dal 1925.
Ma gli eventi cinesi del febbraio del 1923 furono letti, invece, dall’Internazionale come una conferma della debolezza del PCdC, da cui derivava erroneamente la necessità di legarsi al Kuomintang. Si consideravano i risultati drammaticamente diversi dello sciopero dei lavoratori del gennaio 1922 a Hong Kong, che si riteneva fosse stato guidato dal Kuomintang, e lo sciopero del febbraio 1923 sulla ferrovia Pechino-Hankow, guidato dal PCdC: il primo, antimperialista e sostenuto dalla popolazione del Guangdong compresa la borghesia nazionale, ebbe successo; il secondo fallì; i lavoratori guidati dai comunisti, avendo sollevato rivendicazioni di classe, non ne ricevettero il sostegno; ciò avrebbe indicato l’importanza del fronte unito antimperialista.
In realtà, la pretesa debolezza del Partito Comunista di Cina non corrispondeva del tutto alla situazione reale: se era vero che dal punto di vista numerico all’inizio del 1923 i membri del Partito erano effettivamente molto esigui, era anche vero che il Partito dirigeva molti sindacati, che proprio nel corso del 1922 ebbero un grande sviluppo in Cina. Quindi il partito vantava già una notevole influenza sulla classe operaia, incontaminata dal contagio del riformismo e dell’opportunismo come in Europa. Inoltre, nel corso del 1922 il movimento proletario aveva dimostrato una grande capacità di lotta, e la repressione del febbraio 1923 era solo una momentanea interruzione del movimento degli scioperi, che sarebbe ben presto ripreso con una forza superiore, culminando nel grande movimento del 1925-1927.
Ma il Partito Comunista arriverà a quel grande scontro di classe con un Partito
legato mani e piedi dall’alleanza con il Kuomintang, verso cui una tappa fu, in
quell’inizio del 1923, la risoluzione dell’Esecutivo dell’Internazionale e la
dichiarazione congiunta Yoffe-Sun Yat-sen. Assumendo che il Partito Comunista
fosse poco sviluppato in Cina, presunzione speculare a quella adoperata in
Europa per spingere verso la tattica del “fronte unico”, gli si negava la
possibilità di qualunque azione autonoma all’interno della rivoluzione cinese.
12. - Il Terzo Congresso del Partito
La tattica dell’ingresso dei comunisti nel Kuomintang, approvata dall’agosto del 1922 e sancita dalla risoluzione dell’ECCI del 12 gennaio del 1923, continuava a trovare resistenza all’interno del Partito in Cina. Ne era consapevole Maring, promotore di tale indirizzo. Il 31 maggio scriveva una lettera a Bucharin nella quale, oltre a confermare le resistenze di alcuni comunisti cinesi alla tattica dell’ingresso individuale nel KMT, esprime anche una certa incertezza circa l’orientamento dell’Internazionale sulla questione cinese:
«Da Zhang Guotao, il compagno tornato da Mosca, ho appreso che nell’ECCI il legame tra la nostra gente e il KMT è ancora aspramente criticato e che interpretano ancora la tesi accettata a gennaio in modo tale che non mi è chiaro come possano prendere sul serio la connessione con KMT (...) Sulla questione cinese nell’ECCI si parla di una sinistra (Voitinsky, Safarov e Radek), di un centro (voi) e di una destra (Joffe e io). C’è l’idea che la nostra gente qui al Sud dovrebbe lavorare nel KMT ma non fare nulla per questo partito al Nord perché lì non ha influenza (...) Nel Dipartimento Orientale dell’ECCI la gente si diverte ancora a fantasticare sul partito di massa, il nostro, in Cina (...) A mio avviso la posizione dell’ECCI sulla questione cinese non è ancora stata approfondita e non è chiara».
I rapporti con il Kuomintang avevano ricevuto un’accelerazione dai primi mesi del 1923, in seguito all’accordo concluso tra Yoffe e Sun Yat-sen il 26 gennaio. Il 1° maggio 1923 Joffe riceveva un telegramma nel quale il governo sovietico comunicava alcune decisioni prese in merito ai rapporti con il movimento di Sun Yat-sen e scriveva a Maring incaricandolo di comunicare a Sun tali decisioni: si chiedeva di estendere il lavoro ideologico e politico sul quale basare le operazioni militari rivoluzionarie e si inviavano due milioni di rubli d’oro e un modesto quantitativo di armi. Il 15 maggio, colto da “grande speranza”, Sun rispondeva ringraziando e accettando le proposte fatte, scriveva poi che sarebbero stati mandati a Mosca dei delegati per discutere i dettagli.
A conferma di come i rapporti con Sun Yat-sen si stavano facendo sempre più stretti Maring scriveva sia nel suo rapporto all’ECCI sia nella lettera a Bucharin, che lui e Chen Duxiu avevano presentato a Sun Yat-sen un piano per la riorganizzazione del Kuomintang, che il capo nazionalista aveva accettato.
Questi due documenti di Maring sono interessanti anche sotto un altro aspetto in quanto contengono una descrizione della situazione in Cina e impietosa dello stato del Partito, ovviamente così come veniva percepita dall’autore. Nel PCdC quasi non ci sono lavoratori nell’organizzazione e il contatto con la classe operaia esiste solo in alcuni centri dove è presente il lavoro sindacale; dei circa 250 membri del Partito la maggior parte sono studenti; il lavoro sindacale aveva avuto successo solo in pochi centri, in particolare nelle province dell’Hubei e dell’Hunan, mentre non c’erano stati significativi risultati in centri come Shanghai e Hong Kong; il lavoro di propaganda non era stato condotto per molti mesi, fino alla fondazione nel settembre del 1922 di un settimanale, il cui compito era di «creare un’ala sinistra nel movimento nazionalista cinese e nel KMT»; c’erano dei dissensi interni al Partito, con dei compagni che lo avevano lasciato. Maring è lapidario: «Il nostro gruppo è ancora tale che non si può chiamarlo Partito».
Nella lettera a Bucharin, invece, Maring scriveva: «La Cina è molto arretrata rispetto all’India e alle Indie olandesi. La situazione economica è tale che parlare di partito comunista nella fase attuale è un’utopia. Avrà origine in un ulteriore sviluppo del movimento nazionalista».
Secondo Maring il Partito Comunista di Cina non aveva consistenza, e, date le condizioni di arretratezza del Paese, la sua stessa formazione era considerata utopica, facendo intendere che l’origine di un vero partito comunista potesse verificarsi solo in seguito allo sviluppo del movimento nazionalista. Si liquidava così del tutto l’esistenza e l’esperienza del partito cinese degli ultimi due anni, il tutto funzionale alla prospettiva che vedeva nel Kuomintang il protagonista e l’unica guida possibile della rivoluzione in Cina, nel quale bisognava far confluire le già esigue forze comuniste.
Le considerazioni di Maring sull’inconsistenza del PCdC arrivavano ai vertici dell’Internazionale, che avevano il gravoso compito di indicare al giovane partito cinese la corretta strada rivoluzionaria, e andavano a combinarsi con altri condizionamenti che premevano sui capi del comunismo mondiale, ben più potenti dei rapporti di Maring, come l’isolamento della rivoluzione comunista nella sola Russia, alla quale era venuto a mancare il soccorso del movimento rivoluzionario nelle metropoli capitalistiche più avanzate. La pressione di tali forze materiali a partire già dal 1921 aveva prodotto degli sbandamenti tattici, prontamente denunciati dalla Sinistra. Inevitabilmente tale situazione riguardava anche le indicazioni che l’Internazionale impartiva ai comunisti in Cina, che, sebbene non rinnegassero gli insegnamenti del marxismo rivoluzionario restaurati attraverso la vittoria comunista in Russia e la fondazione della Terza Internazionale, introducevano delle pericolose manovre che aprivano la strada a successive deviazioni, che si sarebbero rivelate disastrose per il movimento comunista internazionale.
Nel maggio del 1923, con le “Istruzioni dell’Esecutivo al Terzo Congresso del PCdC” i vertici dell’Internazionale chiarivano alcuni aspetti relativi alla rivoluzione nazionale in Cina. Non mancano corretti richiami agli insegnamenti del marxismo rivoluzionario.
Il documento si apre sottolineando l’importanza della questione contadina nella rivoluzione in Cina: «La rivoluzione nazionale in Cina e la creazione di un fronte antimperialista coincideranno necessariamente con la rivoluzione agraria dei contadini contro le sopravvivenze del feudalesimo. La rivoluzione sarà vittoriosa soltanto se il movimento riuscirà ad attrarre la componente fondamentale della popolazione cinese, i contadini (...) Di conseguenza il partito comunista, come partito della classe operaia, deve tendere a stabilire l’unità fra gli operai e i contadini». Parole d’ordine della rivoluzione agraria dovevano essere: «La confisca delle terre dei grandi proprietari fondiari, dei monasteri e della Chiesa, il trasferimento di esse senza indennizzo ai contadini (...) l’abolizione del canone di locazione (...) la soppressione dell’attuale sistema tributario».
Il documento continuava con importanti dichiarazioni sull’atteggiamento del Partito nella rivoluzione in Cina: «È superfluo sottolineare che la direzione deve appartenere al partito della classe operaia (...) Rafforzare il partito comunista facendone un partito di massa del proletariato, riunire le forze della classe operaia in sindacati, questo è il compito che incombe ai comunisti».
Era però nella cruciale questione dei rapporti con il Kuomintang che si smarriva la corretta strada rivoluzionaria, illudendosi di poterlo utilizzare come strumento della rivoluzione nelle campagne e confermando la politica di lavorare al suo interno: «Il partito comunista deve costantemente spingere il Kuomintang dalla parte della rivoluzione agraria (...) Confisca della terra in favore dei contadini poveri, e attuare tutta una serie di altre misure rivoluzionarie (...) per garantirgli l’appoggio dei contadini e allargare la base della rivoluzione antimperialista (...) D’altra parte dobbiamo lottare con ogni mezzo all’interno del Kuomintang contro qualsiasi accordo militare fra Sun Yat-sen e i signori della guerra». Inoltre il PCdC avrebbe dovuto esigere la convocazione di un Congresso del KMT per discutere di questa questione.
Se da un lato correttamente si poneva la questione contadina alla base della rivoluzione in Cina, con la classe operaia alla testa delle masse contadine, dall’altro si affermava possibile spingere il Kuomintang a sostenere la rivoluzione nelle campagne, il cui orientamento nei confronti della questione agraria era già stato criticato al Congresso dei Toilers l’anno precedente.
Tale illusione derivava dalla mancanza di chiarezza circa la natura sociale del partito nazionalista e della situazione nelle campagne cinesi, dove accanto alle sopravvivenze feudali era una grande borghesia legata da stretti vincoli alla vecchia proprietà fondiaria, in un intreccio di percettori di affitti, usurai, mercanti, funzionari statali, proprietari di fabbrica, con personaggi che univano due o più di queste funzioni, interessati gli uni come gli altri a spremere il contadiname e mantenerlo in soggezione. La grande borghesia cinese, legata da interessi economici alla vecchia proprietà feudale, sarebbe stata disposta a fare blocco comune con le sopravvivenze della Cina pre-borghese per difendere i propri privilegi contro gli operai e i contadini, il cui movimento rivoluzionario avrebbe mandato in aria l’intera struttura politica e sociale della Cina. Gli interessi della borghesia cinese venivano verniciati di rosso nell’ideologia di un socialismo non classista promossa dal Kuomintang.
Il documento dell’ECCI giunse a Shanghai non prima del 18 luglio 1923. Intanto, però, a seguito della risoluzione dell’Internazionale del 12 gennaio, fu convocato per giugno il Terzo Congresso del Partito Comunista di Cina, che si tenne a Canton nel giugno del 1923, sotto la supervisione di Maring, con la partecipazione di 17 delegati in rappresentanza di oltre 400 membri (l’anno precedente erano circa 200). Il principale risultato del Congresso fu l’approvazione da parte della maggioranza dei delegati della linea dell’ingresso dei comunisti nel Kuomintang. Ma la discussione al congresso fu ampia e aspra, con un gruppo di delegati guidati da Zhang Guotao e Cai Hesen che si opposero apertamente e nettamente, e anche molti delegati che votarono a favore lo fecero con riluttanza.
Nel suo rapporto Chen Duxiu riconosce la presenza di posizioni contrastanti sulla questione: «Inizialmente, la stragrande maggioranza era contraria all’adesione al KMT, ma il rappresentante dell’ECCI ha convinto i partecipanti e abbiamo deciso di consigliare a tutti i membri del partito di aderire al KMT (...) La nostra posizione politica non è chiara. Tutti riconoscono che la Cina ha bisogno di portare avanti una rivoluzione democratica, ma le nostre opinioni differiscono su come dovremmo servire la rivoluzione democratica. Alcuni compagni sono ancora contrari all’adesione al KMT».
La questione al centro della disputa al Terzo Congresso era una continuazione di quanto emerso l’agosto dell’anno prima, subito dopo il Secondo Congresso del PCdC che aveva affermato la centralità della rivoluzione nazionale e la necessità della cooperazione tra il PCdC e il Kuomintang. La questione che venne discussa era la forma che doveva assumere questa “cooperazione” con il Kuomintang e, dopo che nel Plenum dell’agosto del 1922 era stato stabilito di lavorare al suo interno, se tutti i membri del PCdC o solo un limitato numero di essi dovevano entrare nel Kuomintang. L’interpretazione che Maring dava delle Istruzioni ricevute da Mosca era che tutti i membri del PCdC senza eccezione dovevano iscriversi al Kuomintang e partecipare attivamente al lavoro al suo interno. Dato che il compito centrale in Cina era rappresentato dalla rivoluzione nazionale tutto il lavoro doveva essere fatto dal Kuomintang. Restava l’indipendenza organizzativa del PCdC e la sua libertà di critica, ma essendo il movimento operaio parte della rivoluzione nazionale, il PCdC avrebbe dovuto reclutare i lavoratori per il Kuomintang, e questi avrebbero dovuto accettare la guida del Kuomintang.
Obiezioni furono mosse da Zhang Guotao, che temeva che la tattica di Maring avrebbe messo in discussione l’indipendenza politica e organizzativa del PCdC, finendo per dissolversi nel Kuomintang, una sua ala sinistra del KMT. Ma al tempo del Terzo Congresso il PCdC aveva già fatto un passo in questa direzione con il Plenum di agosto del 1922, e le Indicazioni dell’Internazionale la rafforzavano, per cui Zhang Guotao si limitò a richiamare la necessità di uno sviluppo indipendente del PCdC e ad esprimersi per una partecipazione limitata al Kuomintang.
Il Terzo Congresso del PCdC alla fine accolse la linea promossa da Maring e sostenuta dall’Internazionale e adottò nuove risoluzioni per riorientare la politica del partito rispetto alle decisioni che erano state prese al Congresso dell’anno precedente. Ciò è quanto venne espresso nella “Risoluzione sul movimento nazionalista e la questione del Kuomintang”:
«2. Gli attuali governanti della Cina sono signori feudali, non borghesi. Il governo dei Signori della Guerra si autodefinisce indipendente, ma in realtà prende ordini dalle potenze imperialiste internazionali (...) La borghesia cinese controlla solo una parte estremamente piccola della produzione effettiva. Gli imperialisti sfruttano il loro potere politico in Cina per ostacolare il libero sviluppo dell’industria cinese. Pertanto la Cina semicoloniale deve fare del movimento nazionale democratico il suo compito centrale per rimuovere l’oppressione interna ed esterna.
«3. In conformità con la situazione sociale della Cina, dovrebbe esserci un potente partito centralizzato che funga da quartier generale supremo del movimento nazionalista democratico. La Cina attualmente ha un partito. Solo il KMT è un partito relativamente rivoluzionario democratico (...)
«4. A causa dell’arretratezza dell’industria, la classe operaia cinese è ancora agli esordi (...) il movimento dei lavoratori non può ancora sollevarsi con forza per creare una forza sociale indipendente, necessaria per l’attuale rivoluzione cinese».
«5. Dal momento che la classe operaia non è diventata potente naturalmente non è possibile sviluppare un PC forte, un grande partito di massa, per soddisfare le esigenze dell’attuale rivoluzione. Pertanto l’ECCI ha approvato una risoluzione secondo cui il PCdC deve cooperare con il KMT cinese. I membri del PC devono aderire al KMT».
I punti fondamentali dei documenti congressuali furono poi riportati nel Manifesto del Congresso, che affermava perentorio: «Il KMT dovrebbe essere la forza centrale della rivoluzione nazionale e assumerne la guida».
Confrontando le decisioni del Terzo Congresso con quelle del Secondo, svoltosi l’anno precedente, il PCdC veniva ad accettare l’imposizione di quella fatale virata, già anticipata dal Plenum dell’agosto del 1922 quando i primi comunisti iniziavano ad entrare nel partito nazionalista. Non solo il Terzo Congresso impose a tutti i militanti di iscriversi al KMT ma, in aperta contraddizione con tutta la dottrina rivoluzionaria comunista, il Kuomintang diveniva la “forza centrale” e la “guida” della rivoluzione democratico-nazionale. La strada indicata era far convergere nel partito della borghesia cinese le forze comuniste e operaie, mentre vi arrivavano i consiglieri politici e militari russi, assicurandogli una base di massa operaia e contadina e una organizzazione centralizzata e disciplinata, con il PCdC ridotto a fare il lavoro da coolie.
Al Terzo Congresso il Partito, abdicato al ruolo di guida della rivoluzione, scivolava nel menscevismo. Peggio dei menscevichi in Russia, che mantennero la indipendenza organizzativa dal partito della borghesia russa, mentre i comunisti cinesi vi restarono intrappolati fino al sanguinoso epilogo nel 1927.
A giustificare la tattica menscevica in Cina si esagerava il carattere rivoluzionario nazionale della borghesia. Inoltre l’adesione dei comunisti al partito nazionalista si motivava con l’estrema debolezza del PCdC, che non avrebbe avuto legami con le masse, e che solo attraverso il Kuomintang il giovane partito comunista sarebbe stato in grado di avvicinarle, ignorando che erano stati proprio i comunisti che avevano contribuito con la loro attività alla nascita dei primi sindacati classisti in Cina.
Era una impostazione che, a pochi anni dal Secondo Congresso dell’Internazionale, ne sconfessava le Tesi sulla questione nazionale e coloniale, che proprio sui rapporti con il movimento nazionalista rivoluzionario nelle colonie erano di estrema chiarezza. Ma se il progressivo sconfinamento nell’opportunismo ha certamente dei portavoce di clamorosi errori rispetto alla teoria rivoluzionaria restaurata dalla Terza Internazionale nei suoi primi due congressi, lo stravolgimento della corretta prospettiva rivoluzionaria affonda le sue radici nel ripiegamento della rivoluzione mondiale che, dopo aver prodotto la conquista del potere in Russia, ritardava ad estendersi nei paesi capitalisticamente sviluppati d’Europa.
Scrivemmo nel 1965: «La Sinistra fu la prima ad avvertire che, qualora il comportamento dello Stato russo, nella economia interna come nei rapporti internazionali, cominciasse ad accusare deviazioni, si sarebbe stabilito un divario tra la politica del partito storico, ossia di tutti i comunisti rivoluzionari del mondo, e la politica di un partito formale che difendesse gli interessi dello Stato russo contingente” (“Considerazioni…”).
Le esigenze della sopravvivenza dello Stato russo premevano sulla sua politica
estera, che veniva orientata alla ricerca di alleati, temporanei, nel resto del
mondo borghese e anche pre-borghese, per contrastare e resistere alla pressione
dei principali imperialismi. Gli interessi diplomatici dello Stato russo,
isolato in seguito al riflusso della rivoluzione mondiale, sarebbero stati
favoriti da un governo amico in Cina. Alla ricerca di un alleato in Oriente
questa esigenza portò ad approcci anche verso figure reazionarie, come il
Signore della Guerra Wu Peifu, fino a trovare un alleato nel Kuomintang e nel
suo centro di potere nella Cina del Sud. Da quel momento la politica cinese
dello Stato dei Soviet in Russia si focalizzò sul mantenimento della
cooperazione con la fazione liberale della borghesia. Fu da questa esigenza che
in realtà scaturì l’ordine al PCdC di unirsi al KMT fin dall’estate del 1922. Il
prezzo pagato fu la consegna del PCdC al Kuomintang.
13. - Dopo il Terzo Congresso
Concluso il Terzo Congresso, in una lettera del 20 giugno 1923 indirizzata ai vertici dell’Internazionale, Zinoviev, Bucharin, Radek e Safarov, Maring ricostruiva i passaggi che avevano portato all’adozione della tattica di ingresso nel Kuomintang e difendeva le ragioni che lo avevano spinto a proporla.
Secondo Maring al Quarto Congresso del Comintern (novembre-dicembre 1922) era emersa una tendenza a lasciare che il PCdC svolgesse un’azione politica indipendente sotto una bandiera comunista, con la proposta per la Cina di sviluppare rapidamente un partito di massa, lanciata da Radek in base, a detta di Maring, di informazioni false sulla situazione cinese. Pertanto, subito dopo il Quarto Congresso, si recò a Mosca, per difendere la continuazione della tattica adottata in agosto, con il risultato che, nel gennaio del 1923, l’ECCI adottò una risoluzione secondo la quale la rivoluzione nazionalista era il principale compito del Partito e che i membri del Partito dovevano restare nel KMT. Ritornato in Cina con questa risoluzione, il Terzo Congresso del PCdC vi si doveva conformare.
La risoluzione, però, fece nascere delle discussioni: cosa significava “lavorare nel KMT”? quanti militanti erano da dedicare a questo scopo e quanti alla propaganda tra i lavoratori? la borghesia cinese aveva un ruolo rivoluzionario o tutto sarebbe dovuto provenire dagli operai e dai contadini? Nelle tesi del Terzo Congresso del PCdC fu stabilito che il compito del partito era “sviluppare il KMT in tutto il Paese”. Nello stesso tempo, però, venivano mosse delle critiche al partito nazionalista per la tattica promossa dai suoi capi, che si basava prevalentemente sull’aspetto militare, conducendo in tal modo alla creazione di legami con i militaristi feudali del Nord, come a ricercare rapporti con gli imperialisti stranieri, tattica del tutto incompatibile con il carattere di un partito nazionalista rivoluzionario.
Secondo Maring occorreva, invece, forzare il KMT sulla strada della propaganda rivoluzionaria e creare un’ala sinistra in questo partito formata da contadini e lavoratori. Scriveva: «Il partito di massa di lavoratori è un’utopia. Al momento i contadini possono essere conquistati solo da un movimento nazionalista. Continuiamo il nostro lavoro organizzativo per i sindacati, ma dobbiamo aspettarci che l’interesse politico dei lavoratori sia principalmente per il movimento nazionalista. I lavoratori che hanno un interesse politico devono sostenerci nell’ala sinistra del KMT. Il nostro Partito continuerà ad esistere come organizzazione fortemente centralizzata che sosterrà il movimento nazionalista ovunque in Cina».
Dopo esser tornato a dipingere un quadro dell’arretratezza economica e politica della Cina, Maring concludeva esponendo la sua concezione della tattica proposta per la situazione cinese: «Se non ci fosse il KMT, creeremmo un buon partito nazionalista accessibile a tutti i nazionalisti che vogliono la lotta rivoluzionaria. Ma c’è un partito nazionalista che ha già una certa importanza. Per la sua modernizzazione è necessario che i nostri compagni affermino lì le loro opinioni antimperialiste. In questo modo possiamo creare al più presto un forte movimento nazionalista rivoluzionario dal mondo contadino e operaio insieme alla piccola borghesia e agli intellettuali».
Zhang Guotao, che si opponeva a tutto questo, nella lettera del 16 novembre 1923 ai funzionari del Comintern Voitinsky e Musin, così sintetizzava la posizione di Maring: «Il movimento operaio è troppo debole e praticamente di nessun significato. Il PCdC fu organizzato in maniera artificiale e fu creato troppo presto. Al momento solo il movimento nazionalista può svilupparsi in Cina. Il Kuomintang rappresenta il movimento nazionalista, ma deve essere riorganizzato. Ora abbiamo la possibilità di riorganizzare il Kuomintang (...) Il Comintern considera che il compito centrale del PCdC in questo momento è il movimento nazionalista e la Russia sovietica dovrebbe sostenere il Kuomintang. Quindi i comunisti cinesi devono concentrare i loro sforzi nella riorganizzazione del Kuomintang e lavorare all’interno del Kuomintang e sviluppare il Kuomintang. Tutto il lavoro di propaganda politica del PCdC dovrebbe essere fatto all’interno del Kuomintang (...) Il movimento operaio dovrebbe essere portato all’interno del Kuomintang e i lavoratori di tutta la Cina devono essere portati dentro il Kuomintang. Solo quando si sarà sviluppata la coscienza di classe degli operai all’interno del Kuomintang, potrà svilupparsi un’ala sinistra del Kuomintang. Solo in quel tempo un reale PCdC può essere formato. Questo è l’unico processo del movimento rivoluzionario in Cina».
Tutti gli sforzi dei comunisti dovevano essere rivolti alla “riorganizzazione” del Kuomintang, confinando il Partito Comunista al suo interno, con il compito di lavorare allo sviluppo del partito nazionalista facendo affluire nelle sue file operai e contadini. Nelle enunciazioni si manteneva l’esistenza indipendente del Partito Comunista, ma nei fatti lo si riduceva ad “ala sinistra” del Kuomintang, concetto esplicitamente formulato nella visione di Maring, fatto proprio dai vertici dell’Internazionale e imposto ai comunisti cinesi.
Nella sua lettera del novembre del 1923 Zhang Guotao conveniva che il movimento operaio cinese e il PCdC erano giovani e deboli, e che in quel tempo poteva imporsi solo un movimento nazionalista, ma esprimeva delle obiezioni sul fatto che fosse il Kuomintang a rappresentarlo, se fosse davvero possibile riorganizzare il Kuomintang e se fosse questo il compito del movimento rivoluzionario in Cina. Zhang Guotao sosteneva che in Cina c’era un movimento nazionalista contro l’imperialismo giapponese, che però era in qualche modo utilizzato dall’imperialismo americano, e che quindi, invece di un vero movimento nazionalista era in realtà una tendenza a favore degli Stati Uniti e dell’impero britannico, da loro stessi creata. Lo stesso Kuomintang scendeva a compromessi con questo o quell’imperialista o militarista locale. Sosteneva, poi, che la borghesia cinese era ancora molto dipendente dai capitalisti stranieri e che, benché ci fossero delle contraddizioni tra i borghesi cinesi e gli imperialisti stranieri, la borghesia locale era ancora lontana dalla formazione di una coscienza contro l’oppressione straniera.
Dall’altro lato, la classe operaia era sì giovane e debole ma aveva già mostrato una innegabile combattività. Zhang Guotao riteneva che, mentre ci sarebbero voluti anni per lo sviluppo di un movimento nazionalista contro tutte le potenze, in quel tempo la forza operaia era già presente e poteva essere uno dei protagonisti di un futuro movimento nazionalista. Pur accettando di organizzare delle sezioni nel Kuomintang non riteneva questo lavoro predominante: i comunisti dovevano continuare a propagandare indipendentemente le proprie posizioni politiche e bisognava evitare che il movimento sindacale passasse dalle mani del PCdC a quelle del KMT. Il compito principale restava quello di organizzare i lavoratori.
In sostanza, Zhang Guotao riteneva che il Kuomintang non solo non fosse un vero partito nazionalista ma che non era neanche un vero partito. Proponeva quindi che nei centri operai dove il Kuomintang non aveva influenza non gli fosse lasciato organizzare sue sezioni, mentre solo a Canton e Hong Kong il lavoro del PCdC nel campo operaio era costretto ad essere condotto all’interno del Kuomintang.
Prosegue la lettera di Zhang Guotao «Non appena la conferenza si è conclusa, sono emersi i suoi errori. L’atmosfera di opposizione alla tesi del nostro rapporto con il Kuomintang si è sviluppata nelle sezioni del Partito e gli oppositori possono essere in maggioranza. Inoltre grandi gruppi come Changsha, Hankow e Pechino cercavano di esigere una conferenza del partito, presto convocata ancora una volta per risolvere la questione dei nostri rapporti con il Kuomintang».
Gli stessi vertici del PCdC, in una riunione dell’Esecutivo del 24-25 novembre 1923, erano costretti a riconoscere che le risoluzioni sul movimento nazionale e la questione del Kuomintang, stabilite al Terzo Congresso del Partito, non avevano ricevuto un sostegno sostanziale dalla base del partito. Nel rapporto dell’Esecutivo si affermava: «La risoluzione del Congresso non è stata pienamente attuata. a) C’è qualche dubbio tra i compagni sulla risoluzione; b) Il KMT stesso non sta gestendo le cose in modo rapido e risoluto; c) Ci sono sospetti reciproci tra compagni e membri del KMT, e ci sono differenze nelle convinzioni politiche; e d) il nostro partito ha difficoltà economiche. Per questi quattro motivi il piano originario di istituire al più presto importanti filiali rispettivamente nel Nord e nel Centro della Cina non è stato realizzato».
Nel rapporto si riconosce che a quel tempo i comunisti avevano partecipato alla creazione di una sola sezione del KMT, a Pechino. Molto arretrata era la situazione negli altri centri: a Tianjin, Harbin e Hunan, gli sforzi per formare sezioni del KMT erano ancora in corso; nell’Hubei e a Nanchino c’erano consultazioni con il KMT; nello Shandong e Sichuan organizzazioni del KMT erano già state istituite da membri del partito nazionalista; nell’Anhui, invece, i membri del KMT si erano divisi in due fazioni, nessuna delle quali con appoggi reali e, pertanto, i comunisti dovevano creare una nuova sezione del KMT anche lì.
Nonostante l’opposizione alla tattica stabilita al Terzo Congresso e le difficoltà riscontrate nella sua implementazione, i vertici del PCdC confermavano di proseguire sulla strada intrapresa. La riunione del novembre 1923 dell’Esecutivo del PCdC condannò risolutamente la “deviazione di sinistra” dalla politica del fronte unico e adottò una decisione che ordinava ai comunisti di partecipare attivamente alla riorganizzazione del partito nazionalista.
Nella Risoluzione riguardante l’attuazione dei piani del movimento nazionalista si affermava:
«Il movimento nazionalista è il fulcro del nostro presente lavoro. Questo perché,
attualmente, il movimento operaio, contadino, studentesco e femminile fanno
tutti parte del movimento nazionalista. Pertanto, secondo la risoluzione del
Congresso, abbiamo elaborato il seguente piano per il movimento nazionalista:
«1) Il movimento nazionalista si concentrerà sull’ampliamento del numero dei
membri del KMT e sulla rettifica delle sue tendenze politiche poiché il
movimento nazionalista ha bisogno di un partito forte che lo guidi.
«a) Ampliare l’organizzazione: nei luoghi in cui il KMT ha una sezione, i nostri
compagni si uniscono ad essa (...) Nei luoghi dove il KMT non ha sezioni (...) i
nostri compagni dovrebbero aiutarlo a crearle. Le nuove sezioni dovrebbero
seguire il programma e la costituzione dell’ufficio centrale del KMT e
distribuire le tessere del partito.
«b) Dovremmo correggere le tendenze politiche del KMT e, in conformità con il
principio nazionalista incarnato nei Tre Principi del Popolo, convincerlo ad
opporsi all’imperialismo e condurre propaganda contro di esso. Nel movimento
nazionalista, il movimento per opporsi all’imperialismo è più importante del
movimento contro i Signori della Guerra. Ogni volta che c’è un conflitto tra i
Signori della Guerra e gli imperialisti, dovremmo sostenere i signori della
guerra (...)
«2) Il KMT è sicuramente la forza centrale del movimento nazionalista. La sua
forza si fonda sul sostegno di diverse organizzazioni popolari. Dobbiamo fondare
o unirci alle organizzazioni progressiste in nome del KMT».
La risoluzione impartiva direttive precise: i comunisti, pur restando membri del PCdC, dovevano aderire alle sezioni del Kuomintang nei centri dove queste erano già presenti o creare essi stessi sezioni del Kuomintang dove ancora non c’erano; inoltre, avrebbero dovuto anche fondare o aderire a varie organizzazioni progressiste a nome del KMT al fine di rafforzare il sostegno attorno al partito nazionalista.
Ci si doveva disciplinare al programma dettato dai vertici del KMT e la “correzione” delle tendenze politiche del KMT doveva svolgersi “in conformità con il principio nazionalista incarnato nei Tre Principi del Popolo”. Ma sottomettersi i comunisti a tali direttive significava accettare il programma borghese di Sun Yat-sen e la direzione politica del partito nazionalista. La soluzione della questione nazionale veniva collocata al disopra degli interessi di classe e della sua lotta.
Il 25 dicembre 1923 l’Esecutivo del PCdC emetteva la “Circolare Numero 13” che obbligava ancora una volta tutti i comunisti ad entrare nel Kuomintang. Per accelerare il processo della sua “riorganizzazione” avrebbero fatto ogni sforzo per garantire l’elezione al prossimo Congresso del KMT, fissato per il gennaio 1924, non solo di comunisti ma anche di figure “relativamente progressiste”. Inviati speciali furono spediti nelle sezioni del Partito per implementare tali decisioni.
Alcuni capi del PCdC vennero a sostenere queste decisioni nel campo della tattica con rinnovate formulazioni teoriche, in sostanza esagerando il carattere rivoluzionario della borghesia e del suo partito nazionale. Tra questi vi era un certo Mao Zedong, appena eletto nel Comitato Centrale.
Subito dopo la chiusura del Terzo Congresso, nel luglio del 1923, scrisse un articolo dal titolo “Il colpo di stato di Pechino e i mercanti”. Secondo Mao sarebbero i mercanti, cioè la borghesia, a sentire “più acutamente e più urgentemente” le sofferenze della duplice oppressione ai militaristi locali e agli imperialisti stranieri, e, sebbene la rivoluzione nazionale per rovesciare militaristi e imperialisti “è la missione storica del popolo cinese” nel suo insieme (commercianti, operai, contadini, studenti e insegnanti, nella formulazione di Mao), a causa della contraddizione tra gli interessi economici dei mercanti e quelli degli stranieri e dei militaristi (“le posizioni delle potenze straniere e dei militaristi da un lato e dei mercanti dall’altro sono veramente incompatibili”, scriveva), il ruolo dei mercanti era considerato da Mao “più urgente e più importante” rispetto al resto del “popolo”.
In tal modo, teorizzando un ruolo preminente dei mercanti, e quindi della borghesia, ci si allinea alla classica posizione del menscevismo, che lascia la guida della rivoluzione nei paesi ancora arretrati alla borghesia nazionale. Già Lenin aveva chiarito che «la rivoluzione borghese è impossibile come rivoluzione della borghesia», separando definitivamente il bolscevismo dalla corrente menscevica. La interpretazione menscevica dello sviluppo rivoluzionario nei paesi arretrati, secondo cui il giogo imperialista rendeva rivoluzionaria la borghesia nazionale dei paesi coloniali e semicoloniali, addirittura ancora più rivoluzionaria della borghesia antifeudale russa nelle formulazioni successive, sarà la stessa con la quale l’Internazionale ormai caduta sotto il controllo di Stalin giustificherà tutte le direttive imposte ai comunisti cinesi, che porteranno alla tragica sconfitta della rivoluzione proletaria in Cina.
(continua al prossimo numero)
Dopo circa tre anni di lavori, le riforme preannunciate da Lord Morley divennero legge solo nel 1909. Al di là della propaganda, erano volte a tutelare quei gruppi sociali sulla cui alleanza si basava il governo della Regina in India. Oltre ai grandi proprietari terrieri, mercanti e uomini d’affari, erano considerati alleati del Raj i notabili musulmani in fase ascendente. Non stupisce quindi che nel 1910 fossero eletti al Consiglio vicereale, 11 musulmani su 27.
Il Congresso, d’altro canto, riteneva queste riforme profondamente insoddisfacenti.
La politica del governo indiano era volta a limitare l’importanza del partito del Congresso e a ridurre all’impotenza le correnti nazionaliste più radicali. In buona parte lo scopo era stato raggiunto perché il Congresso si era spaccato e la “corrente estremista” era di fatto dispersa. Tramite un’accorta politica d’incentivi si era inoltre favorita l’ascesa di un partito musulmano panindiano, caratterizzato da posizioni nettamente distinte da quelle del Congresso. Inoltre, la posizione della dirigenza di Aligarh, e dell’aristocrazia che la sosteneva, era stata rafforzata dai cospicui successi ottenuti con la concessione degli elettorati separati.
Questi erano un sistema di voto in cui le diverse comunità religiose o etniche dell’India potevano eleggere i propri rappresentanti in corpi legislativi distinti, il che garantiva ai rappresentanti musulmani una quota di seggi nei Consigli legislativi provinciali e centrali.
Tuttavia, negli anni immediatamente precedenti la Prima Guerra mondiale un insieme di fattori vanificò gran parte dei successi ottenuti dagli inglesi nello spingere i musulmani su posizioni politiche ostili al Congresso.
Il primo di questi elementi fu la posizione presa da Gokhale sugli elettorati separati. Questi erano stati dapprima fortemente criticati dalla maggioranza dei congressisti, non solo da alcuni influenti esponenti dell’induismo politico ma anche da elementi laici come Baneijea. Gokhale però era convinto della necessità che il Congresso venisse incontro a ogni ragionevole richiesta di qualsiasi parte della popolazione, in modo da promuovere un’atmosfera di collaborazione. Da questo punto di vista gli elettorati separati per i musulmani avrebbero fornito loro una tutela politica effettiva, liberandoli, fra l’altro, dalla necessità di dipendere dalla protezione del governo coloniale. In questa situazione, concludeva Gokhale, «i loro interessi sono in linea di massima a tal punto identici ai nostri che non possono fare a meno, entro breve, di venire a schierarsi con noi».
La posizione presa da Gokhale ebbe il risultato di mantenere aperte le linee di
comunicazione per una eventuale trattativa con la Lega Musulmana, che a sua
volta iniziò a essere spinta verso il Congresso da altri due eventi che si
verificarono nel 1911.
77. - 1911: La guerra italo-turca e la nuova capitale del Bengala
Il primo fu l’attacco nel 1911 dell’Italia all’Impero Ottomano, reso possibile anche dalla benevola neutralità inglese. La guerra innescò lo scoppio della Prima Guerra balcanica, l’8 ottobre 1912, quando anche il Regno del Montenegro dichiarò guerra all’Impero Ottomano, il quale, fatta eccezione per Costantinopoli, perse tutti i suoi residui possedimenti in Europa. Questi eventi, insieme a una serie di massacri perpetrati in Persia dai russi, allora alleati degli inglesi, destarono disapprovazione e sdegno presso i musulmani indiani, profondamente influenzati dal panislamismo, e che percepirono l’Inghilterra come il regista occulto dietro l’attacco finale all’ultimo grande Stato islamico indipendente.
Il secondo evento importante, sempre nel 1911, è la revoca da parte del nuovo re
Giorgio V, durante una visita in India, della spartizione del Bengala spostando
la capitale da Calcutta a Delhi. Questo, giunto del tutto inaspettato, fu visto
dai musulmani indiani come il venir meno a una serie di impegni nei loro
confronti presi dalle autorità coloniali. Fra i più politicizzati emerse la
convinzione che per tutelare gli interessi della comunità musulmana in India
fosse più opportuno cercare un accordo diretto con il Congresso. In questo
contesto la dirigenza filo-britannica della Lega Musulmana si trovò sempre più
in difficoltà. Alla fine del 1912, in una riunione della Lega sotto la
presidenza dell’Aga Khan, venne approvata all’unanimità una mozione che
ricalcava quasi alla lettera il “credo del Congresso” e che auspicava la
promozione dell’unità nazionale.
78. - La crisi del Raj
Gli anni dal 1914 al 1947 furono segnati da una ineluttabile crisi del sistema di potere coloniale, dovuta al sovrapporsi di tre processi. Il primo fu il declino a livello sia economico sia politico-militare dell’Inghilterra; il secondo la crescita del nazionalismo indiano che, subito dopo la Prima Guerra mondiale, si trasformò da fenomeno sostanzialmente elitario a movimento di massa; il terzo fu altrettanto fondamentale, ovvero la progressiva perdita d’importanza economica dell’India per la Gran Bretagna. Un processo che da una parte vedeva l’immensa povertà del sub continente, dall’altra l’incapacità e la reticenza del regime coloniale a promuovere lo sviluppo economico in India.
L’India invece era molto importante per l’Inghilterra perché ottemperava a un triplice “impegno imperiale”: il pagamento delle home charges e degli altri debiti contratti con l’Inghilterra; il ruolo di acquirente di manufatti industriali inglesi e di esportatrice di prodotti agricoli e di materie prime, vitali per procurarsi la valuta; infine, il libero utilizzo dell’esercito indiano – pagato dai contribuenti indiani – per fini “imperiali”, ovvero gli interessi della borghesia britannica.
Solo il primo obiettivo continuò a essere perseguito con successo (e solo fino agli anni Quaranta quando, l’India cessò di essere debitrice e divenne creditrice dell’Inghilterra), mentre gli altri due “impegni” divennero sempre più problematici già a partire dal tempo della Prima Guerra mondiale.
L’economia inglese, come tutte le capitalisticamente avanzate dell’epoca, attraversò un processo di mutamento che progressivamente la rese meno dipendente dalle colonie, sia per l’acquisto di materie prime sia per la vendita dei manufatti. In particolare l’industria chimica rese disponibili sostanze di sintesi a buon mercato che rimpiazzavano i prodotti delle agricolture tropicali o subtropicali come, ad esempio, l’indaco. L’industria inglese incominciò a produrre beni che, pur avendo un ampio mercato nelle altre economie avanzate, erano scarsamente commerciabili nelle colonie a causa del loro limitato potere d’acquisto. Veicoli, prodotti chimici e apparecchiature elettriche, per esempio, che costituivano i nuovi settori dell’economia britannica che non avevano gran mercato in India. Per di più le esportazioni tradizionali della Gran Bretagna in India declinarono a causa della duplice concorrenza delle nascenti industrie locali e giapponesi: ad esempio i manufatti di cotone.
Alla vigilia del secondo macello mondiale l’India era debitrice nei confronti dell’Inghilterra, come era sempre stata; ma nel 1946 la situazione si era capovolta e l’Inghilterra doveva all’India 1,3 miliardi di sterline, una cifra che rappresentava «oltre 17 volte gli introiti annui del governo indiano e un quinto del prodotto nazionale lordo della Gran Bretagna».
Ed è proprio su questo scenario che possiamo lavorare per addivenire a una
corretta valutazione degli avvenimenti storici da qui fino all’indipendenza del
1947.
79. -L’esercito indiano e la Prima Guerra mondiale
A questi già determinanti fattori si aggiunse la progressiva incapacità per l’impero inglese di utilizzare l’esercito indiano. Durante la Prima Guerra mondiale l’apporto degli indiani alla vittoria dell’Intesa fu notevole. Ma i costi per il suo dispiegamento, soprattutto quando impiegato su larga scala, crescevano. Le richieste di uomini che arrivavano da Londra si scontrarono sempre più con la resistenza dello stesso governo coloniale. Già nel 1927 e nel 1931 i piani dello Stato Maggiore indiano prevedevano come principale l’impegno dell’esercito in Afghanistan e ne limitavano il ruolo imperiale al presidio delle basi strategiche in Asia orientale (Birmania, Cina, Singapore e Hong Kong) e nel Medio Oriente (Aden e i campi petroliferi iracheni), i cui i costi furono trasferiti dai contribuenti indiani a quelli inglesi.
Inoltre, dagli anni Trenta fu palese che, nonostante il notevole peso che il mantenimento dell’esercito continuava a rappresentare per le finanze, le risorse impiegate a questo fine nei precedenti quindici-venti anni erano state insufficienti. Gli indiani non si mantenevano al passo con eserciti come quelli dell’Egitto, dell’Iraq e dell’Afghanistan. Con le avvisaglie di un imminente nuovo conflitto mondiale e una popolazione indiana sempre più in fermento, nel novembre 1939 il governo inglese dovette assumersi una parte del mantenimento dell’esercito indiano e far fronte all’intero costo del suo ammodernamento.
Nell’agosto 1914 l’India venne a sapere di essere entrata in guerra al fianco
dell’Inghilterra contro gli Imperi Centrali. Subito vi furono manifestazioni di
lealtà alla Corona e dichiarazioni di solidarietà da parte di diversi settori
della borghesia indiana. Questo mirava a indurre gli inglesi a nuove e più
generose concessioni politiche, sicuri dell’appoggio dei dirigenti coloniali a
un loro progetto di riforme dell’agosto del 1915 e del novembre del 1916, in cui
si prevedeva che il governo inglese concedesse formalmente all’India
l’autogoverno, pur nell’ambito dell’Impero. Per il momento le buone intenzioni
di qualche politico del governo indiano non trovarono alcun riscontro in
Inghilterra, lasciando quindi campo aperto alla radicalizzazione politica. Tale
prospettiva sembrò concretizzarsi nel 1915 con la ricomparsa di Bal Gangadhar
Tilak dopo i sei anni di carcere nelle galere inglesi di Mandalay. Oltre a Tilak
anche la figura di Annie Besant rivestì un ruolo importante per la politica
indiana.
80. - Annie Besant e l’alleanza tra Congresso e Lega
La Besant, inglese di origini irlandesi, si trasferì in India nel 1893 per sostenere la società teosofica e con il tempo si convinse che gli indiani fossero ormai maturi per l’autogoverno. La congiuntura politica determinata dalla guerra la persuase che si fosse arrivati al momento in cui l’Inghilterra doveva fare concessioni di una certa portata. Nel 1914 entrò a far parte del Congresso, promotrice di una linea articolata in tre punti principali: riunificazione fra moderati ed estremisti; un’alleanza fra il Congresso e la Lega Musulmana; una campagna di agitazione costituzionale in tutto il subcontinente per procurare un vasto appoggio popolare alla richiesta dell’autogoverno. La riunificazione fra moderati ed estremisti o, per meglio dire, la riammissione degli estremisti nel Congresso, se da un lato ebbe subito l’assenso di Tilak, dall’altro, e solo in un primo momento, si scontrò con la decisa opposizione di Gokhale e Mehta, che nel 1915 morirono entrambi e le lasciarono campo libero.
Grazie all’influenza di Annie Besant il congresso di Bombay nel Natale 1915 modificò la costituzione del 1908: la possibilità di eleggere i delegati del Congresso fu conferita a tutte le associazioni che avessero fra i loro obiettivi «l’ottenimento dell’autogoverno nell’ambito dell’Impero britannico mediante l’uso di mezzi costituzionali». Nel 1916 Tilak accettò l’articolo numero 1 del Congresso e nel dicembre dello stesso anno partecipò al Congresso di Lucknow durante il quale si costituì formalmente l’alleanza organica fra il Congresso e la Lega Musulmana.
A partire dal 1914 fu lanciata un’agitazione di massa volta a diffondere fra gli indiani l’idea che l’autogoverno fosse un obiettivo legittimo. Inizialmente la Besant cercò di coinvolgere il Congresso ma, di fronte ai dubbi e alle esitazioni dei capi moderati, decise di creare una propria organizzazione: l’All-India Home Rule League, inaugurata nel settembre 1916, alcuni mesi dopo che Tilak aveva creato l’Indian Home Rule League. Sin dalla loro fondazione le due organizzazioni collaborarono suddividendosi il Paese in distinte aree geografiche d’influenza.
Nel giugno del 1917 il governatore della presidenza di Madras confinò la
presidentessa e i suoi due principali collaboratori nella piccola stazione
collinare di Ootacamund, proibendo loro ogni attività politica. Questo gesto
eclatante si rivelò un grossolano errore che favorì la repentina crescita del
movimento per la Home Rule e trasformò la Besant in eroe nazionale. Per
distendere gli animi, il 20 agosto 1917 il neoeletto Segretario di Stato per
l’India Edwin Samuel Montagu dichiarò: «la politica del governo di Sua Maestà,
sulla quale il governo dell’India è completamente d’accordo, è nel senso della
crescente partecipazione degli indiani a tutte le branche dell’amministrazione e
del graduale sviluppo di istituzioni basate sull’autogoverno, in considerazione
della progressiva realizzazione di un governo responsabile in India come parte integrante dell’impero».
81. - La rivoluzione russa e la questione coloniale
Nel 1917 la nostra rivoluzione in Russia fu seguita con interesse da molti indiani politicizzati, che da tempo sottolineavano le analogie esistenti fra l’Impero dello zar e quello anglo-indiano. Tra questi c’era anche Manabendra Nath Roy che, dopo aver dato vita al Partito Comunista messicano nel 1919 (il primo dopo quello russo), aveva partecipato al Secondo Congresso dell’Internazionale Comunista. Tornato in patria come agente dell’Internazionale non aveva trovato l’accoglienza sperata tra i marxisti indiani; nemmeno riuscì a stabilire un contatto stabile con le classi operaia e contadina. Nel 1925 diede il suo contributo alla costituzione formale del Partito Comunista indiano. Vicino alle posizioni di Bucharin, fu espulso da Stalin nel 1929.
Ma davvero poche erano le similitudini tra la Russia sovietica e l’India, in particolare il giovane proletariato indiano non aveva alle spalle alcun partito rivoluzionario radicato e organizzato per la lotta.
Le riforme promesse da Edwin Montagu nel 1917 non arrivarono; una bozza fu pubblicata solo un anno dopo, l’8 luglio 1918, ma si trattava di concessioni considerate ormai insufficienti. Due sessioni speciali del Congresso e della Lega Musulmana, convocate a Bombay nell’agosto 1918, dopo un lungo dibattito finirono comunque per accettare il progetto di riforma, pur richiedendone delle modifiche. Alla sessione dell’agosto 1918 non partecipò un gruppo di moderati, fra cui Baneijea, che preferirono abbandonare il Congresso, preoccupati per la crescita al suo interno di forze sempre più radicali.
L’11 novembre 1918 la Germania firmò l’armistizio, che segnò la fine della Prima Guerra mondiale. Il 19 marzo del 1919 furono approvate dal parlamento britannico una serie di proposte legislative, ideate da sir Sidney Rowlatt, secondo cui in India avrebbe dovuto mantenersi lo stesso regime speciale adottato durante il conflitto. Già nel febbraio, prima ancora della approvazione della legge, si era cominciato a parlare di una campagna di disubbidienza civile.
Pochi anni prima, al Secondo Congresso dell’Internazionale, erano state esposte
le nostre Tesi sulla questione nazionale e coloniale, un chiaro indirizzo
teorico e pratico per tutti i comunisti. Lenin, già dal 1916, nell’articolo “La
rivoluzione socialista ed il diritto delle nazioni all’autodecisione” distingue,
alla Tesi numero sei, tre tipi di Paesi in rapporto all’autodecisione dei popoli.
Il primo era formato dalle nazioni capitalisticamente avanzate, in cui il
movimento nazionale borghese progressivo era terminato da tempo. Il secondo
includeva i Paesi dell’Europa orientale, l’Austria, i Balcani e la Russia dove
nel XX secolo si erano in parte sviluppati i movimenti nazionali. Nel terzo
c’erano i Paesi semicoloniali. Qui i socialisti «devono sostenere gli elementi
più rivoluzionari dei movimenti democratici borghesi di liberazione nazionale,
aiutarli nella loro insurrezione, e se il caso si presenta nella loro guerra
rivoluzionaria contro le potenze imperialiste che li opprimono». Nell’articolo
“A proposito dell’opuscolo di Junius”, commentando uno scritto di Rosa
Luxemburg, criticava la tesi secondo cui non vi potevano esser più guerre
nazionali. «Ogni guerra è continuazione della politica con altri mezzi.
Continuazione della politica di liberazione nazionale delle colonie saranno,
necessariamente, le guerre nazionali da parte di queste contro l’imperialismo».
Aveva anche previsto che «le forze motrici della rivoluzione nazionale
democratica borghese in Asia saranno gli operai e i contadini», auspicando «la
più stretta alleanza tra il proletariato comunista dell’Europa occidentale e il
movimento rivoluzionario contadino dell’Oriente, delle colonie e dei paesi
arretrati in genere».
82. - Gandhi: come disarmare le masse
L’uomo che sostenne questa iniziativa e che, subito dopo, si impegnò a concretizzarla fu Mohandas Karamchand Gandhi, che ben presto i suoi connazionali l’avrebbero indicato come il Mahatma (“grande anima”), un titolo indiano con cui venivano chiamati i grandi visionari.
Già nel 1919 Gandhi (1869-1948) non era uno sconosciuto. Gujarati, nativo della piccola città di Portbandar, aveva trascorso gran parte della sua vita in Sud Africa (1893-1914). All’inizio vi esercitò da avvocato e poi divenne il riconosciuto capo politico della locale comunità indiana, composta da circa 150.000 persone, guidandola in una lotta contro le discriminazioni razziali. Figura estremamente controversa, dopo la sua morte verrà riconosciuto come il padre della nazione indiana; la borghesia mondiale, con il tempo, lo santificherà per i metodi di lotta “non violenti”, da lui denominati satyagraha («fermezza nella verità»).
Principi ed ideali che non gli impedirono di schierarsi dalla parte dei macellai imperialisti britannici, quando tornava utile. Nel 1899, agli inizi della seconda guerra boera, dichiarò che gli indiani dovevano sostenere lo sforzo imperiale per legittimare la loro richiesta di cittadinanza. Organizzò quindi un corpo di ambulanzieri volontari composto da oltre 1.000 indiani di cui 800 coolie (lavoratori manuali). Nel 1906 creò il Corpo Sanitario Indiano per sostenere la Gran Bretagna nel portare assistenza nella guerra contro gli zulu durante la Prima Guerra mondiale, promuovendo anche una campagna di reclutamento di soldati indiani.
Tornato in India nell’aprile del 1917, Gandhi, influenzato dal vento del nazionalismo, fu coinvolto in una serie di agitazioni: la prima nel Bihar, dove i contadini erano sfruttati dai piantatori inglesi di indaco, e altre, entrambe nel Gujarat, a favore dei contadini del distretto di Kaira e degli operai di Ahmedabad. I contadini di Kaira chiedevano la remissione dell’imposta terriera, prevista dal Famine Code in seguito al cattivo raccolto dell’inverno 1917-18 ma non concessa dal governo coloniale; gli operai di Ahmedabad chiedevano un aumento salariale, originariamente incentivo in un periodo di peste ma che i padroni avevano annullato una volta terminata.
Nei tre casi Gandhi ottenne alcuni moderati successi che gli procurarono un certo seguito, in particolare nel Gujarat, tra i contadini e gli operai. Ad Ahmedabad fondò il movimento sindacale. Il tutto però doveva essere circoscritto alla mediazione tra le parti. È significativo ricordare che nel grande sciopero tra il dicembre del 1918 e il gennaio del 1919 gli operai tessili di Bombay avessero chiamato Gandhi a dirigere la loro lotta; quest’ultimo però declinò l’invito molto probabilmente perché non intendeva sostenere la lotta degli operai maratti contro gli imprenditori indiani, prevalentemente gujarati e parsi, che avevano iniziato ad appoggiarlo politicamente ed economicamente.
Gandhi non fu di sicuro l’elemento più rivoluzionario del movimento borghese indiano ma attraverso il metodo della non violenza contribuì a disarmare le masse indiane di fronte alla ferocia dei loro oppressori.
Pur battendosi per i paria, gli ultimi delle caste indiane, sosteneva la divisione della società in caste, che riteneva fondamentale. Nel 1920 scriveva: «Penso che le caste abbiano salvato l’induismo dalla disintegrazione. Ma come tutte le altre istituzioni hanno sofferto di “escrescenze”. Considero fondamentali, naturali ed essenziali soltanto le quattro divisioni. Le numerosissime sottocaste possono essere talvolta un vantaggio, ma il più delle volte rappresentano un ostacolo».
Nel 1931 su “Prometeo” scrivevamo: «Questo monaco colla sua politica della “non resistenza” rappresenta il più valido sostegno dell’imperialismo britannico per mantenere nell’oppressione i 300 milioni di indù e che la sua auspicata “indipendenza” significherebbe null’altro che la dittatura della classe della borghesia indigena e un identico sfruttamento per il proletariato».
L’ascesa di Gandhi segnava in definitiva il tramonto di Tilak e del suo tentativo di organizzare una coalizione di forze e interessi nazionali in grado di rappresentare la maggioranza della borghesia indiana. Le posizioni di compromesso e ambiguità che Tilak aveva espresso in quegli anni fecero sì che alla sua morte i suoi seguaci si dividessero in diversi gruppi.
Nel frattempo Gandhi era spalleggiato da un gruppo di intellettuali gujarati residenti a Bombay, esponenti della All-India Home Rule. Da lì in poi questa importante sezione della Lega della Besant avrebbe subito sempre più l’influenza del Mahatma.
Alla fine della guerra Gandhi era già un capo politico con una notevole esperienza e un solido seguito nel Gujarat e a Bombay, con contatti importanti nell’ala radicale della comunità musulmana. Il 24 febbraio 1919, durante un periodo di forti tensioni sociali e importanti scioperi in diverse città indiane, annunciò il lancio di una campagna di disubbidienza civile contro l’approvazione delle leggi Rowlatt. Grazie all’assenza di Tilak, in Inghilterra per cercare un appoggio del Labour britannico, e al declino di Annie Besant, le cui posizioni apparivano oramai troppo moderate, Gandhi fu in grado di valersi delle due leghe per la Home Rule.
Spinto dal basso dalle crescenti lotte, il metodo inizialmente scelto da Gandhi, una volta che la legge Rowlatt venne approvata, fu di indire una serie di harlal (scioperi generali) in tutta l’India. I primi si tennero il 30 marzo e il 6 aprile, a seconda delle zone e si distinsero per la partecipazione e le scene di fraternizzazione fra indù e musulmani. La situazione sfuggì ben presto al controllo sia dell’imperialismo inglese sia dello stesso Gandhi e in varie parti del subcontinente scoppiarono disordini con morti e feriti, in particolare nel Punjab ma anche a Bombay, Ahmadabad e Calcutta. Richiamato all’ordine dalla codarda borghesia indiana, Gandhi il 18 aprile 1919 sospese il movimento di disubbidienza civile creando successivamente un corpo di volontari da addestrare alle tecniche di lotta non violente, che avrebbero inquadrato e diretto i futuri movimenti di massa.
Nel 1919, a seguito delle spese eccezionali sostenute dal governo indiano nel primo conflitto mondiale, vi fu una fortissima crescita dei prezzi; l’anno seguente il processo inflazionistico continuò ma, a peggiorare le cose, il boom produttivo avviato dalla guerra fu seguito da un periodo di recessione. La crisi economica coinvolse non solo le classi urbane ma anche settori consistenti del mondo rurale, soprattutto nelle Province Unite e nel Bihar.
In un contesto caratterizzato dal deterioramento della situazione economica si inserirono ulteriori fattori. Il primo era legato alla questione del Punjab, in cui i disordini verificatisi in occasione del movimento satyagraha erano stati particolarmente gravi e sfociarono il 13 aprile 1919 nell’imposizione della legge marziale. In quello stesso giorno, ad Amritsar, l’alto ufficiale a cui era toccato l’incarico di mantenere l’ordine pubblico, il generale Reginald Dyer, diede l’ordine di aprire il fuoco su una folla disarmata che assisteva a un comizio, uccidendo alcune centinaia di persone e ferendone oltre un migliaio. Nei giorni successivi lo stesso Dyer impose una serie di punizioni collettive, studiate in modo da risultare particolarmente umilianti.
L’altro fattore che contribuì a radicalizzare parte della popolazione fu il
destino dell’Impero Ottomano, uscito sconfitto dalla Prima Guerra mondiale.
Ancor prima della fine della guerra, infatti, Inghilterra, Francia e Russia
zarista si erano accordate per dividersi le spoglie del “Grande Malato”. Molti
musulmani indiani con idee panislamiche chiedevano che un Califfo continuasse a
regnare sull’insieme dell’Impero. Si trattava di un progetto irrealistico,
osteggiato non solo dalle grandi potenze ma dalle stesse popolazioni, turchi
inclusi, ma la questione dell’integrità territoriale dell’Impero, presentata
come difesa dell’istituzione religiosa, coinvolgeva la grande maggioranza dei
musulmani indiani, sia intellettuali sia le masse. Nel 1919 nacquero e si
svilupparono rapidamente i comitati locali per il Khilafat (califfato) e a
novembre si tenne il primo convegno organizzativo panindiano.
83. - Governo centrale e governi provinciali
Nello stesso anno furono promulgate le prime riforme. La legge prevedeva che il governo centrale e le province avessero bilanci separati, e l’anno successivo uno schema che suddivideva le entrate tributarie fra i governi centrale e provinciali: al primo andavano i proventi dei monopoli dell’oppio e del sale, quelli delle imposte sulle entrate e delle tariffe doganali; i governi provinciali riscuotevano l’imposta terriera, le tasse sull’irrigazione, sul monopolio degli alcolici e la vendita dei valori bollati. Questa ripartizione escludeva che una quota prefissata e cospicua delle entrate fiscali fosse in alcun modo utilizzata dall’Impero. Inoltre, la legge stabiliva che il funzionamento delle riforme sarebbe stato sottoposto a revisione ogni dieci anni, con la possibilità di devolvere ulteriori poteri agli indiani.
La norma fu presentata come un concreto passo in avanti verso il “governo responsabile” promesso nel 1917, ovvero l’autogoverno. Era un meccanismo che cooptava nel sistema coloniale circa il 3% più ricco della popolazione indiana, che era anche l’elettorato attivo, devolvendo a queste classi (essenzialmente proprietari terrieri, mercanti e prestatori di denaro, industriali e ricchi professionisti) la gestione di oltre un terzo delle risorse finanziarie delle province e offrendo a quest’élite la possibilità di influenzare, assai più di quanto fosse mai avvenuto in precedenza, la destinazione delle restanti risorse.
In conclusione, se da una parte le riforme del 1919 furono del tutto
insufficienti rispetto agli ideali e alle necessità del nascente nazionalismo
indiano, dall’altra rappresentarono un’offerta imperdibile per una parte della
borghesia indiana e per quei politici che ne erano i portavoce.
84. - Il movimento di non cooperazione non violenta
Gandhi si trovò a far fronte a questi due interessi inconciliabili: da una parte operai e contadini che, seppur privi di un partito realmente rivoluzionario ma spinti da una crisi economica di grandi dimensioni, ponevano realmente la questione sociale unita a quella nazionale; dall’altra una parte della borghesia indiana, ben contenta di accettare queste parziali concessioni.
Nel 1920 Gandhi, per deviare dalle loro aspirazioni operai e contadini, si dette a rilanciare la lotta anticoloniale sul terreno della non cooperazione e della non violenza. Tale politica attirò potenti alleati, fra cui il movimento Khilafat, rappresentato dai fratelli Ali, suoi dirigenti, che erano stati messi in libertà con un’amnistia reale. La strategia proposta da Gandhi prevedeva il progressivo boicottaggio dello Stato coloniale attraverso la rinuncia ai titoli e agli incarichi onorifici, le dimissioni dagli impieghi statali civili e l’evasione fiscale. Successivamente aggiunse le dimissioni dall’esercito e dalla polizia e il boicottaggio delle elezioni. Nonostante questa azione così moderata, molti nel Congresso e nella Lega Musulmana temevano che la rivoluzione nazionale contro gli inglesi si trasformasse in rivoluzione sociale contro i loro strati di privilegiati. Gli esiti del movimento contro la spartizione del Bengala costituivano un memento preoccupante di questo pericolo, nonché quanto accaduto nella doppia rivoluzione in Russia.
La politica di Gandhi prevalse: in alleanza con i khilafatisti si impadronì progressivamente di gran parte della Lega della Besant (che sarebbe poi confluita nel Congresso), della Lega musulmana e infine, come vedremo, dello stesso Congresso.
Morto Tilak, il 1° agosto 1920 il gandhismo conquistò il Congresso. Durante la sessione di Nagpur del dicembre 1920 fu adottata una nuova costituzione. L’articolo 1 affermava che il fine del Congresso era «il raggiungimento dello swarajya da parte del popolo dell’India per mezzo di tutti i mezzi pacifici e legittimi». Swarajya o swaraj è un termine con un certo margine d’ambiguità, che poteva essere interpretato a livello politico come autogoverno o indipendenza e a livello personale come pieno controllo della propria vita. Gandhi affermò come l’obiettivo fissato dall’articolo 1 fosse il raggiungimento dell’«autogoverno completo, se possibile ancora in associazione con il popolo britannico, ma anche senza, nel caso che ciò fosse necessario».
Quando Gandhi trionfò a Nagpur la campagna di non cooperazione era già in corso, articolata su due livelli: da un lato il boicottaggio dello Stato coloniale e delle sue funzioni, dall’altro tramite strutture organizzative di lotta e quelli che potremmo definire dei contropoteri, istituzioni destinate a sostituirsi a quelle dell’apparato coloniale.
Il boicottaggio trovò espressione, oltre che nel rifiuto di titoli e carichi onorifici, nell’abbandono delle scuole da parte degli studenti e nel rifiuto di avvalersi dei tribunali. Furono istituiti scuole e organi di arbitrato “nazionali”.
Le dimostrazioni organizzate dei non cooperanti erano inquadrate da un Corpo di volontari, che, con la sessione di Nagpur, divenne parte del Congresso. Erano sovvenzionati da uno Swaraj Fund, o Tilak Fund, sempre ideato da Gandhi. La raccolta di fondi per la lotta anticoloniale divenne una parte importante del movimento. I contributi più consistenti arrivarono da industriali e uomini d’affari, ma un flusso continuo di donazioni, anche di scarsa entità, arrivava da gruppi sociali marginali, come i mendicanti di Puri o le prostitute di Barisal.
Un’altra iniziativa della non cooperazione introdotta in un secondo tempo fu il
boicottaggio dei prodotti dell’industria inglese: una strategia adottata dal
Mahatma per compiacere alle richieste degli industriali indiani.
(continua al prossimo numero)
Siamo ancora alla preistoria dell’ideologia borghese. Se andiamo ad esaminare
concezioni del XIII e del XIV secolo non è perché ci interessino particolarmente
in quanto tali: il partito non è un’accademia di studi storici o filosofici. E
neanche di studi marxisti. Ciò che ci interessa di quelle concezioni è quanto è
stato utile alla nascente borghesia, e che quindi ha fatto proprio. Il tutto
indipendentemente dalla fedeltà o meno alle dottrine in questione, quasi sempre
stravolte a seconda delle necessità delle varie società nelle varie epoche.
La scolastica
Scolastica significa filosofia della scuola: scholasticus nel medioevo era l’insegnante di arti liberali, e poi di filosofia e teologia, che insegnava nel chiostro e nella cattedrale, e poi nelle Università. Compito della Scolastica era portare l’uomo a comprendere la verità rivelata, grazie all’attività razionale, il che significava l’uso di una qualche determinata filosofia. Ma, non fidandosi della sola ragione, fa appello anche alla tradizione religiosa o filosofica, con l’uso delle auctoritates. Auctoritas è la decisione di un concilio, la sentenza di un padre della Chiesa, un detto biblico: se questo era un limite, era al tempo stesso un pregio, cioè la manifestazione del carattere comune e non individuale della ricerca. Manifestazione di ciò era anche il fatto che spesso gli scritti non erano firmati. Su questo singolo punto siamo perfettamente d’accordo: la proprietà intellettuale è la forma più spregevole di proprietà privata, che tende a separare la specie umana dall’utilizzo dei suoi migliori risultati. Anche su questo non abbiamo inventato nulla: abbiamo recuperato, non ecletticamente ma dialetticamente, una parte della nostra storia, della storia della specie, storia che, come abbiamo già scritto, rivendichiamo per intero, dalla clava al computer.
Scolastica è ogni filosofia che si pone come compito illustrare e difendere razionalmente una tradizione o rivelazione religiosa. Scolastiche furono nell’antichità il neoplatonismo e il neopitagorismo, nel medioevo il neoplatonismo e l’aristotelismo, nel mondo moderno la filosofia di Malebranche, di Berkeley, della destra hegeliana, di Rosmini, ecc.
Comunemente per Scolastica si intende la filosofia cristiana dal IX secolo circa al XVI, anche se possiamo collocarne l’inizio già nel IV con Agostino di Tagaste, il quale viene abitudinariamente catalogato come appartenente alla “Patristica”, classificazione che comprende la dottrina dei primi Padri della Chiesa.
Nei primi secoli del cristianesimo si alternavano le posizioni di chi rifiutava tutto il sapere precedente, in quanto pagano, e di chi lo riteneva poco in confronto alla Rivelazione, ma comunque non disprezzabile in quanto frutto della ragione umana, che era sì limitata ma comunque creata da Dio, e avente lo scopo di realizzarsi pienamente con e nella Rivelazione.
Agostino mette il neoplatonismo a base filosofica del cristianesimo, depurandolo
di alcuni aspetti, in quanto era pur sempre una filosofia pagana. Si prestava a
tale scopo molto meglio di altre filosofie per vari motivi: il principale era
che accettava il concetto di creazione dal nulla, il che lo rendeva accettabile
alle religioni cristiana, islamica ed ebraica. Le altre filosofie del mondo
greco, comprese quelle di Platone ed Aristotele, parlavano di un mondo eterno ed
increato, cosa inaccettabile per le religioni nominate. Alcuni secoli dopo
un’operazione simile avviene anche nell’islam e nell’ebraismo, sempre su una
base neoplatonica. Il neoplatonismo, unito allo stoicismo, resta sostanzialmente
alla base del cristianesimo per circa otto secoli, fino alla riscoperta di
Aristotele, nel XIII secolo.
Lo stereotipo dell’uniformità dei “secoli bui“
Gli intellettuali borghesi da alcuni secoli contrappongono una loro presunta libertà di pensiero alla sua mancanza e all’uniformità negli intellettuali dei “secoli bui” del medioevo. Quanto alla libertà di pensiero dei borghesi non è necessario insistere sull’insignificanza di tale espressione: ricordiamo solo quanto detto da Marx, che le idee dominanti sono le idee della classe dominante, tanto più false quanto più appaiono vere e addirittura scontate.
Il culto delle auctoritates è sicuramente forte e indiscusso nella Scolastica, ma questo non significa uniformità nelle sue dottrine e scritti. Per sostenere una data posizione se ne cercava una citazione a sostegno negli scritti di Agostino, Aristotele o altri; il sostenitore della posizione opposta allo stesso modo andava a cercare una citazione spesso nello stesso autore, a volte nella stessa opera, e quasi sempre la trovava. Così troviamo posizioni non coincidenti anche tra autori molto vicini.
Le classificazioni sono utili per orientarci, per cui parliamo di aristotelici,
averroisti, tomisti, ecc. Non esistono però due aristotelici, averroisti o
tomisti che la pensino allo stesso modo. Ogni autore fa una personale sintesi
dei vari classici, i quali a loro volta avevano fatto altrettanto. Tutto ciò
ovviamente mai mette in discussione la Rivelazione, ma vuole esserle di conferma.
L’originalità è un criterio a cui non attribuiamo alcuna importanza, ma quanto a
uniformità di pensiero i borghesi odierni non si distinguono particolarmente
dagli uomini della Scolastica: come questi non mettevano in discussione la
Verità rivelata, così quelli non mettono in discussione il Capitalismo. Verità
rivelata e Capitalismo erano e sono il denominatore comune di concezioni e
filosofie anche notevolmente diverse tra loro.
La riscoperta di Aristotele
Aristotele, filosofo greco del IV secolo a.C., e il suo maestro Platone, sono stati i filosofi a cui tutti i successivi si sono ispirati. Con la crisi e la fine dell’impero romano d’occidente, e del mondo antico in generale, molte opere, non solo di Aristotele, erano andate perdute, del tutto o in parte, per vari motivi: a causa di guerre e incendi e talvolta di fanatici cristiani e islamici. Questi, non sempre, ragionavano così: i testi in contrasto con i Sacri sono pericolosi e vanno distrutti; quelli che affermano le stesse cose sono inutili, e quindi vanno distrutti. Va detto che ci sono state diverse e importanti eccezioni a questo comportamento.
Molti testi di scienza, filosofia, astronomia, medicina, ecc. andati perduti nel mondo cristiano, erano invece conservati in quello islamico, a Il Cairo, a Marrakech, a Toledo, a Baghdad. Quest’ultima, capitale della dinastia abbaside, tra l’VIII e il X secolo fu centro di traduzioni e di una caccia a testi greci, arabi, persiani, indiani, ecc., riguardanti tutto lo scibile. Nell’XI e soprattutto nel XII secolo, a Toledo, a Palermo, a Costantinopoli, molti testi antichi furono tradotti in latino dall’arabo, dal greco, dal siriaco, ecc. Se a Toledo, arrivata nelle mani dei regni cristiani nel 1085, si traducevano testi dall’arabo e dall’ebraico, a Costantinopoli si traducevano dal greco, a Palermo da tutte queste lingue. Spesso i testi ebraici erano tradotti dall’arabo, e quelli arabi dal greco o dal siriaco. Tutti questi passaggi ne rendevano evidentemente incerta la traduzione e difficile la comprensione.
Importanti sono stati i commenti ad Aristotele da parte di Alessandro di Afrodisia, autore greco tra II e III secolo, tradotto in parte da Avicenna, e in seguito nel Rinascimento. Particolare importanza nel XII secolo hanno avuto i commenti ad Aristotele scritti nell’Al Andalus, la Spagna musulmana, cioè il califfato di Cordova, da Ibn Rushd, chiamato dai latini Averroè. Insieme ai suoi commenti molte opere di Aristotele prima sconosciute nel secolo successivo sono arrivate nel mondo cristiano, per lo più in traduzioni ebraiche. Ci sono stati traduttori di altra provenienza come Costantino Africano e l’inglese Adelardo di Bath, questi per testi in particolare di medicina e di scienza. Direttamente o attraverso Averroè erano arrivati testi in arabo e persiano di Al Kindi, Al Farabi, Avicenna, Al Gazali, ecc. A complicarne la comprensione c’erano gli elementi di misticismo islamico sciita mescolati alle dottrine aristoteliche.
Alla maniera dei cristiani anche gli islamici Al Kindi, Al Farabi e il medico Ibn Sina, chiamato dai latini Avicenna, erano neoplatonici: inserivano l’Aristotele che commentavano in uno schema neoplatonico, pur nella diversità delle sintesi dei tre autori. Nella Spagna e negli anni di Averroè lo stesso valeva per il medico e filosofo ebraico Moseh ben Majmon, conosciuto poi come Maimonide. La sua “Guida dei perplessi”, in cui si sosteneva una assoluta convergenza tra ragione e fede, fu di ispirazione per Tommaso d’Aquino.
All’inizio del XIII secolo le opere di Aristotele, arrivate nel mondo cristiano,
incontrarono subito diffidenza e ostilità, motivate, da parte della Chiesa. La
concezione di eternità del mondo era estranea alle religioni rivelate, come
quella di mortalità dell’anima, non apertamente sostenuta ma facilmente
deducibile dalle opere del filosofo. Se l’individuo, come qualsiasi cosa, era
composto da “materia”, cioè il corpo, e “forma”, cioè l’anima (almeno
nell’Aristotele di cristiani, islamici ed ebrei), con la morte si dissolveva,
con la materia, la forma, che ne era inscindibile. Materia e forma non potevano
esistere separatamente, almeno nell’Aristotele originale.
Condanna dell’averroismo e accettazione dell’aristotelismo
Nel 1210 il Concilio Provinciale parigino vietava la lettura pubblica o privata della “Fisica” di Aristotele, e negli anni successivi furono messe al bando molte proposizioni considerate eretiche, più che singoli individui. La cosa non valeva dappertutto, per cui nel 1228 e nel 1231 fu papa Gregorio IX ad esprimersi contro tali dottrine, pur ammettendo, dopo attento esame da parte di una commissione di teologi, la revoca del divieto di lettura della “Fisica”. Ma alla metà del secolo tutti gli scritti in questione erano letti e conosciuti. Verso il 1240 era stata tradotta anche l’“Etica nicomachea”, e intorno al 1265 Guglielmo di Moerbeke tradusse dal greco, per la prima volta, la “Politica”, questi ultimi due testi divennero particolarmente importanti.
Nel 1270 il vescovo di Parigi Tempier condannò 15 tesi aristoteliche, per lo più averroiste. Lo stesso nel 1277, sostenuto da papa Giovanni XXI, promulgò un nuovo decreto di interdizione e di condanna riguardante 219 proposizioni, tra cui molte di Avicenna e Averroè, ma anche alcune di Tommaso d’Aquino.
Con Alberto Magno di Colonia e con Tommaso d’Aquino, fortemente critici nei
confronti dell’averroismo, l’aristotelismo fu inglobato nella visione cristiana.
Tommaso depurò Aristotele da tutto ciò che era in contrasto con la religione
cristiana, della quale divenne la struttura filosofica portante. Nel 1325, due
anni dopo che Tommaso fu dichiarato santo, furono revocate le condanne
riguardanti l’aquinate: il suo aristotelismo era ormai pienamente accettato
dalla Chiesa, di cui ha costituito da allora la dottrina ufficiosa, e dal XVI
secolo anche ufficiale. Il tomismo è tutt’ora la dottrina ufficiale della Chiesa
cattolica.
Aristotelismo medioevale
L’importanza dell’averroismo è stata innegabile ma al tempo stesso sopravvalutata: la cosa più importante è stata la riscoperta di Aristotele, al di là delle differenze tra averroisti, alessandristi o altri. La Chiesa, con Tommaso, si è inconsapevolmente adeguata a un mondo che vedeva la nascita di una nuova classe, la borghesia, e il lento declino del feudalesimo, e conseguentemente delle sue basi ideologiche. Il tomismo è stata l’ideologia di un mondo ancora feudale, ma in cui avevano sempre più importanza le città e i borghesi che le abitavano. Fu un capolavoro per la Chiesa: aprì le porte al nemico, l’aristotelismo, catturandolo.
Ci interessa il ruolo svolto dall’aristotelismo per la borghesia, che esprimeva in misura sempre maggiore la classe dirigente comunale. L’importanza dell’aristotelismo del XII e XIII secolo, come del platonismo e neoplatonismo rinascimentale, è fuori discussione. Ciò che è ovvio, ma solo per noi marxisti, è che tali concezioni non hanno trasformato il loro mondo, ma sono state il riflesso delle sue trasformazioni. I problemi della conoscenza non sono risolvibili dalla conoscenza, ma solo dalla attività pratica, e cioè dalla Rivoluzione.
Nel terzo manoscritto dei “Manoscritti economico-filosofici del 1844” Marx scrive: «Si vede come il soggettivismo e l’oggettivismo, lo spiritualismo e il materialismo, l’agire e il patire smarriscano la loro opposizione soltanto nello stato sociale, e quindi perdano la loro esistenza in quanto opposizioni; si vede come la soluzione delle opposizioni teoretiche sia possibile soltanto in maniera pratica, soltanto attraverso l’energia pratica dell’uomo, e come questa soluzione non sia per nulla soltanto un compito della conoscenza, ma sia anche un compito reale della vita, che la filosofia non poteva adempiere, proprio perché essa intendeva questo compito soltanto come un compito teoretico».
Non tratteremo qui gli aspetti e gli esiti materialistici rintracciabili nell’aristotelismo, in quanto al di fuori del tema che trattiamo, aspetti ed esiti non esclusivi dell’aristotelismo ma presenti anche nella tradizione platonico-agostiniana. L’interesse per l’indagine della natura, stimolato dai testi aristotelici, è stato un passo, per quanto timido, sulla strada della rivendicazione di una maggiore autonomia da parte della nascente borghesia. Autonomia e fiducia in sé stessa nei confronti di una tradizione religiosa e filosofica agostiniana, per la quale la conoscenza del mondo era cosa di minima importanza, dato che Dio era dentro l’uomo e quindi vera conoscenza era considerata quella interiore. Era inoltre importante il ragionare in termini di causa ed effetto: il determinismo di Aristotele, ancora più forte in Avicenna ed Averroè, portava a vedere un cosmo retto da leggi necessarie, che in alcuni autori potevano identificarsi con lo stesso Dio, un Dio comunque diverso da quello della tradizione biblica. Un Dio a cui di fatto la necessità negava i caratteri dell’onnipotenza e della libertà assoluta, fino a renderlo un’ipotesi inutile, come nella risposta attribuita a Laplace nei confronti di Napoleone.
I vari filosofi, chierici e non, si sono trovati a svolgere il ruolo di involontari e inconsapevoli rappresentanti della neonata borghesia fornendole strumenti ideologici. Notevole importanza nella seconda metà del XIII secolo ha avuto la conoscenza della “Politica” di Aristotele. Qui troviamo che le comunità umane sono rette dalle loro proprie leggi, dalle loro leggi di natura, senza quindi il bisogno di introdurvi il concetto di legge divina. Anche qui non ci interessa una inesistente legge di natura in quanto tale, ma il modo in cui questa viene intesa nel contesto in questione. Aggiungiamo che questa nel XVII e XVIII secolo era un’ideologia rivoluzionaria, mentre nella Grecia del V a.C. era conservatrice, funzionale all’aristocrazia, come si evidenzia anche nell’Antigone di Sofocle.
Se nei secoli precedenti la legge di natura era parte della legge divina, da cui non si differenziava, ora guadagna una sua autonomia, più o meno ampia. Per Tommaso d’Aquino importante è il rapporto dell’uomo con Dio, considerando di scarsa importanza quello degli uomini tra loro. Si scopre ora un ambito, la politica, regolato interamente dalla legge di natura, dove non è necessario introdurre la legge divina. Il fatto che alcuni secoli dopo la borghesia abbia ampliato enormemente quel diritto di natura, molto limitato e di scarsa importanza, facendone la propria ideologia rivoluzionaria, non è attribuibile a un errore di Tommaso, ma a una realtà di classe che travolge e stravolge, insieme al vecchio mondo, anche le vecchie ideologie.
Abbiamo già detto che alla lotta tra papato e Impero si è andata sempre più sostituendo una lotta che vede papato e impero dalla stessa parte, in quanto perni del sistema feudale, contro i re di monarchie ancora feudali ma tendenti all’assolutismo, in genere alleati della nascente borghesia. In Italia al posto dei regni ci sono poi le signorie regionali, che hanno un comportamento analogo, per quanto, molto più deboli dei regni di vaste dimensioni, più propensi a cambiare frequentemente alleanze. La lotta tra papa Bonifacio VIII e il re di Francia Filippo il Bello, alla fine del XIII secolo, evidenzia la sconfitta della teocrazia papale, e un ruolo sempre più defilato dell’Impero, che Petrarca definirà poi “un vano nome senza soggetto”.
Se i sostenitori della teocrazia adoperavano un linguaggio aristotelico, lo stesso antico linguaggio era adoperato per sostenere concezioni politiche espresse dalla nuova realtà storica delle monarchie e della borghesia. Mentre le monarchie che ne avevano la forza rivendicavano una totale autonomia dalla Chiesa e dall’Impero, lo cercavano anche le varie borghesie, facendo valere i loro servigi, e in particolare i loro prestiti, presso i re.
Nel XIV e XV secolo, con l’Umanesimo e il Rinascimento, a cominciare da Petrarca, c’è un maggiore interesse per Platone, Agostino, Cicerone, e poi per i neoplatonici. La polemica di allora contro gli Ordini religiosi e la vita ascetica, era dovuta a una rivalutazione della vita attiva, con al centro l’attività di mercanzia. La vita contemplativa non era più la prospettiva privilegiata, come era stato per Aristotele, gli stoici, i neoplatonici e gli scolastici in generale. Il maggiore interesse per Platone era dovuto anche al fatto che questi, con il suo mito della caverna, parlava della necessità di isolarsi dalla comunità umana, ma con il fine di arrivare a una conoscenza da riportare poi presso gli uomini: rispetto ad Aristotele c’erano meno elementi suscettibili di sviluppo in senso scientifico e materialista, ma c’era un fine riguardante la vita attiva e non contemplativa.
I cancellieri umanisti della Repubblica fiorentina del XIV secolo, come Coluccio
Salutati e Leonardo Bruni, se erano più interessati a Platone non per questo
ignoravano Aristotele. Mentre di quest’ultimo nella Scolastica interessavano
soprattutto la logica e la fisica, ora l’interesse va all’etica e alla politica.
Nell’etica e nella politica di Aristotele la borghesia del XIV e XV secolo, pur
restando sicuramente cristiana, trova il modo di affermare una propria parziale
autonomia rispetto alla Chiesa e al mondo feudale che questa rappresenta. A
questo stesso fine, nel XV secolo, viene recuperato il vecchio neoplatonismo, a
cui viene dato un nuovo significato.
La Spagna islamica
La penetrazione islamica nella penisola iberica inizia nell’anno 711 e in breve si afferma ovunque, ad eccezione di poche zone montuose del nord, dai Paesi Baschi alla Cantabria e alle Asturie. Nell’anno 756 Abd Al-Rahman, superstite della dinastia omayyade di Damasco, spodestata e sterminata dagli abbasidi, inaugura il potere omayyade in Al Andalus, “la terra della luce”, potere che dura quasi tre secoli, prima nella forma di emirato poi di califfato.
La leggenda di una “tolleranza religiosa” della Spagna musulmana ha qualche aggancio con il periodo omayyade, ma non con le dinastie successive. In realtà nel periodo omayyade, come avveniva in genere nell’islam, “i popoli del Libro”, cioè cristiani ed ebrei, avevano un trattamento migliore rispetto agli altri non musulmani. Cristiani ed ebrei, e altrove anche zoroastriani, indù e buddisti, erano chiamati “dhimmi”. Questi in cambio del riconoscimento dell’autorità di governo musulmana, e del pagamento di un tributo, erano sotto la protezione della stessa autorità: potevano conservare la loro fede e i loro luoghi di culto, possedere beni e trasmetterli. Non sempre la convivenza era tranquilla, ma sicuramente gli ebrei vivevano meglio sotto la dinastia omayyade che sotto i vari regni cristiani d’Europa. Gli stessi cristiani d’oriente trovarono spesso meno pesante la dominazione islamica rispetto a quella dell’impero bizantino.
Nel 1031, a causa di lotte interne, termina la dinastia e appaiono i “Reinos de Taifas”, una quarantina di piccoli Stati in lotta tra di loro e con i regni cristiani, che dal Nord si espandono sempre più fino a conquistare Toledo nel 1085. A questo punto i Reinois de Taifas chiamano in aiuto dal Marocco la dinastia berbera degli Almoravidi, i quali ben presto fermano l’avanzata dei regni cristiani, annettendo al loro dominio quella metà della penisola iberica che era quanto restava del califfato di Cordova. Gli Almoravidi, pur continuando formalmente nel medesimo comportamento verso i dhimmi, in realtà aumentavano la pressione fiscale e li costringevano di fatto a scegliere tra la conversione e l’esilio.
Nel 1147 gli Almohadi, altra dinastia berbera, presero Marrakech, capitale degli Almoravidi, e il resto del regno, comprendente il califfato di Cordova. Furono poi spodestati dai Merinidi che presero Marrakech nel 1269. I regni cristiani avevano già preso Cordova nel 1236, Valencia nel 1238, e Siviglia nel 1248.
Gli Almohadi spesso perseguitano, esiliano, uccidono o obbligano alla
conversione forzata cristiani, ebrei, e musulmani considerati eterodossi;
vengono bruciate moschee, sinagoghe, monasteri e biblioteche, per epurare Al
Andalus da ogni contaminazione sciita, il che significa da ogni influsso dei
califfi Abbasidi. Le concezioni religiose degli Almohadi erano comunque di
difficile definizione. Il loro fondamentalismo sunnita e il loro odio anti-sciita
si accompagnavano all’appropriazione di elementi propri dello sciismo: il loro
fondatore, Ibn Tumart, si era proclamato Mahdi, guida dei fedeli. Il Mahdi era
una figura propria degli sciiti.
Struttura sociale della Spagna islamica
Di ciò sappiamo poco date le scarse testimonianze, e non è questo il tema del
presente lavoro; esponiamo quindi brevemente quanto riguarda tale complessa
struttura sociale. Ci avvaliamo di un testo dal titolo “La legge e la spada”,
della studiosa Alessandra Minniti, che parla di 5 gruppi umani distinti:
«1. Arabi, molto minoritari, ma proprietari e signori per diritto di conquista;
«2. Berberi, più numerosi, anch’essi proprietari per diritto di conquista, ma
socialmente e politicamente sottomessi agli arabi;
«3. Muladies, gruppo sociale molto numeroso, formato dai cristiani convertiti
spontaneamente all’Islam;
«4. Mozarabes, gruppo numeroso formato da coloro che restano fedeli al
cristianesimo… I mozarabes godono al pari degli ebrei di uno statuto sociale e
giuridico proprio in qualità di protetti in quanto gente del Libro;
«5. Ebrei, gruppo poco numeroso ma molto coeso.
«Il potere islamico aveva al suo vertice il sovrano; a lui faceva immediato riferimento giuridico l’establishment politico-amministrativo, l’aristocrazia funzionale; riferimento non giuridico ma reale è la nobiltà, jassa. Al servizio dell’aristocrazia funzionale vi sono gli schiavi e i liberti. Al di sotto nella scala sociale vi sono i notabili, A’yan, tra cui letterati, scienziati, filosofi; grandi artigiani, ingegneri, architetti, artisti; commercianti e possidenti di terre. Da questi dipendevano anche giuridicamente schiavi e liberti. Infine la massa, il popolo, ’Amma, composta da piccoli artigiani, venditori, impiegati, coloni, contadini braccianti. Qualcuno di loro poteva permettersi di mantenere uno schiavo».
Riguardo ai mozarabi va detto che non erano una sorta di quinta colonna dei regni cristiani, pronti al tradimento nei confronti del potere islamico: a volte cristiani e musulmani combattevano insieme contro altri cristiani o musulmani. Quando Carlo Magno nel 778 assediò Saragozza, sperando nell’aiuto dei cristiani di tale città, i mozarabi fecero causa comune con i propri concittadini musulmani, facendo fallire l’assedio.
Lo storico Felipe Maillo Salgado, nel suo testo “La desaparicion de Al-Andalus”, scrive: «Al-Andalus si potrebbe descrivere come una formazione sociale tributaria mercantile, nella quale le città primeggiavano sulla campagna. Non come nelle coeve società dei regni cristiani del Nord della penisola e dell’occidente europeo medievale, caratterizzate sia per i legami giuridici di vassallaggio e feudo nella loro sovrastruttura, sia per una economia dominica ancorata alla campagna. Questo non vuol dire che nella formazione sociale tributaria andalusa la maggior parte della gente non vivesse dei proventi della terra; però la sede del potere, delle istituzioni e delle decisioni, in definitiva, si radicava nella città, luogo in cui abitava una buona parte dei proprietari terrieri recettori di rendite, e luogo nel quale funzionava pienamente il mercato, che riceveva e distribuiva i prodotti».
Aggiungiamo che al tempo degli Almohadi del commercio terrestre si svolgeva tra
le città vicine al confine tra il califfato e i regni cristiani, mentre nel
commercio marittimo c’era un rapporto preferenziale con la città di Pisa.
Cordova nel X secolo era la città più grande e più prospera del mondo di allora.
Come è evidente dalla precedente citazione, la Spagna di Averroè e di alcuni
secoli precedenti ha alcuni elementi in comune con la coeva Italia dei Comuni,
dove la città prevale sulla campagna. Una differenza consiste nel fatto che,
mentre nei Comuni dell’Italia centro-settentrionale la borghesia prende il
potere nelle proprie mani, nella Spagna islamica il potere resta nelle mani di
una struttura tribale collegata alla dinastia regnante, come aveva già compreso
Ibn Khaldun, storico islamico magrebino del XIV secolo. Questa società così
composita lascia poi il posto al feudalesimo, arrivato sulla punta delle spade
della Reconquista cristiana.
Il mito di Averroè campione del “libero pensiero”
Questo mito è arrivato fino ad oggi, dipingendo un Averroè razionalista se non ateo, facendone una sorta di illuminista ante litteram. Ma, entro precisi binari politico-religiosi, tutti i filosofi nominati avevano una sostanziale libertà di ricerca e di studio, stando attenti a non sconfinare nell’eresia e a non irritare i loro protettori. Più o meno lo stesso valeva per i loro colleghi cristiani. Quanto ai califfi abbasidi, va specificato che erano sunniti, ma inizialmente ambigui sull’argomento, necessitando dell’appoggio di popolazioni sciite nella lotta contro la dinastia sunnita degli Omayyadi. In seguito hanno avuto molti visir e funzionari persiani, quindi sciiti, che hanno utilizzato insieme a funzionari cristiani, utili alla gestione e conservazione del proprio potere, in un impero dove la componente sciita era molto forte. Ciò non toglie che in alcuni periodi abbiano perseguitato gli sciiti.
Averroè non era ateo né sostenitore della teoria, a lui attribuita, della “doppia verità”. Sosteneva una rigida distinzione tra ambito della fede e ambito della ragione, per cui i problemi potevano sorgere solo dalla confusione tra i due ambiti.
La teoria della “doppia verità” era più confacente alla borghesia, che vedeva in essa una nuova forma della partita doppia: mentre in quanto cristiani condannavano il prestito a interesse, considerato sempre usura, in quanto borghesi banchieri o commercianti lo praticavano. A volte i borghesi lasciavano in eredità alla Chiesa parte dei beni guadagnati con l’usura, per ottenere sconti sulle pene per i propri peccati nell’aldilà; la paura dell’inferno non gli impediva però di praticare l’usura.
Averroè nel suo scritto “Il trattato decisivo sull’accordo della religione con la filosofia” scrive: «Ora, dal momento che la nostra religione è vera e incita a un’attività speculativa che culmini nella conoscenza del vero, noi musulmani non possiamo che essere fermamente convinti del fatto che la speculazione dimostrativa non può condurre a conclusioni diverse da quelle rivelate dalla religione, perché il vero non può contrastare con il vero, ma anzi gli si armonizza e gli porta testimonianza».
Gli studiosi borghesi vedono in Averroè un limite nel credere che la retta ragione illumini la retta fede e viceversa. Noi marxisti invece siamo d’accordo con Averroè: anche per noi “la retta ragione illumina la retta fede e viceversa”. La nostra scienza, senza la nostra fede comunista, non sarebbe nulla. Non è neanche possibile scinderle, se non facendo un’astrazione. Se la fede e il sentimento comunista senza scienza sono ciechi e vanno a sbattere, una scienza marxista, separata dalla fede e dal sentimento comunisti, somiglierebbe ad un Golem. Come il Golem della tradizione ebraica mitteleuropea, sarebbe priva di direzione: una sorta di fantomatica pura scienza, o pura tecnica, destinata a rivolgersi contro il suo creatore.
Qualcosa del genere è già accaduto con il riformismo e con la controrivoluzione
staliniana. Ovviamente il paragone è valido solo in parte: il crollo della fede
e del sentimento comunista non poteva che comportare il crollo della scienza
comunista, al di là della ribadita fedeltà ai principi, tanto più ostentata
quanto più tradita. Alla base di tutto c’era la sconfitta del proletariato da
parte della borghesia, sconfitta che ha trovato espressione ideologica nel
riformismo, nel socialpatriottismo della Seconda Internazionale e nella
degenerazione della Terza.
Intelletto unico averroista e intelletto generale in Marx
Ci sono alcuni punti di contatto tra le due concezioni, il che non significa che Averroè fosse un materialista dialettico né che Marx fosse un averroista o un aristotelico, anche se non è mancato chi ha sostenuto questa ennesima sciocchezza.
Partiamo dalla fine, e cioè dal VII quaderno dei “Grundrisse” di Marx: «La natura non costruisce macchine, locomotive, ferrovie, telegrafi elettrici, telai meccanici, ecc. Questi sono prodotti dell’industria umana; materiale naturale, trasformato in organi della volontà dell’uomo sulla natura o del suo operare in essa. Sono organi dell’intelligenza umana creati dalla mano umana; potenza materializzata del sapere. Lo sviluppo del capitale fisso mostra in quale misura il sapere sociale generale, la conoscenza, si è trasformato in forza produttiva immediata, e quindi fino a che punto le condizioni del processo vitale stesso della società sono passate sotto il controllo dell’intelligenza generale e rimodellate in accordo con essa. In quale misura le forze produttive sociali sono prodotte non solo nella forma del sapere, bensì come organi immediati della pratica sociale; del processo reale della vita».
In Averroè troviamo un’interessante intuizione che va in tale direzione, che non
può essere altro che un’intuizione, e che non ha avuto particolare influsso sul
cristianesimo dei suoi tempi né sullo stesso islam. Nel cristianesimo
l’individualismo borghese si è riflesso nel concetto di anima individuale di
Tommaso, e analogamente è accaduto nell’islam. Rifacendosi ad Aristotele,
Averroè parla di un intelletto agente unico, identificato solitamente con Dio,
che apporta la conoscenza unendosi all’intelletto materiale degli uomini. Questo
intelletto materiale viene da lui considerato unico e non più moltiplicato per
ogni uomo. Questo significava che non esistevano anime individuali, e che alla
morte del corpo i singoli intelletti individualizzati dalla materia, si
ricongiungevano all’unico intelletto. Era un duro colpo al potere della Chiesa,
che non poteva più determinare il destino delle anime nell’aldilà, e questo fu
sicuramente il maggiore scandalo. In questa concezione l’immortalità non era più
del singolo individuo ma della specie; la conoscenza era dell’intelletto unico,
per cui alla morte dei singoli, che ne partecipavano solamente, non andava
perduta ma restava nella specie. Nell’“Incoerenza dell’incoerenza dei filosofi”,
tradotto in latino come la “Distruzione della distruzione dei filosofi”, Averroè
scrive «nell’intelletto non vi è individualità purchessia».
Averroismo
Anche qui non parleremo degli aspetti di materialismo rintracciabili in tali concezioni: il materialismo poteva essere una conseguenza di un panteismo, non presente in Averroè ma possibile approdo della sua concezione di unità dell’Intelletto.
La possibile interpretazione panteista non ha avuto accoglienza nel mondo cristiano, con alcune eccezioni nel Rinascimento: alla borghesia erano utili altri aspetti del filosofo. Paradossalmente Averroè non era un averroista, mentre lo erano coloro che ne stravolgevano il senso: l’averroismo nel mondo cristiano era la concezione di alcuni filosofi, utile alla nascente borghesia, per cui la rigida separazione tra ambito della ragione e ambito della fede, tra indagine della natura e verità rivelata, era lo strumento per affermare un’autonomia tra “città terrena” e “città di Dio”. Tutto ciò significava maggiore autonomia della borghesia dal potere della Chiesa e dai rapporti feudali che questa incarnava. La “città terrena” pur restando la copia corrotta e sbiadita dell’altra, era il luogo dove l’uomo poteva arrivare alla felicità: felicità inferiore a quella eterna ma comunque importante, e consistente nella conoscenza. Mentre in Aristotele, Al Farabi e Averroè, la felicità consiste nell’arrivare alla conoscenza e alla contemplazione, ora quest’ultima diviene propria della “città di Dio”, mentre la conoscenza ha sempre più per fine la vita attiva, la politica, e la produzione della ricchezza.
L’averroista Giovanni di Jandun, nato nelle Ardenne intorno al 1280, dichiarato eretico nel 1326 insieme a Marsilio da Padova, con quest’ultimo si rifugia presso l’imperatore Ludovico il Bavaro, al seguito del quale muore a Todi nel 1328. Nel suo commento alla “Metafisica” di Aristotele scrive: «Di fronte alla questione se la maggior parte degli uomini può arrivare alla conoscenza del vero, bisogna distinguere l’individuo dalla collettività. Ma dire che il singolo è in grado di avere una perfetta conoscenza, è falso… Se vogliamo risolvere la questione in senso collettivo, diremo che nella maggior parte degli uomini insieme riuniti, la filosofia diventa perfetta sapienza e tutti pervengono collettivamente alla verità».
L’autore resta nella scia di Averroè e di Sigieri di Bramante, per cui il fine
ultimo è la felicità consistente nella contemplazione, ma l’importanza data alla
collettività è un tema ripreso da Dante e da Marsilio da Padova, con un fine,
soprattutto nel secondo, molto più rivolto alla vita attiva. L’aristotelico
Pietro Pomponazzi, tra XV e XVI secolo, rifiuta l’ascetismo di quella che
considera una mistica averroista dando maggior valore alla “dimensione corporea”
dell’uomo. Nel suo trattato “De immortalitate animae” nega l’immortalità
dell’anima, senza per questo essere materialista. In tale trattato espone una
concezione organicista della società ispirata al famoso apologo di Menenio
Agrippa: in tale concezione l’armonica convivenza tra le classi ha per
presupposto l’ineguaglianza tra gli uomini, vista come una necessità sia
metafisica sia politica. Quella che oggi sarebbe una visione reazionaria allora
non lo era: era una visione certamente di classe, ma funzionale all’affermarsi
della borghesia su di una struttura sociale epifeudale.
Ockham
Il francescano inglese Guglielmo di Ockham nasce intorno al 1290 e muore intorno al 1350. Studia e poi insegna all’università di Oxford, centro dell’agostinismo francescano, così come Parigi lo era stato per l’aristotelismo e l’averroismo. Nel 1324 va ad Avignone per difendersi da accuse di eresia, e da lì nel 1328 va prima a Pisa e poi a Monaco presso l’imperatore Ludovico il Bavaro, insieme al generale dei francescani Michele da Cesena e altri confratelli, tutti dichiarati eretici da Papa Giovanni XXII.
Ockham separa nettamente la scienza dalla fede, ma anche qui non c’è nessuna concezione che possiamo definire scientifica, avendo come presupposto il primato della fede, nel solco di una tradizione che va dall’agostinismo francescano con venature gioachimite fino a Lutero e al giansenismo. Il concetto che l’ordine cosmico non fosse necessario ma contingente e dovuto alla libertà divina, distruggeva le cosmologie e le filosofie aristoteliche e neoplatoniche. È una concezione tradizionale che in quel momento ha avuto una funzione ideologica rivoluzionaria, al contrario delle odierne teste d’uovo che parlano dell’“inesauribile ricchezza della storia” e adoperano i medesimi argomenti contro la necessità per negare la stessa possibilità della comprensione e quindi dell’intervento sulla realtà. Costoro sono al di sotto di Averroè, il quale diceva che «chi nega la causa, nega l’effetto».
Ockham nella sua polemica contro la metafisica aristotelica e neoplatonica,
arriva a negare lo stesso principio di causalità: questo non va in direzione
della scienza, ma dello sperimentalismo, che prende il posto dell’apriorismo
delle idee platoniche e delle categorie aristoteliche. Già in Ruggero Bacone,
francescano e filosofo inglese del XIII secolo, lo sperimentalismo è in primo
piano, assieme alla magia e all’alchimia. Queste ultime avranno rilievo anche
nel Rinascimento e contribuiranno alla nascita della scienza moderna. La magia è
all’opposto della scienza, ma nasce dalla fiducia nelle capacità dell’uomo di
trasformare il mondo che lo circonda, stessa fiducia che è alla base della
scienza. Ciò che viene fatto proprio dalla borghesia non è la negazione del
principio di causalità, e solo in parte dello sperimentalismo, ma il nominalismo
che ne è alla base.
Nominalismo
La disputa sugli Universali inizia nella Scolastica dell’XI secolo. Gli Universali sono i generi e le specie (Terra, Acqua, Aria, Fuoco; gli Elementi, ecc.), che per alcuni, chiamati “realisti”, hanno una loro esistenza propria: non sono solo un concetto ma una essenza necessaria, una reale sostanza delle cose, secondo la tradizione logica platonico-aristotelica. Altri, chiamati “nominalisti” e ispirati dalla tradizione stoica, negano realtà agli Universali, considerandoli dei concetti, delle forme verbali, dei segni. All’inizio del XII secolo già Rossellino e poi il suo discepolo Abelardo in maniera diversa avevano sostenuto quest’ultima posizione.
La scienza quindi non ha più per oggetto l’universale, secondo le concezioni
aristoteliche e tomiste, ma l’individuale, la cui conoscenza può essere fondata
solo sulla esperienza.
Critica della fisica aristotelica
Il crollo della fisica aristotelica ha trascinato con sé il crollo delle concezioni della Scolastica. Il nominalismo di Ockham non riconosce alcuna realtà propria al moto, che non può più essere distinto dalle cose reali. Nella “Storia della filosofia medioevale” di Cesare Vasoli leggiamo: «La prospettiva “qualitativa”, che era propria della meccanica aristotelica, viene definitivamente ripudiata. Né è difficile intendere come da queste posizioni, spinte più tardi alle più estreme conseguenze, potessero svolgersi delle dottrine di evidente impianto atomistico e, insieme, delle significative tendenze ad applicare i metodi già evoluti del calcolo matematico all’intelligenza delle diverse fasi dei fenomeni. È evidente che questa incipiente matematizzazione dell’indagine naturale – che riprende il filo di una tendenza già delineatasi nel XII secolo, e interrotta dal predominio della fisica aristotelica – non ha affatto quei caratteri di rigore e di consapevole necessità che ebbe più tardi la scienza galileiana… Ma… il fatto che nella scienza occamista il senso concreto dell’esperienza si unisca già all’esigenza di una precisa definizione quantitativa dei fenomeni naturali, rappresenta una prova indiscutibile del progresso compiuto dalle discipline scientifiche nella prima metà del Trecento».
Il “rasoio di Ockham”, e cioè il suo metodo di eliminare tutti gli enti
superflui in quanto non necessari alla spiegazione dei fenomeni, unito a
elementi della tradizione agostiniana e francescana, portano il filosofo a
considerare la “materia terrena” non più diversa dalla “materia celeste”. Il
termine materia aveva allora dei significati diversi: si parlava anche di una “materia
celeste” di cui erano costituiti gli angeli e i cieli delle “stelle fisse”.
Secondo la fisica aristotelica c’era un mondo delle “stelle fisse”, a cominciare
dalla Luna, non soggetto a mutamento e corruzione, e un mondo sublunare soggetto
a mutamento e corruzione, e quindi alle leggi della fisica. Dire che tutto
l’universo è retto dalle stesse leggi significa rigettare tutte le costruzioni
della Scolastica e tutte le preoccupazioni teologiche di raccordare fede e
ragione, arrivando, dal lato opposto, a conclusioni analoghe a quelle di Averroè.
Al termine di questo percorso troviamo Galileo.
Nominalismo, rasoio di Occam e materialismo
Il nominalismo con il conseguente “rasoio di Occam” e il rifiuto del moltiplicarsi degli enti superflui, è un primo passo in direzione del materialismo. Riguardo all’anima Ockham scrive: «Colui che segue la ragione naturale ammetterebbe soltanto che sperimentiamo in noi l’intellezione, che è l’atto di una forma corporea e corruttibile. E direbbe conseguentemente che una tale forma potrebbe essere ricevuta nella materia estesa. Ma non sperimentiamo mai quella specie di intellezione che sia l’operazione propria di una sostanza immateriale; perciò mediante l’intellezione, non possiamo concludere che ci sia in noi, come forma, una sostanza incorruttibile».
Nicola Abbagnano, nella sua “Storia della filosofia”, scrive: «Ockham ammette la
possibilità che sia il corpo stesso a pensare cioè che il corpo sia il soggetto
di quegli atti di intellezione che sono il solo dato sicuro da cui il
ragionamento può partire... Tutti i concetti... sono causati naturalmente dagli
oggetti singoli presenti nell’esperienza, cioè senza che intervengano né
l’intelletto né la volontà. Conosciute le cose singole nell’intuizione, gli
universali si formano in noi spontaneamente, per l’azione di esse».
Eredità dell’occamismo nella ideologia borghese
Averroismo e occamismo hanno portato alle estreme conseguenze le loro basi filosofiche: l’aristotelismo, in gran parte dei domenicani, e l’agostinismo, in gran parte dei francescani. Così facendo ne hanno mostrato anche l’inconsistenza. È stato un attacco da due lati ideologici opposti che ha contribuito al dissolvimento della Scolastica.
L’occamismo, con il suo nominalismo e l’importanza attribuita all’esperienza, è stato tra i due il più dirompente. L’individualismo, che Ockham riprende anche da Duns Scoto, è stato sicuramente l’aspetto principale ripreso da una borghesia che si è disinteressata di altri aspetti del suo pensiero. Collegate al nominalismo di Ockham sono anche le sue concezioni politiche, fatte proprie dalla borghesia, per cui la Chiesa non deve avere pretese di potere temporale. La rigida separazione del piano spirituale della fede da quello mondano della ragione si traduce in una posizione filoimperiale, per cui la verità non risiede più nella Chiesa intesa come gerarchia o nel Pontefice, ma nella Chiesa totalità dei credenti. Una totalità formata dalla realtà dei singoli individui cristiani, nei quali risiede la fede e la verità. Tali concezioni erano funzionali a tutte le classi che mal sopportavano la struttura feudale della società: alla borghesia come ai contadini poveri. A volte anche a re e nobili in contrasto con il potere ecclesiastico.
A Duns Scoto e ad Ockham si è ispirato John Wyclif, riformatore politico-religioso dell’Inghilterra del XIV secolo, le cui idee sono state radicalizzate, e trasformate in una ideologia rivoluzionaria politico-religiosa ispirata al comunismo evangelico, dal movimento dei Lollardi, artefice di una grande rivolta contadina nel 1381, duramente repressa. A Wyclif si è ispirato Jan Hus, finito sul rogo nel 1415 a Costanza, in occasione del Concilio. Wyclif venne accusato di eresia ma riuscì a non avere conseguenze, grazie all’appoggio del re e di parte della nobiltà, che condividevano con lui l’opposizione alle prerogative della Chiesa e alle sue proprietà, che spesso re e nobili volevano incamerare. Nel 1377 papa Gregorio XI condanna con una “bolla” le dottrine di Wyclif, dicendo che «presentano, con alcuni piccoli cambiamenti, la perversa teoria e le opinioni eretiche di Marsilio da Padova e di Giovanni di Jandun». Nel 1428 i resti di Wyclif furono riesumati, bruciati e dispersi.
Se la borghesia non ha ancora elaborato una propria ideologia, altrettanto e più vale per le classi subalterne costituite da contadini e artigiani.
(continua al prossimo numero)
Nella capitolo precedente abbiamo visto come la potenza navale e le reti mercantili marittime delle città-Stato italiane nel Medioevo abbiano consentito lo sviluppo di un primo capitale bancario. Dopo il completamento della Reconquista presupposti finanziari e logistici permisero l’emergere delle potenze coloniali portoghese e spagnola. Con la caduta di Costantinopoli e l’espansione del potere ottomano, che dominava il commercio con l’Oriente, gli europei furono costretti a cercare nuove rotte verso le Indie. I portoghesi stabilirono rapporti commerciali con l’Africa occidentale, accedendo all’altra estremità del già consolidato commercio transahariano di schiavi. Quando apparvero in Europa gli schiavi africani il vecchio modello romano di gestione delle piantagioni, il latifundia, sarebbe stato esteso nelle Americhe sotto forma di Encomienda. Verso la metà del XVI secolo, la Chiesa cattolica e la Corona spagnola governavano in modo egemonico sulla maggior parte dell’Europa e delle Americhe.
Per comprendere la storia degli Stati Uniti, le sue dinamiche razziali, di classe e agrarie nella loro totalità dialettica, è essenziale conoscere le complesse condizioni sociali ed economiche dell’Inghilterra e il suo rapporto con le potenze coloniali dell’epoca. Base sociale dell’impianto delle colonie inglesi in America e dell’espansione verso ovest era la classe dei contadini indipendenti che, a differenza degli altri contadini europei, erano riusciti a evitare la sottomissione alla servitù della gleba sulla scia dei rivolgimenti sociali seguiti alla peste nera in Inghilterra.
Il commercio inglese della lana e l’industria tessile olandese erano collegati da un sistema di finanza internazionale guidato dai banchieri italiani. Mentre le colonie spagnole, anch’esse sostenute dal capitale finanziario italiano, accrescevano la loro ricchezza, le contraddizioni sociali in Europa esplosero nelle guerre contadine tedesche, che aprirono la strada a trasformazioni più ampie durante la Riforma protestante.
In questo periodo emersero soggezioni di razze dal bisogno di manodopera dell’Impero spagnolo, che doveva affrontare ribellioni di schiavi indigeni nelle Americhe, rivolte contadine e rivoluzioni borghesi in Europa. Il periodo culminò nell’ascesa dei primi Stati completamente borghesi, la Repubblica olandese e più tardi il Common Wealth inglese.
In questo processo storico vediamo un’affermazione dell’ipotesi di base del
marxismo rivoluzionario che tutta la storia è storia di rivoluzioni e di lotta
tra classi. Le complesse dinamiche che portarono alla colonizzazione del Nord
America furono un processo che coinvolse questi interessi di classe tra
sfruttatori e sfruttati. Lontano dalle narrazioni riduttive dei falsificatori
accademici contemporanei, che descrivono la colonizzazione come uno confronto
fra presunte classi di colonizzatori e colonizzati, in questo periodo una
congerie di classi, contadini, mercanti, aristocratici, fondiari, artigiani
urbani, difendevano i loro interessi gli uni contro gli altri. Come abbiamo
cercato di dimostrare in questo studio, era impossibile che la storia prendesse
un altro corso, dal comunismo primitivo alle società di classe, dal feudalesimo
al capitalismo, e come il capitalismo inevitabilmente lascerà il posto al
comunismo, del quale crea le condizioni, con la lotta di classe fra i due campi
del proletariato e della borghesia. È solo con lo sviluppo del proletariato e
della sua dottrina storica, incarnata negli scritti della corrente marxista
rivoluzionaria, che emerge una classe sociale con un programma pienamente
coerente, che esprime gli interessi irrimediabilmente antagonisti con il
capitale e la necessaria loro soluzione nella distruzione di tutte le classi e
dall’imporsi del comunismo.
9. - Prima del re cotone c’era la lana normanna
Quando i Romani soggiogarono la Gran Bretagna la qualità del vello e dei tessuti delle isole era già ben nota, pur nelle limitate reti commerciali indigene dell’epoca. Il clima umido e i fertili pascoli alimentavano greggi di pecore acclimatate con pelliccia lunga, morbida e resistente, rendendo la lana delle isole la più richiesta sul continente. Roma aveva presto stabilo laboratori e reti commerciali, ma dopo la dissoluzione dell’autorità imperiale centrale, sotto i regni anglosassoni le pecore furono utilizzate solo per il consumo locale con esportazioni di piccole eccedenze, mentre sulle greggi continuava ad operare il lavoro silenzioso della selezione naturale. Ciononostante nell’XI secolo la lana inglese era ancora nota come la più pregiata d’Europa, anche se non merce da esportare in massa sui mercati mondiali emergenti, che cominciavano a prendere forma quando le prime crociate portarono al ritessersi delle reti commerciali in tutta Europa e collegate all’Oriente.
Prima della conquista normanna del 1066 il sistema agricolo inglese si era plasmato da secoli secondo le pratiche anglosassoni. Al suo centro c’era il sistema dei campi aperti a disposizione della comunità del villaggio. La terra era divisa in grandi campi coltivabili, ulteriormente suddivisi in strisce. Ogni famiglia contadina possedeva strisce sparse in diversi campi, garantendosi così la condivisione di terreni fertili e poveri. I campi erano circondati da terreni comuni (prati, boschi e pascoli) utilizzati collettivamente per il pascolo del bestiame, la raccolta di legna da ardere e altre necessità di sussistenza. Questo sistema era mantenuto attraverso diritti e obblighi consuetudinari, applicati a livello dei villaggi locali e delle hundred courts, tribunali locali. Sebbene esistessero contadini dipendenti, schiavi, servi e braccianti, il sistema anglosassone consentiva a un numero significativo di ceorl,contadini liberi, di possedere e lavorare la terra in modo relativamente autonomo, pagando affitti o rendendo servizi ai signori locali, ma spesso conservando mobilità e diritti.
La conquista normanna ristrutturò radicalmente questo ordine nel sistema feudale. Guglielmo e i suoi baroni confiscarono la terra ai nobili anglosassoni e ai contadini liberi concentrandola in tenute assegnate ai signori normanni e alla Chiesa. Queste tenute (manieri) divennero unità produttive dove i contadini erano legati al demanio (la terra del signore) attraverso la servitù della gleba, obbligati a prestare servizi di lavoro, oltre ai canoni e alle decime. I normanni ampliarono anche il ruolo dei monasteri, grandi proprietari terrieri, molti dei quali specializzati nell’allevamento di pecore e nelle prime forme di agricoltura commerciale. Mentre l’Inghilterra anglosassone era stata relativamente decentralizzata e sostenuta da un’agricoltura mista di sussistenza, il dominio normanno militarizzò e monetizzò le campagne, integrandole più strettamente nelle reti di estrazione delle eccedenze e di commercio a lunga distanza.
All’epoca della conquista normanna le città tessili fiamminghe di Gand, Bruges e Ypres erano già fiorenti centri di produzione di tessuti, che impiegavano decine di migliaia di tessitori e follatori. I loro telai consumavano grandi quantità di lana pregiata che era relativamente scarsa nel continente ma abbondante in Inghilterra. I normanni, con i loro forti legami feudali oltre Manica (molti signori normanni possedevano anche feudi nelle Fiandre), si mossero rapidamente per sfruttare questa opportunità. Assumendo il controllo della produzione inglese, potevano convogliare la lana prima direttamente negli opifici fiamminghi, dove veniva trasformata in tessuti di alto valore venduti in tutta Europa. Questa partnership anglo-fiamminga arricchì gli abati e i baroni normanni, approfondendo al contempo l’integrazione dell’Inghilterra nei mercati continentali. Per i contadini, tuttavia, ciò significò la riorganizzazione della loro agricoltura di sussistenza in pascoli per l’esportazione di materie prime, con affitti, decime e lavori forzati imposti per sostenere un commercio i cui profitti andavano alle élite piuttosto che a chi tosava le pecore.
Alla fine del XII secolo, l’Inghilterra esportava circa 35.000 sacchi di lana
all’anno, ciascuno dei quali valeva all’incirca il reddito annuo di un cavaliere,
rendendo la lana inglese la più pregiata e ricercata d’Europa e conferendo alla
Corona un enorme potere nella politica e nella finanza continentale. Nel
XIII-XIV secolo, il commercio della lana inglese si era espanso e le
esportazioni raggiungevano anche i 40.000-45.000 sacchi all’anno. La tassa
doganale sulla lana, introdotta nel 1275, fornì ben presto oltre la metà del
reddito della Corona. Queste entrate permisero ai re inglesi di finanziare le
guerre in Francia e di affermare la loro influenza politica in tutta Europa. Nel
XIII e XIV secolo l’allevamento di pecore in Inghilterra assomigliava già a un
aspetto semi-industriale, tanto che l’intero paese era considerato “una grande
fattoria di pecore”. Regioni come le Marche gallesi, il Lincolnshire e il
Sud-Ovest erano specializzate nella produzione di velli, spedite in enormi
quantità alle città tessili dei Paesi Bassi, della Francia e dell’Italia. Porti
inglesi come Hull, King’s Lynn e Southampton prosperarono grazie a questo
commercio, mentre i monarchi dalle esportazioni di lana traevano la loro
principale fonte di reddito. È da questo commercio che iniziò a svilupparsi in
Inghilterra una crescente classe mercantile.
10. - La guerra dei cent’anni e la crisi bancaria:
il contesto delle rivoluzioni borghesi
La guerra dei cent’anni iniziò formalmente nel 1337, quando Edoardo III rivendicò il trono di Francia. Alla base c’era l’economia della lana e del tessile. Le Fiandre, con le loro grandi tessiture di Gand, Bruges e Ypres, dipendevano da un flusso costante di lana inglese di alta qualità, ma rimanevano sotto la sovranità francese. I borghesi fiamminghi, minacciati dai propri signori, invitarono Edoardo a intervenire, non per lealtà alla Corona, ma per salvaguardare i propri telai e i propri profitti. Edoardo impose pesanti dazi sulle esportazioni di lana, una forma embrionale di politica fiscale-militare: questi dazi all’esportazione per un breve periodo permisero alla Corona di far fronte ai propri impegni militari, ma alla fine ricaddero sui contadini e sui piccoli produttori, gravando i costi della guerra all’estero sul loro lavoro di sussistenza.
Ma a una guerra di quella portata non bastavano i proventi dei dazi, e trascinò l’Inghilterra direttamente nei circuiti della finanza internazionale. Le banche fiorentine dei Bardi e dei Peruzzi concessero a Edoardo ingenti prestiti, garantiti proprio dalle esportazioni della lana sottratta alle campagne. Per un certo periodo questo accordo funzionò, gli eserciti furono finanziati e l’industria tessile fiamminga continuò a rifornirsi. Ma le campagne finirono per prosciugare le eccedenze più rapidamente di quanto potessero essere ricostituite. Nel 1345 Edoardo non riuscì a ripagare somme colossali. Il crollo di entrambe le banche destabilizzò la stessa Firenze, provocando una contrazione del credito, fallimenti e conflitti di classe. Tuttavia il potere finanziario non svanisce con un fallimento, si sposta: con la rovina delle grandi banche fiorentine il baricentro della finanzia europea si spostò verso nord. I mercanti e i banchieri fiamminghi e tedeschi, in particolare quelli che operavano da Bruges e Lubecca, colmarono il vuoto, espandendo la loro influenza all’interno della nascente rete commerciale anseatica e rafforzando la loro presa sui circuiti della lana e dei tessuti che Firenze non poteva più dominare.
I kontors della Lega Anseatica (uffici commerciali esteri, Steelyard di Londra, Bruges, Bergen, Novgorod) rafforzarono la loro presa sul commercio tra il Mare del Nord e il Baltico; Bruges (poi Anversa) si consolidò come stanze di compensazione; i mercanti del Nord ampliarono il credito a breve termine, il cambio e il trasporto marittimo secondo le loro condizioni. La Lega Anseatica non era una “banca”, ma il suo controllo cartellizzato delle materie prime sfuse (grano, legname, pesce, metalli) e i privilegi nei porti inglesi consolidarono i circuiti di capitale e di approvvigionamento non italiani, riducendo per le Corone del Nord la necessità di intervento quotidiano dei finanzieri toscani.
Una volta che le élite inglesi e della Germania settentrionale poterono finanziarsi tramite i dazi sulla lana, controllando lo smercio dei prodotti di base (ad esempio a Calais) e con il credito dei mercanti del Nord, piuttosto che fare affidamento sulle banche italiane legate al papato, l’influenza di Roma e le risorse fiscali della Curia (Annualità, Obolo di Pietro, Provvigioni) si indebolirono. Nell’Impero, i principi trovarono più facile rifiutare le tasse papali, attingendo ai finanzieri locali o imperiali nelle città e, una volta che la Riforma prevalse, impadronirsi delle terre ecclesiastiche per costruire tesori autonomi.
La crisi bancaria fiorentina preparò anche il terreno per l’ascesa dei Medici.
Il fallimento dei Bardi e dei Peruzzi screditò il vecchio modello delle grandi
banche familiari legate ai monarchi attraverso rischiosi prestiti. I Medici, che
costruirono il loro impero finanziario nel XV secolo, impararono da questa
catastrofe, evitarono l’eccessiva esposizione a prestiti sovrani,
diversificarono i loro strumenti di credito e collegarono le loro operazioni
alla Chiesa cattolica e alla finanza, al commercio e all’industria papali. In
questo senso, il default di Edoardo III nel 1345 non solo nel breve termine
spostò il peso finanziario verso i mercanti fiamminghi e tedeschi, ma, nell’era
emergente della Riforma e della Controriforma, creò indirettamente le condizioni
affinché i Medici si affermassero nuovi arbitri della finanza europea sotto il
papato, mentre nel Nord cominciavano a svilupparsi nuovi circuiti commerciali e
finanziari indipendenti. Pertanto, il commercio della lana inglese, le tessiture
fiamminghe e i default fiorentini furono tutti momenti della ristrutturazione
del capitale internazionale, le cui crisi rimodellarono l’economia politica di
tutta l’Europa.
11. - La peste nera e l’ascesa dei contadini anglosassoni
La peste nera del 1348 non fu solo una catastrofe demografica ma una profonda rottura dell’ordine feudale inglese. Verificatasi nel mezzo dell’intensa guerra tra Inghilterra e Francia e poco dopo il default finanziario inglese, fu emblematica un cataclisma sociale che prefigurava massicci sconvolgimenti rivoluzionari tra le classi sfruttate e sfruttatrici. Con la morte di un terzo / una metà della popolazione inglese, interi villaggi furono abbandonati e vaste distese di terra rimasero incolte. In alcune contee i registri mostrano che nell’immediato dopoguerra fino al 40% dei terreni rimase incolto e che i monasteri e le grandi tenute persero centinaia di affittuari. Questa improvvisa scarsità di manodopera diede ai contadini sopravvissuti un potere contrattuale senza precedenti. I signori normanni, desiderosi di mantenere produttivi i loro domini, furono costretti a offrire salari più alti, affitti ridotti o la commutazione del servizio di lavoro in pagamenti in denaro. Molti contadini semplicemente si rifiutarono di sottostare alla servitù della gleba. L’élite al potere rispose con la repressione, promulgando nel 1351 lo Statuto dei Lavoratori che fissava i salari ai livelli pre-peste e di vincolava i servi ai signori. Ma l’applicazione si rivelò impossibile: in molti luoghi i tribunali feudali rimasero inoperanti e gli affittuari si sottrassero ai loro obblighi senza temere ritorsioni.
Da questo sconvolgimento demografico e sociale emerse la classe in espansione dei piccoli proprietari terrieri. Nell’Inghilterra medievale e dell’inizio dell’età moderna, uno yeoman era un membro di una classe sociale che si collocava tra i contadini e la nobiltà terriera. Prima della peste, gli yeomen erano già un gruppo piccolo ma significativo di affittuari liberi e contadini prosperi, che spesso possedevano tra i 30 e i 100 acri. Dopo la peste, il loro numero aumentò quando i sopravvissuti acquisirono appezzamenti abbandonati, negoziarono affitti fissi a lungo termine o acquistarono direttamente terreni da signori immiseriti. Le stime suggeriscono che alla fine del XIV secolo gli yeomen e i proprietari terrieri liberi rappresentavano fino al 20-25% delle famiglie rurali, un aumento drastico rispetto all’inizio del 1300. Questo strato di piccoli proprietari simboleggiava il crollo della dipendenza feudale e l’emergere di nuove relazioni di classe. La loro indipendenza non era assoluta, rimanevano soggetti alle tasse e alle fluttuazioni del mercato, ma si erano ritagliati una certa autonomia che contrastava nettamente con gli obblighi servili dei villani. Il radicamento dei piccoli proprietari terrieri nella terra divenne la base sociale non solo del successivo capitalismo agrario, ma anche dei movimenti radicali della Rivoluzione inglese.
La loro importanza si riflette nell’immaginario dell’epoca. La storia di Robin Hood, tra la fine del XIV e il XV secolo, parlava di contadini e piccoli proprietari terrieri che fantasticavano di vendicarsi degli sceriffi, degli abati e dei signori, che cercavano di sottometterli. L’arco lungo di Robin, arma dello yeoman inglese, con la sua ridistribuzione della ricchezza drammatizzava l’antagonismo tra chi lavorava e chi viveva parassitariamente di affitti, decime e tributi forzati. La monarchia codificò il ruolo militare dei piccoli proprietari: dall’inizio del 1300 tutti gli uomini abili erano tenuti a praticare il tiro con l’arco, per sfruttare le abilità dei contadini al servizio dello Stato. Verso la metà del XIV secolo, gli arcieri piccoli proprietari terrieri erano fondamentali per gli eserciti di Edoardo III. A Crécy (1346) e Poitiers (1356) liberi cittadini armati di archi lunghi annientarono le cariche dei cavalieri francesi, dimostrando che masse disciplinate di contadini potevano distruggere il monopolio militare dell’aristocrazia e dei suoi cavalieri pesantemente corazzati, un tempo considerati imbattibili. Tornati a casa erano consapevoli del loro valore, in guerra e nel lavoro, e riluttanti a tornare alla dipendenza servile.
In tutta Europa, la peste radicalizzò le tensioni sociali. In Francia, la rivolta della Jacquerie del 1358 esplose quando i contadini, schiacciati da pesanti tasse, devastazioni belliche ed esazioni aristocratiche, si ribellarono contro la nobiltà. Con armi improvvisate, attaccarono i castelli e uccisero i signori, sfogando un antico risentimento. La rivolta fu repressa rapidamente e brutalmente dai nobili e dalle forze reali con un massacro stimato di 20-30.000 contadini, ma rivelò le profonde tensioni di classe che la guerra e la peste avevano intensificato. Nelle Fiandre artigiani e tessitori si ribellarono ripetutamente contro le tasse e le élite delle corporazioni. A Firenze il crollo del dominio delle corporazioni della lana nel 1378 scatenò l’aperta rivolta dei Ciompi, lavoratori salariati.
In Inghilterra il malcontento esplose nel 1381 con la Rivolta dei Contadini. L’imposizione da parte della Corona di un testatico per finanziare la guerra ne fu la scintilla immediata, ma le cause più profonde risiedevano in decenni di tensioni economiche, lavoro obbligatorio dopo la peste e risentimento nei confronti dei tributi feudali. Guidati da Wat Tyler e ispirati dalla predicazione radicale dell’uguaglianza di John Ball, decine di migliaia di ribelli marciarono su Londra. Assaltarono la Torre, giustiziarono i funzionari reali e chiesero la fine della servitù della gleba e della schiavitù, la riduzione degli affitti e l’abolizione dei privilegi aristocratici. Tyler premeva per niente meno che un rivoluzionario riordino della società.
La predicazione radicale di John Ball segna una prima frattura nell’apparato ideologico del feudalesimo. Ball non era una figura marginale: i suoi sermoni fornirono la base ideale alla rivolta, dando voce alle lamentele dei servi, degli artigiani e dei piccoli proprietari terrieri schiacciati dal testatico e dalle esazioni signorili. Mentre Tyler guidava la massa dei contadini a Londra, fu Ball a dare alle loro azioni un linguaggio universale, predicando contro i “gentiluomini” e dichiarando che la classe dominante non era divinamente investita. La sua sfida “Quando Adamo zappava ed Eva filava, chi era allora il gentiluomo?” andava oltre la retorica, era un attacco alla giustificazione teologica del privilegio feudale. Ball chiese anche che le Scritture fossero ascoltate e lette nella lingua locale, rifiutando il monopolio clericale del latino come lingua del dominio di classe. Chiedendo una Bibbia in volgare, mirava a dissolvere una delle barriere che mantenevano i contadini dipendenti dai sacerdoti, come erano materialmente dipendenti dai signori per la terra e la sopravvivenza.
Sebbene la ribellione fosse repressa nel sangue e lo stesso Ball giustiziato, la
rottura ideologica che rappresentò ebbe ripercussioni oltre i confini
dell’Inghilterra, la sua insistenza sull’uguaglianza davanti a Dio e la
richiesta che la Bibbia fosse tradotta in volgare prefigurò correnti che
sarebbero riemerse con forza esplosiva nel XVI secolo in Germania. La rivolta
segnò un momento decisivo in Inghilterra: nei decenni successivi il vecchio
ordine feudale non poté essere ripristinato, in combinazione con la scarsità di
manodopera assicurò il crollo della servitù della gleba. Mentre nel continente
la repressione feudale ne preservò le strutture, in Inghilterra la resistenza
contadina e i cambiamenti demografici le indebolirono. Questa divergenza plasmò
il percorso dell’Inghilterra verso il capitalismo agrario e, alla fine, la
rivoluzione borghese, in contrasto con il persistere del dominio signorile che
si manterrà ancora per centinaia di anni nel resto d’Europa.
12. - La base della piccola proprietà terriera inglese e le contraddizioni
del suo idealismo piccolo-borghese
Dopo la ribellione di Wat Tyler nel 1381, la servitù della gleba, sebbene non abolita per decreto, appassì sotto la doppia pressione del crollo demografico dopo la peste nera e delle ondate di resistenza ai tributi feudali. Da queste condizioni nacque la classe dei piccoli proprietari terrieri, piccoli agricoltori indipendenti e affittuari liberi che si godevano del possesso della terra, in affitto o in proprietà, incarnando un ideale di autosufficienza e autonomia. Il XV secolo segnò un’epoca d’oro per gli yeomen inglesi. Le condizioni nelle campagne erano insolitamente favorevoli ai piccoli coltivatori, godevano di affitti sicuri, canoni moderati e accesso ad ampi terreni da coltivare e far pascolare. I salari erano relativamente alti, mentre il costo del grano e di altri prodotti di prima necessità rimaneva basso, consentendo alle famiglie di agricoltori di mantenere un tenore di vita confortevole. Molti piccoli proprietari terrieri furono in grado di espandere le loro proprietà, investire in strumenti migliori e diversificare la produzione, ottenendo così stabilità e una modesta prosperità. Costituivano uno strato sociale sicuro e indipendente tra la piccola nobiltà e i braccianti senza terra, abbastanza forte da sostenere le famiglie, entrare nella politica locale e persino fornire figli per il commercio o la chiesa. In questo periodo, il piccolo proprietario terriero rappresentava un raro equilibrio di autonomia, sicurezza e posizione sociale nelle campagne inglesi.
Tuttavia, successivamente, la trasformazione più netta della campagna inglese fu l’ascesa della piccola nobiltà. Le Guerre delle Due Rose (1455-87) distrussero gran parte della vecchia aristocrazia feudale, riducendo il numero dei grandi magnati che avevano dominato la politica medievale. In questo vuoto si inserì uno strato di piccoli proprietari terrieri, la gentry, che si orientò in modo aggressivo verso l’agricoltura di mercato e il pascolo delle pecore, allineando le proprie fortune al commercio della lana in espansione. Dalla fine del XV secolo in poi, imposero con crescente ferocia la recinzione dei terreni, chiudendo i terreni comuni e convertendo i campi coltivabili in pascoli. Questo processo arricchì quei piccoli proprietari terrieri che riuscirono ad assicurarsi affitti o piccoli possedimenti liberi, ma per la massa dei contadini significò l’espropriazione. Il crescente numero di lavoratori senza terra e di “mendicanti robusti” testimonia la violenta ristrutturazione delle campagne, dove la sussistenza lasciò il posto alla mercificazione.
La monarchia Tudor (1485-1603) consolidò questa trasformazione stringendo un’alleanza strategica con la piccola nobiltà. Enrico VII ed Enrico VIII riconobbero che la sopravvivenza della Corona non dipendeva dalle vecchie casate baronali, ma da una classe emergente di proprietari terrieri locali, i cui interessi economici li legavano al commercio piuttosto che ai servi feudali. I Tudor li impiegarono come giudici di pace, sceriffi e amministratori, conferendo loro un’autorità locale senza precedenti in cambio della fedeltà alla Corona. Questa alleanza si approfondì con la rottura con Roma e l’istituzione della Chiesa d’Inghilterra con il suo protestantesimo anglicano. Con la chiusura dei monasteri Enrico VIII nel 1530 espropriò un quarto delle terre inglesi, gran parte delle quali furono vendute a prezzi vantaggiosi alle famiglie della piccola nobiltà. Questo atto contemporaneamente distrusse il potere istituzionale della Chiesa, trasferì vaste ricchezze in mani private e fornì alla piccola nobiltà la base materiale per la sua ulteriore ascesa. La riforma protestante si sposò così con gli interessi di classe, ruppe il monopolio ideologico del cattolicesimo e allo stesso tempo giustificò e legittimò nuove forme di accumulazione di proprietà.
Dei piccoli proprietari terrieri alcuni prosperarono dando in affitto le terre già dei monasteri e integrandosi nell’agricoltura di mercato, unendosi alla nobiltà come “nuovi arrivati”. Altri, schiacciati tra le recinzioni della nobiltà e le tasse della corona, gradualmente persero la loro forza indipendente. Lo Stato Tudor, mentre retoricamente difendeva il “common wealth” contro le recinzioni, quando i conflitti si acuirono si schierò costantemente con la piccola nobiltà. Nel XVI e XVII secolo la campagna era polarizzata: da un lato una piccola nobiltà sicura di sé, rafforzata da prosperi piccoli proprietari terrieri; dall’altro la massa dei lavoratori espropriati, dei contadini e dei salariati. Da questa polarizzazione emerse il percorso distintivo dell’Inghilterra verso il capitalismo agrario, un ordine sociale in cui le pecore “mangiano gli uomini” (Tommaso Moro), l’ideologia protestante arma la nobiltà e sono gettate le basi per il successivo scontro tra Parlamento e Monarchia nella Rivoluzione inglese.
Nel XVII secolo i piccoli proprietari terrieri impoveriti costituivano gran
parte della base sociale delle ali radicali della Rivoluzione inglese. In
movimenti come i Levellers (Livellatori) e i Diggers (Zappatori) elementi di
questa classe premevano per la proprietà comune, la parità dei diritti e lo
smantellamento dei privilegi aristocratici. Tuttavia rimasero incapaci di
esprimere un programma storico distinto da quello borghese, nonostante le loro
richieste a volte proto-comuniste. Tuttavia la relativa indipendenza materiale
dava loro la forza e la convinzione ideologica per sfidare a volte le gerarchie
di classe consolidate.
13. - Verso il Nuovo Mondo
Tuttavia l’avanzata delle recinzioni dal XV secolo in poi erose costantemente questa indipendenza. L’ondata delle espropriazioni divenne una forza motrice centrale dell’emigrazione inglese verso il Nuovo Mondo. All’inizio del XVII secolo, molti di coloro che si stabilirono in Virginia, nel New England e nelle colonie centrali non erano poveri senza terra, ma contadini medi e piccoli proprietari terrieri in fuga dalle recinzioni e dal destino incombente della proletarizzazione. In America cercavano di ricostituire l’indipendenza perduta dei villaggi inglesi sotto forma di fattorie a conduzione familiare. Ma questa “libertà” si basava su un espropriazione di tipo diverso, la confisca delle terre indigene. Ciò che era iniziato in Inghilterra con la recinzione, continuò all’estero con la colonizzazione. Una frontiera perpetua dove l’ideale del piccolo proprietario terriero poteva essere rinnovato solo attraverso una violenta espansione.
Negli Stati Uniti, questa tradizione si cristallizzò nella figura del piccolo proprietario terriero come ideale repubblicano. Nel XVIII e XIX secolo, i piccoli proprietari terrieri erano tipicamente agricoltori familiari non schiavisti, orientati alla sussistenza in luoghi come gli altipiani degli Appalachi e, dove la terra era fertile, dediti alla commercializzazione. Le loro proprietà variavano da 50 a 200 acri nel Sud, mentre nel nord la stragrande maggioranza delle fattorie era gestita da famiglie di piccoli proprietari.
Thomas Jefferson elevò il piccolo proprietario terriero a archetipo politico, il presunto fondamento della virtù repubblicana, indipendente, incorruttibile e libero dai vizi del lavoro salariato urbano o del capitale speculativo. Questo idealismo agrario fu utilizzato per giustificare e difendere gli interessi del programma economico del primo capitalismo commerciale negli Stati Uniti all’interno delle colonie del Sud e della sua classe dominante di proprietari terrieri, sia contro la vecchia monarchia sia contro il crescente capitale finanziario e industriale del Nord, sotto la guida dei Federalisti poi dei Whigs, con le loro esigenze economiche contrastanti.
Questa visione interclassista jeffersoniana fu portata avanti nella democrazia jacksoniana, che presentava l’“uomo comune” come sovrano, e allo stesso tempo incanalava nel Destino Manifesto la disperazione dei contadini sfollati e difendeva la schiavitù come un modo per mantenere lo status del contadino indipendente contro il dispotismo industriale in via di sviluppo negli ancora piccoli centri manifatturieri urbani. La tragica ironia era che la fuga dalle recinzioni in Inghilterra, e più tardi dalla concentrazione capitalista in America, alimentò un progetto coloniale che deportò violentemente le popolazioni indigene per far posto a un nuovo ciclo di piccola proprietà, destinate, a loro volta, a essere divorate dall’accumulazione del capitale.
In America alla fine del XIX secolo la base materiale della classe dei contadini piccoli proprietari andrà disfacendosi. L’agricoltura industriale, i monopoli ferroviari e il lavoro salariato ridussero l’indipendenza dei piccoli proprietari, anche se movimenti politici come il Grange cercavano di difenderne la posizione. In realtà il piccolo proprietario terriero, il contadino indipendente, non era una classe stabile, ma di transizione. In Europa era stato un prodotto storico della dissoluzione del feudalesimo e dell’ascesa del capitalismo. La sua ideologia di autosufficienza, modesta prosperità e libertà individuale divenne la maschera culturale della classe media americana, che rimane un’aspirazione delirante e nociva all’interno della classe operaia americana, che continua a legarsi alle aspirazioni della piccola borghesia e ai programmi nazionalisti interclassisti dei partiti politici degli sfruttatori. Ma, come osservò Marx, la piccola proprietà è sempre autodistruttiva, divisa tra le pressioni dell’accumulazione di capitale e la sua base ristretta nella piccola produzione. Il sogno dello yeomen era quindi storicamente destinato a fallire, prima espulso dalle recinzioni, poi trasferitosi nella colonizzazione e infine cancellato dal capitale industriale.
Lo stesso vale e varrà per le attuali classi medie e le aristocrazie operaie. Il
perdurante mito della “classe media” yeoman serve solo a oscurare la necessità
della lotta collettiva del proletariato, oltre la proprietà e oltre la
democrazia, verso l’emancipazione della specie umana attraverso la guerra civile
di classe, l’instaurazione della dittatura del proletariato e il successivo
dispiegarsi del comunismo pieno.
14. - Il controllo asburgico delle Low Lands e le prime rivoluzioni
borghesi: il colonialismo inglese e olandese
Il circuito di produzione tessile che interessava Inghilterra e Fiandre non era destinato a durare a lungo. Fu interrotto dall’ascesa dell’egemonia spagnola in Europa, fornendo incentivo economico all’apertura di smercio coloniale dei prodotti di lana prima dell’ascesa dei Tudor e del luteranesimo in Germania.
La conquista delle Fiandre da parte degli Asburgo nel 1482 e il suo consolidamento sotto Carlo V all’inizio del XVI secolo, legarono le città tessili fiamminghe, un tempo semi-autonome, all’orbita di un vasto impero europeo. Il commercio della lana inglese fu soggetto alle politiche dei sovrani asburgici, che controllavano anche la Spagna, la Borgogna e gran parte dell’Europa centrale. Con l’acuirsi delle controversie tra l’Inghilterra e gli Asburgo, soprattutto durante i regni di Enrico VIII ed Elisabetta I, la Corona inglese e i mercanti si trovarono ad affrontare rischi crescenti nell’affidarsi esclusivamente ai mercati fiamminghi. Anversa era diventata il centro commerciale dei Paesi Bassi, ma, per la vulnerabilità delle esportazioni inglesi a embarghi, guerre e pesanti tassazioni, l’Inghilterra, invece di rimanere fornitore di lana grezza per i tessitori continentali, iniziò a costruire una propria industria.
Verso la fine del XV e XVI secolo questa trasformazione era visibile nell’insediarsi di tessitori fiamminghi nel Norfolk, nel Suffolk e nel West Country, dove la lana inglese era filata e trasformata in tessuto. I rifugiati delle guerre continentali e delle persecuzioni religiose, compresi gli ugonotti provenienti dalla Francia, arricchirono ulteriormente le competenze e i metodi inglesi. L’Inghilterra aggirò sempre più gli intermediari fiamminghi, vendendo i tessuti direttamente sui mercati esteri. Questo sviluppo ridusse la dipendenza dai Paesi Bassi, controllati dagli Asburgo, ma creò anche nuove pressioni: un’industria tessile in espansione aveva bisogno sia di fonti sicure di materie prime sia di mercati garantiti per i suoi prodotti.
La logica del colonialismo emerse come una necessità vitale per la continua
crescita dei capitali. La lana rimase centrale, ma la ricerca di fibre
alternative come il cotone e la necessità di consumatori vincolati spinsero
l’Inghilterra verso l’esterno. Alle future colonie nelle Americhe e in Asia fu
impedito di sviluppare industrie tessili concorrenti e fu invece imposto loro di
importare tessuti britannici. Allo stesso tempo, il cotone grezzo proveniente
dall’India e, più tardi, dal Sud degli Stati Uniti si accompagnò alla
meccanizzazione delle fabbriche inglesi della rivoluzione industriale. Pertanto,
il monopolio degli Asburgo sui Paesi Bassi non soffocò l’industria tessile
inglese, ma la spinse piuttosto l’Inghilterra verso l’indipendenza,
l’autosufficienza e, infine, l’espansione imperiale. Lo smercio dei tessuti
spinse ad aprire, poi a mantenere l’impero coloniale inglese, collegando pascoli
di pecore, piantagioni coloniali e mercati globali in un unico sistema di potere
economico.
15. - Gli Asburgo e le rivoluzioni contadine tedesche
L’alba del XVI secolo vide la rapida ascesa della dinastia degli Asburgo a potere centrale in Europa. Attraverso matrimoni ed eredità Carlo V unì le corone di Spagna e del Sacro Romano Impero ponendo sotto un’unica monarchia territori che si estendevano dalla penisola iberica e dalle Americhe alla Germania, ai Paesi Bassi e a parti dell’Italia. Questa concentrazione di autorità rappresentò il tentativo più ambizioso di monarchia universale nell’Europa feudale, concentrando un immenso potere militare. Tuttavia, questo impero, lacerato da contraddizioni, poggiava sulle fondamenta medievali della monarchia di diritto divino, pur dipendendo sempre più dalla emergente borghesia (mercanti, finanzieri e banchieri) che forniva il credito e le infrastrutture per le sue guerre. Il tesoro spagnolo e i prestiti tedeschi alimentarono l’espansione imperiale, ma l’estrazione del surplus per sostenere la dinastia intensificò gli antagonismi di classe in tutto il continente.
Fu proprio in questo crogiolo che esplosero le prime onde d’urto della Riforma. Nel 1517, Martin Lutero affisse le sue Novantacinque Tesi alla porta della chiesa di Wittenberg, condannando le indulgenze e denunciando la corruzione del papato. Ma l’attacco di Lutero agli abusi clericali si trasformò rapidamente in un attacco più ampio all’autorità spirituale e materiale di Roma. Quella che era iniziata come una disputa teologica sulla corruzione della Chiesa divenne un movimento di massa quando i membri delle corporazioni urbane, gli studenti e i contadini fecero proprio il linguaggio della Riforma per sfidare le esazioni opprimenti sia della Chiesa sia dello Stato. Le congregazioni protestanti si organizzarono indipendentemente da Roma, rifiutando la gerarchia centralizzata del cattolicesimo a favore di forme di culto più localizzate e collettive. Per gli artigiani, i cittadini e i contadini, il protestantesimo divenne una bandiera contro i canoni feudali, le decime e i privilegi clericali. Gli stessi principi tedeschi si divisero su queste linee, alcuni abbracciando Lutero come arma per strappare l’autonomia politica all’imperatore asburgico e ai suoi alleati nel papato.
Non molto tempo dopo, nel 1534, fu istituita formalmente la Chiesa d’Inghilterra con l’Atto di Supremazia sotto Enrico VIII, che divise l’Inghilterra da Roma dopo che il papa aveva rifiutato di annullare il suo matrimonio. La rottura di Enrico si affiancava alla sfida dei principi tedeschi che proteggevano Lutero, entrambi affermando la sovranità nazionale contro l’autorità papale e asburgica, mentre consolidavano le forze borghesi emergenti attorno alle alleanze di convenienza con gli Stati monarchici e i principati che cercavano maggiori profitti liberandosi dal pesante giogo spagnolo e cattolico.
I progetti coloniali spagnoli e portoghesi erano già stati sanciti da bolle papali come la Dum Diversas (1452) e la Romanus Pontifex (1455), che autorizzavano la schiavitù e la conquista in nome di Cristo, conferendo alla Spagna e al Portogallo il dominio sulla maggior parte del mondo al di fuori dell’Europa. Mentre il metallo prezioso proveniente dalle Americhe affluiva nelle casse degli Asburgo, l’autorità papale si rivelò non solo spirituale ma uno strumento di saccheggio e di repressione. Nel frattempo i principi della Germania settentrionale avevano chiare ragioni materiali per rompere con Roma. Sotto l’ordine cattolico erano per lo più esclusi dalle ricchezze in espansione, ma erano tenuti a pagare pesanti decime e tributi al papato, e vaste distese di terra e ricchezze erano vincolate a monasteri e vescovadi che agivano come poteri semi-indipendenti. Abbracciando le dottrine di Lutero i principi potevano impadronirsi delle terre della Chiesa, appropriarsi delle rendite monastiche e porre fine al drenaggio finanziario verso Roma, aumentando così le proprie tesorerie e consolidando la sovranità all’interno dei propri territori. La Riforma fu quindi sia una rivolta ideologica contro l’autorità papale sia una redditizia ridistribuzione della ricchezza dalla Chiesa ai governanti secolari. I Tudor in Inghilterra seguirono un percorso parallelo.
Tra il 1500 e il 1650, la Spagna importò circa 180 tonnellate d’oro e 16.000 tonnellate d’argento, gran parte delle quali provenienti dalle miniere di Potosí in Bolivia. Questo afflusso finanziò le guerre imperiali, ma destabilizzò l’Europa, alimentando la “rivoluzione dei prezzi”. Mentre i mercanti e i finanzieri prosperavano, i contadini vedevano aumentare gli affitti e le tasse oltre i livelli di sussistenza. In Spagna i piccoli proprietari terrieri furono rovinati dalle tasse; in Germania i principi asburgici finanziati dalla Spagna intensificarono le esazioni per finanziare le guerre di religione e le ambizioni dinastiche. Il saccheggio coloniale alimentò così direttamente l’oppressione dei contadini europei, fondendo il destino dei minatori andini con quello dei servi tedeschi.
La guerra dei contadini del 1524-25, in cui quasi 300.000 contadini tedeschi insorsero chiedendo l’abolizione della servitù della gleba e l’alleviamento dei gravami feudali, deve essere compresa in questo contesto. I ribelli traevano spesso ispirazione dall’ala radicale della predicazione protestante: Thomas Müntzer, ad esempio, insisteva sul fatto che la giustizia divina esigeva il rovesciamento dei signori e la comunalizzazione della proprietà, facendo eco alle richieste di John Bell durante la ribellione di Wat Tyler. Engels, in La guerra dei contadini tedeschi (1850), sosteneva che queste rivolte non erano esplosioni isolate, ma il «primo grande atto della lotta di classe rivoluzionaria in Germania», collegato da un filo rosso alle rivoluzioni del 1848 e ricollegato allo stesso arco storico iniziato con le rivolte contadine del XIV secolo. Per Engels, la continuità tra i contadini del XVI secolo e i lavoratori del XIX secolo rivelava il carattere incompiuto della rivoluzione borghese tedesca, ripetutamente soffocata dalle alleanze tra aristocrazia, principi e la nascente piccola nobiltà.
Questo arco storico si sarebbe prolungato, con conseguenze sui giovani Stati
Uniti d’America, quando, dopo la sconfitta delle rivoluzioni del 1848, si
verificò un vasto esilio di rivoluzionari tedeschi, i “Quarantottini”, molti dei
quali costretti all’esilio oltre Atlantico. Lì portarono con sé il ricordo delle
rivolte fallite e le tradizioni radicali della democrazia e del socialismo.
Nella Guerra Civile americana questi emigrati a migliaia si arruolarono
nell’esercito dell’Unione per contribuire al completamento della rivoluzione
borghese e della distruzione della schiavitù, mentre dirigenti come Carl Schurz
e Franz Sigel e persino comunisti strettamente legati a Marx come Joseph
Weydemeyer ricoprivano incarichi di comando di rilievo. In questo senso la lotta
contro la schiavitù in America non fu solo un conflitto interno ma la
continuazione delle rivoluzioni incompiute dell’Europa.
16. - La Leggenda Nera spagnola: origini della schiavitù di razza
nella Controriforma
Man mano che il dominio spagnolo sotto gli Asburgo si estendeva fino a comprendere tutta l’Europa, si rafforzava anche il suo controllo sulle Americhe. Quando iniziarono le rivolte indigene nelle colonie e le rivolte protestanti in tutto il cristianesimo del vecchio mondo, gli spagnoli instaurarono la Controriforma, utilizzando l’Inquisizione e una serie di riforme istituzionali e innovazioni nel tentativo di mantenere la loro egemonia feudale, sempre più arretrata, sull’Europa e sul Nuovo Mondo.
La Spagna entrò nel XVI secolo come la monarchia più potente d’Europa, portando avanti la bandiera dell’espansione cattolica. Nelle colonie, attraverso missioni, battesimi forzati e distruzione di templi, la Chiesa in pochi decenni conquistò milioni di anime.
La conquista territoriale del Nuovo Mondo fu organizzata inizialmente attraverso l’istituzione dell’encomienda. Si trattava dell’istituzione centrale della prima colonizzazione, in cui la Corona concedeva terre ai conquistadores, ai coloni e agli ordini ecclesiastici. Sotto l’encomienda, interi villaggi indigeni furono costretti a pagare tributi in beni, raccolti o lavoro coatto. In teoria, gli encomenderos erano i guardiani dei loro protetti, incaricati di cristianizzarli e “proteggerli”. In realtà, si trattava di schiavitù, con gli indiani spinti nelle miniere, nei campi e nelle officine sotto la frusta, spesso lavorando fino alla morte. Solo nell’Hispaniola, in centinaia di migliaia morirono nel giro di una generazione. In Messico e in Perù intere comunità furono sradicate per fornire manodopera per l’estrazione dell’argento e dell’oro.
Accanto all’encomienda sorse l’hacienda, un sistema che consolidava la terra in tenute permanenti. Mentre le encomiendas erano tecnicamente concessioni temporanee, l’hacienda fissava sia il suolo che le persone ai proprietari e agli ordini religiosi. I contadini indigeni furono trasformati in affittuari e peones indebitati, vincolati dalla coercizione e da obblighi senza fine. Insieme, l’encomienda e l’hacienda fusero le esazioni feudali con la logica dell’accumulazione coloniale. Divennero i pilastri del dominio spagnolo nelle Americhe, vincolando gli indiani al tributo, al debito e alla coercizione, mentre concentravano la terra nelle mani di un’oligarchia coloniale legata alla Corona e alla Chiesa.
Tuttavia, questo dispotismo portava con sé delle contraddizioni. La Chiesa predicava la salvezza universale, mentre le encomiendas e le haciendas imponevano il lavoro schiavo ai cristiani battezzati. Le ribellioni indigene su larga scala, come quella di Enriquillo a Hispaniola (1519-33) e la guerra di Mixtón nel Messico occidentale (1540-42), rivelarono la fragilità del controllo spagnolo. Mentre il tumulto sociale e le crescenti contraddizioni della società medievale in decadenza si accentuavano, sacerdoti spagnoli riformisti come Bartolomé de las Casas denunciarono la crudeltà degli encomenderos, sostenendo che gli indiani erano esseri razionali capaci di conversione.
Di fronte alla doppia minaccia delle rivolte indigene e dell’emergente fermento protestante in Europa, la Corona cominciò a rendersi conto di trovarsi di fronte a una crisi esistenziale. Così iniziò in fretta il processo di organizzazione della Controriforma, per consolidare la legittimità e il potere della Chiesa e del dominio spagnolo. Fondamentali in questo senso furono le Nuove Leggi del 1542 volte a limitare la schiavitù degli indigeni. Non si trattò di una scelta dettata dalla coscienza ma da un calcolo politico: la Corona spagnola cercava di ridurre gli eccessi nelle colonie che scatenavano le rivolte, preservando al contempo l’immagine di uno Stato cattolico benevolo in Europa, per contrastare la Riforma protestante che smascherava gli abusi di Roma al fine di fornire alla borghesia ascendente un linguaggio e un pretesto per la rivoluzione.
La Riforma e la Controriforma divennero inseparabili dalla difesa del vecchio Impero coloniale e dalla giustificazione di quelli nuovi e ampliati, dove lo sviluppo dei mezzi di produzione non era più frenato dai vincoli feudali. L’appello di Lutero a utilizzare le Scritture nella lingua locale infranse il monopolio clericale sulle conoscenze. I membri delle corporazioni, i contadini e i cittadini abbracciarono la nuova fede per opporsi ai canoni e alle decime. Il protestantesimo si diffuse a macchia d’olio, trasportato dalla stampa, la nuova arma e tecnologia produttiva dell’epoca. Roma rispose a Trento (1545-63), centralizzando la dottrina, rafforzando il potere dei gesuiti e imponendo la censura attraverso l’Indice dei libri proibiti. La Spagna, il pugno di ferro del papato, giurò di mantenere i suoi domini liberi dal protestantesimo. Lo dimostrò con il sangue a Fort Caroline nel 1565, dove Pedro Menéndez massacrò i coloni ugonotti francesi. La lotta globale tra Riforma e Controriforma fu combattuta con sermoni, opuscoli e massacri.
Nonostante le presunte riforme del lavoro della Spagna, l’ideologia non poteva alterare il bisogno materiale di una forza lavoro sfruttata in continua crescita. Le miniere e le piantagioni divoravano i corpi. Le malattie annientarono milioni di indigeni. Le encomiendas crollarono sotto la rivolta e lo spopolamento. Per sostenere la sua domanda di manodopera la Spagna si rivolse allora sistematicamente alla schiavitù africana. L’asiento de negros (dal 1517 in poi) garantiva il monopolio ai mercanti che fornivano schiavi africani in cambio di pagamenti alla Corona, legando ancora più profondamente il commercio degli schiavi al meccanismo fiscale dell’Impero.
Questo passaggio alla schiavitù africana richiedeva una nuova giustificazione ideologica. Secondo la vecchia disposizione, la schiavitù era giustificata dalla religione, poiché i pagani potevano essere tenuti in schiavitù fino al battesimo. Ma gli africani rimanevano schiavi indipendentemente dalla conversione. Il dibattito di Valladolid del 1550-51, tenuto dal clero spagnolo, tra Juan Ginés de Sepúlveda e Bartolomé de las Casas, cristallizzò le contraddizioni del dominio coloniale spagnolo. Sepúlveda si basò su Aristotele per affermare che gli indiani erano “schiavi naturali”, nati per la servitù, mentre Las Casas difese la loro razionalità e capacità di conversione al cristianesimo. Il dibattito, insieme a riforme come le Nuove Leggi del 1542, contribuì a limitare la schiavitù formale degli indigeni, ma solo per spostare su altri il peso del lavoro nelle colonie.
All’epoca lo stesso Las Casas approvò l’importazione di africani, sostenendo che erano più adatti al lavoro pesante e potevano sostituire gli indigeni, riproducendo di fatto la logica dello “schiavo naturale” che aveva denunciato quando applicata agli amerindi. Più tardi nella vita si pentì amaramente di questa posizione, riconoscendo che la schiavitù africana era altrettanto ingiusta e disumana. Tuttavia, indipendentemente dal suo sentimento personale nei confronti del sistema dell’asiento, la Corona autorizzò l’importazione di massa di africani per sostenere le piantagioni di zucchero nei Caraibi e le miniere d’argento nel Potosí. Da questo cambiamento emerse l’ordine di casta razziale, il sistema de castas, che divise la gerarchia in base al sangue e al fenotipo. Così l’apparente “vittoria” di Las Casas risparmiò agli indiani la schiavitù formale, ma al costo di rendere la schiavitù africana una condizione permanente e ereditaria, gettando le basi per l’ordine coloniale completamente razzializzato dell’America spagnola. In Spagna furono sviluppati statuti di limpieza de sangre per escludere ebrei e mori di discendenza “impura”; nelle colonie fu infine sviluppato il sistema de castas, che codificava la gerarchia in base all’ascendenza e al colore della pelle. La schiavitù si trasformò da pena religiosa a condizione razziale, permanente e ereditaria.
I protestanti, basandosi sugli scritti critici di Las Casas contro il dispotismo spagnolo, avevano sviluppato la nozione degli indigeni americani come “nobili selvaggi”. Gli scrittori protestanti, desiderosi di minare la legittimità della Spagna, reimmaginarono gli indiani d’America all’interno di un nuovo stereotipo come innocenti, non corrotti dalla decadenza europea e quindi vittime della tirannia cattolica piuttosto che un popolo destinato alle catene. Questa mossa retorica servì a due scopi. Fornì alle potenze protestanti munizioni morali nella loro denuncia della “leggenda nera” spagnola e moralizzò il loro disinteresse o incapacità di schiavizzare in massa i nativi americani dopo aver acquisito le proprie colonie. Al contrario, i nativi furono considerati potenziali alleati o partner commerciali, almeno fino a quando la fame di terra e l’espansione non li resero ostacoli da espropriare e sterminare. Ciò si attenuò nelle loro successive giustificazioni teologiche evangeliche sotto il Destino Manifesto e nelle loro affermazioni sul colonialismo come missione umanitaria volta a diffondere la civiltà.
Tuttavia, sia per i protestanti sia per i cattolici, gli africani, al contrario, rimasero intrappolati nella categoria degli “schiavi naturali”, una costruzione ideologica che cancellava le contraddizioni dell’universalità cristiana e li riduceva a una forza lavoro ereditaria. La presunta distinzione morale mascherava un semplice calcolo anche per gli inglesi e gli olandesi. A differenza degli africani, che erano stati sradicati, trasportati e contrassegnati come stranieri fin dall’inizio, i nativi americani erano radicati nelle loro terre, difficili da eliminare in massa, inclini alla resistenza e troppo essenziali come partner commerciali o alleati militari nella lotta contro la Spagna e la Francia. Ridurli in schiavitù in massa, come aveva tentato di fare la Spagna, era impraticabile per gli inglesi, che invece facevano affidamento su trattati forzati e guerre per liberare il territorio alle colonie di insediamento. Gli africani, strappati dalle loro terre d’origine e razzializzati come stranieri permanenti, potevano essere più facilmente ridotti a una forza lavoro ereditaria. Pertanto, l’indignazione selettiva delle potenze protestanti nei confronti della schiavitù degli indigeni americani e il loro silenzio sul commercio africano rivelava il calcolo delle classi borghesi emergenti che cercavano di inquadrare il loro ordine emergente come la causa universale per tutte le classi e tutta l’umanità, quando in realtà servivano solo i loro stretti interessi all’accumulazione del capitale.
Nonostante denunciassero la Spagna attraverso la “Leggenda Nera”, gli inglesi e gli olandesi finirono per costruire i propri sistemi di schiavitù razziale in Virginia, Barbados e Suriname. La “scienza” borghese fornì la sua sanzione empirica: la tassonomia razziale di Bernier (1684), il Systema Naturae di Linneo (1735) e le “varietà dell’umanità” di Blumenbach (1775/1795) ridefinirono il dominio come un fatto naturale. Così cattolici e protestanti, feudatari e mercanti borghesi finirono per convergere sulla stessa nuova realtà oggettiva: la razza, non la religione, come giustificazione universale della schiavitù. Con il dissolversi dell’unità del mondo cristiano, entrambe le potenze coloniali emergenti poterono almeno concordare su questa nuova visione del mondo. La promessa cristiana della salvezza universale non poteva coesistere con un ordine coloniale che richiedeva una schiavitù permanente e ereditaria.
La contraddizione fu risolta abbandonando l’universalità e incoronando la razza.
Spada, sermone e “scienza” borghese si fusero per santificare le catene. Fu
l’alba del capitalismo: l’accumulazione primitiva realizzata attraverso lo
sterminio degli indiani, la schiavitù degli africani e l’invenzione ideologica
della razza per giustificare la gerarchia e le forme storicamente transitorie di
sfruttamento del lavoro, un tempo tramite la legge divina, ora la “legge
naturale“.
17. - Gli olandesi sotto gli Asburgo e la guerra degli ottant’anni
I Paesi Bassi erano un centro commerciale fondamentale all’interno dell’Impero spagnolo degli Asburgo. Nel 1500 i Paesi Bassi settentrionali, in particolare l’Olanda, avevano uno dei tassi di urbanizzazione più alti d’Europa. Una classe mercantile e artigianale dominante, organizzata attorno alla produzione tessile, alla pesca, al commercio di cereali e al trasporto marittimo. Si svilupparono città con una notevole autonomia, autogoverno e milizie urbane proprie.
Sebbene la Spagna avesse conquistato e colonizzato le Americhe, i benefici del saccheggio coloniale confluivano indirettamente nell’economia olandese. I mercanti olandesi fungevano da trasportatori secondari di lingotti e merci spagnole americane, soprattutto prima della rivolta olandese. Amsterdam e Anversa erano i principali centri di ridistribuzione dell’argento, dello zucchero, del tabacco e dei coloranti americani. Le aziende olandesi finanziavano la logistica imperiale spagnola, costruivano navi e prestavano denaro alle case mercantili. La Spagna non aveva una forte classe capitalista interna. Si affidava ai finanzieri genovesi e tedeschi per i prestiti, ai mercanti olandesi e fiamminghi per la circolazione dei lingotti e la distribuzione delle merci, ai costruttori navali e agli artigiani dei Paesi Bassi per sostenere le sue flotte. Questo commercio creò una classe capitalista commerciale autosufficiente nei Paesi Bassi, sviluppando alla fine un modo di produzione che era in gran parte di tendenza capitalista, con lavoro salariato, produzione di merci e scambio di mercato. Questo creò un paradosso. Il sistema coloniale della Spagna feudale dipendeva in parte dal lavoro, dalle infrastrutture e dal capitale della sua futura classe borghese nemica, che aiutò gli olandesi a sviluppare l’autonomia economica e tecnica prima dell’inizio della rivolta.
Mentre il protestantesimo cominciava a diffondersi la monarchia spagnola degli Asburgo tassava pesantemente i Paesi Bassi per finanziare le guerre imperiali. Cercò di imporre alle città olandesi relativamente autonome l’Inquisizione, le guarnigioni militari e le imposte sulle vendite. Ciò incontrò una feroce resistenza da parte dei mercanti, delle corporazioni e dei consigli cittadini, che volevano il libero scambio, tasse basse e l’amministrazione locale. I costi per mantenere il vasto impero spagnolo in Europa e nelle Americhe portarono all’esaurimento economico. La borghesia olandese, specialmente in Olanda e Zeeland, resistette al prosciugamento delle proprie ricchezze per guerre straniere e obiettivi feudali-monarchici. La prima grande rivoluzione borghese di successo scoppiò con la Guerra degli Ottant’anni nel 1566, quando la borghesia olandese entrò in aperta ribellione e alla fine nel 1648 trionfò, fondando la Repubblica olandese completamente borghese. Un anno dopo, in Inghilterra, la Rivoluzione inglese sarebbe iniziata con l’esecuzione di Carlo I da parte del Parlamento inglese e l’Inghilterra sarebbe entrata in una repubblica, il Common Wealth, che durò fino a quando Carlo II fu ristabilito come re d’Inghilterra nel 1660.
Quando gli olandesi si liberarono dal giogo papista degli spagnoli, la borghesia
olandese in ascesa ottenne il controllo di molte delle colonie spagnole in
Oriente e fu in grado di smantellare liberamente le strutture corporative e
sviluppare pienamente il proprio sistema di manifatture urbane a livello
nazionale. Questo richiese una maggiore domanda di lana inglese, il che a sua
volta spinse i nobili inglesi a produrre maggiori eccedenze per l’esportazione.
I proprietari terrieri inglesi consolidarono le loro tenute allontanando i
contadini di sussistenza a favore del mantenimento di grandi greggi di pecore.
18. - La borghesia olandese e inglese e la costruzione navale
L’ascesa finale dell’Inghilterra e dell’Olanda come potenze coloniali nel XVI e XVII secolo era strettamente legata alla loro superiorità nella tecnologia marittima e nella costruzione navale, che dava loro un vantaggio decisivo sugli spagnoli e sugli italiani, entrambi dominatori sul mare nell’era precedente. Questo vantaggio non era solo tecnico ma profondamente legato all’organizzazione economica borghese, agli investimenti di capitale e alla transizione dal mercantilismo feudale al capitalismo marittimo. Il disegno superiore, la produttività e l’efficienza in termini di costi di costruzione delle navi inglesi e olandesi permisero loro di rompere il monopolio iberico sul commercio globale e di sfidare la supremazia imperiale spagnola sui mari.
Gli olandesi svilupparono la fluyt (o fluit), una nave mercantile stretta, leggermente armata e con uno scafo profondo che trasportava più carico con meno equipaggio, aveva un pescaggio ridotto, ideale per la navigazione costiera e fluviale, ed era più economica da costruire e mantenere rispetto ai galeoni spagnoli. La costruzione navale inglese seguì tendenze simili alla fine del XVI secolo: galeoni e mercantili più leggeri e veloci sostituirono i modelli pesanti e ingombranti. Le innovazioni nella progettazione delle attrezzature e dello scafo consentirono una maggiore manovrabilità e velocità, fondamentali per eludere o intraprendere la guerra navale.
I cantieri navali olandesi di Amsterdam e Rotterdam impiegavano una divisione del lavoro avanzata, parti standardizzate e tecniche di produzione di massa, riducendo drasticamente i costi. Nel XVII secolo, i cantieri navali olandesi erano in grado di produrre navi due volte più velocemente e a metà del costo dei cantieri spagnoli. I cantieri inglesi, sostenuti da contratti statali e capitali privati, seguirono l’esempio, soprattutto dopo i Naval Defence Acts della fine del 1500.
La Spagna faceva affidamento su galeoni grandi e pesantemente armati, ideali per le flotte del tesoro ma costosi e lenti, inadatti al commercio commerciale di massa, dipendenti dai finanziamenti statali e afflitti dall’inefficienza burocratica. La costruzione navale spagnola rimase artigianale, dipendente dalle strutture feudali delle corporazioni e priva del coordinamento industriale capitalizzato dei cantieri olandesi o inglesi.
La potenza marittima italiana (Venezia, Genova, Pisa) aveva raggiunto il suo apice nel tardo Medioevo, soprattutto nel contesto mediterraneo. Non riuscì a passare efficacemente al commercio atlantico e alla navigazione in alto mare, in parte a causa della frammentazione politica, delle ristrette oligarchie mercantili e del ritardo nell’adattamento tecnologico (ad esempio, l’evoluzione dalla caravella alla fluyt).
Durante la Guerra degli Ottant’anni, i corsari e le flotte olandesi e inglesi
iniziarono a intercettare le navi del tesoro spagnole, minando il sistema
finanziario degli Asburgo. La Repubblica olandese utilizzò la sua forza nella
costruzione navale per dominare il commercio asiatico e sfidare il controllo
iberico nelle Indie orientali, in Brasile e nell’Africa occidentale. Le flotte
inglesi, sotto Elisabetta I e successivamente Cromwell, lanciarono incursioni
navali, imprese coloniali e monopoli mercantili che sarebbero culminati nella
conquista dei territori caraibici e nordamericani. Verso la metà del XVII secolo
gli olandesi possedevano la più grande flotta commerciale del mondo, mentre gli
inglesi stavano rapidamente costruendo un apparato navale-industriale che
sarebbe diventato la base dell’Impero britannico.
19. - La pirateria borghese inglese
Così la giovane borghesia inglese del XVI e XVII secolo poté arricchirsi attraverso la pirateria sancita dallo Stato, o corsareria, rivolta in gran parte contro le ricchezze coloniali dell’Impero spagnolo. Lungi dall’essere un’illegalità casuale, la corsareria era una strategia deliberata di accumulazione primitiva, che trasferiva tesori, merci e manodopera schiavizzata dagli imperi iberici in declino alle casse di una classe mercantile inglese in ascesa. L’episodio più famoso fu la circumnavigazione di Francis Drake (1577-80), autorizzata dalla regina Elisabetta, durante la quale saccheggiò i porti spagnoli e le flotte del tesoro attraverso il Pacifico. Il suo bottino, oltre 600.000 sterline, più delle entrate annuali dell’Inghilterra, confluì direttamente alla Corona e ai mercanti di Londra, finanziando l’espansione navale, l’avanzamento della nobiltà e le iniziative commerciali. John Hawkins, un altro corsaro, fu il pioniere dell’ingresso dell’Inghilterra nel commercio degli schiavi nell’Atlantico negli anni ’60 del XVI secolo, trafficando africani verso le colonie spagnole in spregio al monopolio papale. Catturando navi spagnole, Hawkins e i suoi successori sequestrarono lingotti, zucchero, spezie ed esseri umani, che furono tutti assorbiti dai circuiti del capitale di Londra e Bristol.
Questa infusione di bottino fornì il capitale iniziale per le prime società per azioni inglesi. La Muscovy Company (1555), la East India Company (1600) e più tardi la Royal African Company (1660) furono costruite sulle fondamenta del bottino piratesco e del commercio di contrabbando. Quello che era iniziato come una serie di incursioni contro i galeoni spagnoli si trasformò in un sistema di compagnie monopolistiche, fortezze costiere armate e insediamenti coloniali. In questo modo il bottino della pirateria fu trasformato nell’infrastruttura dell’Impero: le navi, i magazzini e le stazioni commerciali che ancorarono l’Inghilterra ai mercati globali. La guerra di corsa e la schiavitù non furono episodi marginali, ma centrali per il consolidamento di una classe mercantile che trasformò la pirateria in politica, la schiavitù in commercio e il colonialismo in Impero.
A queste fonti esterne di ricchezza si affiancò una violenta trasformazione interna. La recinzione dei terreni un tempo comunitari espulse i contadini trasformandoli in proletari senza terra. Questo sconvolgimento agrario si accompagnò alla crescita del commercio della lana, poiché i mercanti inglesi esportavano lana grezza ai telai avanzati della Repubblica olandese e reinvestivano i profitti nella navigazione e nel commercio. La nobiltà e i mercanti arricchiti cominciarono a sfidare il vecchio ordine feudale mi
nando il sistema delle corporazioni. I capitalisti subappaltarono la produzione tessile e artigianale a famiglie rurali disperse, aggirando la regolamentazione delle corporazioni e portando la manodopera sotto il loro diretto controllo.
All’inizio del XVII secolo la borghesia, alleata con alcuni settori della monarchia ma sempre più in contrasto con i suoi monopoli, cercò di eguagliare il suo potere politico al proprio dominio economico. Il Parlamento divenne il suo strumento, utilizzato per contestare il controllo reale sul commercio, la tassazione e le compagnie privilegiate. Queste tensioni culminarono nella guerra civile inglese, dove il monopolio della monarchia sul commercio e sulle entrate statali fu spezzato e fu affermata la supremazia politica della proprietà e del capitale. Così la pirateria, le recinzioni e il commercio della lana convergevano come forze parallele dell’accumulazione primitiva: esternamente attraverso il saccheggio e il commercio coloniale, internamente attraverso l’espropriazione dei contadini. Alla fine del XVII secolo, sia la borghesia inglese sia quella olandese avevano consolidato un capitale e un potere marittimo sufficienti per lanciare progetti coloniali sempre più sistematici nelle Americhe, gettando le basi per un mercato mondiale basato sulla schiavitù, l’industria e il commercio.
(Continua al prossimo numero)
Il Congresso si tenne a Roma a partire dal 20 aprile 1922, accolto trionfalmente dalla CGL e dal Partito Socialista. L’“Avanti!” del 21 aprile titolava: “La solenne inaugurazione del Congresso internazionale dei sindacati di Amsterdam”. Sul nostro “Il Comunista” dello stesso giorno: “Abbasso i traditori del proletariato - I comunisti italiani hanno il dovere di esprimere tutto il loro disprezzo ai convenuti, responsabili dei più grandi tradimenti verso la classe operaia”.
Il PCd’I aveva preparato per la diffusione un Manifesto in cui veniva denunciato al proletariato l’operato dell’Internazionale gialla, ponendo in luce come essa continuasse a svolgere una politica di collusione con la classe borghese-padronale, e di complicità con l’imperialismo mondiale; come fosse responsabile del sabotaggio dell’unità d’azione del proletariato; come difendesse e sostenesse l’obiettivo della ricostruzione capitalistica e come operasse per la disfatta delle azioni di massa contrapposte all’offensiva politica ed economica del capitale.
A conferma della loro stretta affinità con la diplomazia degli Stati capitalisti, i congressisti prima di riunirsi a Roma passarono per Genova, dove era in corso la famosa Conferenza, per offrire la loro disponibilità alla collaborazione di classe.
A Roma non si persero a formulare e organizzare progetti di difesa proletaria dagli attacchi padronali e dalla reazione violenta di Stati e guardie bianche: la maggior parte del loro tempo fu impiegata negli attacchi contro il comunismo e le sue organizzazioni. Ci fu chi si fece addirittura paladino della liberazione del proletariato russo dallo sfruttamento dello Stato sovietico-bolscevico; chi come lo svizzero Durr si vantava di aver liberato il sindacato metallurgico dai comunisti; chi come il polacco Zuawsky affermò che il militarismo russo non meno di quello borghese costituiva una grande minaccia per la pace mondiale e che i lavoratori di tutto il mondo dovevano combatterlo con estrema energia.
Ma la parte migliore fu recitata da D’Aragona secondo cui, se in Italia infuriava una spietata reazione lo si doveva ai comunisti, che scoraggiavano le masse seminando scissioni e diffondendo sfiducia tra i lavoratori. Per salvare il proletariato italiano dalla violenta repressione D’Aragona invocò l’aiuto di Amsterdam, chiedendo all’Internazionale gialla nientemeno che di inviare una lettera al governo italiano.
Abbiamo visto innumerevoli volte come i sostenitori della controrivoluzione, di tutte le tendenze, siano per la moderazione nel momento dell’azione, e per l’azione nel momento in cui è impossibile o dannosa. D’Aragona nel 1920 aveva firmato insieme a Lozovsky il manifesto che denunciava l’inefficienza dell’Internazionale di Amsterdam e incitava il movimento sindacale internazionale alla rivoluzione per l’abbattimento del capitalismo e la dittatura del proletariato.
Serrati su l’”Avanti!” del 12 aprile 1922 vestì i panni del difensore della Russia sovietica e dell’Internazionale Comunista, criticando la II Internazionale e concludendo: «Il punto di vista di tutti i socialisti italiani è (...) che bisogna difendere la rivoluzione russa, lottare contro la reazione mondiale, rivedere e abrogare l’infame trattato di Versailles, impedire nuove guerre». Il PCd’I il 27 aprile inviò una lettera alla Centrale del Partito Comunista di Germania riguardo l’Alleanza del Lavoro e il sabotaggio di questa da parte del Partito Socialista: «Se si confronta questo atteggiamento pratico con le dichiarazioni radicaleggianti di Serrati a Berlino, non si può non vedere come noi avessimo ragione nel dire ai compagni che la politica del centrismo italiano personificata da Serrati è molto più pericolosa per l’Internazionale Comunista e per il fronte unico internazionale che la politica della II Internazionale».
Riformisti, massimalisti e anarchici si comportavano in maniera analoga nei vari
Paesi. Aveva certamente ragione Lozovsky, come riportato da “Il Comunista” del
30 aprile 1922: «La differenza tra Amsterdam e l’Internazionale Sindacale Rossa
sta in ciò: che i nostri avversari si sforzano di dar novello vigore alla
vecchia società sfruttatrice che si fonda sul salario, mentre noi ci sforziamo
di distruggere le ultime energie vitali del capitalismo (...) Cosicché su nessun
punto i sindacati riformisti e rivoluzionari hanno in comune l’opinione o la
tattica».
10. - Il Secondo Congresso del Profintern
Il “Sindacato Rosso”, organo sindacale del PCd’I, del 1° luglio 1922 aveva annunciato la prossima apertura del Secondo Congresso del Profintern, riportando le regole di rappresentanza delle Centrali nazionali e delle frazioni sindacali aderenti, apertura contemporanea a quella del Quarto Congresso dell’Internazionale.
Questa, nelle “Direttive del Quarto Congresso per l’azione comunista nei sindacati”, nel dicembre 1922, scrive:
«5. Per conservare la loro autorità, i dirigenti dell’Internazionale di Amsterdam non esitarono a escludere non soltanto singoli individui e gruppi ma intere organizzazioni. In nessun caso gli uomini di Amsterdam intendevano restare in minoranza; e profilandosi la minaccia degli elementi rivoluzionari, dei sostenitori dell’ISR e dell’Internazionale Comunista, si sono decisi a provocare la scissione, avendo come presupposto che in tal modo avrebbero potuto conservare l’apparato amministrativo e le risorse materiali. Così hanno fatto i dirigenti della CGT francese; la stessa strada hanno imboccato i riformisti cecoslovacchi e i dirigenti della ADGB tedesca. Gli interessi della borghesia esigono la scissione del movimento sindacale.
«6. Contemporaneamente all’inizio dell’offensiva riformista nei vari paesi, la stessa offensiva è cominciata su scala mondiale. Le associazioni internazionali che sono seguaci di Amsterdam hanno sistematicamente espulso le corrispondenti associazioni nazionali rivoluzionarie, o si sono rifiutate di accettarle. Così i Congressi internazionali degli sterratori, dei tessili, degli impiegati, dei lavoratori delle pelli e del cuoio, dei lavoratori del legno, degli edili e dei postelegrafonici hanno rifiutato l’accesso ai sindacati russi e agli altri sindacati rivoluzionari, perché appartengono all’ISR (...)
«11. L’influenza della borghesia sul proletariato trova la sua espressione nella teoria della neutralità: i sindacati dovrebbero porsi obiettivi esclusivamente corporativi e strettamente economici e nessun obiettivo generale di classe (...) I sindacati che non si pongono obiettivi di classe, vale a dire non hanno di mira l’abbattimento del sistema capitalistico, nonostante la loro composizione proletaria sono i migliori difensori dell’ordine sociale borghese (...)
«14. Questa lotta contro la “politica” e i partiti politici della classe operaia provoca un regresso del movimento operaio e delle organizzazioni operaie, e parimenti una campagna contro il comunismo, espressione concentrata della coscienza di classe del proletariato. L’indipendenza in tutte le sue forme, sia essa anarchica o anarco-sindacalista, è una dottrina anticomunista e bisogna opporle il più strenuo rifiuto: nel migliore dei casi, infatti, ha come conseguenza l’indipendenza dal comunismo e l’antagonismo tra sindacati e partiti comunisti, quando non conduce a una dura lotta dei sindacati contro i partiti comunisti, il comunismo e la rivoluzione sociale (...)
«17. I comunisti non possono e non debbono, in nome di astratti principi anarco-sindacalisti, rinunziare al proprio diritto di organizzare “cellule” all’interno dei sindacati, qualunque ne sia l’orientamento (...)
«21. La parola d’ordine dell’Internazionale Comunista contro la scissione dei sindacati deve essere applicata anche in futuro con energia immutata, nonostante le rabbiose persecuzioni cui i riformisti di tutti i paesi espongono i comunisti (...)
«23. Nei paesi nei quali sussistono contemporaneamente due centrali sindacali (Spagna, Francia, Cecoslovacchia, ecc.), i comunisti debbono lottare per la fusione delle due organizzazioni. Poiché l’obiettivo è quello della riunificazione dei sindacati che sono già scissi, è assurdo che singoli comunisti e operai rivoluzionari si tolgano dai sindacati riformisti per inserirsi nei sindacati rivoluzionari. Nessun sindacato riformista deve essere privato dei fermenti rappresentati dai comunisti. Un’attività efficiente e vigorosa dei comunisti in entrambe le organizzazioni è la premessa per la ricostituzione della distrutta unità (...)
«27. L’espulsione dei comunisti dopo che sono stati eletti dalle organizzazioni locali non può provocare unicamente proteste contro la violazione della volontà degli elettori: tale espulsione deve avere come conseguenza una opposizione decisa e bene organizzata. Gli espulsi non debbono disperdersi. Il compito più importante del partito comunista consiste nel non permettere che gli elementi espulsi si disperdano. Essi debbono organizzarsi in sindacati degli espulsi e assumere come nucleo centrale del loro lavoro politico la parola d’ordine della loro riammissione nei sindacati.
«28. La lotta contro l’espulsione è di fatto una lotta per l’unità nel movimento sindacale. Sono quindi buone tutte le misure che hanno come obiettivo la ricostituzione dell’unità distrutta. Gli espulsi non debbono restare isolati e tagliati fuori dall’intera opposizione né dall’organizzazione rivoluzionaria indipendente che esiste. I gruppi esclusi debbono immediatamente legarsi all’opposizione nei sindacati e nelle organizzazioni rivoluzionarie esistenti nei rispettivi paesi, sotto il punto di vista di una lotta comune contro l’esclusione e per l’unità d’azione nella lotta contro il capitale».
Nelle “Tesi e risoluzioni del Secondo Congresso del Profintern” si denunciano le burocrazie sindacali che, per contrastare lo spostamento delle masse verso sinistra e ridurre l’opposizione al silenzio, ricorrevano indiscriminatamente «alla espulsione di individui e gruppi, fino a quella di diverse centinaia di migliaia di operai». Per contrastare questa azione la ISR dava la direttiva che ad ogni riunione operaia, in ogni officina, in ogni fabbrica fosse posta la questione della riammissione degli espulsi, ponendo la questione al giudizio della base.
Queste giuste Direttive del Quarto Congresso sono però vanificate dalle conclusioni: «Nel perseguire la sua strada volta alla conquista dei sindacati e alla lotta contro la politica scissionista dei riformisti, il Quarto Congresso dell’Internazionale Comunista dichiara solennemente che ogni qualvolta l’organizzazione di Amsterdam non ricorrerà alle esclusioni, ogniqualvolta darà ai comunisti la possibilità di combattere con armi ideologiche per i loro principi all’interno dei sindacati, i comunisti combatteranno come membri disciplinati nelle file della loro organizzazione, restando in prima fila nonostante tutti gli attacchi e tutti i conflitti con la borghesia». Il discorso sarebbe stato giusto se l’Internazionale di Amsterdam fosse stata una federazione sindacale, mentre di fatto era un’organizzazione politica al servizio della borghesia.
Un’altra organizzazione apparentemente rivoluzionaria ma avente lo scopo di sabotare l’unità sindacale era quella degli anarco-sindacalisti che, in nome di una pretesa autonomia dai partiti, di fatto affiancava i riformisti nell’opera scissionista.
Il Secondo Congresso del Profintern, iniziato il 21 novembre 1922, si concentrò su obiettivi che accomunavano l’insieme del movimento internazionale, su questioni pratiche: Fronte unico, Unità sindacale, Organizzazione, Rapporto con gli anarco-sindacalisti. Ai lavori parteciparono 213 delegati, sensibilmente meno rispetto ai 380 del Primo Congresso, ma ciò non significava che l’influenza del Profintern fosse diminuita. I proletari aderenti o influenzati dall’ISR erano tra i 12 e i 15 milioni, una cifra analoga a quella di Amsterdam, con la differenza che un terzo dei membri di questa simpatizzava per Mosca, mentre nel Profintern nessuno simpatizzava per Amsterdam.
Scrive Lozovsky nel dicembre 1922 ne “I compiti dei comunisti nei sindacati”: «L’incapacità dei sindacati di offrire una resistenza efficace, dei dirigenti di guidare le masse alla battaglia, causò una profonda delusione tra i lavoratori con il conseguente ritiro di interi gruppi dai sindacati. La crescita del movimento sindacale durante il 1921-22 non solo fu frenata, ma gli iscritti diminuirono rapidamente. Centinaia di migliaia di lavoratori stanno lasciando i sindacati che, a causa di questa contrazione, diventano deboli e incapaci di resistere all’offensiva capitalista. La Confederazione Generale del Lavoro di Francia, che all’inizio del 1920 contava oltre due milioni di iscritti, ora, insieme alla Confederazione Unita, ne ha solo 600.000. In Italia gli iscritti ai sindacati sono diminuiti da 2.000.000 a 700.000. In Inghilterra i sindacati hanno perso 1.300.000 iscritti e negli Stati Uniti hanno perso quasi un milione e mezzo di iscritti. Una tendenza analoga al ribasso si osserva in Cecoslovacchia, Svezia, Norvegia, Olanda, Danimarca, ecc. Solo in Germania e in Austria il numero degli iscritti ai sindacati è rimasto pressoché costante. Ciò non va attribuito all’eccessivo spirito rivoluzionario dei dirigenti del movimento sindacale di quei paesi, ma alla tragica condizione del proletariato austro-tedesco e alla sua maggiore suscettibilità all’organizzazione».
Il Congresso approvava quindi: 1. L’attività svolta per la realizzazione del fronte unico proletario; 2. Le reiterate offerte di azione comune rivolte all’Ufficio Esecutivo dell’Internazionale di Amsterdam, naturalmente cadute nel vuoto; 3. Gli sforzi tentati per raggruppare all’interno dell’ISR tutte le organizzazioni anarco-sindacaliste in vista della comune lotta contro la borghesia e il riformismo; 4. L’opposizione al tentativo di costituzione di una nuova Internazionale anarchica; 5. Il riconoscimento che si era costituito un fronte riformista e anarchico in lotta tanto contro l’ISR quanto contro l’IC e la rivoluzione russa; 6. La necessità di rafforzare l’influenza e il ruolo dei Comitati internazionali di industria per la concentrazione di tutte le forze rivoluzionarie del movimento sindacale; 7. Si ammetteva un insufficiente legame tra le organizzazioni aderenti all’ISR e il loro Centro, prospettando però la realizzazione di un collegamento permanente e sistematico tra tutte le organizzazioni in vista delle future battaglie.
Sulla parola d’ordine del fronte unico non ci furono obiezioni, e per realizzarlo fu stabilito che i sostenitori dell’ISR dovessero innanzitutto: 1. Organizzare e condurre una energica resistenza all’offensiva del capitale; 2. Mai perdere di vista che il compito principale consisteva nell’organizzazione di movimenti comuni a tutti i gruppi operai; 3. Perseguire unità, disciplina e solidarietà nell’azione di tutte le forze rivoluzionarie; 4. Svolgere nei luoghi di lavoro e tra le masse proletarie un intenso lavoro, non frutto di accordi tra i vertici sindacali.
La difesa dagli attacchi del capitale doveva basarsi su obiettivi elementari e condivisibili da ogni operaio: lotta per il mantenimento delle otto ore; lotta a favore delle rivendicazioni economiche della gioventù proletaria e resistenza al suo utilizzo come concorrente al proletariato adulto; parità salariale tra uomini e donne; mantenimento delle conquiste sindacali e loro estensione alle lavoratrici e alla maternità; indennità ai disoccupati per tutto il periodo della disoccupazione con pari indennità per uomini e donne; lotta sistematica e organizzata contro i gruppi paramilitari della borghesia e dello Stato, con armamento del proletariato; lotta per l’abrogazione dei trattati di pace imperialisti e contro gli attacchi alla Russia sovietica; lotta contro lo sfruttamento e l’asservimento delle masse proletarie delle colonie, senza distinzioni di razza.
Il Congresso riservò una particolare attenzione ai movimenti sindacali dei paesi coloniali e semicoloniali, dove «lo spirito classista si fa sempre più nettamente sentire in questo formidabile torrente rivoluzionario. E il dovere dell’ISR, come quello dell’IC, è di dare a questo movimento di classe una forma sempre più precisa e profondamente rivoluzionaria, di penetrarlo di uno spirito comunista perché possa ottenere il massimo dei risultati nella lotta contro il capitale straniero e nazionale. I lavoratori di Europa, di Asia, di Africa e di Australia si avvicinano alla bandiera rossa del Profintern perché essi vi leggono: “Guerra a morte al capitalismo, in nome del potere della classe operaia!”».
Il Secondo Congresso si occupò principalmente di questioni organizzative, limitandosi ad approvare il programma di azione elaborato al Primo Congresso, che riassumeva l’esperienza del movimento sindacale rivoluzionario di tutti i paesi. Vennero prese in considerazione le difficoltà da superare, consistenti innanzitutto nel fatto che decine di milioni di proletari seguivano ancora i riformisti; milioni erano inquadrati in sindacati democratici, cattolici, protestanti, ecc., mentre altre decine di milioni erano al di fuori di qualsiasi organizzazione. In presenza di una classe operaia di cui una parte molto consistente era inserita in organizzazioni complici del capitalismo l’ISR avrebbe dovuto adottare un programma e una tattica adeguati.
L’altro aspetto, ancora più grave, era costituito dalle enormi masse proletarie non organizzate. «Il compito più importante del prossimo periodo consiste nella lotta per il raggruppamento degli operai dispersi, per l’aumento della forza dei sindacati, per l’attrazione delle larghe masse nelle organizzazioni sindacali. La nostra parola d’ordine è: “Nessun operaio deve restare fuori dai sindacati”. È della massima importanza combattere la teoria che tende a giustificare l’abbandono dei sindacati in nome di considerazioni rivoluzionarie (...) La loro propaganda deve essere energicamente combattuta (...) perché la rivoluzione sociale è impossibile senza gli operai organizzati sindacalmente (...) Le larghe masse possono essere attratte nei sindacati solo attraverso un lavoro instancabile e sistematico per le rivendicazioni e i bisogni quotidiani e pratici degli operai».
Lozovsky, ne “I compiti dei comunisti nei sindacati” del dicembre 1922, ammonisce: «C’è un bel po’ di atteggiamento passivo nei confronti del Profintern. A molti comunisti sembra che, sebbene la questione del Profintern possa essere interessante, sia, dopo tutto, solo di secondaria importanza. Questo errore è molto pericoloso per il movimento operaio comunista, il movimento sindacale rivoluzionario deve avere il suo centro. Altrimenti si spezza il collegamento tra l’Internazionale Comunista e i lavoratori rivoluzionari di tutte le sfumature di opinione. Rafforzare il Profintern significa rafforzare simultaneamente il Comintern».
Sempre Lozovsky nel luglio 1923, nel suo su “Il movimento operaio - La nostra lotta per l’unità sindacale”, scrive: «Dobbiamo combattere l’opposizione di una parte dei nostri compagni di partito nella nostra lotta per l’unità sindacale. Questi sono i compagni che preferirebbero vivere da soli nei loro piccoli sindacati piuttosto che partecipare con i riformisti in grandi organizzazioni comuni».
Ma tutte queste posizioni classiste erano poi vanificate dai tentativi di accordo con Amsterdam, dai Fronti unici con i Partiti presunti operai, fino ai Governi operai, e poi operai e contadini. Il tentativo di portare le masse proletarie dalla propria parte con qualsiasi mezzo ed espediente era inizialmente dovuto più a disperazione che altro. Ma era purtroppo prevedibile, e da noi previsto, che, soprattutto con la fine del momento ascendente della rivoluzione, il fronte unico innaturale con i dirigenti sindacali e politici riformisti ci avrebbe portato all’abbandono delle posizioni classiste e comuniste.
Un altro problema importante preso in esame dal Secondo Congresso fu quello finanziario.
Il Congresso portò sostanzialmente a un consolidamento dell’Internazionale
Sindacale Rossa che, a differenza di Amsterdam, radicata solo in Europa e in
parte dell’America del Nord, fin dalla sua nascita aveva stabilito un gran
numero di contatti nei paesi coloniali e semicoloniali e in questo Secondo
Congresso fu in grado di dimostrare la sua presenza e attività in ogni parte del
mondo. A tale proposito dice giustamente Lozovsky: «Cosa hanno fatto finora i
partiti comunisti e i sindacati rivoluzionari per i sindacati nelle colonie
sfruttate dalla loro borghesia? Molto poco, quasi niente. Mentre il Partito
Laburista inglese e i sindacati inglesi lavorano energicamente in India, per
mettere nelle loro mani la direzione del movimento sindacale indiano, il Partito
Comunista inglese ha fatto poco o niente in questa direzione. Cosa stanno
facendo i comunisti e i sindacati rivoluzionari delle madripatrie per aiutare i
sindacati rivoluzionari in Egitto, Algeria, Giava, ecc.? Molto poco,
infinitesimamente poco. E tuttavia è chiaro che l’imperialismo continuerà a
opprimere i lavoratori dei paesi colonizzatori finché i lavoratori dei paesi
coloniali sfruttati non si sveglieranno all’attività».
11. - Ancora sui due primi Congressi dell’ISR
Come la Terza Internazionale era sorta per combattere e sconfiggere l’opportunismo e il tradimento della Seconda, così nel 1920 la creazione di una Internazionale Sindacale rivoluzionaria venne ritenuta indispensabile per sconfiggere quella di Amsterdam, strettamente legata agli interessi della borghesia e dell’imperialismo. La direttiva data ai comunisti fu di rimanere “ad ogni costo” nei sindacati gialli per conquistarne la direzione. La loro conseguente adesione a Mosca e abbandono di Amsterdam quale centro del movimento sindacale mondiale avrebbe costituito la premessa per l’espansione della rivoluzione a livello internazionale.
La risoluzione sulla tattica approvata al Congresso di fondazione del Profintern nel luglio 1921 dichiarava che «la creazione di questo centro del movimento rivoluzionario sindacale rappresenta il punto d’inizio di una aspra lotta all’interno del movimento sindacale mondiale sotto la parola d’ordine: Mosca o Amsterdam (...) La rottura con Amsterdam costituisce per i centri sindacali nazionali una condizione preliminare all’entrata nell’Internazionale Rossa».
Ma, nei paesi in cui la Federazione nazionale aderiva all’Internazionale di Amsterdam, «i sindacati singoli, le federazioni e le minoranze organizzate su scala nazionale possono appartenere al Profintern, pur restando nelle vecchie confederazioni». Venivano quindi condannate parole d’ordine come “distruzione dei sindacati” o “fuori dai sindacati”. Lo scopo non era portar fuori dai sindacati gli operai migliori e più coscienti formando piccole organizzazioni, ma di rimanere nei vecchi sindacati per “rivoluzionarli”.
La struttura dell’Internazionale sindacale di Amsterdam non si basava esclusivamente sull’adesione delle varie Federazioni nazionali, ma ne facevano parte anche Unioni internazionali di categoria, di particolari rami del commercio e dell’industria, che avevano propri segretariati e tenevano periodici congressi. Di queste le più importanti erano la Federazione Internazionale degli Operai Metallurgici e la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti. La regola imposta era che potevano essere ammessi alle Internazionali di categoria di Amsterdam solo i sindacati ad essa affiliati. Quindi un sindacato nazionale aderente al Profintern non avrebbe potuto farne parte, a meno che non uscisse da Mosca per aderire all’Internazionale gialla. La linea del Profintern fu di non provocare scissioni, né di creare nuove Internazionali di categoria rosse, ossia mantenne la stessa posizione assunta nei confronti delle centrali sindacali nazionali. Il problema si pose quando i sindacati russi chiesero di far parte delle rispettive Internazionali di categoria: i russi avrebbero dovuto uscire da Mosca per abbracciare Amsterdam.
L’argomento più spinoso che il Congresso dovette affrontare fu quello del rapporto organico tra Comintern e Profintern, che la componente anarco-sindacalista rifiutava di accettare. Unite in questo rifiuto, all’interno del movimento anarco-sindacalista si ebbero due correnti: da una parte gli anarchici “puri”, che vollero fondare una loro autonoma Internazionale, con uno spiccato indirizzo anticomunista e antisovietico; dall’altra i sindacalisti rivoluzionari, tra i quali ci fu una forte tendenza che, ponendosi interamente sulla stessa piattaforma dei comunisti e ammettendo la dittatura del proletariato, si dichiararono disposti a restare nel Profintern qualora fosse sciolto lo stretto legame tra IC e ISR. Questa aspirazione aveva preso corpo soprattutto nelle risoluzioni del Congresso di Saint-Ètienne e nelle richieste della delegazione francese.
Nel dicembre 1921 in Francia si era avuta la scissione del movimento sindacale e la creazione della CGTU, che pose a condizione della sua adesione al Profintern la rottura del legame organico con l’Internazionale Comunista. In seguito la CGTU, al suo Quarto Congresso a Bordeaux nel settembre 1927, pur restando in un ISR ormai stalinizzata, arriverà addirittura a pronunciarsi per l’abolizione del riferimento alla dittatura del proletariato.
In risposta a Gaston Monmousseau, che in nome della vecchia tradizione anarco-sindacalista francese aveva posto la condizione della rottura dello stretto legame tra le due Internazionali, replicava l’italiano Pietro Tresso affermando che la tradizione invocata dai sindacalisti francesi era un pericoloso avanzo di mentalità piccolo-borghese, dimostrando invece la necessità di una stretta alleanza con il partito politico. Dichiarò quindi l’opposizione dei comunisti italiani ad apportare modifiche agli statuti. L’ultimo intervento su questo punto dell’ordine del giorno fu di Zinoviev, rappresentante del Comintern, che concluse dicendo che «il movimento operaio francese vale per noi più di una dozzina di costruzioni teoriche».
Il principale risultato del Secondo Congresso del Profintern fu quindi lo scioglimento del legame organico tra le due Internazionali di Mosca, la politica e la sindacale. Tale legame era stato sancito dallo Statuto del Congresso di fondazione.
Le concessioni agli anarco-sindacalisti non furono poche e non si limitarono a lievi modifiche dello Statuto.
In nome del “pragmatismo” si finisce spesso per abbandonare i principi, abbandono che a sua volta rende insolubili i problemi pratici. È ciò che i riformisti hanno sempre fatto: in nome di un successo “pratico”, sempre molto limitato, svendono il futuro del proletariato.
Quanto proposto al Secondo Congresso del Profintern era l’eco delle decisioni già prese dal Quarto Congresso dell’Internazionale Comunista, alle quali si era opposto il rappresentante della Sinistra italiana che, successivamente, ricorderà: «Al Quarto Congresso noi ci siamo opposti per ragioni di principio a una concessione che si faceva ai sindacalisti rivoluzionari quando si volevano cambiare gli statuti dell’ISR e rinunciare a un collegamento organico tra il Comintern e l’Internazionale Sindacale Rossa. Questa, a mio avviso, era una questione, dal punto di vista marxista, di importanza decisiva. Quando si fece questa concessione io dissi: questa concessione porterà necessariamente ad altre concessioni in campo sindacale. Come oggi si fa questa importante concessione alla sinistra, alle tendenze anarco-sindacaliste, così domani si dovranno fare delle concessioni ai sindacalisti di destra, quella tendenza sindacale che sotto le due diverse forme della sinistra e della destra rappresenta l’identico, sempre ricorrente ostacolo antimarxista sul nostro cammino».
Queste ambiguità, e peggio, accanto a posizioni ineccepibili, sono presenti anche nelle “Tesi del Quarto Congresso sulla tattica del Comintern”, in data 5 dicembre 1922: «10. (...) La tattica del fronte unico significa che l’avanguardia comunista deve assumere la guida delle lotte quotidiane delle masse lavoratrici per i loro interessi di vita più urgenti. In questa lotta i comunisti sono persino disposti a trattare con i capi traditori dei socialdemocratici e con quelli di Amsterdam (...) Il vero successo del fronte unico scaturisce “dal basso” (...) Tuttavia i comunisti non possono rinunciare a trattare, a certe condizioni, anche con i vertici dei partiti operai avversari».
Nella Relazione sulla questione sindacale al Quarto Congresso dell’Internazionale, del 20 novembre 1922, Lozovsky fa delle giuste osservazioni su manchevolezze e limiti del movimento comunista, riferendosi particolarmente alla Francia:
«Ci sono membri del Partito Comunista di Francia che quando si iscrivono a un sindacato, dimenticano di essere comunisti. Alle riunioni del loro partito sono comunisti, ma fuori delle riunioni si riservano il diritto di fare ciò che vogliono, e a volte si comportano come i più entusiasti sostenitori dell’indipendenza e dell’autonomia sindacale (...) Nel numero più recente di “Lutte des classes” c’è un articolo, o più precisamente una dichiarazione, firmata dai compagni: (...) “Alcuni di noi sono membri del partito, altri no. Ma siamo tutti sindacalisti rivoluzionari, cioè attribuiamo ai sindacati il ruolo principale nella lotta rivoluzionaria per la liberazione del proletariato. Il ruolo del partito dovrebbe essere di supporto, non di direzione”.
«Bisogna chiedersi perché questi sindacalisti rivoluzionari siano membri del partito (...) Questa domanda deve essere risolta storicamente. Il Partito comunista di Francia è eterogeneo nella composizione. È formato da una varietà di correnti ideologiche. La vecchia ideologia di ogni corrente è arrivata con essa nel partito e vi ha messo radici (...) I comunisti sono per l’unità, ma non possono sacrificare il comunismo sull’altare di tale unità (...)
«Va detto che tra il Terzo e il Quarto Congresso in alcuni partiti sono emersi stati d’animo liquidazionisti riguardo alla ISR. Ci sono persone che hanno l’opinione che, poiché siamo per il fronte unito, per l’unità del movimento sindacale, per la vittoria piuttosto che la distruzione dei sindacati, quindi la ISR deve essere sciolta. Pensano che la vera unità del mondo sindacale sarebbe allora raggiunta e il compito dei comunisti per quanto riguarda la vittoria dei sindacati sarebbe reso molto più facile. Questo concetto è stato sollevato in passato da Paul Levi e dai suoi sostenitori in Germania. C’è un barlume di questa visione anche tra alcuni comunisti in altri paesi.
«All’inizio molti compagni non percepirono l’essenza di questa posizione liquidazionista. A molti sembrò che la differenza non riguardasse i principi, ma semplicemente la convenienza. Ma questi compagni si sbagliavano. Gli atteggiamenti liquidazionisti nei confronti della ISR implicavano fondamentalmente la liquidazione dell’Internazionale Comunista. Cosa significa, in effetti, liquidazione della ISR? Significa abbandonare il compito di riunire il movimento sindacale rivoluzionario attorno a un focus internazionale; significa lasciare le forze rivoluzionarie del movimento sindacale internazionale disperse e divise».
E ha sicuramente ragione Lozovsky quando il giorno successivo, in data 21
novembre, nel suo “Riassunto della discussione sulla questione sindacale”,
critica l’atteggiamento del KPD, il partito comunista tedesco, nei confronti del
sindacato UHK: «Cos’è la Federazione dei lavoratori manuali e intellettuali? È
un’organizzazione che comprende varie forze sindacaliste, comuniste e non
affiliate. Include molti lavoratori arretrati che non hanno ancora una
comprensione chiara e definita del comunismo in termini teorici o pratici ma che
sono buoni rivoluzionari pronti alla battaglia. È naturale che la nostra
influenza con un’organizzazione del genere sarà diversa nelle sue forme e nei
suoi metodi rispetto a un’organizzazione direttamente affiliata al Partito
comunista».
12. - Tra il Secondo e il Terzo Congresso
Nel senso delle già viste ambiguità, va la “Risoluzione del Terzo Plenum sulla questione sindacale” del 23 giugno 1923, che inizia così: «Negli ultimi mesi si è verificato all’interno dell’ala riformista del movimento operaio un gran cambiamento. Questo cambiamento trova la sua espressione nel fatto che all’interno dell’Internazionale di Amsterdam s’è costituita un’ala sinistra che tende a formare un fronte unico con le organizzazioni russe e, loro tramite, anche con l’Internazionale dei Sindacati Rossi e con le organizzazioni ad essa collegate».
“Il Sindacato Rosso” del 14 luglio 1923 riporta una proposta del Consiglio Centrale panrusso dei Sindacati alla Federazione di Amsterdam “Per la costituzione del fronte unico proletario mondiale, in difesa delle conquiste operaie e contro la reazione”. Pur lamentando di essere inascoltati da Amsterdam, si ribadisce la disponibilità nei loro confronti a un fronte unico, con il compito di elaborare un programma di azione contro la guerra e contro il fascismo, concludendo: «Il Consiglio Centrale panrusso dei Sindacati è convinto che l’Internazionale di Amsterdam farà da parte sua quanto è necessario per facilitare l’intesa fra gli operai di tutte le tendenze nella lotta contro la reazione mondiale».
“Il Sindacato Rosso” commenta favorevolmente la proposta: «Se la risposta di Amsterdam sarà favorevole, un grande passo in avanti potrà essere compiuto sulla via della liberazione del proletariato dallo sfruttamento e dalla reazione borghese e contro il terribile pericolo della guerra. Se, invece, la risposta di Amsterdam rifiuterà la proposta di accordo, ciò significherà in maniera definitiva che la socialdemocrazia è contraria a una intesa di tutte le forze proletarie per un’azione comune contro l’offensiva capitalistica, e favorevole, quindi, al mantenimento delle attuali condizioni di depressione del proletariato».
Lo stesso giornale riporta la risposta della Federazione Sindacale Internazionale, vale a dire di Amsterdam, che somiglia ad una richiesta di resa senza condizioni: «Il Comitato internazionale della F.S.I. (...) considerando (...) che questa unità sindacale, per raggiungere il suo scopo, deve realizzarsi nel quadro di ciascun centro sindacale nazionale e della F.S.I.; rinnovando il desiderio sincero della F.S.I. di vedere i sindacati russi avvicinarsi alla massa dei lavoratori organizzati del mondo e a conformarsi alle risoluzioni dei Congressi sindacali d’ Amsterdam, di Londra e di Roma; considerando, tuttavia, che di unità sindacale non si potrà utilmente parlare se prima non si sarà creata un’atmosfera di stima e di fiducia reciproca; che per creare questa atmosfera gli attacchi e le ostilità contro la F.S.I., le sue organizzazioni affigliate ed i suoi militanti devono cessare in modo assoluto; che, inoltre, gli operai russi devono dichiararsi disposti ad agire in Russia identicamente ai loro compagni operai organizzati d’altri paesi che combattono la guerra e la reazione in tutte le sue forme; approvando le dichiarazioni anteriori del Bureau della F.S.I., afferma di essere disposto ad entrare in trattative con i delegati della Centrale Sindacale di Russia alla sua volta mandataria delle organizzazioni russe, allorché le condizioni su enunciate siano state accettate e realizzate dalle organizzazioni suddette».
Segue quindi una “Dichiarazione di principio”: «La lotta di classe è la dottrina, la sparizione del salariato e l’emancipazione operaia ne è il suo ideale, ma la F.S.I. non saprebbe disconoscere che il regime democratico è la condizione essenziale di tutti i progressi in questo senso. Essa deve dichiarare che le riforme, i progressi sociali preparano più sicuramente l’emancipazione morale e materiale delle masse popolari che le dichiarazioni demagogiche, dalle quali la reazione trae i suoi argomenti di terrore delle collettività e gli elementi dei suoi successi sulle forze del progresso».
Alla Dichiarazione della Sinistra sulla questione della tattica sindacale al Quinto Congresso dell’Internazionale Comunista, XXX seduta, 7 luglio 1924, ora su “Comunismo” n.17 del 1985, facciamo una premessa:
«L’intervento della Sinistra italiana sulla questione della tattica sindacale, per quanto breve, mette in luce quella che fu la caratteristica essenziale del Quinto Congresso dell’Internazionale Comunista; cioè la continuazione della politica opportunistica varata semi-ufficialmente al Quarto Congresso del 1922 con l’aggiunta di una verniciatura di “sinistrismo”. Il Quinto Congresso, abbiamo appena visto, riaffermò in modo “categorico” e “totale” l’ortodossia dei principi e dei fini del marxismo rivoluzionario; dichiarò di voler combattere ed espellere dalle file dell’Internazionale le reminiscenze della socialdemocrazia e gli interpreti dei suoi metodi, prese atto della necessità di rivedere e ritoccare le tesi del Quarto Congresso nei punti in cui avrebbe potuto dare adito a deviazioni di destra; in una parola dichiarò che bisognava fare chiarezza.
«La chiarezza fu richiesta dalla destra che, trovandosi alla direzione dei partiti nazionali, dopo aver applicato le direttive degli organi dirigenti del Comintern, veniva ora tacciata di disfattismo, se non addirittura di tradimento. La chiarezza fu invocata dalla Sinistra che deprecava il triste andazzo delle enunciazioni vaghe, aperte a cento interpretazioni, fatte in modo che ogni partito potesse trovarvi la scappatoia per eludere le direttive generali e invocare le necessità e particolarità locali. Chiarezza sarebbe stata fatta, dichiaravano gli organi dirigenti dell’Internazionale (...)
«Cosa è ciò che distingue il buon partito? A questa domanda la Sinistra italiana ha sempre risposto senza esitazioni: “È la buona tattica che distingue il buon partito”. In altre parole ciò vuol dire che non deve esistere contraddizione tra l’azione tattica della lotta quotidiana sostenuta dal proletariato contro il permanente attacco padronale e il disegno strategico del “grande momento”. Ogni volta che si ritenga “opportuno” cercare una via più breve, una tattica più comoda, più “comprensibile” dalle masse proletarie, ogni volta che succede questo vuol dire che si è abbandonata l’ortodossia marxista per lasciare spazio all’opportunismo che, anziché abbreviare le doglie del parto rivoluzionario, altro non è che lo strumento della classe nemica per fare abortire la rivoluzione.
«Che valore può quindi avere l’epurazione dei partiti, il rimpasto delle loro direzioni con iniezioni di elementi di sinistra, la condanna dei metodi di collaborazione di classe, quando poi sul piano tattico si continua ad operare in stretta continuità con i sistemi appena deprecati? La questione sindacale (...) è quella che meglio di tutte le altre fa piena luce su questo andazzo: l’atteggiamento dell’Internazionale riguardo alla questione è quello classico dell’opportunismo. Si parte con il riaffermare dei giusti principi, ed incontestati dalla Sinistra, per approdare al loro totale stravolgimento».
Dalla “Dichiarazione” leggiamo:
«La Sinistra italiana è sempre stata contro la tattica dell’abbandono dei sindacati gialli. In questo in Italia non abbiamo incontrato grandi difficoltà. I problemi che oggi si presentano, e che riguardano la ricostruzione dei sindacati operai, sono più difficili di quelli relativi al sabotaggio da parte dei capi riformisti. Noi ci siamo sempre battuti con tutte le forze contro le tendenze, del resto poco rilevanti, favorevoli all’uscita dalla Confederazione Generale del Lavoro dei sindacati indipendenti schieratisi dalla nostra parte (...) Il problema dell’unità sindacale sul piano nazionale, si è posto molto prima che il Comintern si occupasse della tattica del fronte unico. Per esempio, noi in Italia sin dalla fondazione del partito ci siamo battuti per la fusione organizzativa di tutte le centrali esistenti, ed è stato proprio il nostro partito quello che ha lottato contro il frazionamento del proletariato in diverse centrali sindacali. Esso è, in Italia, l’unico partito che non abbia creato una speciale centrale sindacale per proprio uso e consumo, e abbia invece lavorato all’interno di tutte le organizzazioni sindacali esistenti degli altri partiti (...)
«In Italia appena sei mesi dopo la formazione del partito noi lanciammo la parola d’ordine del fronte unico sindacale, che allora ebbe un certo grado d’attuazione nell’Alleanza del lavoro (...)
«Toccherò solo uno dei motivi del nostro atteggiamento. Le condizioni che intendete porre per l’attuazione dell’unità possono essere sufficienti dal punto di vista pratico, ma in base ad esse l’unificazione non avverrà mai, perché sono tali che fatalmente l’Internazionale di Amsterdam dovrà respingerle. Voi ribattete: tanto meglio, avremo fatto la nostra proposta e Amsterdam l’avrà respinta; non è la prima volta, e gli operai riformisti ne dedurranno che noi siamo davvero per l’unità! Ma, in caso di rifiuto da parte di Amsterdam della nostra proposta, l’impressione che ne riceverà la classe lavoratrice sarà che, essendoci convinti che la nostra organizzazione manca di solide basi, abbiamo cercato di liquidarla, e che se questa liquidazione non è avvenuta è solo perché Amsterdam ha respinto le nostre avances. Ciò renderà ancora più difficile il nostro lavoro.
«Nel caso invece di una realizzazione della unità sindacale, noi non avremmo a
fianco dell’Internazionale Comunista che un ufficio di propaganda internazionale
per il lavoro nei sindacati, un ufficio del genere di quelle “commissioni
sindacali” del partito francese, che non hanno mai svolto un’attività veramente
marxista, che non sono mai state altro che dei bureaux, che non sono mai
riuscite ad organizzare la più piccola ed energica azione, diretta dal partito,
in campo economico e sindacale. E allora la nostra Internazionale diverrà di
fatto poco più di una setta politica, un movimento che si limita alla propaganda
ideologica e non sa né può intervenire direttamente e attivamente nelle lotte
economiche del proletariato. Siamo quindi contrari a tali proposte, anche se
fossero destinate a non essere respinte».
13. - Al Quinto Congresso dell’Internazionale
Nel giugno 1924, all’apertura del Quinto Congresso dell’IC (al quale seguì il Terzo del Profintern), in nome del fronte unico e dell’unità proletaria i delegati si trovarono di fronte inaspettatamente alla proposta di scioglimento del Profintern e di adesione ad Amsterdam. Le imbarazzate e contraddittorie motivazioni della nuova tattica vennero più volte ritirate e ripresentate sotto camuffata forma. Naturalmente si continuò a parlare di tradimento dei capi di Amsterdam, ma allo stesso tempo si dava rilievo alla nascita al suo interno di una corrente di sinistra, che aveva recentemente posto il problema dell’ammissione dei sindacati russi nelle internazionali di categoria. Fu affermato che l’unità internazionale del movimento sindacale «sarebbe stata ristabilita mediante la convocazione di un Congresso mondiale a cui tutti i sindacati affiliati o all’Internazionale di Amsterdam o all’Internazionale Rossa dei Sindacati sarebbero stati rappresentati su base proporzionale».
Contro le critiche mosse al progetto della nuova tattica sindacale, Zinoviev intervenne richiamandosi all’autorità di Lenin: «Il leninismo nei sindacati significa lotta contro lo scissionismo nei sindacati (...) La vera sinistra leninista si trova sempre dove sono i lavoratori (...) La socialdemocrazia si è in parte consolidata, persino nella sfera sindacale. Noi dobbiamo ora combatterla ricorrendo a vie indirette, che sono più lente e ardue. Questo è il fatto nuovo che voi non volete comprendere».
Si disse che la fusione delle due Internazionali sarebbe stata possibile soltanto se sostenuta dalla spinta di un movimento dal basso delle masse lavoratrici, e che i sindacati russi sarebbero rimasti parte integrante del Profintern, e che nei loro negoziati separati con Amsterdam si consideravano semplicemente come agenti del Profintern, e ne avrebbero portato avanti la tattica senza perseguire nessuna politica da esso indipendente. Venne proposta la nomina di una “commissione internazionale” che avrebbe «visitato l’Inghilterra e Amsterdam al fine di studiare la situazione del movimento sindacale e, eventualmente, iniziare negoziati con Amsterdam».
Di lì a poco Lozovsky avrebbe detto che, poiché «i sindacati dell’URSS costituiscono la base e il fondamento del Profintern, e i sindacati inglesi il fondamento e la base dell’Internazionale di Amsterdam» un accordo anglo-sovietico avrebbe preparato la strada all’intesa tra le due Internazionali.
Nel corso del Quinto Congresso dell’IC si pose un nuovo quesito: «attraverso quale porta la rivoluzione proletaria potesse entrare in Inghilterra: se attraverso il Partito comunista oppure attraverso i sindacati».
Il rappresentante della Sinistra replicava che «per la nostra tattica in
Inghilterra è estremamente importante che non tutta la nostra attenzione e
quella del proletariato sia rivolta esclusivamente al movimento sindacale di
sinistra. Non ci si deve mai dimenticare del partito, anche se oggi è un piccolo
partito; si deve sempre mettere in rilievo che esso nello sviluppo della crisi
sociale in Inghilterra e nel corso della lotta, dovrà essere necessariamente la
guida del proletariato e lo stato maggiore della rivoluzione».
14. - Il Terzo Congresso del Profintern
La nuova impostazione sindacale, espressa nel Quinto Congresso dell’IC, fu riproposta al Terzo Congresso del Profintern, che si aprì l’8 luglio 1924. Bucharin portò il saluto del Comintern, ribadendo che la conquista dei sindacati era «una questione di vita o di morte», e affermando che la comparsa di un’ala sinistra nella F.S.I. rappresentava «uno dei fatti più importanti della nostra vita politica».
Dopo una breve relazione introduttiva di Lozovsky, la questione dell’unità sindacale fu divisa in tre parti: 1. sul piano nazionale; 2. nelle Internazionali di categoria; 3. l’unità internazionale al massimo livello tra ISR e F.S,I.
È manifesto il disaccordo della Sinistra italiana: «Riconfermiamo la nostra contrarietà alla scissione sindacale. Non così siamo però favorevoli alle attuali manovre per la fusione delle due Internazionali Sindacali perché, avendo l’Internazionale Comunista bisogno di un centro di concentrazione delle forze sindacali comuniste, ed avendo già risolto il problema con la creazione dell’ISR, invece che con la costituzione di una sezione sindacale dell’IC, non vediamo le ragioni rivoluzionarie che consigliano a tale revisione radicale di tattica, perché riconfermiamo che Amsterdam ha la funzione di agenzia della borghesia».
Ricapitoliamo l’evoluzione della linea sindacale sviluppatasi parallelamente
nell’Internazionale Comunista e nel Profintern:
1. Al Secondo Congresso dell’IC, nel 1920, era stato proposto di dare a
determinate organizzazioni sindacali di sinistra la possibilità di prendere
parte ai Congressi dell’IC. I comunisti italiani si opposero all’ammissione dei
sindacati nei Congressi mondiali dei partiti politici.
2. Al Terzo Congresso si decise invece di fondare il Profintern, in antitesi ad
Amsterdam, con la parola d’ordine “Mosca contro Amsterdam”.
3. Al Quarto Congresso, per assecondare le richieste degli anarco-sindacalisti
francesi, fu sciolto il “rapporto organico” tra Comintern e Profintern.
4. Al Quinto Congresso fu proposta l’unificazione delle due Internazionali
sindacali, in cui i comunisti avrebbero agito come frazione.
Nell’“Appello dei Comitati Esecutivi dell’IC e dell’ISR per l’unità del movimento sindacale internazionale”, sempre nel luglio 1924, è ribadita la volontà di costituire una Internazionale sindacale unitaria, con la fusione dell’ISR e dell’Internazionale di Amsterdam.
La semplicistica obiezione che ci veniva posta era: «se in materia di tattica siete per il fronte unico allora dovete essere per l’unità in materia di organizzazione». Rispondevamo che lavoriamo per l’unità sindacale a livello nazionale, per penetrare nei sindacati, radicarci in essi e conquistare le grandi masse alla nostra influenza, sapendo che queste organizzazioni sono destinate a svolgere un ruolo importante sia nella lotta per la conquista del potere sia successivamente. Ma per quanto riguarda il movimento internazionale la questione si presenta diversamente: mentre i sindacati nazionali e le confederazioni, anche quando sono dirette da opportunisti, restano pur sempre organizzazioni proletarie, ciò non vale per le Internazionali, che hanno solo una funzione politica. L’Internazionale Sindacale di Amsterdam non era una organizzazione proletaria di massa, ma uno strumento della borghesia, in stretto contatto con l’Ufficio Internazionale del Lavoro e con la Società delle Nazioni, organi che non possono essere conquistati dal proletariato e dal suo partito rivoluzionario.
Nelle Tesi presentate dalla Sinistra a Lione, nel 1926, al punto 8, “Questione sindacale”, leggiamo:
«L’Internazionale ha mutato successivamente la concezione dei rapporti tra organismi politici ed economici nel quadro mondiale, e in questo è un esempio importante del metodo che, anziché derivare dai principi le azioni contingenti, improvvisa teorie nuove e diverse per giustificare azioni suggerite da apparenti comodità e facilità di esecuzione e di successo immediato (...) L’ufficio dell’Internazionale di Amsterdam andava considerato e trattato non come un organismo delle masse proletarie ma come un organo politico controrivoluzionario della Società delle Nazioni (...)
«Non è però da escludersi la utilità di una tattica di fronte unico su base mondiale con tutti gli organismi sindacali anche aderenti ad Amsterdam. La sinistra del partito italiano ha sempre sostenuto e lottato per la unità proletaria nei sindacati, attitudine che contribuisce a renderla inconfondibile con le false sinistre a sfondo sindacalista e volontarista, combattute da Lenin.
«Inoltre la sinistra rappresenta in Italia la concezione esattamente leninista del problema dei rapporti tra i sindacati e consigli di fabbrica, respingendo sulla base dell’esperienza russa e delle apposite tesi del Secondo Congresso la grave deviazione di principio consistente nello svuotare d’importanza rivoluzionaria il sindacato, basato su adesioni volontarie, per sostituirvi il concetto utopistico e reazionario di un apparato costituzionale e necessario aderente organicamente su tutta la superficie al sistema della produzione capitalistica, errore che praticamente si concreta nella sopravvalutazione dei consigli di fabbrica e in un effettivo boicottaggio del sindacato».
Tra le questioni affrontate invece dal corretto punto di vista marxista al Terzo Congresso dell’ISR c’è quella degli immigrati e dei lavoratori delle colonie. Ai punti XVIII e XIX leggiamo, contro i sindacati “di razza” come negli USA, e di soli immigrati separati dagli altri proletari, era necessaria una «attenzione puntuale e premurosa nei riguardi degli operai stranieri». Si raccomandava di non cercare di incorporare nel movimento sindacale della metropoli i sindacati delle colonie, perché questi operai potevano vedervi una forma di oppressione imperialistica.
Al punto XIX, titolato “Il lavoro tra gli immigrati”, leggiamo: «La questione
della nazionalità è strettamente legata alla questione degli immigrati. In
alcuni paesi (Stati Uniti, Francia, ecc.), questa questione è di immensa
importanza, e una soluzione sbagliata può ritardare lo sviluppo del movimento
operaio per molti anni. Un esempio classico è quello degli Stati Uniti, dove la
borghesia e la burocrazia del lavoro ricorrono a tutti i mezzi possibili per
dividere il movimento operaio lungo questa linea. Il lavoro tra gli immigrati è
il più importante dovere del lavoro rivoluzionario (...) Tanto più importante in
quanto i diritti di tutti questi lavoratori “stranieri” sono limitati in misura
molto maggiore rispetto ai diritti dei lavoratori nazionali, circostanza che
viene utilizzata dalla borghesia per abbassare i salari di entrambi i gruppi
(...) Nessun sindacato di immigrati, un sindacato per tutti».
15. - Le frazioni comuniste nei sindacati e il Comitato Anglo‑Russo
Su “Comunismo” n. 26, pagina 17, leggiamo: «Il Sesto Esecutivo Allargato ratificò la risoluzione elaborata dalla Conferenza organizzativa “sulla organizzazione e la struttura delle frazioni comuniste nei sindacati”. In tale risoluzione si affermava che le frazioni comuniste avrebbero dovuto costituirsi in tutti i sindacati “nell’ambito dello statuto e delle deliberazioni dei relativi sindacati” (...) Inoltre veniva stabilito che (...) le frazioni potevano: “prendere posizione unicamente riguardo a problemi del loro particolare ambito di attività”. Tutto ciò rappresentava semplicemente la morte dell’attività sindacale comunista. Ai compagni impegnati nelle organizzazioni sindacali non solo veniva impedita ogni attività politica all’interno delle organizzazioni di classe, ma si ordinava loro di svolgere un’azione sindacale che non esorbitasse dall’ambito dello statuto e delle deliberazioni dei rispettivi sindacati. Quando si pensi poi che i comunisti sarebbero dovuti entrare anche nei sindacati liberali, cristiani e fascisti non si può non considerare tali indicazioni come un totale disarmo di classe».
Su quest’ultimo punto specifichiamo che i comunisti non militano in tutti i sindacati. Se esistono sindacati di classe o influenzabili a fini di classe dal partito non ha senso militare in sindacati reazionari. Possono iscriversi a sindacati reazionari solo a determinate condizioni, fra cui che vi possano propagandare le proprie posizioni sindacali, situazione questa certo contingente.
Continuiamo la citazione: «Il consiglio della F.S.I. aveva rifiutato la proposta di Mosca definendola “una fantasia impraticabile e dannosa”. Ma se la fusione non poté realizzarsi a scala generale, tuttavia, dopo contatti durati circa un anno con Purcell, dirigente delle Trade Unions, nell’aprile del 1925, a Londra si riunirono i rappresentanti dei sindacati russi con quelli britannici. In questa riunione fu dato vita a un Comitato Congiunto. La realizzazione di questo “Comitato anglo-russo” fu presentata da Zinoviev al 14° Congresso del PCUS, come la dimostrazione della correttezza della tattica del fronte unico. Per il Sesto Esecutivo Allargato il Comitato anglo-russo “rappresenta la possibilità pratica di creare una Internazionale unificata e una lotta comune da parte dei lavoratori di differenti tendenze politiche, contro la reazione, il fascismo e l’offensiva capitalista”. Alla seduta comune del C.C. del PCUS e della C.C.C. (luglio 1926) Stalin dichiarò: “Se i sindacati reazionari inglesi sono disposti a formare con i sindacati rivoluzionari del nostro paese una coalizione contro gli imperialisti controrivoluzionari del loro paese, perché non si dovrebbe approvare questo blocco?”. Per Trotski fu facile replicare che “se i sindacati reazionari fossero capaci di lottare contro i loro imperialisti non sarebbero reazionari”».
Nel 1926 il Consiglio Generale dei sindacati inglesi fu costretto dalla pressione proletaria a indire uno sciopero generale in conseguenza della serrata delle miniere di carbone. Ma lo sciopero fu presto sabotato dai bonzi sindacali. «Il Partito Comunista inglese in tutta questa vicenda restò spettatore passivo dal momento che, secondo gli accordi stabiliti con Mosca, la guida del movimento operaio doveva restare in mano ai dirigenti ufficiali. Inoltre, nel tentativo di conquistare cariche rappresentative all’interno del sindacato, il C.P.G.B. ritenne opportuno concedere ai propri militanti “una certa libertà di azione” non limitandosi a presentare “il puro e semplice programma comunista” (...) Addirittura dopo l’aperto sabotaggio dello sciopero da parte dei sindacati inglesi, l’Internazionale volle a tutti i costi continuare a tenere in piedi il Comitato anglo-russo e, dopo le conferenze di Parigi del luglio e di Berlino dell’agosto 1926, alla conferenza di Berlino dell’aprile 1927 i delegati russi, i quali avevano riconosciuto nel Consiglio Generale “l’unico rappresentante e portavoce del movimento sindacale d’Inghilterra”, si impegnarono a “non diminuire l’autorità” dei capi tradeunionisti e a “non occuparsi degli affari interni dei sindacati inglesi”».
L’“Appello dei Comitati esecutivi dell’IC e dell’ISR a tutte le sezioni e a tutti i lavoratori”, del 9 maggio 1926, ribadisce le posizioni già viste, e da noi condannate, sulla lotta dei lavoratori britannici: «L’Esecutivo dell’IC e quello dell’ISR esortano tutte le sezioni a compiere ogni sforzo per assicurare l’unità d’azione. A tale scopo si raccomandano riunioni con i rappresentanti degli altri partiti e delle altre organizzazioni».
Nelle “Tesi del Settimo Plenum sulla trustificazione, sulla razionalizzazione e sui compiti dei comunisti nei sindacati”, del 16 dicembre 1926, ai punti 10, 12 e 13 leggiamo:
«10. La nuova situazione che si è venuta creando ci pone in modo particolarmente pressante di fronte al problema del fronte unico internazionale e dell’unità internazionale. Lo sciopero generale e quello dei minatori in Inghilterra hanno operato tutta una serie di mutamenti nei rapporti di forza, mentre il fallimento dello sciopero generale e il fronte unico dell’Internazionale di Amsterdam col Consiglio Generale, causato dal sabotaggio dello sciopero dei minatori, ha avuto come conseguenza il consolidamento dell’organizzazione di vertice dell’Internazionale di Amsterdam. Tutte le discordanze che prima sussistevano tra il Consiglio Generale e l’Internazionale di Amsterdam sono ora praticamente sparite. Il Consiglio Generale promuove attualmente la stessa identica politica dell’Internazionale di Amsterdam, e in questo senso si può tranquillamente affermare che il fallimento dello sciopero generale è stato vantaggioso per l’Internazionale di Amsterdam nella stessa misura in cui la svolta a destra dell’apparato sindacale in qualunque paese è vantaggiosa per coloro che difendono gli interessi della burocrazia e della borghesia europea reazionaria (...)
«12. La crisi nel Comitato anglo-russo ha offerto il pretesto ai nostri avversari per parlare di fallimento dell’unità e della tattica del fronte unico (...)
«13. Prendendo le mosse dall’applicazione conseguente della tattica del fronte unico il CC del VKP(b) e il Presidium dell’Internazionale comunista si sono pronunciati contro la tattica dello scioglimento del comitato anglo-russo».
È infine ribadita l’alleanza con l’Internazionale di Amsterdam, e la conseguente difesa dell’indifendibile comitato anglo-russo.
(Continua nel prossimo numero)
La crisi delle relazioni umane nella società capitalista – che si manifesta nella mercificazione della sessualità, nel degrado dei legami intimi e nella solitudine pervasiva che caratterizza la vita moderna – non può essere compresa separatamente dalle condizioni materiali che plasmano l’esistenza sociale. Questi fenomeni non sono semplicemente problemi culturali o psicologici, ma conseguenze dirette del modo di produzione capitalistico e delle relazioni sociali che lo accompagnano.
Come Marx ha dimostrato nella sua analisi del lavoro alienato, il capitalismo
separa sistematicamente gli esseri umani dalla loro natura di esseri sociali e
creativi. Questa alienazione si estende ben oltre il luogo di lavoro, fino alle
sfere più intime dell’esperienza umana, trasformando le amicizie, l’amore, la
sessualità e i rapporti familiari in scambi mercificati governati dalla stessa
logica che domina la vita economica.
La base materiale dell’alienazione
Il concetto di alienazione di Marx fornisce la base teorica per comprendere il degrado delle relazioni umane sotto il capitalismo. Nei suoi Manoscritti economico-filosofici del 1844, Marx identificò quattro forme di alienazione vissute dai lavoratori sotto il capitalismo: l’alienazione dal prodotto del lavoro, dall’atto di produzione, dall’essere una specie e dagli altri esseri umani.
Quest’ultima forma, l’alienazione dagli altri esseri umani, è fondamentale per comprendere le dinamiche relazionali contemporanee.
Marx osservò che sotto il capitalismo, «il rapporto dell’uomo con l’uomo» è mediato dalla forma merce. Gli esseri umani non si incontrano come persone complete, ma come portatori di valori di scambio, come mezzi per fini privati piuttosto che come fini in sé. Questa mercificazione delle relazioni umane permea ogni aspetto della vita sociale, comprese le relazioni personali più intime.
L’alienazione insita nella produzione capitalistica crea individui isolati e
competitivi, incapaci di formare legami umani autentici. Come scrisse Marx nei
Grundrisse, «l’individuo porta in tasca il suo potere sociale, così come il suo
legame con la società». Questa riduzione dei legami sociali a relazioni
monetarie mina la possibilità di una comunità umana autentica e del
riconoscimento reciproco.
Sviluppo storico della famiglia
Il capolavoro di Engels, L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, fornisce un contesto storico essenziale per comprendere come le società di classe abbiano plasmato le relazioni. Engels ha dimostrato che la famiglia monogama moderna non è un’istituzione naturale o eterna, ma un prodotto storico emerso insieme alla proprietà privata e alla divisione di classe.
«La famiglia individuale moderna si basa sulla schiavitù domestica, palese o nascosta, della moglie» scriveva Engels, «e la società moderna è una massa composta da queste famiglie individuali come molecole». La famiglia borghese svolge molteplici funzioni per il capitale: riproduce la forza lavoro, fornisce lavoro domestico non retribuito e crea una sfera di consumo per le merci capitalistiche.
Engels spiegò che il matrimonio monogamo non si sviluppò dall’amore tra individui, ma dalla necessità economica: la necessità di garantire l’eredità patrilineare della proprietà privata. «Fu la prima forma di famiglia basata non su condizioni naturali, ma economiche: sulla vittoria della proprietà privata sulla proprietà comune primitiva e naturale». Questo fondamento economico continua a plasmare le relazioni contemporanee, anche se il romanticismo oscura queste realtà materiali.
La lotta contro l’oppressione delle donne non può essere separata dalla più ampia lotta contro il capitalismo. Come è stato chiarito in “La rivoluzione comunista e l’emancipazione delle donne” (in “Comunismo” n.2, maggio 1979): «L’oppressione delle donne non è semplicemente una questione di atteggiamenti maschilisti o di cultura patriarcale, ma è radicata nella struttura materiale della società di classe stessa».
Qui, “donna” non deve essere intesa come una categoria biologica, ma come una
posizione sociale ed economica all’interno dei rapporti capitalistici di
produzione e riproduzione. Le donne rappresentano coloro che svolgono il lavoro
non retribuito di riproduzione della forza lavoro, cioè il parto, l’educazione e
il mantenimento dei lavoratori per lo sfruttamento capitalistico. Ciò include i
rapporti sessuali e il lavoro domestico non retribuito che sostiene la
produzione capitalistica riducendo il costo di mantenimento della forza lavoro.
All’interno della struttura familiare, come ha dimostrato Engels, le donne
occupano la posizione proletaria rispetto alla posizione borghese degli uomini,
caratterizzata da dipendenza economica, mancanza di controllo sulla proprietà e
sottomissione all’autorità patriarcale. Questa categoria è un prodotto storico
piuttosto che naturale, insieme alla proprietà privata e alla società di classe
per soddisfare le esigenze dell’accumulazione di capitale attraverso un doppio
sfruttamento: come lavoratrici salariate e come riproduttrici non retribuite
all’interno del nucleo familiare.
Oggettivazione e mercificazione della sessualità
L’oggettivazione delle donne e la mercificazione della sessualità sono forme particolarmente acute di alienazione nel capitalismo. La logica delle merci, che riduce tutte le qualità al valore di scambio quantitativo, trasforma il desiderio sessuale e le relazioni intime in beni commerciabili.
L’analisi di Marx sul feticismo delle merci illumina questo processo. Proprio come le relazioni sociali tra gli uomini appaiono come relazioni tra cose nello scambio di merci, le relazioni sessuali assumono sempre più il carattere di transazioni tra oggetti piuttosto che di incontri tra soggetti. L’enorme industria della pornografia, la diffusione delle app di incontri, che riducono la complessità umana a profili fugaci, e la sessualizzazione generale della cultura riflettono tutti questo processo di mercificazione.
Le donne in particolare subiscono una doppia alienazione sotto il capitalismo. In quanto appartenenti alla categoria sociale delle “donne”, definite dalla loro funzione di riproduttrici di forza lavoro e di esecutrici di lavoro domestico non retribuito, sono sfruttate sia come lavoratrici (quando partecipano al lavoro salariato) sia come riproduttrici non retribuite di forza lavoro all’interno della famiglia. Questo doppio sfruttamento crea le condizioni in cui il corpo e la sessualità delle donne diventano luoghi di particolare oggettivazione e controllo.
La mercificazione della sessualità allontana anche gli uomini da un’autentica
relazione intima. La riduzione delle relazioni sessuali ad atti di consumo, sia
attraverso la pornografia, la prostituzione o la cultura degli appuntamenti
mercificata, impedisce lo sviluppo di un autentico riconoscimento reciproco e di
una cura reciproca che caratterizzano le relazioni umane non alienate.
Le contraddizioni della famiglia borghese
Pur riconoscendo il carattere oppressivo della famiglia borghese, Marx ed Engels la consideravano anche un’istituzione contraddittoria che racchiude in sé sia i semi della liberazione umana sia i meccanismi di dominio. La famiglia dovrebbe offrire uno spazio di intimità emotiva e cura reciproca che è in gran parte assente dalla sfera competitiva delle relazioni di mercato, ma lo fa all’interno di strutture di disuguaglianza e dipendenza economica.
«All’interno della famiglia, lui [l’uomo] è il borghese e sua moglie rappresenta il proletariato», osservava Engels. Questo rapporto di classe all’interno della famiglia crea tensioni che rispecchiano contraddizioni sociali più ampie. L’ideologia dell’amore romantico e della felicità familiare è in conflitto con la realtà materiale della dipendenza economica, dello sfruttamento del lavoro domestico e dell’autorità patriarcale.
I problemi relazionali contemporanei – femminicidio, violenza domestica,
comportamenti deviati, distanza emotiva, crisi della mascolinità, ecc. – possono
essere intesi come espressioni di queste sottostanti contraddizioni. La famiglia
non può mantenere la sua promessa ideologica di fornire un rifugio dalla
competizione capitalista quando è essa stessa strutturata dagli stessi rapporti
di proprietà e dalle stesse dinamiche di potere che governano la società
capitalista.
Alienazione e crisi della mascolinità
L’assalto del capitalismo alle relazioni umane colpisce tutti i generi, anche se in modi diversi. La evidente crisi della mascolinità nella società contemporanea, che si esprime in fenomeni come i celibi involontari e nell’aumento dei suicidi fra i maschi, riflette il modo particolare in cui l’alienazione capitalista influisce sulla capacità degli uomini di costruire relazioni intime.
L’identità maschile tradizionale era costruita attorno al ruolo di capofamiglia e patriarca, ruoli che il capitalismo richiede e allo stesso tempo mina. L’individualismo competitivo richiesto dall’accumulazione capitalistica è in conflitto con la vulnerabilità e la disponibilità emotiva necessarie per una relazione intima. Gli uomini, costretti socialmente fra la razionalità strumentale e la repressione emotiva, lottano per formare i legami empatici necessari per relazioni autentiche.
Questa crisi non può essere risolta con terapie individuali o cambiamenti
culturali, ma richiede di affrontare le condizioni materiali che producono la
soggettività maschile alienata. Finché gli uomini dovranno competere tra loro
per la sopravvivenza economica e lo status, e finché il valore sociale sarà
misurato dal successo sul mercato piuttosto che dal contributo umano, persisterà
la base strutturale dell’alienazione maschile.
L’amore sotto il capitalismo: ideologia e realtà
L’ideologia dell’amore romantico svolge funzioni importanti per la società capitalista, indicando al contempo la possibilità di una liberazione umana. L’amore romantico promette il superamento dell’individualismo isolato imposto dal capitalismo, offrendo la possibilità di un autentico riconoscimento e cura reciproci. Tuttavia questa promessa è sistematicamente minata dalle condizioni materiali in cui devono svilupparsi le relazioni contemporanee.
Marx comprese che l’amore autentico richiede il riconoscimento dell’altro come soggetto umano completo piuttosto che come mezzo per i propri fini. Nei Manoscritti del 1844 scrisse: «Se ami senza suscitare amore in cambio, cioè se il tuo amore come amore non produce amore reciproco; se, attraverso l’espressione vivente di te stesso come persona amorevole, non ti fai amare, allora il tuo amore è impotente, una disgrazia».
Nel capitalismo, questo riconoscimento reciproco è sistematicamente impedito dalla riduzione degli esseri umani a portatori di valore di scambio. La mercificazione dell’intimità, le pressioni economiche sulle relazioni e l’individualismo competitivo richiesto dal capitalismo ostacolano la possibilità di riconoscimento reciproco che l’amore autentico comporta.
La crisi del matrimonio, l’aumento dei tassi di divorzio e la diffusa
disfunzionalità delle relazioni non riflettono fallimenti personali, ma la
contraddizione tra il bisogno umano di connessioni autentiche e le strutture
alienanti della società capitalista. Le persone entrano in una relazione alla
ricerca del riconoscimento autentico che il capitalismo nega loro, solo per
scoprire che le loro relazioni riproducono la stessa logica strumentale che
governa la società in generale.
Liberazione sessuale e trasformazione rivoluzionaria
La vera libertà nelle relazioni intime non può essere raggiunta all’interno delle relazioni sociali capitalistiche. I movimenti di liberazione sessuale che si concentrano principalmente sul cambiamento culturale, lasciando intatte le strutture economiche, alla fine non riescono ad affrontare la base materiale dell’oppressione sessuale.
La vera liberazione sessuale richiede l’abolizione delle condizioni economiche che riducono gli esseri umani a merci e rendono coloro che occupano la posizione sociale di “donna” economicamente dipendenti dagli “uomini”. La liberazione delle donne – e con essa la liberazione della sessualità dalle sue forme distorte sotto il capitalismo – richiede la trasformazione rivoluzionaria della società nel suo complesso.
Ciò non significa che le lotte per riforme immediate – diritti riproduttivi, parità salariale, protezione dalla violenza sessuale – non siano importanti. Significa piuttosto comprendere queste lotte come parte di un progetto rivoluzionario più ampio volto a creare condizioni sociali in cui siano possibili relazioni umane non alienate.
Engels, a proposito del socialismo, una volta eliminata la base economica
dell’oppressione delle donne, concluse che «ciò che possiamo ora ipotizzare sul
modo in cui saranno ordinati i rapporti sessuali dopo l’imminente rovesciamento
della produzione capitalistica è principalmente di carattere negativo, limitato
per lo più a ciò che scomparirà. Ma cosa ci sarà di nuovo? La risposta sarà data
quando sarà cresciuta una nuova generazione».
Le donne nella lotta sindacale e i limiti del femminismo borghese
Il potenziale rivoluzionario di coloro che occupano la posizione sociale di “donna” si estende in modo cruciale alla sfera della lotta sindacale organizzata. Le lavoratrici subiscono uno sfruttamento particolare in quanto svolgono sia lavoro salariato sia lavoro domestico non retribuito, il che le rende una forza potenzialmente esplosiva all’interno del movimento proletario. La loro partecipazione agli scioperi e all’organizzazione sindacale offre una visione unica della totalità dello sfruttamento capitalista, che si estende oltre il luogo di lavoro fino alla casa.
Tuttavia, questo potenziale rivoluzionario è costantemente minacciato dal
femminismo, un’ideologia democratica borghese che cerca di incanalare le
legittime rivendicazioni delle donne in vicoli ciechi riformisti che lasciano
intatti i rapporti di proprietà capitalistici. Il femminismo borghese si
concentra sul raggiungimento dell’uguaglianza all’interno del sistema esistente
– pari accesso allo sfruttamento, pari opportunità di diventare sfruttatori –
piuttosto che sfidare le basi materiali dell’oppressione. Promuove l’illusione
che la liberazione delle donne possa essere raggiunta attraverso riforme legali,
cambiamenti culturali o avanzamenti individuali, lasciando intatte le strutture
fondamentali della società di classe. Il pericolo del femminismo borghese
risiede nella sua capacità di dirottare la vera energia rivoluzionaria e di
reindirizzarla verso obiettivi che in realtà servono gli interessi capitalisti.
Quando le lotte delle donne sono separate dalla lotta di classe e ridotte a
politiche identitarie, diventano strumenti per dividere la classe lavoratrice
invece che per unirla contro il capitale. Il movimento rivoluzionario deve
combattere l’ideologia femminista borghese sostenendo le lotte concrete delle
lavoratrici come parte integrante del più ampio movimento proletario.
Forme di relazione nel capitalismo: monogamia, poligamia e l’illusione della scelta
I dibattiti contemporanei sugli stili di relazione – monogamia contro poligamia, matrimonio tradizionale contro forme alternative – sono spesso presentati come questioni di scelta personale e liberazione individuale. Queste forme di relazione devono essere analizzate in termini di funzione all’interno delle relazioni sociali capitalistiche piuttosto che come espressioni di preferenze personali o di superiorità morale.
L’attenzione agli stili di relazione come luoghi di liberazione rappresenta ciò che Marx identificava come la feticizzazione delle relazioni sociali, ovvero la trasformazione delle condizioni storiche e materiali in scelte apparentemente naturali o personali. Questo oscura la base materiale delle relazioni umane sotto il capitalismo e impedisce il riconoscimento della trasformazione rivoluzionaria necessaria per una vera liberazione.
Il matrimonio monogamo, come ha dimostrato Engels, si è sviluppato come meccanismo per garantire l’eredità patrilineare della proprietà privata. La sua continuazione sotto il capitalismo svolge molteplici funzioni interconnesse all’interno del sistema di accumulazione del capitale: fornisce lavoro domestico non retribuito che sovvenziona la riproduzione della forza lavoro, crea unità stabili per il consumo di merci, mantiene la riproduzione privatizzata della classe operaia e stabilisce un quadro giuridico per il trasferimento della ricchezza accumulata tra le generazioni. L’ideologia romantica della monogamia serve a oscurare queste funzioni materiali, presentando il matrimonio come l’espressione naturale dell’amore umano. Questa mistificazione ideologica è fondamentale per il capitalismo perché trasforma quella che Engels chiamava «la schiavitù domestica aperta o nascosta della moglie» in un’espressione apparentemente volontaria di impegno personale e appagamento emotivo.
Il poliamore e altri stili di relazione alternativi, che sono in parte espressione del desiderio degli esseri umani di eliminare i rigidi rapporti di proprietà della forma monogama e spesso presentati come sfide radicali alle strutture tradizionali, riproducono frequentemente la stessa alienazione di fondo in forme nuove e più complesse. Quando le relazioni poliamorose operano all’interno delle relazioni sociali capitalistiche, spesso diventano sistemi elaborati per gestire scambi multipli mercificati piuttosto che espressioni di autentica liberazione umana. La complessità di organizzare più partner, concordare confini e accordi e gestire la gelosia e la competizione rispecchiano spesso la razionalità strumentale che governa altre sfere della vita capitalista. La riduzione delle relazioni intime a una trattativa tra individui autonomi – per quanto complessa ed egualitaria possa apparire – riflette piuttosto che trascendere la logica mercantile che struttura tutte le relazioni sociali sotto il capitalismo.
Ciò che si presenta come liberazione dai vincoli tradizionali spesso diventa una forma più sofisticata della stessa alienazione fondamentale. La moltiplicazione delle relazioni emotive e sessuali non supera la mercificazione dell’intimità, ma la estende a una rete più ampia di connessioni, ciascuna governata dalla stessa logica di scambio e vantaggio reciproco che caratterizza le relazioni di mercato.
Né la monogamia né il poliamore rappresentano una forma di relazione intrinsecamente rivoluzionaria. Entrambe possono servire come veicoli sia per lo sfruttamento sia per autentiche connessioni umane, a seconda delle condizioni materiali in cui operano. L’attenzione agli stili di relazione come luoghi di liberazione rappresenta una forma di individualismo borghese che colloca il problema nelle scelte personali piuttosto che nelle strutture sociali.
Come affermato in “Rivoluzione comunista ed emancipazione della donna”: «Ci opponiamo all’ideologia dell’“amore libero” solo nella misura in cui essa cerca di sostituire la rivoluzione come mezzo per stabilire una volta per tutte il problema dei rapporti tra i sessi». Al contrario, vogliamo chiarire che è proprio il femminismo – come ideologia – che cerca di distorcere in un obiettivo politico autosufficiente la ricerca positiva di milioni di donne alla ricerca della loro indipendenza interiore ed esteriore e dell’affermazione della loro individualità, mentre cercano di sottrarsi alla tutela degli uomini per ristabilire un rapporto paritario anziché antagonistico».
Questo passaggio mette in luce l’errore fondamentale degli approcci che individuano la soluzione ai problemi relazionali nell’adozione di particolari stili di comportamento piuttosto che nella trasformazione rivoluzionaria dei rapporti sociali. La tendenza positiva verso l’indipendenza e l’uguaglianza che si manifesta nella sperimentazione relazionale contemporanea va oltre sé stessa e indica la necessità di una rivoluzione sociale, ma l’ideologia borghese cerca di contenerla all’interno di soluzioni individualistiche che lasciano intatti i rapporti di proprietà capitalistici.
La concezione comunista fornisce una netta critica del femminismo borghese e della politica identitaria. Questi movimenti, nonostante le loro pretese di radicalismo, rimangono intrappolati in forme borghesi di coscienza e di organizzazione che riproducono piuttosto che trascendere l’alienazione capitalista. Il femminismo borghese, anche nelle sue forme più radicali, concepisce la liberazione in termini di diritti individuali e opportunità all’interno della società capitalista. È incapace di immaginare relazioni che trascendano l’individualismo competitivo e la soggettività privatizzata imposte dal capitalismo. Allo stesso modo, la politica identitaria contemporanea, con la sua attenzione all’esperienza personale e alle scelte di vita, rappresenta una forma esasperata di individualismo borghese.
Il nostro testo del 1979 prosegue con una visione radicale del rapporto tra liberazione personale e trasformazione sociale: «La ricerca dell’amore libero, se epurata da tutte le ideologie radical-borghesi e dall’anatema dei conservatori e dei reazionari, è un aspetto dell’affermazione di sé come esseri umani di cui milioni di donne sentono il bisogno. Nuove forme di relazione tra i sessi non possono emergere senza distruggere completamente l’ordine sociale esistente, ma il processo che porta a questo fine è già riconoscibile nel percorso indipendente seguito, nonostante le difficoltà, da molte donne e che di fatto deriva dalla crescente decomposizione delle istituzioni attuali».
Una vera trasformazione delle relazioni intime è inseparabile dalla «distruzione totale dell’ordine sociale esistente». La sperimentazione di forme alternative di relazione che caratterizza la società contemporanea riflette la «crescente decomposizione delle istituzioni attuali» sotto la pressione delle contraddizioni capitalistiche, ma queste sperimentazioni non possono realizzare il loro potenziale liberatorio entro i limiti delle relazioni sociali capitalistiche.
La vera liberazione sessuale ed emotiva non sarà raggiunta attraverso l’adozione
di particolari stili di relazione, ma attraverso la trasformazione
rivoluzionaria delle condizioni materiali che riducono i rapporti umani a
rapporti di proprietà. Nel socialismo, con l’abolizione della proprietà privata
e la socializzazione del lavoro domestico, emergeranno nuove forme di rapporti
umani che difficilmente possiamo immaginare dalla nostra attuale condizione
alienata.
Il partito di classe e i rapporti comunisti tra compagni
Il partito, nella sua lotta contro il capitalismo, non rappresenta semplicemente una delle tante organizzazioni politiche, ma l’anticipazione delle relazioni sociali comuniste.
Nel capitalismo, la prassi umana – l’attività cosciente e creativa – è sistematicamente invertita, con gli esseri umani al servizio delle esigenze dell’accumulazione del capitale piuttosto che dello sviluppo umano. Il partito di classe, espressione organizzata della coscienza rivoluzionaria, rappresenta l’inizio di questa inversione già all’interno della società capitalista.
Nel socialismo la specie umana cessa di essere un mero oggetto delle forze storiche e diventa un soggetto cosciente in grado di dirigere il suo sviluppo in base ai propri bisogni reali.
Come Marx ha dimostrato nella sua critica dell’economia politica, le relazioni umane autentiche richiedono il riconoscimento degli altri come soggetti completi piuttosto che come mezzi per fini particolari. Il partito, nella misura in cui incarna il programma del comunismo, diventa uno spazio in cui tale riconoscimento diventa possibile già all’interno della società capitalista. Il partito non può essere uno strumento in lotta per il comunismo mantenendo al suo interno gli stessi rapporti alienati che caratterizzano la società capitalista. Al contrario, il partito deve tendere a prefigurare relazioni comuniste nella sua stessa vita organizzativa, aspirando a mantenere al suo interno “un ambiente ferocemente antiborghese”.
Mentre le relazioni sociali – che si tratti di matrimonio, amicizia o lavoro – rimangono irretite nei rapporti di proprietà privata e nell’individualismo competitivo, i rapporti tra comunisti si basano su un impegno rivoluzionario condiviso e sul riconoscimento reciproco di combattenti per la stessa causa, indipendentemente dal borghese “valore” individuale: età, genere, sesso, nazionalità, occupazione, preparazione, istruzione... sostenendo e incoraggiando lo sviluppo armonioso di tutti, al di fuori di ruoli o aspettative fisse.
L’uguaglianza del ruolo nel partito delle compagne trascende così sia la tradizionale subordinazione delle donne all’interno del matrimonio, sia la negazione competitiva che caratterizza le alternative progressiste che pretendono di aver superato il patriarcato.
Questa trasformazione delle relazioni umane all’interno del partito si manifesta in diverse caratteristiche cruciali che attingono dal futuro comunista. Le relazioni tra compagni trascendono il calcolo del vantaggio privato che caratterizza tutte le relazioni borghesi, comprese le forme più progressiste di sperimentazioni alternative. I compagni non si relazionano tra loro come potenziali fonti di beneficio personale, ma come partecipanti a un progetto rivoluzionario comune che trascende gli interessi individuali.
La coscienza del comunismo, collettiva e condivisa, fornisce la base per una comprensione e solidarietà che va oltre le simpatie personali, la compatibilità di provenienza e le affinità elettive.
Il concetto di Marx di essere-specie – la natura essenziale degli esseri umani come esseri sociali e creativi – trova la sua prima espressione concreta nel partito rivoluzionario. Le relazioni tra compagni anticipano la libera associazione dei produttori che caratterizzerà la società comunista, dove lo sviluppo umano diventa sia il mezzo sia il fine dell’organizzazione sociale.
Alla scala della società l’alternativa concreta tanto alle strutture patriarcali tradizionali quanto alle alternative femministe borghesi potrà realizzarsi solo dopo la rivoluzione comunista.
Il partito non è come un ordine monastico, autarchico e chiuso, ove albergano asceti, santi o eroi, e che per alcuni utopisti avrebbe dovuto essere anche produttivo e riproduttivo. Sebbene il partito dedichi estrema attenzione e ogni energia a mantenere al suo interno un ambiente comunista e di relazioni fraterne e organiche, i singoli militanti rimangono condizionati dal contesto più ampio delle relazioni sociali capitalistiche e dalle difficoltà materiali quotidiane da cui non possono completamente sfuggire.
Questo vale anche nei rapporti di coppia, sia questo fra compagni di partito sia con un partner non comunista. Non si può affermare che la questione uomo-donna, che è economica e strutturale, nell’interno del partito sia risolta né risolvibile.
È solo il partito nel suo insieme che può “rovesciare la prassi”. E aiutare i suoi militanti a superare i comportamenti legati alla società da cui provengono. L’impegno rivoluzionario dei singoli individui non può generare quelle forme nuove che saranno possibili solo dopo la rivoluzione, mancandone ora le premesse materiali. Non dobbiamo quindi essere vittime di delusioni nel constatare le debolezze nel comportamento anche di compagni personalmente più vicini senza scadere in inutili moralismi. È solo nella lotta comune che ci possiamo aiutare vicendevolmente a compensare le debolezze e le carenze individuali e sviluppare le relazioni che ci consentono di sfruttare al meglio i doni e le capacità dei nostri compagni per realizzare questo grande bisogno umano di emancipazione definitiva.
Nel comunismo, le relazioni romantiche e sessuali si svilupperanno all’interno della comunità umana più ampia e contribuiranno ad essa, piuttosto che formare unità isolate in competizione tra loro. La privatizzazione della vita intima che caratterizza la società borghese sarà superata attraverso forme di relazione che rafforzano la solidarietà umana invece di frammentarla.
Esse saranno sostenute da condizioni materiali che incoraggiano invece che
minare la solidarietà umana e la cura reciproca. La base economica
dell’oppressione relazionale sarà eliminata attraverso l’abolizione della
proprietà privata e la socializzazione del lavoro riproduttivo.
Pratica rivoluzionaria e liberazione umana
L’analisi dell’alienazione nelle relazioni intime, sviluppata attraverso il quadro teorico marxista, indica la necessità di una trasformazione rivoluzionaria e non soluzioni riformiste. La crisi delle relazioni umane sotto il capitalismo non può essere risolta attraverso migliori tecniche di comunicazione, terapie, cambiamenti culturali o l’adozione di stili di relazione alternativi, anche se questi possono fornire un sollievo temporaneo agli individui intrappolati in relazioni alienate.
La liberazione delle relazioni umane richiede l’abolizione della proprietà privata, la socializzazione del lavoro domestico e condizioni economiche che consentano a tutti gli individui di sviluppare il proprio potenziale. Quando gli esseri umani non saranno più costretti a vendere la propria forza lavoro per sopravvivere e quando la produzione sociale sarà organizzata in base ai bisogni piuttosto che al profitto, esisterà la base materiale per relazioni veramente libere.
Questa trasformazione rivoluzionaria richiede una lotta politica organizzata della classe operaia guidata dal suo partito comunista. Coloro che occupano la posizione sociale di “donne” – in quanto riproduttrici e nutrici della forza lavoro e fornitrici di lavoro domestico non retribuito – hanno un ruolo cruciale da svolgere in questa lotta, poiché la loro oppressione è sia parte integrante dell’accumulazione capitalistica sia potenzialmente esplosiva nelle sue implicazioni rivoluzionarie.
La loro partecipazione all’organizzazione sindacale e alle lotte sul posto di lavoro apporta una critica radicale della totalità dello sfruttamento capitalistico.
Il partito di classe, in quanto espressione cosciente del movimento rivoluzionario, svolge un ruolo indispensabile nel collegare tutte le lotte sparse al più ampio progetto di emancipazione umana.
La lotta contro l’oppressione delle donne è quindi inseparabile dalla più ampia
lotta di classe contro il capitalismo. Sono fronti diversi nella stessa
battaglia storica per la liberazione: creare le condizioni in cui gli esseri
umani possano relazionarsi tra loro come soggetti liberi, creativi e
reciprocamente riconosciuti, piuttosto che come oggetti in un’economia di
mercato.
Lavoratori di tutti i paesi, unitevi! Rompete le catene del capitale!
Per la trasformazione rivoluzionaria di tutti i rapporti umani!
La crisi delle relazioni amorose, della sessualità e della vita familiare sotto il capitalismo riflette l’alienazione insita in un sistema sociale basato sulla produzione di merci e sullo sfruttamento di classe. L’oggettivazione delle donne, la mercificazione della sessualità, la rottura dei legami intimi e la pervasiva solitudine che caratterizza la vita moderna non sono sottoprodotti accidentali di un sistema altrimenti benefico, ma conseguenze necessarie della riduzione delle relazioni umane a transazioni di mercato.
L’analisi marxista afferma che la vera liberazione umana, compresa la liberazione nella sfera delle relazioni intime, richiede una trasformazione rivoluzionaria delle basi materiali della società. Solo quando gli esseri umani saranno liberi dalla costrizione di vendere la loro forza lavoro, dalla competizione patriarcale, quando la produzione sociale servirà lo sviluppo umano piuttosto che l’accumulazione di capitale, esisteranno le condizioni materiali per l’amore autentico, la sessualità autentica e il riconoscimento reciproco, che rimangono promesse non mantenute sotto il capitalismo.
Il percorso da seguire richiede delle forti organizzazioni difensive, sia della classe operaia sia di tutti gli oppressi, in particolare delle donne. Richiede anche la chiarezza storica, apportata dal programma teorico del partito comunista, che indirizzi tutti questi movimenti spontanei verso il comune obbiettivo rivoluzionario.
La crisi delle relazioni sotto il capitalismo indica la possibilità della loro liberazione nel socialismo. La liberazione delle relazioni tra gli individui sarà un aspetto fondamentale della generale emancipazione umana. Il partito di classe, in quanto portatore della coscienza rivoluzionaria e organizzatore della lotta rivoluzionaria, è lo strumento indispensabile attraverso il quale si realizzerà questa liberazione.