|
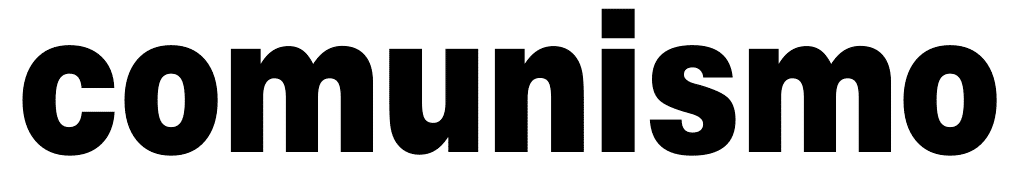 |
n.99 - luglio 2025 - Anno XLVII aggiornato al 15 luglio 2025 |
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
La retorica capitalista parla di diritti, da quelli dei cittadini a quelli delle nazioni. E nelle “democrazie perfette” come quelle occidentali, che sono allo stesso tempo anche perfette dittature fasciste, il proletariato dalla tenera età è indottrinato con la falsa illusione di essere tutelato da solenni documenti legali, la Costituzione, le varie Carte dei Diritti, mentre la realtà della vita ogni giorno smentisce quanto quei documenti dovrebbero garantire.
Per contro i borghesi rispettano o infrangono Leggi e Costituzioni secondo il loro comodo e, di fatto, le utilizzano solo come armi nel loro arsenale di dominio di classe e nella guerra che si fanno, fra aziende e fra Stati, sul mercato mondiale.
La brutale realtà dello sfruttamento di classe e il permanente scontro fra Stati comprovano la materiale impossibilità del concetto stesso di “uguaglianza”, sia tra individui sia tra nazioni, in un ambiente di capitalismo, di proprietà privata dei mezzi di produzione. La legalità è una imposizione dalla classe dominante per nascondere, in un universo fantastico, le disuguaglianze sociali e garantire la uguaglianza giuridica degli uomini sul mercato della forza lavoro.
Il diritto borghese storicamente ha avuto un ruolo rivoluzionario, espressione degli interessi della classe progressista, al tempo: sancire il libero dominio della proprietà privata e l’uguaglianza dei diritti spianò la strada al completamento dell’accumulazione primitiva e all’espansione del capitale. Spazzare via le reliquie feudali dei privilegi nobiliari e imporre l’uguaglianza creò le condizioni ottimali per lo sfruttamento del lavoro nelle imprese. Era il quadro giuridico perfetto per il lavoro salariato, l’estrazione incessante del plusvalore dal sudore e dal sangue della classe operaia in generale.
Ma in alcuni Paesi e momenti storici si riuscì, per altro, a far rientrare nella “legalità” anche il lavoro degli schiavi. In ogni tempo detenzioni illegali e sospensione dei diritti sono state e sono legalmente giustificate da “minacce alla sicurezza nazionale” o per la “guerra al terrorismo”. Fuori da ogni diritto legale sono considerati i lavoratori immigrati “irregolari”, che devono vivere nel terrore e non osare avanzare richieste di alcun tipo, tanto meno salariali, né farsi vedere a manifestare nelle strade, per non rischiare di essere imprigionati e deportati al di fuori di ogni norma e legge.
La crisi economica che sta attraversando il capitale è attualmente così profonda che ogni regola stabilita e forma procedurale deve essere messa da parte. Quando i profitti sono minacciati i capitalisti sono costretti a infrangere la stesse istituzioni che si erano dati. “La legalità ci uccide!”. Nello stato di emergenza per il capitale si impiegano le forze dell’ordine per minacciare e arrestare giudici e politici non compiacenti, la magistratura deve sottomettersi all’esecutivo, i mezzi di informazione devono allinearsi. I parlamenti si smascherano per quello che ormai sono: niente.
Noi comunisti, quindi, non chiediamo ai borghesi di tornare alla loro legalità, dalla retorica, tracotanza e violenza esplicita del fascismo alla ragionevole ipocrisia delle forme democratiche.
Nemmeno noi comunisti abbiamo da sostituire all’ordinamento borghese un nuovo quadro giuridico definente le “libertà dell’uomo comunista”. Come scrisse Marx in “La questione ebraica”: «I cosiddetti diritti dell’uomo, i droits de l’homme distinti dai droits du citoyen, non sono altro che i diritti di un membro della società civile, cioè i diritti dell’uomo egoista, dell’uomo separato dagli altri uomini e dalla comunità (...) Il diritto dell’uomo alla libertà non si basa sull’associazione dell’uomo con l’uomo, ma sulla separazione dell’uomo dall’uomo. È il diritto di questa separazione, il diritto dell’individuo limitato, ritirato in sé stesso. L’applicazione pratica del diritto dell’uomo alla libertà è il diritto dell’uomo alla proprietà privata (...) senza riguardo per gli altri uomini, indipendentemente dalla società, il diritto all’interesse personale. Questa libertà individuale e la sua applicazione costituiscono la base della società civile. Essa fa sì che ogni uomo veda negli altri uomini non la realizzazione della propria libertà, ma l’ostacolo ad essa».
La delirante mistificazione borghese pretende estendere la mitologia della uguaglianza fra cittadini alla uguaglianza fra le nazioni, su scala globale. Proprio come la forza bruta è l’unico mezzo per far rispettare la legge tra le classi sociali, l’unica legge tra gli Stati è la forza della guerra. “Uguaglianza delle nazioni bidone supremo”.
Organismi internazionali come le Nazioni Unite e la precedente Società delle Nazioni furono create dagli Stati vincitori delle guerre mondiali per dividersi i continenti e coordinare il loro comune sfruttamento. Approvarono Carte e Statuti, ma il l’indiscusso dominio dei più forti è assicurato col diritto di veto. Con tutto il loro Diritto Internazionale e Tribunali dell’Aja niente hanno potuto né voluto fare per impedire o fermare i conflitti, come niente fanno per arrestare gli efferati eccidi in corso e come niente faranno contro la prossima guerra mondiale, verso cui il morente capitalismo sta spingendo l’umanità.
Intanto oggi il proletariato ha da rivendicare un solo “diritto”, quello di organizzarsi e lottare contro la classe dei proprietari del capitale e della terra, il diritto rivoluzionario ad abolire le classi e il sistema salariale, il denaro e il plusvalore. Il che significa necessariamente lottare contro le finzioni dei “diritti umani e civili” e dello “Stato di diritto” borghese.
Il comunismo sostituirà tutti i Codici e i Trattati con un solo Articolo: Scopo
della specie umana è accompagnare l’armonico sviluppo della vita sul pianeta
Terra.
Le battaglie attorno a Caricyn (conosciuta anche come Tsaritsyn, Stalingrado, e ora Volgograd), sul fronte meridionale furono di rilevante importanza strategica. La sua posizione sulla fiume Volga la rendeva un nodo cruciale per il controllo dei collegamenti e delle risorse.
Prima battaglia per Caricyn luglio‑settembre 1918
Il generale Pyotr Krasnov, convinto antibolscevico, appoggiato dal Krug (l’assemblea cosacca) e soprattutto dal solido aiuto economico e militare tedesco, riuscì a conquistare la Repubblica sovietica del Don, nell’attuale sud-est dell’Ucraina.
Krasnov dichiarò di aver stipulato un contratto con i rappresentanti militari tedeschi per la consegna di armamenti vari, inclusi aeroplani, cannoni, fucili, granate. In caso di azioni congiunte i tedeschi avrebbero consegnato gratuitamente metà del bottino di guerra all’Armata del Don. Krasnov enumerò le consegne tedesche alla sua armata: 11.651 fucili, 46 cannoni, 99 mitragliatrici, 109.104 granate e 11.594.721 cartucce. Krasnov cedette un terzo delle granate e un quarto delle cartucce all’Armata dei Volontari, i cui capi, sebbene finanziati dagli Alleati anglo-francesi, gli rimproveravano i suoi stretti legami con i comandi tedeschi, ma non rifiutarono le munizioni rivendute loro.
Krasnov pagherà l’aiuto di Berlino in seguito: durante la Seconda Guerra Mondiale organizzò una formazione cosacca nell’esercito tedesco; catturato dagli inglesi, fu consegnato ai russi. Dopo un breve processo per crimini di guerra contro civili in Iugoslavia, fu condannato a morte per impiccagione nel 1947 nei sotterranei della Lubjanka a Mosca.
Krasnov aggiunse altri territori cosacchi all’ex repubblica sovietica e il 17 aprile 1918 fondò la Repubblica del Don, che si estendeva su una vasta superficie (poco più della metà dell’Italia) con meno di 4 milioni di abitanti, metà dei quali cosacchi e la restante parte contadini e operai immigrati mal sopportati. Sfruttando al meglio il nazionalismo indipendentista cosacco, Krasnov intendeva guidare una repubblica cosacca indipendente e antibolscevica estesa tra il Don e il Volga.
Krasnov espose ai suoi ufficiali la conquista di Caricyn, fuori dai loro territori, come una necessità per una maggiore sicurezza dei confini della neonata repubblica del Don. Tentò così di superare la nota ritrosia dei cosacchi a combattere dai rispettivi lontano dai “territori nativi”, sguarniti in caso di incursioni nemiche.
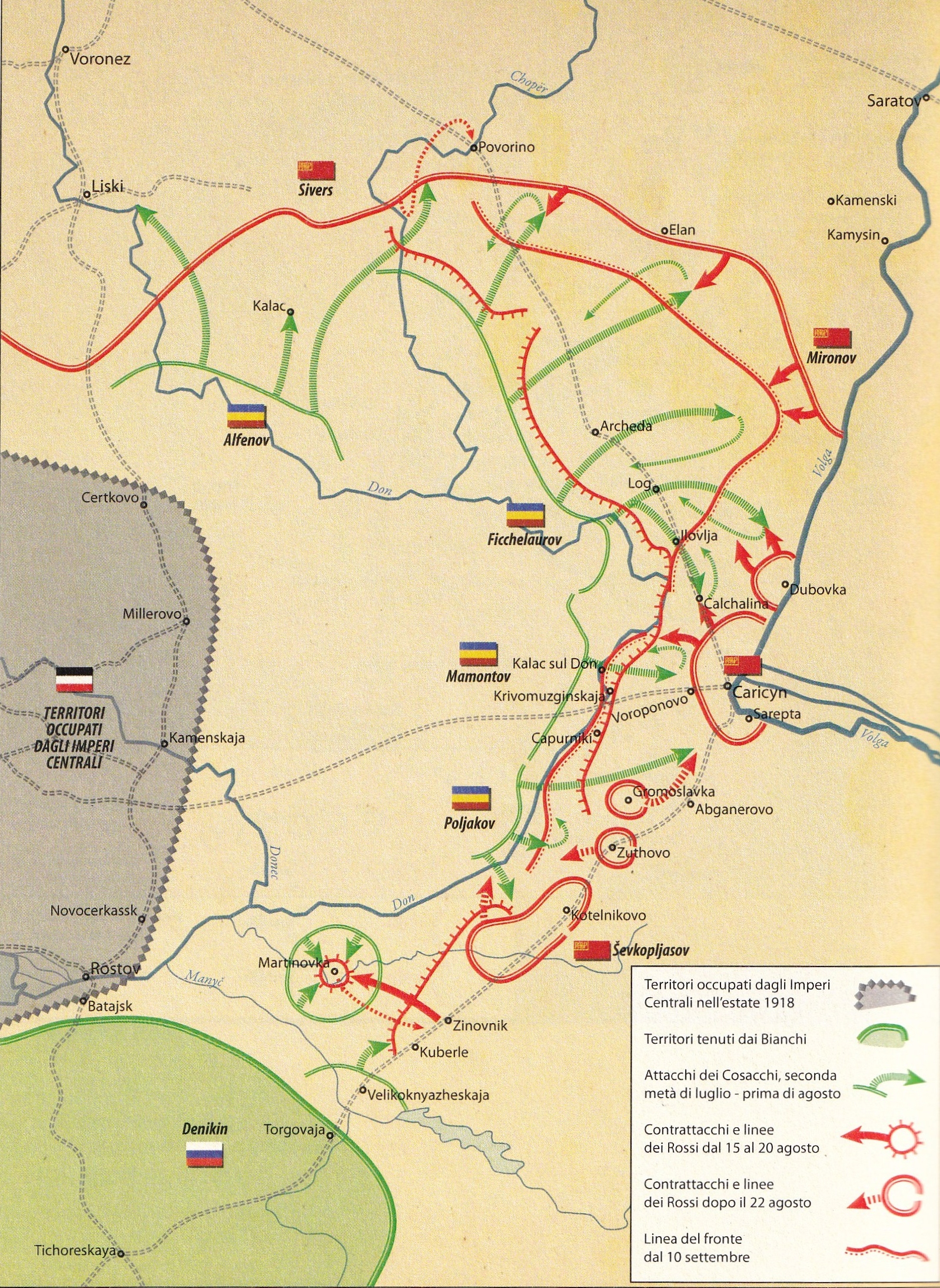 Caricyn si trova sulle rive del Volga, che per un breve tratto lì scorre a un
centinaio di chilometri al Don. Krasnov considerava necessaria la presa di
Caricyn per due principali motivi: era un importante nodo ferroviario che
collegava il centro della Russia con le regioni del basso Volga e del Caucaso.
Da lì transitava la maggior parte del grano, delle derrate alimentari e di
combustibile dal Sud verso le grandi città del Nord, controllate dai bolscevichi,
che necessitavano di quei rifornimenti per alimentare la popolazione e
specialmente per l’industria bellica e per l’Armata rossa. Questa era impegnata
a sostenere la difesa della “fortezza accerchiata” della rivoluzione su un
fronte di 8.000 chilometri ai quattro punti cardinali: interrompere quel flusso
significava portare un colpo mortale alla rivoluzione.
Caricyn si trova sulle rive del Volga, che per un breve tratto lì scorre a un
centinaio di chilometri al Don. Krasnov considerava necessaria la presa di
Caricyn per due principali motivi: era un importante nodo ferroviario che
collegava il centro della Russia con le regioni del basso Volga e del Caucaso.
Da lì transitava la maggior parte del grano, delle derrate alimentari e di
combustibile dal Sud verso le grandi città del Nord, controllate dai bolscevichi,
che necessitavano di quei rifornimenti per alimentare la popolazione e
specialmente per l’industria bellica e per l’Armata rossa. Questa era impegnata
a sostenere la difesa della “fortezza accerchiata” della rivoluzione su un
fronte di 8.000 chilometri ai quattro punti cardinali: interrompere quel flusso
significava portare un colpo mortale alla rivoluzione.
La difesa di Caricyn era cruciale anche per ragioni strategiche: la sua conquista avrebbe permesso ai cosacchi di Krasnov di unirsi alle forze di Aleksandr Dutov sul Volga (450 chilometri a nord), facilitando una avanzata su Mosca.
I piani del comandante cosacco bianco Denisov per la prima battaglia prevedevano due direttrici offensive: una principale su Caricyn e una secondaria per contenere i rinforzi rossi da nord. Il piano d’attacco principale sulla città era una manovra avvolgente su tre direttrici: un assalto principale a nord (23.000 effettivi) per tagliare i collegamenti ferroviari dal Sud con la Russia sovietica, per poi scendere a sud su Caricyn; un attacco centrale (12.000 uomini) direttamente sulla città; una terza direttrice da sud (10.000 combattenti) per occupare i collegamenti con il Nord del Caucaso e poi risalire verso Caricyn, chiudendo l’accerchiamento. Il controllo completo richiedeva l’occupazione stabile di tutti i villaggi circostanti lungo il Volga.
Le difese sovietiche, distribuite principalmente lungo il Don, erano numericamente uguali alle nemiche ma inferiori in qualità e coordinamento. Erano concentrate su Caricyn (23.000 uomini, 250 mitragliatrici/cannoni), indebolendo i settori a nord (7.000 uomini, 70 mitragliatrici/cannoni) e a sud (10.000 uomini, 100 mitragliatrici/cannoni). La riserva era esigua (1.500 uomini, 50 pezzi di artiglieria). Inoltre, il comando militare bolscevico doveva sottostare all’approvazione di Stalin, inviato con poteri straordinari dal 31 maggio come “dirigente generale degli approvvigionamenti nel Sud della Russia”. Stalin aveva deviato 6 reggimenti diretti a Bakù per la difesa di Caricyn. Le direttive dello Stato maggiore bolscevico si focalizzavano sulla protezione dei collegamenti nord-sud verso il Caucaso, incitando all’arruolamento. La difesa della città si basava sui treni blindati sull’anello ferroviario e sulle cannoniere fluviali del Volga per soccorrere i difensori.
L’attacco bianco a nord, favorito dalla loro forte superiorità numerica (23.000 contro 7.000) e dal mancato coordinamento rosso, interruppe le comunicazioni ferroviarie con Mosca, isolando la città il 30 luglio e rendendo vani i successi rossi altrove. Le truppe russe dovettero retrocedere, accorciare il fronte e ridistribuire le unità. Furono emanati severi decreti contro i disertori e fu attuata una mobilitazione delle classi più giovani.
Riorganizzate le forze, il 22 agosto l’Armata Rossa lanciò una controffensiva su due direzioni, rompendo le linee nemiche con assalti alla baionetta. Altre vittorie rosse nelle settimane seguenti respinsero i cosacchi bianchi oltre il Don, decretando il fallimento della prima offensiva di Krasnov. Un telegramma trionfale di Stalin a Lenin del 6 settembre dichiarò: “Caricyn è assicurata! L’offensiva continua”.
Le perdite bianche furono pesanti (12.000 tra morti, feriti e prigionieri), ma le perdite rosse furono molto più gravi (50.000). In realtà, lo “sfondamento” non era avvenuto, poiché Denisov aveva ordinato un ritiro lento ma tattico, frenando i contrattacchi bolscevichi che risentivano delle loro perdite.
Trotski, come Presidente del Consiglio militare rivoluzionario e capo dell’Armata Rossa, chiese a Lenin il richiamo immediato di Stalin, poiché la battaglia «era comunque andata male” nonostante le forze superiori. Il grande lavoro di riorganizzazione dell’Armata Rossa diretto da Trotski portò a una struttura militare efficiente e alla controversa reintroduzione di militari di professione (ex zaristi), che componevano il 75% degli ufficiali all’inizio e l’83% alla fine della guerra civile (solo 5 su 82 generali zaristi tradirono, mala loro fedeltà era spesso ottenuta tenendo in ostaggio le famiglie). Tra gli ex ufficiali zaristi che servirono la rivoluzione si distinse Michail Nikolaevič Tuchačevskij, entrato nell’Armata rossa nel 1918. Per le sue notevoli doti strategiche e di comando, già nel 1918 gli fu affidato, a soli 25 anni, il comando della Prima Armata.
Secondo il piano di riorganizzazione, fu istituito il nuovo Fronte Sud (con 4 armate, tra cui la X di Caricyn comandata da Kliment Yefremovich Vorošilov), con a capo l’ex ufficiale zarista Sytin.
Seconda battaglia per Caricyn settembre-ottobre 1918
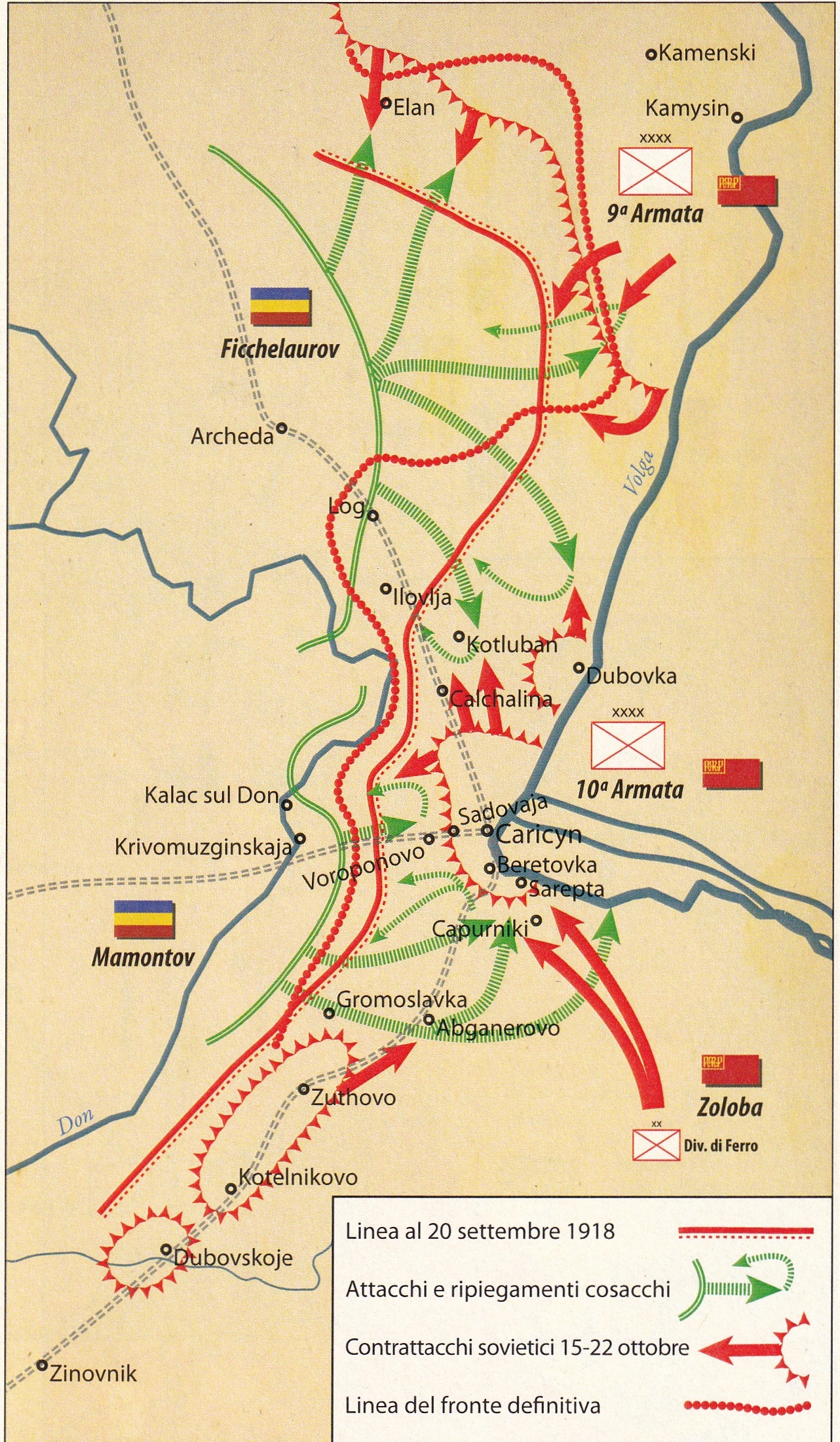
Nella seconda metà di settembre, Denisov lanciò una nuova offensiva per Caricyn su due direttrici. La prima, da nord-ovest (20.000 uomini, 122 mitragliatrici, 47 artiglierie, 2 treni blindati), doveva tagliare le comunicazioni con il Nord controllando il tratto ferroviario Caricyn-Archeda-Povorino. La seconda, affidata al generale Konstantin Mamontov per l’attacco principale da ovest verso est (25.000 soldati, 156 mitragliatrici, 93 artiglierie, 6 treni blindati), era considerata indispensabile per la velocità delle operazioni. Le riserve bianche erano 20.000 giovani.
Le difese bolsceviche contavano circa 40.000 uomini, 200 mitragliatrici, 152 pezzi d’artiglieria e 13 treni blindati, con un’organizzazione migliorata e una rete di fortificazioni.
In questo frangente, si acuì il contrasto tra Stalin e Trotski. Il primo, recatosi a Mosca per chiedere rinforzi, si scontrò con Trotski che, su parere di Sytin, ritardò i rifornimenti a Caricyn per dare priorità al settore orientale. Vorošilov ottenne l’invio della Divisione di Ferro di Žoloba dal Caucaso per rafforzare il sud di Caricyn. Stalin fu fortemente contrario alla reintroduzione degli ex ufficiali zaristi, voluta da Trotski. Sfiduciato verso Sytin lo accusò di disinteresse presso il Consiglio militare rivoluzionario. Di fatto sul Fronte Sud operavano due comandi militari (quello ufficiale di Sytin a Kozlov e quello non ufficiale di Stalin e Vorošilov a Caricyn), generando ordini e contrordini che creavano scompiglio.
Negli ultimi giorni di settembre l’offensiva bianca si concentrò nei settori centrale e meridionale per tagliare i collegamenti con Astrachan’ e il Caucaso. Gli attacchi riuscirono a penetrare fino a Sarepta (ora Krasnoarmeyskiy Rayon, circa 40 chilometri da Caricyn), isolando l’ala meridionale bolscevica, che dovette passare alla difesa passiva.
Dall’8 all’11 ottobre, l’offensiva si intensificò intorno a Sarepta, un punto chiave per l’anello ferroviario cittadino, dove operavano i “diavoli rossi” (treni corazzati). Per i controrivoluzionari prendere quella parte dell’anello ferroviario significava scardinare il sistema difensivo di Caricyn e aprirsi un ampio varco d’accesso nel settore meridionale della città.
L’attacco impetuoso dei cosacchi di Mamontov fu bloccato dal fuoco dei treni corazzati e dai contrattacchi alla baionetta della fanteria sovietica, costringendo Mamontov a una pausa per radunare le riserve. Stalin tempestò di telegrammi lo Stato maggiore sovietico per ottenere rinforzi e cibo, senza immediata risposta. Vorošilov si rivolse direttamente a Lenin. Il 15 ottobre, Jukums Vacietis (comandante in capo del RVSR) rispose addossando a Stalin la responsabilità della situazione, ma dispose l’invio di rinforzi.
Nel campo cosacco, certi della vittoria, gli ufficiali consumarono le scorte prima dell’assalto finale nel settore sud-ovest, contro le difese dell’”anello d’acciaio” ferroviario tra Voroponovo e Čapurniki, dove Vorošilov aveva personalmente organizzato una doppia linea di trincee a difesa della stazione di Sadovaja. Il 15 ottobre, Mamontov lanciò 25 reggimenti, ma le difese russe resistettero. Pochi chilometri a sud, a Beretovka, due reggimenti sovietici di contadini reclutati di recente si ammutinarono, uccisero i loro comandanti e si consegnarono ai cosacchi bianchi che, scambiandoli per un assalto, li falcidiarono sotto il fuoco incrociato bianco e rosso.
Lo stesso giorno, da sud arrivò la Divisione di Ferro di Žoloba (15.000 uomini, ma con poche munizioni) che, con marce forzate e un percorso defilato, colpì i cosacchi alle spalle presso Čapurniki. I cosacchi in quel settore ressero meno di un’ora, perdendo 1.400 uomini, 6 cannoni e 49 mitragliatrici, e il comandante del settore fu catturato, ripiegando verso ovest. Krasnov attribuì l’insuccesso alla mancata intercettazione della Divisione di Ferro da parte dell’Armata dei Volontari di Denikin.
Il 16 ottobre, Mamontov lanciò un secondo attacco, conquistando Voroponovo con pesanti perdite. I sovietici, a corto di munizioni, arginarono l’avanzata con contrattacchi alla baionetta per permettere il riassetto delle difese di Sadovaja. Quella sera, le avanguardie controrivoluzionarie erano a soli 7 chilometri da Caricyn, separate dall’ultima linea difensiva di Sadovaja. Vorošilov organizzò l’ultima resistenza concentrando tutte le bocche da fuoco, inclusi i treni blindati (27 batterie, 10 treni corazzati, per un totale di 200 cannoni su 40 chilometri di fronte), su settori predefiniti del nemico.
Il giorno dopo, all’alba, iniziò il bombardamento bianco, a cui le batterie rosse non risposero per carenza di munizioni. Cessato il fuoco, la fanteria cosacca avanzò con sicurezza. Arrivati a 400 metri dalle trincee, il comandante dell’artiglieria diede l’ordine di aprire il fuoco simultaneamente, creando un “tremendo muro di fuoco di sbarramento”. Cannoni, obici e mitragliatrici crearono enormi varchi nei ranghi cosacchi. Fu poi ordinato alla fanteria di uscire e inseguire il nemico in rotta, che ripiegò nel panico. L’anello ferroviario di Caricyn rimase sotto controllo bolscevico.
Questa pesante sconfitta, seppur parziale, indebolì i cosacchi nel morale e nei numeri, decimando le migliori truppe di Mamontov. L’ultima speranza risiedeva nell’attacco a nord di Ficchelaurov, che manteneva una consistente capacità offensiva. Questa avanzata fu favorita dalla perdita di contatto tra la IX e X Armata rossa a causa del ritiro di reparti del comandante Mironov (poi accusato di indisciplina) per le pesanti perdite. Ciò permise ai bianchi di aggirare Caricyn da nord su due direttrici, una su Kotluban e una più a nord per bloccare il traffico fluviale sul Volga. Vorošilov, con rapidi spostamenti interni e l’arrivo di esperti reggimenti lettoni dal fronte orientale, ripristinò le difese e la superiorità numerica rossa. Il 22 ottobre, l’avanzata bianca da nord fu bloccata e respinta a circa 30 chilometri dalla città, permettendo alle due Armate rosse di riunirsi e, a novembre, ripristinare i collegamenti ferroviari con la Russia sovietica.
A fine ottobre, la seconda offensiva controrivoluzionaria per Caricyn era chiaramente fallita. I bianchi arretrarono da tutte le posizioni conquistate, lamentando 20.000 uomini persi contro i 30.000 sovietici. Questa sconfitta tolse a Krasnov ogni speranza di unirsi a Dutov. Le ingenti perdite abbatterono il morale dei cosacchi, che erano sempre meno disposti a combattere lontano dai loro territori d’origine. L’arrivo del freddo rallentò le operazioni e favorì il ripiegamento dei cosacchi nei villaggi retrostanti, mentre anche le manovre sovietiche furono ostacolate dalle strade impraticabili.
L’11 novembre l’armistizio tedesco sancì la loro sconfitta e uscita dalla guerra, privando le formazioni cosacche del loro sostegno e costringendo Krasnov a cercare un’apertura verso l’Armata dei Volontari di Denikin (sostenuta da inglesi e francesi). Strategicamente, il ritiro tedesco dall’Ucraina offrì ai bolscevichi l’opportunità di aprire un fronte a ovest, obbligando Krasnov a spostare due divisioni da Caricyn verso Lugansk. In questo contesto, Vācietis ordinò un’offensiva generale entro il 23 novembre per assicurare collegamenti nord-sud. Nello stesso giorno, però, i cosacchi presero il nodo ferroviario di Liski, ma non avevano più le forze per uno sfondamento generale, e la loro offensiva limitata si bloccò.
L’esito della battaglia non fu una vittoria definitiva sui cosacchi di Krasnov, che si riorganizzarono per il controllo delle regioni del Don. Si arrivò a uno stallo, con azioni limitate di alleggerimento da parte della X Armata rossa a difesa di Caricyn.
Il fallimento dell’Esercito del Don a Caricyn ebbe diverse concause: l’attaccamento dei cosacchi ai loro territori (che spesso li portava a disertare) e l’uso inadeguato della loro cavalleria rispetto alla guerra moderna (cariche al galoppo contro mitragliatrici in posizioni fortificate). Denisov, inoltre, disperse le forze su più direttrici, mentre i bolscevichi si concentrarono saggiamente su un terreno limitato, agevolati da ferrovie e treni blindati per rapidi spostamenti. Le scelte difensive di Vorošilov e Stalin (difesa mobile e attiva, lasciando sfogare l’impeto cosacco in assalti sanguinosi per poi contrattaccare alla baionetta) furono possibili grazie al miglioramento qualitativo delle truppe rosse. Questo cambiò la dinamica della battaglia dagli attaccanti ai difensori.
In questo contesto la frattura di Stalin e Trotski costituì una sorta di “opposizione militare” assolutamente inconcepibile nel mezzo della guerra civile per la difesa della rivoluzione proletaria. Lenin, pressato da entrambi le parti, infine richiamò Stalin a Mosca.
Terza battaglia per Caricyn gennaio-febbraio 1919
Il ritiro dei tedeschi costrinse Krasnov a cercare nuove alleanze e finanziatori, rivolgendosi alle potenze dell’Intesa (che già sostenevano Denikin). Queste, per colmare il vuoto lasciato dai tedeschi, nel dicembre 1918 sbarcarono contingenti nel Sud dell’Ucraina ma imposero a Krasnov una condizione: la formazione di un comando unificato delle operazioni sul fronte Sud affidato a Denikin come comandante supremo, includendo tutte le unità cosacche del Don, del Terek e l’Armata dei Volontari. Nel frattempo, le truppe rosse di Vladimir Aleksandrovič Antonov-Ovseenko si infiltrarono nei territori sgomberati, dovendo contrastare sia le nuove forze alleate sia quelle del nazionalista ucraino Symon Vasyliovych Petljura e dei suoi "kuren".
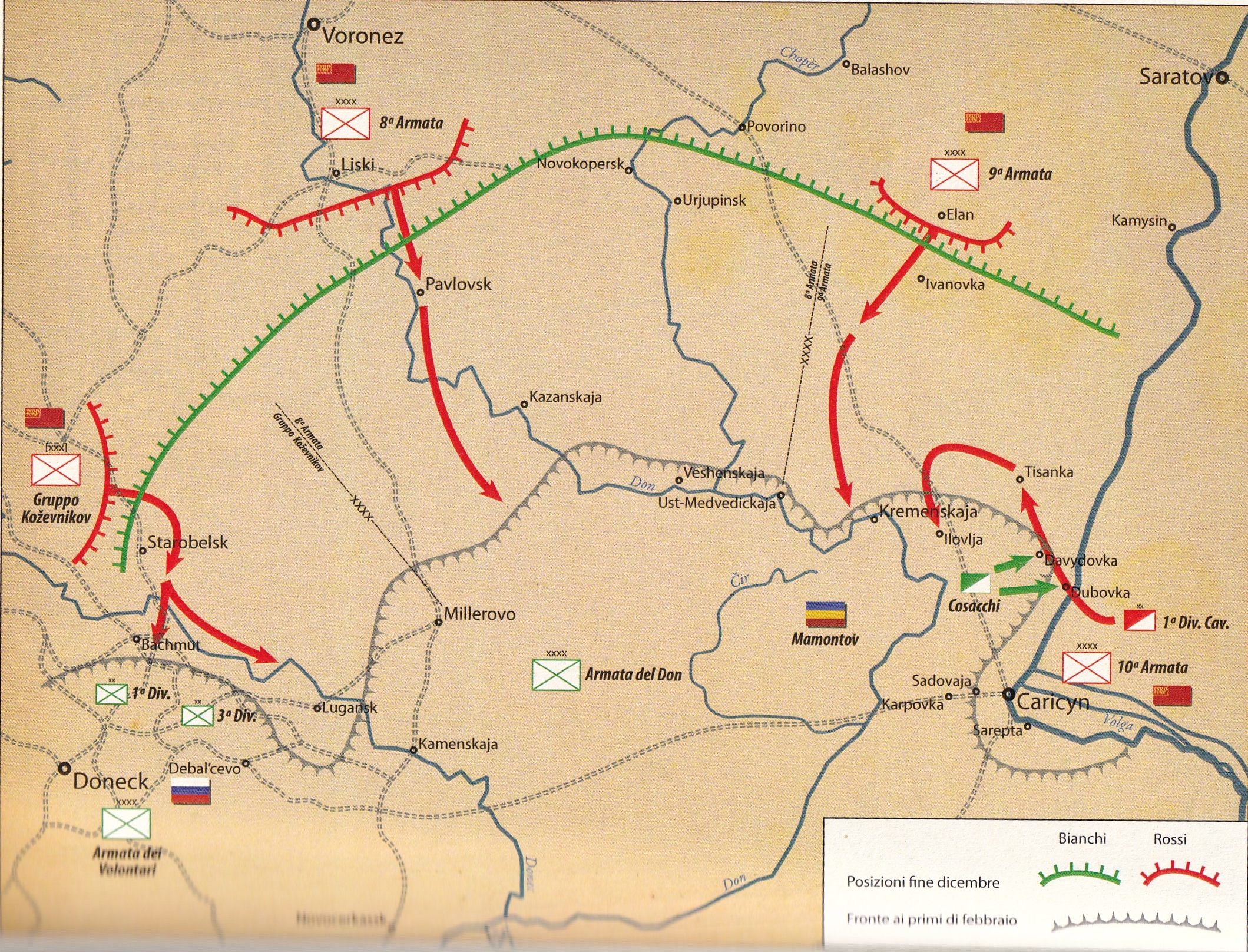
Dopo la riorganizzazione e il riposizionamento delle forze di Denikin, a fine dicembre 1918 si era formato un esteso fronte controrivoluzionario. Il suo vertice avanzato era presso l’asse ferroviario a Liski, il fianco orientale era tenuto dalle forze di Mamontov con centro di comando a Caricyn, e il precario fianco occidentale, sul fiume Donec, era difeso da soli 2.500 uomini del generale zarista Vladimir Mai-Maevskii. Quest’ultimo, abile organizzatore, dislocò le sue truppe insufficienti presso i nodi ferroviari intorno a Bachmut per rapidi spostamenti. I due centri di comando distavano 350 chilometri.
Nonostante la debolezza del fianco sinistro, Krasnov e Denisov insistettero per proseguire l’offensiva su Caricyn, mobilitando fino a 50.000 uomini, inclusi giovanissimi, con 63 cannoni (più 20.000 uomini e 16 cannoni a Liski). Difficoltà negli approvvigionamenti li portarono a requisire riserve alimentari per l’Armata del Don, minando la fiducia dei contadini. Vista la situazione, Lenin sostenne il piano del Consiglio Militare Rivoluzionario (RVSR) presieduto da Jukums Vācietis, quello di dare priorità allo scontro coi cosacchi, sfruttando le debolezze nemiche. Il piano bolscevico prevedeva un attacco frontale della VIII e IX Armata rossa da Voronež-Liski verso sud. Il fianco occidentale del saliente sarebbe stato attaccato dalle ali dell’VIII Armata unite al gruppo di Koženicov (20.000 uomini) per tagliare le vie di fuga cosacche. La X Armata sul Volga avrebbe impegnato l’Armata del Don nel settore di Caricyn con una difesa elastica. L’offensiva avrebbe impiegato 50.000 uomini su un totale di 124.500 effettivi del fronte sud.
L’offensiva bolscevica, accuratamente preparata, iniziò ai primi di gennaio. Il nucleo centrale dell’VIII Armata conquistò facilmente i nodi ferroviari di Liski e Pavlovsk. Il gruppo di Koženicov penetrò da ovest fino a Starobilsk. Nel frattempo, i cosacchi, con rinforzi, riattivarono l’offensiva a nord, attaccando duramente il congiungimento tra l’VIII e IX Armata verso Povorino. Per evitare di essere intrappolati, il Comando centrale dell’Armata del Don ordinò un rapido ripiegamento di circa 200 chilometri verso sud per connettersi al fianco destro dell’Armata dei Volontari di Maj-Majevskii, già impegnato contro le formazioni anarchiche di Nestor Ivanovič Machno in Ucraina. La ritirata cosacca fu ostacolata dalle due armate rosse, abbattendone ulteriormente il morale già provato da fatiche, privazioni, clima invernale e disillusione per gli aiuti alleati.
A fine gennaio, il vertice del saliente era ceduto: l’VIII Armata scese fino a Kazanskaja, mentre il gruppo di Koženicov conquistò Bachmut, poi Lugansk, e stabilì contatto con l’VIII Armata a nord di Millerovo. Nel settore orientale, Krasnov riprendeva ostinatamente l’offensiva su Caricyn, nonostante le difese rosse fossero nettamente superiori. I cosacchi riuscirono comunque a recuperare parte del territorio presso l’asse ferroviario di Karpovka. A fine dicembre, le condizioni atmosferiche peggiorarono con tempeste di neve e basse temperature, causando congelamenti e diffusione di tifo e colera, che portarono molti reparti a rifiutarsi di combattere. Nonostante queste difficoltà e un cambio di comando e strategia bolscevica, a fine dicembre 1918 i bianchi avanzarono leggermente a nord-est, occupando un tratto della ferrovia da Caricyn verso nord, isolando la città dal comando sovietico.
Il 1° gennaio 1919 iniziò la terza battaglia per Caricyn. Sfruttando la situazione favorevole, i bianchi occuparono Dubovka sul Volga, da cui le loro artiglierie colpirono la periferia nord di Caricyn. Alcuni distaccamenti usarono il Volga ghiacciato per scendere verso Caricyn e completare l’accerchiamento, poiché da sud i cosacchi avevano già occupato Bol’šie Čapurniki. L’euforia del momento e la stanchezza li spinsero all’assalto di Caricyn senza considerare la frammentazione delle loro unità di cavalleria e la mancanza di difese notturne nei villaggi. Vista l’importanza della cavalleria, di cui l’Armata rossa era sprovvista, a Semën Michajlovič Budënnyj, collaboratore di Trotski, fu affidato il compito di organizzare un corpo di cavalleria specializzato, reclutando volontari dai territori cosacchi. In un mese fu creata la 1ª Divisione di Cavalleria.
Il primo nucleo della cavalleria sovietica, con autoblindo e mitragliatrici, organizzò una controffensiva per rompere le linee a nord-est di Caricyn in una notte di bufera. Con minime perdite, Budënnyj fece 2.000 prigionieri, catturò 30 cannoni, centinaia di cavalli e un treno blindato con 6 treni a vapore. Nonostante questo successo sovietico a nord e le rigide temperature, i cosacchi avanzarono su Caricyn nei settori centrale e meridionale. Nella settimana successiva, un timido tentativo bianco di sfondare le difese rosse con un treno blindato subì forti perdite e li costrinse a ritornare alle posizioni di partenza.
Il 26 gennaio, lo Stato maggiore cosacco di Denisov considerò la terza offensiva su Caricyn destinata a un pesante fallimento. Le sue formazioni nel settore nord-orientale si sfaldarono quasi senza combattere, disperdendosi in gruppi che si preparavano alla guerriglia. Nelle retrovie cosacche si scatenò la cavalleria rossa, sostenuta dalla Divisione di Ferro di Žoloba, la cui organizzazione divenne un modello. La sfiducia nel settore cosacco era rafforzata da un rapporto di forze sfavorevole: 130.000 rossi contro 38.000 cosacchi bianchi. A fine gennaio, i bolscevichi ottennero successi tali da far pensare a una rapida chiusura della partita con Krasnov e l’Armata del Don, i cui cosacchi erano ora costretti a difendere i loro villaggi d’origine, complicando ulteriormente la situazione.
Krasnov richiese urgentemente a Denikin rinforzi, armamenti e vettovaglie per le sue truppe a Caricyn, ma questi furono inviati con notevole ritardo. Denikin non agiva per risentimento personale, ma per un dilemma strategico tra inviare le truppe migliori a Caricyn per congiungersi con Aleksandr Vasil’evič Kolčak o rinforzare il suo fianco sinistro per difendere il ricco bacino del Donec. Inizialmente autorizzò il trasferimento, ma poi decise di rafforzare le sue unità sul Donbass, temendo che un trasferimento massiccio verso Caricyn avrebbe indebolito il suo fianco sinistro, favorendo una conquista sovietica del Donec ed esponendo altre unità. Questa decisione fu criticata dal generale Pëtr Nikolaevič Vrangel’, che, data la superiorità numerica rossa, riteneva si dovessero concentrare gli attacchi sui punti bolscevichi più deboli, inclusa Caricyn.
Il 25 gennaio, il nuovo dislocamento delle unità nel bacino del Donec rafforzò il fianco sinistro del fronte sud con unità d’assalto dell’Armata dei Volontari, costituendo il XX Corpo d’Armata affidato a Maj-Majevskii, che perfezionò l’uso degli assi ferroviari. Ciò permise di arrestare l’avanzata di Koženicov verso Millerovo-Kamensk-Šachtinskij. Nei primi giorni di febbraio, vi furono combattimenti alterni per il controllo di Bachmut. Le formazioni anarchiche di Machno premevano sul fianco sinistro diretto da Maj-Majevskii, rallentando la sua controffensiva per non compromettere la tenuta del Donec.
Dall’altra parte del fronte, le truppe di Krasnov continuavano a perdere posizioni sul Don, sia militari che politiche. I contatti con gli alleati per armamenti si arenarono a causa dei suoi precedenti legami con i tedeschi, nonostante la sottomissione a Denikin. Il rifiuto di una clausola francese che richiedeva a Krasnov il pagamento dei danni economici subiti dai francesi e la sottomissione completa al comando francese fu un colpo durissimo, annullando la speranza di aiuti e compromettendo il sostegno dell’esercito e della popolazione. L’Armata del Don teneva le linee in condizioni impossibili, priva di tutto. La propaganda bolscevica ebbe facile presa sulla popolazione, che iniziava a ribellarsi, e tra i cosacchi si moltiplicavano ammutinamenti e insubordinazioni (7.000 si arresero, 20 reggimenti disertarono).
L’Armata del Don passò da 70.000 uomini a fine dicembre a 38.000 a fine gennaio 1919, riducendosi a 15.000 a febbraio, nonostante il richiamo di cosacchi tra i 19 e 52 anni. Dopo otto mesi di duri combattimenti, sconfitte e la disillusione per gli aiuti alleati, anche il generale Denisov, comandante dell’esercito del Don, cedette. In un rapporto al Krug, insofferente verso Krasnov, elencò, oltre alle cause tecnico-militari, la efficace propaganda sovietica che portò anche al tradimento delle truppe del Nord. Di conseguenza, Denisov e Poljakov si dimisero, e il 14 febbraio 1919 si dimise anche Krasnov, addossandosi la responsabilità e riconoscendo che il mancato sostegno alleato era conseguenza della sua persona e della precedente alleanza tedesca. Il 16 febbraio 1919, il Krug nominò l’Atamano Mitrofan Bogaevskij, in ottimi rapporti con Denikin (il che avrebbe favorito la collaborazione con l’Armata dei Volontari e migliorato le relazioni con gli alleati). Al comando dell’esercito fu posto Vladimir Ilyich Sidorin. La nuova disposizione delle truppe voluta da Denikin spostava il baricentro del fronte sud sul Donbass.
(continua al prossimo numero)
4.1. - Breve biografia
Thomas Robert Malthus nacque nel Surrey a sud di Londra, figlio di un illuminista sostenitore delle idee liberali che educò il figlio secondo gli ideali di Rousseau e Hume; Thomas venne iscritto alla Warrington Academy, una scuola dissenziente nei confronti della Chiesa d’Inghilterra gestita dall’unitarianista Gilbert Wakefield; successivamente si iscriverà al Jesus College di Cambridge dove otterrà il nono grado nel corso di matematica nel 1788, anno della sua nomina a ministro della Chiesa d’Inghilterra. Attorno al 1793 divenne curato della cappella di Okewook ad Albury, a pochi chilometri dalla casa paterna; nello stesso anno venne nominato assegnista di ricerca a Cambridge e dovette di conseguenza dividersi fra gli impegni ecclesiastici e accademici.
Gli scontri ideologici col padre lo spinsero a pubblicare lo scritto “The Crisis”, di critica all’amministrazione Pitt, che tuttavia non venne pubblicato su consiglio del padre. Lo scritto di William Godwin sulla politica convinse Malthus a replicare alle idee liberali cosicché nel 1798 venne dato alle stampe il “Essay on the Principle of Population” contenente la teoria sulla progressione geometrica della popolazione in contrapposizione alla progressione aritmetica dei mezzi di sussistenza. La controreplica di Godwin costrinse Malthus alla ricerca delle prove empiriche a sostegno della propria tesi; intraprese perciò un lungo viaggio in Germania, Scandinavia e Russia e, dopo la firma del trattato di pace di Amiens del 1802 tra Francia e Inghilterra, poté anche visitare la stessa Francia e la Svizzera; così nel 1803 apparve, molto rivista e ampliata, la seconda edizione del Saggio.
Nel 1805 fu nominato professore di storia moderna ed economia politica all’East India College di Haileybury, diventando probabilmente il primo economista accademico d’Inghilterra. Attorno al 1800 si era interessato anche di problemi monetari, tanto che pubblicò un lavoro che esponeva una teoria endogena della moneta; ma sarà nel decennio successivo che s’imbatterà negli scritti di David Ricardo sulla controversia bullionista ed intraprenderà con lo stesso una fitta corrispondenza.
Nel 1814 entrò nel dibattito sulle Corn Laws e dopo un primo scritto, “Observations on the Effects of the Corn Laws”, che delineava vantaggi e svantaggi delle leggi protezionistiche, sostenne provvisoriamente i libero scambisti per poi mutare fronte l’anno successivo pubblicando il pamphlet “Grounds of an Opinion” in cui si incoraggiava la produzione interna di cereali per garantire l’autosufficienza alimentare. Lo stesso anno diede alle stampe lo scritto sulla teoria della rendita, “An Inquiry Into the Nature and Progress of Rent”, in cui sosteneva che la rendita fosse semplicemente una detrazione dall’eccedenza che si genera in agricoltura; di lì a poco apparirà anche il saggio di Ricardo in parziale risposta a Malthus, circostanza che spingerà i due a un dibattito più generale sulla teoria del valore; controversia che sfocerà nella pubblicazione nel 1820 del trattato di Malthus “Principles of Political Economy”, nel quale sono esposti fondamenti teorici che si differenziano dalla scuola classica in tema di valore, abbracciando la seconda definizione, errata, di Smith.
4.2. - Teoria generale
Nell’ambito dell’economia classica Malthus occupa un posto peculiare per presupposti filosofici, metodo d’indagine e problematiche affrontate identici a quelli di Ricardo e J.S. Mill, assumendo tuttavia una posizione che si distingue dal solco ricardiano. Malthus fornì all’edificio di Ricardo essenzialmente due strumenti essenziali: la teoria della popolazione e il principio dei rendimenti decrescenti delle terre successivamente coltivate.
Malthus crede di introdurre ipotesi innovative e soluzioni alternative nel dibattito economico in base al principio di base per cui l’economia è sì una scienza, ma più vicina alle scienze morali e politiche che a quelle naturali, col risultato che lo schema teorico assume connotazioni eclettiche. La sua posizione metodologica è chiarita nelle pagine dell’Introduzione ai Principles dove si afferma: «La causa principale degli errori e delle discrepanze che attualmente regnano fra gli economisti a me sembra dipendere dalla troppa fretta con cui si corre a semplificare e a generalizzare (...) In economia politica il desiderio di semplificare ha prodotto una specie di avversione a riconoscere l’influenza di più cause nella generazione di un medesimo effetto (...) La medesima tendenza a semplificare e generalizzare produce un’avversione ancora più grande contro le modificazioni ed eccezioni a cui un principio possa andare soggetto che contro il bisogno di ammettere l’influenza di molte cause in un solo fenomeno».
Già il fisiocratico Richard Cantillon aveva tentato di enunciare in forma di principio generale il contrasto fra la tendenza biologica della specie al rapido accrescimento e la disponibilità dei mezzi di produzione; Malthus tentò però di proseguire oltre nell’analisi per formalizzare quel contrasto in base all’evidenza empirica. Osservando il comportamento demografico nelle colonie nord-americane, dove, per l’abbondanza e la gratuità di terre disponibili, si poteva supporre che l’accrescimento demografico non incontrasse ostacoli economici, Malthus formulò la nota legge della progressione geometrica dell’incremento naturale della popolazione, mentre dall’osservazione dell’andamento della produzione agricola nel lungo periodo e nei paesi dove la terra è limitata, affermò che i mezzi di sussistenza, nel caso più favorevole, potrebbero crescere solo in progressione aritmetica. È la stessa natura che tenderebbe a evitare che tale divario diventi incolmabile; da una parte con freni conseguenziali che aumentano la mortalità, dall’altra preventivi che diminuiscono la natalità. Da questa teoria della popolazione derivano implicazioni, tra cui la legge del salario tendente al livello di sussistenza; mentre le implicazioni di ordine politico portano a sostenere l’abolizione delle “leggi sui poveri” e in generale le forme di assistenza pubblica.
Mentre lo scritto sulla popolazione ha uno schema teoretico rigido, l’opera principale di Malthus in materia economica, i Principles, è un tentativo di opporsi allo schema ricardiano, considerato eccessivamente rigido. La teoria del valore non viene perciò rifiutata ma è considerata solamente come un caso limite, ovvero il principio ricardiano sarebbe valido solo nello scambio fra due merci prodotte con capitali di uguale composizione organica. Non essendo pertanto generalizzabile, il principio generale andrebbe ricercato nella legge della domanda e offerta, la prima essendo intesa come volontà unita ai mezzi per poter acquistare una merce e la seconda come quantità di merci da vendere combinata col desiderio di venderle.
Nello stesso scritto si tratta anche di teoria della rendita insistendo sul fatto che all’origine della rendita differenziale non c’è tanto la scarsità quanto la fertilità del terreno che permette un raccolto superiore alle spese di mantenimento del coltivatore. La diversa impostazione del problema da parte di Malthus gli consente di trarre dallo stesso principio implicazioni diverse da quelle ricardiane; le alte rendite allora si identificherebbero con un’abbondanza di “doni gratuiti” della terra; perciò, l’interesse dei proprietari terrieri coinciderebbe con quello dell’intera società. Ricardo viene accusato d’aver considerato l’incremento della rendita sotto il solo aspetto dell’aumento di prezzo delle derrate agricole dovuto ad una crescente difficoltà nella loro produzione; questo tuttavia sarebbe solo un caso limite; le rendite invece possono accrescersi anche per altre cause, tra cui un aumento di accumulazione tale che riduca l’incentivo ad investire nel settore manifatturiero e renda conveniente l’impiego dei capitali esuberanti anche nei terreni meno fertili; un aumento di popolazione che, in presenza di elevati salari, li riduca in modo da rendere conveniente la coltivazione di terre meno fertili; miglioramenti in agricoltura; incremento della domanda estera di prodotti agricoli.
La critica malthusiana del sistema ricardiano porta l’autore a contestare anche il concetto di “salario naturale”, che generalizzerebbe solo il caso limite, che si verificherebbe in un’ipotetica situazione finale di stazionarietà; i fattori che determinano il salario sarebbero in primo luogo la domanda di lavoro dipendente dalla quantità e dal valore del capitale variabile; in secondo luogo l’offerta di lavoro dipendente dalla popolazione; in terzo luogo le abitudini di consumo della classe lavoratrice; in quarto luogo la decisione dei capitalisti in merito alla ripartizione del loro reddito fra accumulazione e consumo.
Nel libro II dei Principles si affronta la teoria dello sviluppo: qui non si nega la validità del modello ricardiano, ma ciò che interessa l’autore non è tanto l’analisi del processo che porta alla stazionarietà, quanto le modificazioni ed eccezioni che il processo subisce durante il suo svolgimento. Smith e Ricardo accettarono il principio secondo il quale la produzione crea sempre la domanda sufficiente ad assorbirla, cosicché il sistema può subire una crisi da sovrapproduzione relativa se si eccede nella produzione di una merce a scapito di un’altra, ma non potrà esserci una crisi da sovrapproduzione generale.
Malthus nega invece la cosiddetta “legge degli sbocchi”: «Un terzo errore, il più grave di quelli che gli autori citati han commesso, consiste nel supporre che l’accumulazione assicuri la domanda o che il consumo degli operai impiegati dalle persone il cui scopo è di risparmiare, generi una domanda reale di derrate, sufficiente ad incoraggiare in modo continuo l’accrescimento della produzione». Vuole cioè dimostrare che, oltre una certa misura, l’accumulazione provoca necessariamente un aumento di produzione senza un corrispondente aumento di domanda delle merci prodotte, dando quindi luogo a una saturazione generale del mercato che diminuisce il saggio di profitto e arresta lo sviluppo ancor prima di raggiungere lo stato stazionario. Secondo Malthus l’offerta generata dal processo di accumulazione non provoca automaticamente una domanda sufficiente per assorbirla; pertanto è necessario elaborare strumenti di politica economica atti a stimolare la domanda effettiva. In primo luogo sarebbe necessaria una riforma della struttura della proprietà fondiaria che favorisca la formazione di una numerosa classe media perché, senza diminuzione della capacità di produzione, si abbia un aumento delle abitudini di consumo. In secondo luogo occorrerebbe stimolare e facilitare gli scambi interni e internazionali. In terzo luogo lo strumento fondamentale di sostegno alla domanda effettiva rimane l’esistenza del consumo improduttivo. «È assolutamente necessario che un paese fornito di grandi mezzi di produzione possieda un corpo di consumatori i quali direttamente non si trovino impegnati nella produzione». Il consumo improduttivo avrebbe una funzione equilibratrice impedendo al capitalismo di ristagnare ancora prima di arrivare allo stato stazionario.
4.3. - Confusione delle categorie merce e capitale
Nelle “Teorie sul Plusvalore” Marx analizza essenzialmente tre scritti di Malthus: “The Measure of Value Stated and Illustrated”; “Definitions in Political Economy”; “Principles of Political Economy”. Sia i Principles sia gli altri due devono in gran parte la loro origine all’invidia per il successo dello scritto ricardiano in materia e al tentativo di riconquistare quel primato che egli era riuscito ad accaparrarsi fraudolentemente. A ciò si aggiungeva il fatto che, nello scritto di Ricardo, lo svolgimento, sia pur ancora astratto, della determinazione del valore era diretto contro gli interessi dei proprietari terrieri e dei loro lacchè, che Malthus rappresentava ancor più immediatamente che gli interessi della borghesia industriale. Il merito di questi tre scritti risiede nel fatto che, mentre Ricardo non spiega il modo in cui lo scambio ineguale fra capitale e lavoro vivo scaturisce dallo scambio delle merci secondo la legge del valore (del tempo di lavoro in esse contenuto), e non chiarisce quindi l’origine del plusvalore (in quanto sostiene che il capitale si scambia direttamente con il lavoro e non con la capacità lavorativa), Malthus pone l’accento sullo scambio ineguale fra capitale e lavoro salariato. «Occorre distinguere lo scambio delle merci dalla distribuzione (salari, rendita, profitto) (...) Le leggi della distribuzione non dipendono tutte da quelle relative allo scambio» (Definitions). Il che non significa altro che il rapporto fra salario e profitto, lo scambio fra capitale e lavoro salariato non coincide immediatamente con la legge dello scambio delle merci.
Se si considera la valorizzazione del denaro o della merce in quanto capitale è chiaro che il plusvalore non è altro che il lavoro non pagato comandato dal capitale, dalla merce o dal denaro, oltre la quantità di lavoro che vi è contenuta. Tale eccedenza costituisce il plusvalore; la sua grandezza determina la proporzione della valorizzazione. E questa quantità eccedente di lavoro vivo, con cui si scambia, costituisce la sorgente del profitto. Il profitto (anzi il plusvalore) non scaturisce dall’equivalente di lavoro oggettivato che è scambiato con un’uguale quantità di lavoro vivo, bensì dalla porzione di lavoro vivo di cui ci si appropria in questo scambio senza pagare per essa un equivalente. Se si prescinde dunque dalla mediazione di questo processo, se si guarda unicamente al contenuto effettivo e al risultato del processo, allora valorizzazione, profitto, trasformazione di denaro o merce in capitale non derivano dal fatto che le merci si scambiano secondo la legge del valore, vale a dire in rapporto al tempo di lavoro che esse costano, ma, al contrario, dal fatto che le merci o il denaro si scambiano contro più lavoro vivo di quello che è contenuto, speso in esse.
L’unico merito di Malthus è di aver evidenziato questo punto, che in Ricardo emerge con tanta minor chiarezza in quanto egli presuppone sempre il prodotto finito che viene ripartito fra il capitalista e l’operaio, senza considerare lo scambio, il processo di mediazione che conduce a tale ripartizione. Questo merito è annullato dal fatto che egli confonde la valorizzazione del denaro o della merce in quanto capitale, e quindi il suo valore nella specifica funzione di capitale, con il valore della merce come tale; perciò nella sua esposizione ricade nelle vacue concezioni del sistema monetario. «Su uno stesso paese e in una stessa epoca il valore di scambio delle merci che si risolvono unicamente in lavoro e profitto è misurato esattamente dalla quantità di lavoro che risulta dal lavoro accumulato e dal lavoro immediato effettivamente impiegato, più il variabile ammontare del profitto su tutte le anticipazioni misurate in lavoro» (“The Measure of Value”).
Malthus vuole assumere il profitto già nella definizione del valore, affinché consegua immediatamente da tale definizione, come invece non accade in Ricardo. Da ciò si vede che egli avverte dove si trovava la difficoltà. Ma è insulso che egli identifichi il valore della merce con la sua valorizzazione in quanto capitale. Se merce o denaro si scambiano come capitale contro lavoro vivo, allora si scambiano sempre contro una maggiore quantità di lavoro di quella che essi stessi contengono; e se si confronta da un lato la merce prima di questo scambio e dall’altro il prodotto che risulta dal suo scambio con il lavoro vivo, si trova che la merce si è scambiata contro il suo proprio valore più un’eccedenza sul suo valore, il plusvalore. Insulso però concludere che il valore della merce sia uguale al suo valore più un’eccedenza su questo valore. Se la merce si scambiasse come merce contro altre merci e non come capitale contro lavoro vivo, allora essa, in quanto scambio di equivalenti, si scambierebbe contro la medesima quantità di lavoro oggettivato che è contenuta in essa.
4.4. - La concezione volgare del plusvalore
Malthus, che trasforma la valorizzazione della merce in quanto capitale nel suo valore, è così coerente da trasformare tutti i compratori in operai salariati; tutti i compratori scambiano con il capitalista lavoro immediato invece che merce, e gli restituiscono più lavoro di quello contenuto nella merce, mentre il profitto scaturisce dal fatto che il capitalista vende tutto il lavoro contenuto nella merce, pur avendone pagato soltanto una parte. In Ricardo c’è la difficoltà che la legge dello scambio delle merci non spiega lo scambio fra capitale e lavoro salariato, anzi sembra contraddirlo; Malthus risolve la difficoltà trasformando ogni scambio di merci in scambio fra capitale e lavoro salariato.
Ciò che Malthus non comprende è la differenza fra la somma totale di lavoro contenuta in una merce e la somma di lavoro pagato che essa contiene. È proprio questa differenza che costituisce la fonte del profitto. Malthus è poi costretto a far derivare il profitto dal fatto che il venditore non soltanto vende la merce al di sopra di ciò che gli costa, ma al di sopra di ciò che essa costa, e ritorna quindi alla concezione volgare del profitto mediante espropriazione, a far derivare il plusvalore dal fatto che il venditore vende la merce al di sopra del suo valore, cioè a un tempo di lavoro maggiore di quello in essa contenuto. Ciò che egli guadagnerebbe così come venditore di una merce, lo perderebbe come compratore di un’altra, e non si vede quale profitto potrebbe derivare da un tale rialzo nominale dei prezzi.
Malthus fa il tentativo confuso, ma fondato su una intuizione esatta e sulla consapevolezza di una difficoltà non ancora domata, di opporre a Ricardo una nuova teoria; ma subito si compie il passaggio da questo tentativo alla concezione volgare. Se il compratore è un capitalista, il suo denaro deriva da merce che ha venduto: ne risulterebbe semplicemente che entrambi vendono le loro merci a un prezzo troppo alto, e così si truffano reciprocamente, e si truffano nella stessa misura se entrambi realizzano soltanto il saggio generale del profitto. Ma da dove vengono allora i compratori che pagano al capitalista la quantità di lavoro contenuto nella merce più il suo profitto? L’unica eccezione è costituita dalla classe operaia.
Poiché il prezzo del prodotto viene elevato al di sopra del suo costo, gli operai possono ricomprare solo una parte del prodotto, e così l’altra parte costituisce il profitto per il capitalista. Ma, poiché il profitto deriva appunto dal fatto che gli operai possono ricomprare soltanto una parte del prodotto, la classe dei capitalisti non può mai realizzare il suo profitto per mezzo della domanda operaia, non può cioè realizzarlo scambiando l’intero prodotto contro il salario. È necessaria dunque un’altra domanda e sono necessari altri compratori oltre gli operai stessi; altrimenti non vi sarebbe profitto.
Ma da dove vengono questi altri compratori? Se sono capitalisti, venditori essi stessi, si ha la truffa reciproca, poiché essi aumentano reciprocamente il prezzo nominale delle loro merci, e ciascuno guadagna come venditore ciò che perde come compratore. Affinché il capitalista possa realizzare il suo profitto, vendere al loro valore le merci, sono quindi necessari compratori che non siano venditori. Di qui la necessità di proprietari terrieri, di chi fruisce di pensione o sinecura, dei preti, ecc.
Malthus non spiega come questi compratori vengano in possesso dei mezzi d’acquisto, come essi debbano prima sottrarre ai capitalisti, senza equivalente, una parte del loro prodotto, per ricomprare poi, con questa parte sottratta, meno l’equivalente del plusvalore. Ne deriva la sua perorazione in favore del massimo accrescimento possibile delle classi improduttive, affinché i venditori trovino un mercato; e ne risulta che il moralizzatore della popolazione predichi come condizione della produzione un sovraconsumo costante e la massima appropriazione possibile del prodotto annuo da parte di oziosi. A questa perorazione se ne aggiunge una secondo la quale il capitale rappresenterebbe l’inclinazione alla ricchezza astratta, l’impulso della valorizzazione, che potrebbe però realizzarsi solo mediante una classe di compratori che rappresentino la tendenza a spendere: le classi improduttive, che sono compratrici senza essere venditrici.
4.5. - L’interpretazione unilaterale della teoria del valore di Smith
La prima preoccupazione di Malthus è quella di cancellare la distinzione ricardiana fra “valore del lavoro” e “quantità di lavoro”, e di ridurre la giustapposizione di Smith al suo aspetto sbagliato. «Una data quantità di lavoro deve avere lo stesso valore del salario che essa comanda o contro cui è scambiata» (“The Measure of Value”). In sé la frase esprime una tautologia: i salari, o ciò contro cui si scambia una quantità di lavoro, costituisce il valore di questa quantità di lavoro. Il valore di una determinata quantità di lavoro è uguale al salario o alla massa di denaro o di merci contro cui questo lavoro si scambia. Ciò vuol dire semplicemente che il valore di scambio di una determinata quantità di lavoro è uguale al suo valore di scambio, chiamato anche salario. Ma non consegue affatto che una determinata quantità di lavoro sia uguale alla quantità di lavoro contenuta nei salari, o nel denaro o nelle merci in cui i salari si rappresentano. Non ne consegue che il valore dei salari sia uguale al valore del prodotto. Ne consegue unicamente che il valore del lavoro (misurato mediante il valore della capacità lavorativa e non del lavoro da essa compiuto), il valore di una data quantità di lavoro contiene meno lavoro di quello effettivamente prestato.
Malthus trae la conclusione inversa. Dal fatto che il valore di una data quantità di lavoro è uguale al suo valore consegue, secondo lui, che il valore in cui questa quantità di lavoro si rappresenta sia uguale al valore dei salari. Ne consegue che il lavoro immediato (detratti cioè i mezzi di produzione) assorbito, contenuto in una merce, non crea un valore più grande di quello che l’ha pagato; che riproduce solo il valore dei salari. Ne consegue che, se il valore delle merci è determinato dal lavoro in esse contenuto, il profitto non può essere spiegato e bisogna quindi derivarlo da una altra fonte. Il lavoro in essa assorbito consta, in primo luogo, del lavoro contenuto nel macchinario, ecc., che è stato consumato e che quindi ricompare nel valore del prodotto; in secondo luogo del lavoro contenuto nella materia prima consumata. Questi due elementi non accrescono il lavoro che essi contenevano prima della produzione della nuova merce per il fatto di diventare elementi di produzione di una nuova merce. Resta, in terzo luogo, il lavoro contenuto nei salari, che è stato scambiato con lavoro vivo. Ma quest’ultimo, secondo Malthus, non è maggiore del lavoro oggettivato con cui si scambia. Quindi una merce non contiene alcuna parte di lavoro non pagato, ma solo lavoro che sostituisce un equivalente. Ne consegue che, se il valore della merce fosse determinato dal lavoro in essa contenuto, essa non produrrebbe alcun profitto. Se essa crea un profitto, questo è un’eccedenza del suo prezzo sul lavoro che essa contiene. Dunque il suo valore (che include il profitto) deve comprendere un’eccedenza realizzata nella vendita della merce.
4.6. - L’interpretazione della tesi di Smith dell’invariabilità del valore
Affinché il lavoro in quanto merce, non la quantità di lavoro richiesta per la produzione, possa servire come misura dei valori, Malthus afferma che «il valore del lavoro è costante». Ciò non è originale, ma la perifrasi e lo sviluppo ulteriore della proposizione di Smith: «È necessario che in ogni tempo e in ogni luogo uguali quantità di lavoro abbiano, per l’operaio, lo stesso valore. Nel suo stato normale di salute, di forza e di attività e con il grado medio di abilità, egli deve sempre sacrificare la stessa parte del suo riposo, della sua libertà e felicità. Il prezzo che egli paga è sempre lo stesso, qualunque sia la quantità di merci che egli riceve per il suo lavoro. Con questo prezzo, egli può comprare (...) ora una quantità più piccola, ora una più grande di queste merci, ma è il valore delle merci che cambia e non quello del lavoro che le acquista (...) Soltanto il lavoro, il cui valore non cambia mai, è quindi l’unica misura reale e definitiva, che permette di misurare e di confrontare il valore di tutte le merci in ogni tempo e in ogni luogo» (“An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”).
Ovvero la scoperta di cui Malthus è così fiero, cioè che il valore è uguale alla quantità di lavoro contenuto nella merce, più una quantità di lavoro che rappresenta il profitto, appare semplicemente come una combinazione delle due frasi di Smith: «Il valore reale di tutte le varie componenti del prezzo è misurato dalla quantità di lavoro che ognuna di esse può comprare o comandare. Il lavoro misura il valore non soltanto di quella parte del prezzo che si risolve in lavoro, ma anche di quella che si risolve in rendita e di quella che si risolve in profitto».
4.7. - Concezione del profitto come supplemento sul prezzo
Secondo Malthus il valore di una merce è uguale alla somma di denaro che il compratore deve pagare, e questa somma di denaro è valutata dalla massa di lavoro comune che con essa si può comprare. Ma da che cosa sia determinata questa somma di denaro, non viene detto. È la rappresentazione volgare che se ne ha nella vita comune in cui prezzo di costo e valore sono identici; una confusione che in Smith e più ancora in Ricardo contraddice il loro reale svolgimento, ma che ora Malthus innalza a legge. È quindi l’immagine del valore propria del filisteo impigliato nella concorrenza, che ne conosce solo la parvenza. Da che cosa è determinato il prezzo di costo? Dalla grandezza delle anticipazioni più il profitto. E da che cosa è determinato il profitto? Se si tratta unicamente di un aumento nominale del prezzo monetario, niente di più facile che aumentare il prezzo delle merci. E da che cosa è determinato il valore delle anticipazioni? Dal valore del lavoro in esse contenuto, dice Malthus. E questo, da che cosa è determinato? Dal valore delle merci in cui si spende il salario. E il valore di queste merci? Dal valore del lavoro più il profitto. E così il circolo va avanti.
Posto che all’operaio venga effettivamente pagato il valore del suo lavoro, cioè che le merci che costituiscono il suo salario siano uguali al valore delle merci in cui si realizza il suo lavoro, il profitto può consistere unicamente in un supplemento all’effettivo valore della merce che il venditore aggiunge nella vendita. È ciò che fanno tutti i venditori. Dunque, in quanto i capitalisti scambiano fra di loro, nessuno realizza un vantaggio con questo supplemento, e tanto meno si costituisce un fondo in eccedenza, da cui essi possano attingere il loro reddito. Soltanto quei capitalisti le cui merci entrano nel consumo della classe operaia realizzeranno un profitto reale, perché rivendono la merce agli operai a un prezzo maggiore di quello a cui l’hanno comprata da essi. Che altro vuol dire se non che, rispetto alla classe operaia, il profitto deriva dal fatto che gli operai forniscono gratuitamente ai capitalisti una parte del loro lavoro, cioè che la “quantità di lavoro” non è la stessa cosa che il “valore del lavoro”?
4.8. - Capitale costante e capitale variabile
«Il lavoro accumulato [ma si dovrebbe parlare di lavoro oggettivato] è il lavoro contenuto nelle materie prime e negli utensili che vengono usati nella produzione di altre merci» (“Definitions”). «[Se si parla] del lavoro contenuto nelle merci, il lavoro impiegato nel capitale necessario a produrle dovrebbe chiamarsi lavoro accumulato, per distinguerlo dal lavoro immediato impiegato dall’ultimo capitalista». È essenziale fare questa distinzione, ma in Malthus non conduce a niente, e anche il tentativo di ridurre il plusvalore, o almeno il suo saggio (che confonde sempre con il profitto e il saggio del profitto), al suo rapporto con il capitale variabile, con la parte del capitale investita in immediate labour, è infantile e non poteva non esserlo, data la sua concezione del valore.
«Il profitto sarà determinato dal rapporto fra il valore del prodotto complessivo [e la parte di esso] necessaria a pagare il lavoro impiegato (...) Supponiamo ora che le anticipazioni del capitalista non constino soltanto di lavoro. Il capitalista si attende lo stesso vantaggio da tutte le parti del capitale che egli anticipa» (“Principles”). Qui percepisce vagamente che il plusvalore, quindi il profitto, si trova in un determinato rapporto con il capitale variabile e vuole dimostrare che «il profitto è determinato dalla proporzione fra il valore del prodotto complessivo e il valore di quella sua parte che è necessaria per pagare il lavoro impiegato». Dapprima procede correttamente, in quanto suppone che tutto il capitale consti di capitale variabile. In questo caso, profitto e plusvalore sono effettivamente identici. Ma anche in questo caso si limita a una riflessione molto sciocca. Se il capitale investito è 100 e il profitto è del 10%, il valore del prodotto è uguale a 110 e il profitto costituisce 1/10 del capitale investito e 1/11 del valore del prodotto complessivo.
Fin qui abbiamo solo una tautologia però. Supponiamo un capitale composto non soltanto di capitale variabile, ma anche di capitale costante. «Il capitalista si attende lo stesso vantaggio da tutte le parti del capitale che egli anticipa». Ciò contraddice l’affermazione appena enunciata, che il profitto (si dovrebbe dire plusvalore) è determinato dal rapporto con il capitale investito in salario.
4.9. - Sovrapproduzione
Dalla teoria malthusiana del valore deriva la dottrina della necessità di un consumo produttivo sempre crescente. Il valore di una merce è uguale al valore delle materie prime, del macchinario, ecc., anticipati, più la quantità del lavoro immediato in essa contenuto, il che in Malthus è uguale al valore dei salari in essa contenuti più un profitto aggiunto a queste anticipazioni secondo il suo saggio generale. Questo rincaro nominale costituirebbe il profitto e sarebbe una condizione dell’offerta, cioè della riproduzione della merce. Questi elementi formerebbero il prezzo per il compratore, differente dal prezzo per il produttore, e questo sarebbe il valore reale della merce.
Come si può realizzare questo prezzo? Chi lo deve pagare? In Malthus dobbiamo operare una distinzione. Una parte dei capitalisti produce merci che entrano direttamente nel consumo dell’operaio; un’altra parte che entrano solo indirettamente in questo consumo, in quanto entrano cioè come materie prime e macchinario nel capitale necessario alla produzione dei mezzi di sussistenza, oppure merci che non entrano affatto nel consumo dell’operaio, perché entrano unicamente nel reddito di chi non lavora.
I capitalisti che producono articoli che entrano nel consumo degli operai sono non soltanto compratori di lavoro, ma anche venditori del proprio prodotto agli operai. Se la quantità di lavoro aggiunta dall’operaio vale 100 talleri, il capitalista gli paga 100 talleri. E questo secondo Malthus è l’unico valore che il lavoro comprato dal capitalista aggiunge alla materia prima, ecc. L’operaio quindi riceve il valore del suo lavoro e dà in cambio al capitalista un equivalente di questo valore. Ma sebbene il lavoro contenga nominalmente questo valore l’operaio in realtà riceve una massa di merci inferiore a quella da lui prodotta. Supponiamo, come Malthus, che il capitale consti unicamente di capitale investito in salario. Se si anticipano 100 talleri all’operaio per produrre la merce, il capitalista però vende questa merce a 110 talleri, e l’operaio, con i 100 talleri, può ricomprare solo i 10/11 del prodotto; 1/11, 10 talleri di valore in cui si rappresenta questo plusvalore, rimane al capitalista.
Supponiamo che la classe dei capitalisti A produca merci che entrano direttamente nel consumo degli operai, qui abbiamo un caso in cui, mediante un rialzo nominale, mediante l’aggiunta normale del profitto al prezzo delle anticipazioni, si costituisce un plusvalore per il capitalista. Con questo giro, restituisce all’operaio soltanto una parte del prodotto da lui creato, appropriandosi dell’altra. Questo risultato non deriva dal fatto che il capitalista vende all’operaio l’intero prodotto a un valore più elevato, ma dal fatto che il rincaro del prodotto mette l’operaio nell’impossibilità di ricomprare con il suo salario tutto il prodotto. La domanda dell’operaio non può mai essere sufficiente per realizzare l’eccedenza del prezzo d’acquisto sul prezzo di costo. Il capitalista A possiede dunque una determinata quantità di merce di un determinato valore, di cui egli non ha bisogno per reintegrare il capitale e che quindi può in parte spendere come reddito, in parte impiegare per l’accumulazione. L’entità di questo fondo dipende dal supplemento di valore che egli ha aggiunto al prezzo di costo e che determina la proporzione secondo la quale il capitalista e l’operaio si spartiscono l’intero prodotto.
Marx a questo punto indaga le conseguenze della errata ipotesi di Malthus, e la dimostra falsa per assurdo, distinguendo altre classi di capitalisti: la B, che produce la materia prima, il macchinario, ecc., in breve il capitale costante, per i capitalisti della classe A; la C, che rappresenta quei capitalisti che producono il capitale costante necessario alla produzione degli articoli di lusso; la classe D quelli che producono direttamente gli articoli di lusso.
E ne conclude che è impossibile capire come possa risultare un profitto dal fatto che coloro che scambiano si vendono reciprocamente le loro merci a un prezzo uniformemente troppo alto, ingannandosi a vicenda nella medesima proporzione.
A questo inconveniente si rimedierebbe se, oltre allo scambio fra una classe di capitalisti e i suoi operai e allo scambio tra le differenti classi di capitalisti, si aggiungesse una terza classe di compratori, che pagasse le merci al loro valore nominale, senza rivendere merci; una classe cioè che percorresse il ciclo D-M, non quello D-M-D, che compri non per ricostituire il suo capitale con un profitto ma per consumare le merci. In questo caso, i capitalisti non realizzerebbero un profitto scambiandosi le merci fra di loro, ma: 1) scambiando con gli operai, cioè rivendendo a questi una parte del prodotto complessivo per la medesima somma di denaro con la quale hanno comprato dagli operai la loro forza lavoro; 2) con la parte, sia dei mezzi di sussistenza sia delle merci di lusso, che è venduta alla terza specie di compratori. Il profitto sarebbe realizzato in duplice maniera: rivendendo agli operai il meno possibile del prodotto complessivo e rivendendo il più possibile alla terza classe, che paga con denaro contante senza rivendere.
Ma compratori che non siano nello stesso tempo venditori devono essere consumatori che non siano nello stesso tempo produttori, consumatori improduttivi, ed è questa classe che in Malthus scioglie la contraddizione. Ma questi consumatori improduttivi devono essere consumatori solventi, cioè le somme di valore che essi posseggono e spendono annualmente devono essere sufficienti non solo a pagare il valore di produzione delle merci che essi comprano e consumano, ma anche il supplemento nominale di profitto, il plusvalore, la differenza fra il valore di vendita e il valore di produzione. Questa classe rappresenterà nella società il consumo per il consumo, come la classe dei capitalisti rappresenta la produzione per la produzione. Nella classe dei capitalisti, l’impulso all’accumulazione è mantenuto desto dal fatto che le loro entrate sono costantemente maggiori delle loro uscite, il profitto è il pungolo dell’accumulazione. Malgrado questo loro zelo di accumulare, essi non sono indotti alla sovrapproduzione o almeno lo sono molto difficilmente, perché i consumatori improduttivi non solo costituiscono un enorme canale di scarico per i prodotti gettati sul mercato, ma da parte loro non gettano alcun prodotto sul mercato; quindi, per quanto numerosi siano, non fanno concorrenza ai capitalisti, ma rappresentano tutti una domanda senza offerta, e quindi compensano la preponderanza dell’offerta rispetto alla domanda da parte dei capitalisti.
Ma da dove vengono i mezzi annui di pagamento di questa classe? Vi sono i proprietari fondiari che attirano a sé, sotto il titolo di rendita, una gran parte del valore del prodotto annuo, e spendono quindi questo denaro così sottratto ai capitalisti nel consumo delle merci prodotte dai capitalisti, nell’acquisto delle quali vengono truffati. Questi proprietari fondiari non devono produrre. In quanto spendono denaro nell’acquisto di lavoro, è essenziale che non tengano operai produttivi ma semplici commensali i quali tengono alto il prezzo dei mezzi di sussistenza, in quanto li comprano senza contribuire ad accrescere l’offerta di quelle o di altre merci. Ma queste persone che vivono di rendita fondiaria non bastano a creare domanda adeguata. Bisogna ricorrere a mezzi artificiali. Questi consistono in forti imposte, in una massa di sinecuristi ecclesiastici e statali, in grandi eserciti, pensionati, decime per i preti, in un considerevole debito pubblico e in guerre dispendiose.
La terza classe citata da Malthus come “rimedio” riceve dunque, senza pagarla una parte considerevole del valore del prodotto annuo e arricchisce i produttori: i produttori devono prima cedere gratuitamente a questa classe il denaro per comprare le loro merci, per riprendere poi questo denaro vendendo ad essa le merci al di sopra del loro valore o recuperando da essa più valore in denaro di quello che le hanno fornito in merci.
4.10. - L’essenza sociale della polemica contro Ricardo
Le conclusioni di Malthus sono tratte correttamente dalla sua teoria del valore; ma questa teoria si adattava al suo scopo, cioè l’apologetica della situazione inglese, caratterizzata da proprietari fondiari, esattori d’imposte, speculatori di borsa, sbirri, preti e servitori domestici, che furono combattuti dai ricardiani come altrettanti inconvenienti inutili della produzione borghese. Ricardo rappresentava la produzione borghese in quanto tale, in quanto essa significava il più sfrenato dispiegamento delle forze produttive sociali, sana preoccupazione per la sorte di chi si fa carico della produzione, siano essi capitalisti o operai. Anche Malthus vuole lo sviluppo più libero possibile della produzione capitalistica, in quanto sia prodotto unicamente dalla miseria di coloro che ne sono i principali artefici, le classi lavoratrici, ma esso deve in pari tempo adattarsi ai “bisogni di consumo” dell’aristocrazia e delle sue succursali nello Stato e nella Chiesa. Malthus vuole la produzione borghese nella misura in cui non è rivoluzionaria, in cui non è un momento dello sviluppo storico, ma crea unicamente una più ampia e comoda base materiale per la “vecchia” società.
Da un lato la classe operaia, sempre sovrabbondante per il principio della popolazione rispetto ai mezzi di sussistenza, ovvero sovrappopolazione da sottoproduzione; poi la classe dei capitalisti che, in seguito a questo principio della popolazione, è sempre capace di rivendere agli operai il loro prodotto a prezzi tali che essi ne possano riottenere soltanto quanto basta a tener l’anima unita al corpo; poi un’enorme parte della società, formata da parassiti che si appropriano gratuitamente, sia sotto titolo di rendita sia sotto titoli politici, di una considerevole massa della ricchezza della classe dei capitalisti, ma che pagano le merci al di sopra del loro valore con il denaro sottratto ai medesimi capitalisti; la classe dei capitalisti sferzata a produrre dall’impulso di accumulazione, mentre gli improduttivi rappresentano, economicamente, il mero impulso a consumare. E questo è l’unico mezzo per sfuggire alla sovrapproduzione che coesiste con una popolazione eccessiva in rapporto alla produzione. La sproporzione fra la popolazione operaia e la produzione viene superata perché una parte della produzione è divorata da non-produttori.
Malthus non ha interesse a celare le contraddizioni della produzione borghese; al contrario, ha tutto l’interesse a metterle in evidenza, da un lato per dimostrare che la miseria delle classi lavoratrici è necessaria per questo modo di produzione, dall’altro per dimostrare ai capitalisti che, affinché essi abbiano una domanda adeguata, è indispensabile un clero ecclesiastico e statale ben ingrassato.
(continua al prossimo numero)
Il Secondo Congresso del Partito si tenne a Shanghai a partire dal 10 luglio del 1922. Presenti 9 delegati ufficiali, in rappresentanza dei 123 membri che il Partito contava in quel periodo. Il Congresso si aprì con i rapporti del Comitato Centrale. Chen Duxiu delineò lo stato generale del lavoro del Partito e Zhang Guotao parlò del Congresso dei Comunisti e delle Organizzazioni Rivoluzionarie dell’Estremo Oriente, della situazione del movimento operaio e del congresso nazionale dei sindacati. Poi intervenne il rappresentante della Lega Giovanile che si soffermò sul recente congresso della sua organizzazione.
Il primo giorno fu dedicato all’esposizione dei rapporti del CC e portò alla decisione di ratificare il lavoro del CC, il Manifesto sulla situazione corrente del 10 giugno e le risoluzioni del congresso dei sindacati e quelle delle Lega Giovanile.
Per problemi di sicurezza, dato l’alto livello di repressione che caratterizzava Shanghai in quel periodo, fu deciso di non tenere regolari sessioni plenarie che coinvolgessero troppi compagni contemporaneamente.
A tal fine il Congresso individuò un comitato di tre compagni al quale fu affidato il compito di redigere il nuovo Manifesto congressuale. Questo, inizialmente redatto da Chen Duxiu, fu poi rivisto dagli altri due compagni, Zhang Guotao e Ts’ai Ho-sen, con l’apporto di modifiche e integrazioni.
A distanza di una settimana il Congresso, riunito in sessione plenaria discusse e approvò il Manifesto e nominò il nuovo CC, con la conferma di Chen Duxiu e Zhang Guotao, e la sostituzione di Li Da, che lasciava su sua richiesta, con Ts-ai Ho-sen.
Oltre al Manifesto, altri documenti congressuali contengono una serie di decisioni: quelle sulla situazione mondiale, sull’imperialismo in Cina e i compiti del Partito, sul movimento nazionalista, sull’adesione alla Terza Internazionale, sull’azione parlamentare, sul movimento sindacale, sul movimento giovanile e su quello delle donne, e sulla costituzione del Partito.
Rispetto al precedente Manifesto, incentrato principalmente sulle condizioni politiche interne della Cina, questi documenti congressuali approfondivano la situazione internazionale e le vicende che avevano caratterizzato l’aggressione imperialistica alla Cina, dando maggior risalto agli aspetti della lotta contro l’imperialismo.
L’aggressione alla Cina si inseriva nella necessità del capitalismo mondiale di depredare le colonie e le semi-colonie delle loro risorse e sfruttarne la manodopera. La Cina era un paese ricco di materie prime e con una grandissima popolazione, ciò la rendeva un campo di battaglia delle potenze imperialiste. Queste utilizzavano i Signori della Guerra per controllare la politica e la vita economica cinese. Per undici anni, dalla nascita della Repubblica, la Cina era stata spazzata dalla guerra civile che aveva provocato la divisione del paese e uno stato confusionale. Senza il rovesciamento dell’oppressione militarista e dell’imperialismo la guerra civile non sarebbe mai cessata e la Cina non avrebbe mai raggiunto la sua unità nazionale.
Analizzando le forze sociali della rivoluzione nazionale veniva messo in evidenza come la borghesia cinese fosse nata come appendice del capitalismo straniero che si doveva appoggiare ai mercanti cinesi. In questo modo si era formata la borghesia compradora, che operava come intermediaria dei capitalisti stranieri e a questi si univa nello sfruttamento della Cina.
In questo contesto fu possibile l’avvio del primo stadio dell’industrializzazione in Cina. Una grande opportunità di sviluppo per la borghesia cinese si ebbe con la prima guerra mondiale, che determinò un allentamento della penetrazione dei prodotti europei e americani e il boicottaggio delle merci giapponesi. Ma alla fine della guerra il ritorno degli imperialisti e dei Signori della Guerra tornò ad ostacolare l’ulteriore sviluppo della borghesia cinese. Data questa situazione, secondo il Manifesto «la giovane borghesia cinese per prevenire l’oppressione economica dovrebbe insorgere e lottare contro l’imperialismo capitalistico internazionale». Il movimento antigiapponese del 1919 aveva dimostrato che la giovane borghesia cinese poteva unirsi contro l’imperialismo e il corrotto governo di Pechino, mentre il governo di Canton era considerato come espressione della borghesia cinese illuminata.
A parte queste considerazioni sul ruolo della borghesia cinese nella rivoluzione, si affermava correttamente che il più importante fattore del movimento rivoluzionario era costituito dai trecento milioni di contadini che vivevano in una condizione di miseria generale dovuta alla mancanza di terre, alle guerre civili, al banditismo, alla pressione dei prodotti stranieri. I contadini potevano essere divisi in tre gruppi: i grandi proprietari terrieri e i ricchi contadini, i contadini che coltivavano la propria terra, e gli affittuari e i giornalieri. I più miseri del secondo gruppo e quelli del terzo costituivano il 95% del totale. Solo la rivoluzione poteva tirarli fuori da questa condizione di miseria e la vittoria rivoluzionaria poteva realizzarsi solo attraverso la loro alleanza con la classe operaia.
Anche artigiani e piccoli commercianti, a causa dell’invasione delle merci straniere, erano caduti in miseria e più il capitalismo nazionale si sviluppava più cresceva la loro miseria. La valutazione era che, data questa condizione, anche la piccola borghesia si sarebbe unita alla lotta rivoluzionaria.
Infine la classe operaia, in sviluppo. Il grande sciopero dei marittimi di Hong Kong e gli altri scioperi nel resto del paese dimostravano la forza del proletariato. In crescita erano anche le sue organizzazioni sindacali.
Dallo specifico documento congressuale si evince come tale posizione traesse il suo fondamento sulla valutazione di trovarsi nel periodo tra il feudalesimo e il capitalismo (“democrazia” nel testo congressuale). La Cina era sotto il dominio di militaristi feudali e un paese semi-indipendente controllato dalle potenze imperialiste. In questo periodo «è inevitabile per la borghesia lottare contro il feudalesimo». In questo contesto, ove il proletariato non sia in grado di condurre la lotta rivoluzionaria da solo, dovrebbe affiancarsi alla lotta antifeudale, come d’altronde aveva stabilito l’Internazionale per i paesi arretrati al suo secondo Congresso.
È qui necessario fare un commento sulle valutazioni contenute nel Manifesto e nei documenti congressuali, in particolare su due questioni: la teoria del feudalesimo cinese e la natura della borghesia cinese.
Dal quadro descritto dai comunisti cinesi sembra emergere per la Cina una situazione tipica della fase di passaggio dal feudalesimo al capitalismo, con la borghesia nazionale impegnata nella lotta rivoluzionaria contro il regime feudale, rappresentato in Cina dai “militari feudali”. Senza entrare nell’analisi della struttura economico e sociale della Cina degli anni Venti – di cui abbiamo già delineato le caratteristiche essenziali e la cui questione sarà approfondita quando presenteremo la lotta di Trotski contro la tattica staliniana in Cina – si può però rilevare che già nella rivoluzione russa i bolscevichi avevano dimostrato come falsa la tesi menscevica che nella rivoluzione democratica il proletariato non avesse che un ruolo di appoggio alla lotta antifeudale della borghesia, ma avevano affermato, e con successo dimostrato, che la parola d’ordine del proletariato era quello della rivoluzione permanente. Tale prospettiva non era delineata con chiarezza dal PCdC, mancando nei documenti del secondo congresso del Partito una chiara concezione del ruolo delle classi nella rivoluzione doppia, come quella che attendeva la Cina.
In questa fase però, le decisioni del secondo congresso del PCdC, seppur tratteggiando un impianto teorico che lasciava spazio alla tattica menscevica della rivoluzione per tappe, avevano lo scopo di recepire la corretta tattica rivoluzionaria così come era stata stabilita dall’Internazionale sull’unione della rivoluzione proletaria nei paesi a capitalismo maturo con le rivoluzioni nazionali nei paesi arretrati come la Cina. Nonostante una certa debolezza dal punto di vista teorico, il Partito cinese aveva comunque il merito di mantenersi fermo sulla necessità di preservare l’indipendenza politica del proletariato nella rivoluzione nazionale. In seguito le teorie sul carattere antifeudale della rivoluzione cinese e sulla natura rivoluzionaria della borghesia nazionale saranno utilizzate per giustificare un aperto tradimento di classe perché serviranno per far passare la tattica dell’alleanza con il Kuomintang, cioè la sottomissione del proletariato al partito della borghesia cinese, processo iniziato nel corso del ’22 e completamente realizzato nel ’24.
Ritornando ai documenti congressuali vediamo come il PCdC intendeva i suoi compiti. Citiamo dal Manifesto del congresso:
«Noi, il proletariato, osserviamo le condizioni politiche ed economiche cinesi esistenti, sosteniamo che il proletariato e i contadini poveri devono appoggiare il movimento rivoluzionario nazionale. Crediamo che durante la lotta ci sia un solo modo per realizzare rapidamente la vera rivoluzione nazionale: la cooperazione delle forze rivoluzionarie proletarie e delle forze rivoluzionarie nazionali.
«Non significa che il proletariato si arrende alla borghesia quando si affianca alla rivoluzione nazionale. È il passo necessario che il proletariato deve compiere per favorire la sua reale forza e per abbreviare la vita del feudalesimo. Noi, il proletariato, abbiamo i nostri vantaggi; quando la rivoluzione nazionale avrà successo, il proletariato si assicurerà solo un po’ di libertà e alcuni diritti, e non sarà ancora completamente emancipato. Non appena il nazionalismo trionferà, la giovane borghesia si svilupperà rapidamente ponendosi nella posizione di sfida per opporsi alla classe proletaria. Il proletariato dovrebbe allora resistere alla borghesia, lottando per unire i contadini poveri sotto la dittatura del proletariato. Se l’organizzazione e il potere combattente sono forti, il passo successivo avrà successo molto presto dopo la vittoria del nazionalismo.
«Il partito comunista di Cina è il partito politico del proletariato cinese. I nostri obiettivi sono organizzare la classe proletaria, instaurare la dittatura sovietica, rovesciare il sistema della proprietà privata e raggiungere gradualmente una comunità comunista attraverso la lotta di classe.
«Al fine di promuovere gli interessi immediati dei lavoratori e dei contadini, il PCdC sta guidando i lavoratori ad appoggiare il movimento rivoluzionario democratico, in modo che i lavoratori e i contadini possano stabilire un fronte unito democratico con la piccola borghesia».
Seguiva poi un elenco degli obiettivi della rivoluzione democratica: eliminazione delle guerre civili e rovesciamento dei militaristi; cacciare l’imperialismo internazionale e raggiungere la completa indipendenza nazionale; unificazione della Cina in Repubblica; riconoscimento di Mongolia, Tibet e Turkestan come Stati autonomi; riunione di Cina, Mongolia, Tibet e Turkestan in una libera federazione; conquista di alcune libertà: suffragio per gli operai e i contadini senza restrizioni, piena libertà di parola, stampa, riunione, associazione, sciopero; altre misure per la protezione della classe operaia: giornata lavorativa di otto ore, servizi sanitari, educazione universale, protezione del lavoro delle donne e dei bambini.
Affermava il Manifesto: «Queste rivendicazioni sono vantaggiose per tutti gli operai, i contadini e la piccola borghesia, e sono necessarie per emancipare queste classi dall’oppressione esistente».
Ma gli operai, in questo fronte unito democratico, dovevano fare attenzione a non diventare un’appendice della piccola borghesia: dovevano allo stesso tempo lottare per i propri interessi di classe.
Era molto importante che i lavoratori si organizzassero nel Partito Comunista e nei sindacati. Tutti i lavoratori dovevano ricordare che sono una classe indipendente, disciplinarsi per prepararsi all’organizzazione e alla lotta, invitare i contadini a unirsi e organizzare i propri soviet per raggiungere la completa emancipazione.
Il punto centrale era la indipendenza politica del proletariato, difesa dal giovane e piccolo PCdC. Oltre al Manifesto anche gli altri documenti congressuali sono chiari su questo punto. «Questa unione non significa che ci arrendiamo ai nazionalisti, che rappresentano solo la borghesia (…) Nemmeno ne consegue che la vittoria dei nazionalisti sarà la completa emancipazione del proletariato. Ma l’unione temporanea con i nazionalisti è necessaria per unire le forze per rovesciare i nostri nemici, i militaristi feudali all’interno e gli imperialisti internazionali all’esterno (…) Ma in nessun modo affidare loro il nostro partito, perché il partito nazionalista non è il partito che rappresenta il proletariato e non lotta per il proletariato. Al contrario, dobbiamo formare il partito proletario e lottare per la lotta indipendente della nostra classe».
Dal secondo congresso del PCdC scaturì quindi la decisione di unirsi in un fronte democratico: «Il nostro PC dovrebbe unirsi a tutti i partiti rivoluzionari della nazione e organizzare un fronte unito democratico per realizzare il rovesciamento dei militaristi feudali e dell’oppressione imperialista e stabilire una vera nazione democratica e indipendente».
A tal fine, il Partito stabilì tre linee d’intervento: primo, «il Kuomintang e il SYL sono invitati a convocare una conferenza rappresentativa in un luogo adatto per discutere il metodo migliore per convocare altri partiti rivoluzionari e cosa dovrebbe essere fatto”; secondo, «i membri del parlamento che sostengono il comunismo devono contattare i membri che sono veramente democratici per formare un’alleanza democratica di sinistra»; terzo, «sindacati, contadini, commercianti, insegnanti e associazioni studentesche, alleanza politica delle donne, circolo degli avvocati, ed editori in varie città organizzeranno una “grande alleanza democratica”».
È interessante notare come al Congresso non fu assolutamente presa in considerazione la proposta di Maring sull’ingresso dei comunisti nel Kuomintang, facendo invece emergere una soluzione che si basava sulla cooperazione tra i due partiti. Si prefigurava, in termini ancora vaghi, ma già citando il Kuomintang, una cooperazione con la borghesia nazionale, ma si trattava ancora solo di sostenere dall’esterno il partito di Sun Yat-sen.
Con questa “Alleanza Democratica”, che avrebbe dovuto coinvolgere gli operai sindacalizzati insieme ai membri delle organizzazioni di contadini, commercianti, insegnanti, studenti, donne, e giornalisti, così come pure deputati parlamentari che simpatizzavano con il comunismo, i comunisti sembravano voler dar vita ad un movimento che di fatto avrebbe offuscato il convergere fra il PCdC e il KMT. Così, dopo il Congresso, iniziarono a formarsi queste organizzazioni dell’Alleanza Democratica in varie città e province, prima a Pechino, poi in Hunan, Hubei, Shanghai e nel Guangdong. Ma il Kuomintang non sostenne questa iniziativa. L’iniziativa per l’Alleanza venne a cadere del tutto, all’indomani del congresso del Partito, non appena rientrò Maring in Cina col proposito di far prevalere la tattica dell’ingresso dei comunisti nel Kuomintang.
Al Congresso importanti decisioni furono prese anche sulla questione sindacale, che trovavano fondamento nella situazione cinese, nelle prime attività sindacali del partito e nelle lezioni trasmesse dal movimento sindacale in Europa. La Risoluzione “Sul movimento sindacale e il PC” è riportata più avanti nell’Archivio della Sinistra.
Il partito dava la massima rilevanza al movimento sindacale e riconosceva la necessità di indirizzare le sue forze per l’organizzazione dei lavoratori industriali e per la lotta in difesa degli interessi immediati del proletariato. Veniva espressa chiaramente l’inconciliabilità di interessi tra la classe operaia e la borghesia.
L’adozione di una legislazione del lavoro e il miglioramento della condizione operaia dipendeva dalla forza dell’organizzazione sindacale.
La lotta per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori sotto il regime del capitale doveva elevarsi a quella per il rovesciamento del capitalismo. Era anche da considerare un errore tener separato il movimento sindacale dal movimento politico, affermando la necessità della lotta per l’indipendenza nazionale e per i diritti politici e le libertà, nonché si sosteneva l’importanza per il movimento sindacale di assumere un ruolo determinante nel fronte unito democratico. Nello stesso tempo queste lotte non dovevano essere usate per gli obiettivi politici degli opportunisti e bisognava evitare che le organizzazioni sindacali finissero sotto la direzione di elementi non proletari.
Per evitare che i lavoratori rimanessero divisi per mestieri o in base al sesso, all’età, alla provenienza ecc., due erano i principali obiettivi del sindacato: la lotta per i contratti collettivi e la stessa paga per lo stesso lavoro. Ciò avrebbe contrastato l’azione dei padroni volta a tenere divisi i proletari e avrebbe rafforzato l’unità di classe. A differenza delle gilde, il sindacato avrebbe dovuto organizzare solo i lavoratori salariati, senza alcuna discriminazione in base al sesso, all’età, alla razza, all’opinione politica, alla qualifica ecc. L’attività principale del sindacato era la lotta contro i capitalisti e il governo, che quindi si configurava come un organismo di lotta che lascia in secondo piano altre funzioni come per esempio il mutualismo. La struttura del sindacato sarebbe avrebbe dovuto essere centralizzata e basata sul settore industriale, non doveva permettere la formazione di gruppi autonomi in base al mestiere, che avrebbe compromesso l’unità della lotta. L’organizzazione di base doveva essere il comitato di fabbrica, per arrivare poi alla formazione di un sindacato di categoria.
Il sindacato doveva unire la classe operaia ed evitare che si verificassero conflitti fra gli interessi particolari dei lavoratori di una fabbrica e gli interessi di tutto il settore, come quelli di un determinato settore rispetto all’intera classe operaia. Nello stesso tempo la classe operaia cinese avrebbe dovuto evitare conflitti di interesse con il proletariato degli altri paesi e formare una organizzazione unificata a livello mondiale per combattere il capitalismo, rappresentata dal Profintern. Compito del PCdC era quello di far marciare il sindacato cinese sotto le insegne del Profintern.
Il documento congressuale si soffermava anche sulla differenza tra il Partito e il sindacato: il primo è una organizzazione di elementi proletari con coscienza di classe, è l’avanguardia del proletariato con un programma fisso, mentre il sindacato è una organizzazione di tutti i lavoratori. Il partito deve guidare il movimento sindacale. Per raggiungere questo scopo il partito deve avere forti gruppi nei sindacati. Quando i comunisti lavorano nei sindacati diretti dal Kuomintang, dagli anarchici o dalle organizzazioni cristiane, non devono spingere i lavoratori a separarsi da questi sindacati ma lottare al proprio interno per rovesciare i capi nazionalisti, anarchici o cristiani e conquistarne la guida. Nella lotta per la difesa degli interessi immediati il partito deve cooperare con il Kuomintang, gli anarchici e le organizzazioni cristiane, ma deve sempre presentarsi ai lavoratori come la loro avanguardia, il loro vero partito politico.
Il lavoro nel movimento operaio era ancora visto come l’obiettivo principale del PCdC, che si impegnava a promuovere un movimento di classe indipendente. Anche se le condizioni cinesi determinavano la necessità di un fronte di tutte le forze rivoluzionarie, e in particolare del movimento guidato da Sun Yat-Sen, era da considerarsi un’unione temporanea tra il proletariato e i contadini poveri da un lato, e la borghesia nazionale dall’altro, ed era chiaro al giovane Partito che l’impegno per la rivoluzione nazionale non significava una capitolazione dinanzi alla borghesia.
Emersero alcuni disaccordi interni sulla centralizzazione del partito, con una tendenza, guidata da Li Hanjun, che si opponeva alla visione centralizzata del PCdC. Li sosteneva un partito meno centralizzato e più focalizzato sulla promozione del comunismo tra gli intellettuali, una visione che fu sostenuta da Maring per la sua apertura al Kuomintang.
9. - Il Plenum di agosto 1922
Il secondo congresso del Partito Comunista di Cina aveva quindi confermato la decisione del Partito di unirsi al movimento rivoluzionario democratico in un’alleanza temporanea. In questo modo veniva corretta l’impostazione che era venuta fuori dal primo congresso del Partito, che aveva sancito una netta ostilità verso tutte le altre organizzazioni politiche e si recepiva quanto stabilito al Secondo Congresso dell’Internazionale sulla tattica da adottare nella questione nazionale e coloniale, con la quale i comunisti cinesi avevano potuto familiarizzare soltanto con la partecipazione di propri delegati al Congresso dei Toilers di inizio 1922.
È importante notare, però, che il secondo congresso con questa decisione si riferiva non solo al Kuomintang, presentato come un partito “rivoluzionario”, ma a “tutti i partiti rivoluzionari della nazione”. Inoltre il Partito Comunista di Cina aveva chiaro che, poiché gli “elementi democratici” non rappresentavano gli interessi del proletariato, il Partito doveva continuare la sua azione per lo sviluppo di un movimento di classe indipendente, per cui il lavoro nel movimento operaio era ancora considerato come l’obiettivo principale del Partito. Correttamente il Partito riconosceva che esso inquadrava gli elementi di avanguardia del proletariato che erano già sul terreno di una lotta volta al rovesciamento del capitalismo. Nello stesso tempo riteneva necessaria la formazione di sindacati in grado di organizzare i lavoratori indipendentemente da qualunque distinzione, comprese quelle di carattere politico.
Tuttavia non mancavano ancora profonde divisioni sulla questione della tattica da seguire rispetto al movimento nazional-rivoluzionario, in particolare sulla questione della collaborazione con il Kuomintang. Il Partito prevedeva di marciare a fianco del Kuomintang, ritenuto comunque un partito nazional-rivoluzionario.
Comunque il suo secondo congresso non discusse della formula proposta da Maring di un “blocco interno” al Kuomintang, con i comunisti che sarebbero dovuti entrare nel partito nazionalista per svolgervi il lavoro rivoluzionario dall’interno, andando – nell’idea di Maring, che si rifaceva evidentemente all’esperienza che aveva maturato in Indonesia – a formarvi un’ala di sinistra. Quindi, nonostante la questione della tattica rispetto al movimento nazional-rivoluzionario fosse tutt’altro che definitivamente stabilita, la conclusione del secondo congresso non lasciava dubbi sulla proposta caldeggiata da Maring, che semplicemente non fu adottata.
Data questa posizione appena assunta dal congresso del PCdC, al suo ritorno in Cina nell’estate del 1922 Maring si ritrovò dinanzi una forte opposizione alla sua linea. Questa, in gradazioni diverse, era generale, dal vertice alla base del Partito. In particolare si era formato un “piccolo gruppo”, sotto la guida di Zhang Guotao e che ruotava attorno al Segretariato del lavoro, quindi direttamente a contatto con il movimento operaio cinese e le sue organizzazioni, che era assolutamente ostile alla tattica di entrare nel Kuomintang.
Maring aveva, però, ottenuto a Mosca dall’ECCI una sorta di via libera alla sua linea. Il 18 luglio 1922 infatti l’ECCI aveva deciso di attuare formalmente alcune raccomandazioni di Maring sulla Cina attraverso un documento, probabilmente redatto da Radek, col quale i comunisti cinesi furono incaricati di spostare la loro sede a Canton e di svolgere il loro lavoro a stretto contatto con Maring, mentre un altro documento individuava Maring come il rappresentante del Comintern e del Profintern nella Cina meridionale, con validità fino a settembre del 1923. Lo spostamento della sede del Partito a Canton, se poteva trovare come fondamento il fatto che nella Cina meridionale vi fosse una minore repressione, andava sicuramente incontro alle direttive di Maring. Nel rapporto presentato all’Internazionale sulla situazione in Cina aveva indicato nell’area cantonese un ambiente più favorevole allo sviluppo del movimento rivoluzionario data la presenza e la forza che vi esercitava il Kuomintang. Per cui tale decisione assumeva anche il significato di una scelta a favore della politica di una più stretta collaborazione con il Kuomintang.
L’Internazionale in questa occasione non fece sua in via formale, in una dichiarazione scritta, l’indicazione per la Cina della tattica dell’ingresso dei militanti comunisti nel Kuomintang. I documenti citati riguardano, infatti, esclusivamente la decisione dell’ECCI di spostare la sede del PCdC a Canton e l’incarico di rappresentante del Comintern e del Profintern conferito a Maring.
L’ECCI, però, produsse un ulteriore documento, le “Istruzioni per il rappresentante dell’ECCI nella Cina meridionale”, col quale stabiliva la linea che i comunisti cinesi avrebbero dovuto adottare. Anche questo documento è qui riprodotto nell’Archivio.
Il documento dà anche indicazioni per la creazione di un’organizzazione di propaganda speciale per la lotta contro l’imperialismo straniero, istituita possibilmente in accordo con il Kuomintang ma totalmente indipendente da esso, che doveva cercare di sviluppare il suo lavoro in tutto il paese sulla base di un programma d’azione non solo contro l’aperta oppressione giapponese ma anche contro la politica ipocrita dell’imperialismo britannico e americano e per l’alleanza con la Russia sovietica e l’unione con gli elementi rivoluzionari del Giappone.
Infine il documento individuava nell’organizzazione delle masse lavoratrici il compito più importante dei comunisti in Cina, possibile unicamente nella forma della creazione di sindacati.
Queste indicazioni dei vertici dell’Internazionale, seppur non contenendo un esplicito avallo alla linea di Maring, contengono non pochi elementi di ambiguità rispetto alla corretta impostazione rivoluzionaria che era stata stabilita al Secondo Congresso dell’Internazionale, elementi che, una volta sviluppati in tutta la loro interezza aprivano la strada all’opportunismo.
Addirittura dal documento dell’ECCI sembra emergere la convinzione dei vertici dell’Internazionale della inconsistenza del giovane Partito cinese, tanto che veniva individuato tra i principali compiti dei comunisti in Cina quello di educare degli elementi che in futuro avrebbero costituito il nucleo del PCdC, praticamente come se il Partito fosse ancora da formare.
Da ciò si arrivava alla decisione di obbligare i comunisti a sostenere il Kuomintang e si introduceva la direttiva di sostenere quell’“ala” del Kuomintang che si riteneva rappresentasse gli elementi proletari, formula che, nel corso degli eventi successivi, sarà in più circostanze nefasta per le sorti della rivoluzione in Cina. Per la prima volta si faceva strada la teoria per cui all’interno del partito della borghesia cinese potesse essere individuata una “sinistra”, una fazione disposta a rappresentare le aspirazioni del proletariato, che andava sostenuta e rafforzata con il lavoro dei comunisti.
Quindi già a metà del 1922 l’Internazionale dava ai comunisti cinesi l’indicazione di “organizzare gruppi comunisti di seguaci nel Kuomintang”, che, sebbene non in modo esplicito, era quanto proposto da Maring e rifiutato dai comunisti cinesi.
Per superare le resistenze all’interno del Partito Comunista di Cina e far accettare la sua linea Maring convocò il Plenum di Hangzhou, il primo tenuto dal Partito, probabilmente tra il 28 e il 30 agosto 1922, ma le date sono incerte. Presenti i membri del Comitato Centrale, Chen Duxiu, Zhang Guotao, Cai Hesen, Gao Junyu e Li Dazhao. Oltre a Maring vi partecipò anche Zhang Tailei. Secondo i ricordi di Chen Duxiu, tutti i membri del CC presenti si opposero alla proposta di Maring sostenendo che in questo modo sarebbe stata introdotta confusione nell’organizzazione di classe e ostacolata l’indipendenza politica del Partito. Secondo la versione di Maring la sua proposta fu accettata dalla maggioranza del CC e chi si oppose lo fece con la motivazione che il Kuomintang non avesse un reale peso politico e che difficilmente sarebbe potuto diventare un movimento di massa. Addirittura, secondo Maring, Chen Duxiu aveva prontamente accettato la proposta di aderire al Kuomintang.
Diversa ancora è la versione di Zhang Guotao…
In ogni caso, come già espresso nella lettera di Chen Duxiu a Grigori Voitinsky, la convinzione abbastanza generalizzata tra i comunisti di Cina era che il Kuomintang fosse un organo privo di vita e non doveva essere preso troppo sul serio.
Contrastanti sono anche le versioni riguardanti la modalità con la quale si arrivò alla decisione finale. Secondo Chen Duxiu e Zhang Guotao, l’adesione al Kuomintang fu votata perché Maring invocò la disciplina verso l’Internazionale. Dal canto suo, Maring contestò questa versione precisando che in quell’occasione non aveva in mano istruzioni specifiche, nessun documento da poter far valere per far adeguare i comunisti cinesi alla sua proposta.
Con molta probabilità, Maring utilizzò le “Istruzioni per il rappresentante dell’ECCI nella Cina meridionale” come avallo dell’Internazionale alla sua tattica. Maring invocò l’autorità dell’Internazionale Comunista, esortando i partecipanti a sottomettersi alla sua disciplina. I dirigenti del PCdC votarono quindi all’unanimità per la tattica di entrare nel Kuomintang, capovolgendo l’atteggiamento precedentemente assunto dal Partito.
Solo il Segretariato del Lavoro continuò a opporsi.
L’opposizione alla politica di Maring era così diffusa nel partito e così detestata persino dai membri del Comitato Esecutivo Centrale che Maring, per mutarne la composizione, ne suggerì l’espansione aggiungendo membri favorevoli alla linea dell’Internazionale, come Li Hanjun e Li Dazhao.
Il Plenum di Hangzhou con la decisione di far aderire i comunisti al Kuomintang rappresenta una svolta nella politica fino a quel momento adottata dai comunisti cinesi e segna l’avvio di un periodo decisivo per le relazioni tra il Partito Comunista di Cina e il Kuomintang, al termine del quale, col terzo congresso del partito, i comunisti cinesi, seguendo le indicazioni dell’Internazionale, cederanno definitivamente al Kuomintang la bandiera della rivoluzione in Cina, che diventerà quindi la forza centrale della rivoluzione nazionale. I comunisti andranno a lavorare per il partito della borghesia, rinunciando all’indipendenza politica e organizzativa del Partito, e finendo legati mani e piedi alla direzione e alla disciplina borghese del Kuomintang, che dopo averli utilizzati passerà alla brutale liquidazione delle forze proletarie e comuniste.
10. - La nuova tattica al IV Congresso dell’IC
All’inizio di settembre 1922 furono ammessi nel Kuomintang i primi comunisti, tra i quali Chen Duxiu, che si dettero a partecipare alla riorganizzazione del partito nazionalista. Intanto, tra settembre e dicembre, inviati di Sun Yat-sen conducevano con Joffe una serie di discussioni su una possibile assistenza militare sovietica.
In questo contesto, che vedeva l’inizio della messa in pratica della tattica caldeggiata da Maring di ingresso dei comunisti nel Kuomintang, nel novembre del 1922 si svolse il Quarto Congresso dell’Internazionale, con la delegazione cinese che prese parte attivamente ai lavori congressuali, in particolare quelli della commissione sulla questione orientale.
Per diversi aspetti risulta particolarmente interessante il rapporto presentato dal delegato cinese Lin-Yen-Chin alla commissione che si occupava della questione orientale. Nel descrivere la situazione in Cina il delegato affrontò due questioni. Prima di tutto quella delle vicende politiche del paese, che nel corso del 1922 aveva visto la caduta di due governi: quello di Sun Yat-Sen nel sud, per mano di un generale del Kuomintang, e quello filo-giapponese nel nord in seguito alla vittoria nella guerra civile del generale Wu Peifu, di orientamento filo-americano.
La caduta di Sun Yat-Sen, avvenuta in seguito al dissidio circa la spedizione militare contro il Nord, secondo il delegato cinese significava «il completo fallimento del piano militare della rivoluzione». Il limite del Kuomintang era da individuare nel voler utilizzare il solo strumento militare per la rivoluzione in Cina, in quanto ritenevano che «con la conquista militare delle province avrebbero realizzato la democrazia in Cina». Mancava del tutto nel paese la propaganda e l’organizzazione delle masse. La strategia del Kuomintang avrebbe potuto avere un senso nella fase iniziale quando, dopo la conquista del Guangdong e la formazione di un governo rivoluzionario, permaneva nel partito l’idea di utilizzare le risorse della provincia meridionale per organizzare la spedizione contro il Nord. Ma presto emerse all’interno del partito una tendenza conservatrice volta solo a mantenere il controllo della provincia, disinteressandosi del resto della Cina. La fazione che aveva deposto Sun Yat-Sen rappresentava questa tendenza conservatrice. Il giudizio che se ne ricavava era che «la maggioranza del partito è potenzialmente reazionaria», e quindi che «la rivoluzione, se vuole avere successo, deve organizzare le masse e portare avanti la propaganda tra le masse, e non solo con la conquista militare, poiché questo metodo è fuori tempo in Cina».
Dall’altro lato la vittoria di Wu Peifu non avrebbe potuto risolvere i problemi politici della Cina, come l’abolizione del sistema dei Signori della Guerra. Le masse sarebbero rimaste deluse da questa cricca militare e avrebbero visto confermato che la conquista della democrazia sarebbe potuta avvenire solo dalle loro stesse mani.
L’altra questione trattata nel rapporto del delegato cinese era la situazione della lotta di classe in Cina, che era descritta particolarmente positiva in quanto nel corso del 1922 si era dispiegato un vasto movimento di scioperi, che si prevedeva avrebbe favorito lo sviluppo del partito: «Tutti questi scioperi si sono succeduti molto rapidamente. La diffusione della rivolta contro la classe capitalista si è risvegliata nelle masse lavoratrici. Questo dimostra che il movimento di massa in Cina non è un sogno dei socialisti ma che è già in atto, e mostra anche che il Partito Comunista può avere successo nella sua agitazione tra le masse. Dimostra che il Partito Comunista in Cina progredirà favorevolmente, a differenza degli anni precedenti quando era solo un circolo di studio, una setta. Quest’anno possiamo assistere allo sviluppo del nostro Partito Comunista fra le masse».
Dopo di ciò il delegato cinese si soffermò sui compiti del Partito Comunista di Cina. Quanto fu affermato dal delegato cinese risulta di particolare importanza perché venne a precisare che il fronte unito con il Kuomintang si stava realizzando con l’ingresso individuale dei comunisti nel partito nazionalista:
«Il nostro partito, tenendo presente che il fronte unito antimperialista deve essere istituito per espellere l’imperialismo dalla Cina, ha adottato questo atteggiamento, cioè che dobbiamo stabilire un fronte unito tra di noi e il partito rivoluzionario nazionalista: il partito Kuomintang. La forma di questo fronte unito è che entriamo in questo partito con i nostri nomi e capacità individuali. Nel fare questo abbiamo due cose in vista. In primo luogo, il partito rivoluzionario nazionale ha molti lavoratori organizzati. Entriamo per fare agitazione fra gli operai e portarli dalla nostra parte.
«Allora dobbiamo lottare contro l’imperialismo unendo le nostre forze: la piccola borghesia e il proletariato. Intendiamo competere con questo partito nell’organizzazione e nella propaganda tra le masse. Se non entriamo resteremmo del tutto isolati, sostenendo un comunismo che sembrerebbe un principio alto e potente ma che le masse non seguirebbero. Esse seguirebbero invece questo partito della piccola borghesia e verrebbero utilizzate da questo partito per gli interessi di quest’ultimo. Qualora ci unissimo a esso saremmo in grado di mostrare alle masse che anche noi sosteniamo la democrazia rivoluzionaria, ma che la democrazia rivoluzionaria è semplicemente un mezzo per raggiungere i nostri fini più vasti. Saremmo anche in grado di sottolineare che, sostenendo l’obiettivo lontano, non trascuriamo le esigenze immediate e intermedie delle masse. Possiamo portare le masse dietro di noi e dividere il partito del Kuomintang».
Veniva quindi annunciato l’inizio della sciagurata tattica di infiltrarsi nel Kuomintang, giustificata con l’illusione di strappare ai nazionalisti l’influenza sulle masse. Erano i primi passi che avrebbero portato il PCdC e il proletariato cinese a sottomettersi alla direzione e alla disciplina del partito della borghesia cinese, il tutto secondo le direttive dell’Internazionale, che iniziava a mostrare i primi pericolosi sbandamenti dalla corretta via rivoluzionaria.
Radek, nel suo intervento sulla questione orientale, non condivise i toni trionfalistici adoperati dal delegato cinese sulle prospettive di sviluppo del partito in Cina e mise in evidenza l’arretratezza del movimento rivoluzionario nei paesi orientali, per cui, proprio come in Occidente, si lanciava la parola d’ordine di “andare alle masse”. Dall’intervento di Radek emergeva come la situazione del movimento rivoluzionario fosse molto meno favorevole di quella al tempo del Secondo Congresso nel 1920. Dall’arretratezza del movimento rivoluzionario si derivava la necessità di collegarsi a qualunque forza in grado di svolgere un ruolo antimperialista, il che esponeva al rischio di marciare insieme a fazioni anche reazionarie, che inevitabilmente sarebbero passate all’attacco contro il movimento rivoluzionario.
«La nostra tesi era che l’Est sfruttato deve e vuole difendersi dal capitale internazionale. Ecco perché sosteniamo l’Est sfruttato. Tuttavia, i popoli orientali sono ora guidati da coloro che non solo non sono comunisti, ma per la maggior parte nemmeno rivoluzionari borghesi. Sono ancora guidati da rappresentanti di cricche feudali moribonde, da cui è stato costituito il corpo degli ufficiali e la burocrazia in questi paesi.
«Il nostro sostegno ai popoli orientali solleva quindi la questione del nostro rapporto con queste forze di governo. La questione è posta in pratica dalla persecuzione dei comunisti in Turchia e dalle lotte condotte nelle ultime settimane da Wu Peifu in Cina contro gli scioperanti. Come comunisti siamo in grado di esprimere la nostra posizione su questi argomenti in modo completo e con assoluta franchezza. Quando abbiamo promesso il nostro sostegno all’Oriente che si sta risvegliando, non abbiamo dimenticato per un momento le lotte di classe che vi sarebbero sorte».
Dopo essersi soffermato sulla situazione in Turchia Radek passa alla Cina:
«Quando Wu Peifu entrò in battaglia con Zhang Zuolin aveva alle spalle la linea del fiume Yangtze e i suoi arsenali ma non controllava le ferrovie settentrionali, che erano detenute da uomini al soldo del Giappone. Cosa ha fatto? Si è rivolto al giovane Partito Comunista Cinese per chiedere sostegno. Gli diedero dei commissari, che tenevano saldamente sotto controllo le ferrovie per le sue truppe, che vi stavano conducendo una guerra rivoluzionaria.
«Chiunque combatta in Cina contro l’imperialismo giapponese sta combattendo per lo sviluppo rivoluzionario della Cina. Poiché i comunisti l’hanno capito, crearono nella classe operaia la coscienza della loro indipendenza e importanza. Successivamente i lavoratori fecero le loro richieste a Wu Peifu, e in parte le realizzarono. Grazie a questo sostegno e all’adempimento dei loro obblighi storici verso le forze rivoluzionarie borghesi, i nostri compagni sono riusciti a stabilirsi tra le masse lavoratrici della Cina settentrionale».
La questione era molto delicata: era concreto il pericolo di compromettere i giovani partiti con forze reazionarie, ma che in quel momento avrebbero potuto svolgere una funzione antimperialista. Non passerà qualche mese che l’illusione di poter utilizzare personaggi alla Wu Peifu si scontrerà con la realtà della violenta repressione del movimento e dell’organizzazione dei ferrovieri per mano della soldataglia di Wu Peifu nel febbraio del 1923.
I vertici dell’Internazionale giustificavano il loro indirizzo al PCdC con valutazioni riduttive della forza del partito, ritenuto lontano dall’aver stabilito legami con le masse. In tal senso Radek volle confutare quanto affermato dal delegato cinese nel suo rapporto, che aveva parlato di una situazione favorevole alla lotta di classe e allo sviluppo del partito.
«Come sempre, compagni, vorrei iniziare dicendo che non dovreste avere una visione troppo rosea della situazione. Non esagerate con la vostra forza. Il compagno cinese dice qui: Abbiamo affondato radici in tutta la Cina. Devo rispondere: Cari compagni, è bello sentire che abbiamo abbastanza forza per iniziare il lavoro. Ma dobbiamo guardare i fatti in faccia. Il nostro partito cinese si è sviluppato in maniera del tutto separata in ciascuna delle due parti del paese.
«I compagni che lavorano a Canton [Guangzhou] e a Shanghai hanno fatto pochissimi progressi nel legarsi alle masse lavoratrici. Abbiamo lottato con loro per un anno intero perché molti obiettavano “come può un buon comunista essere coinvolto in faccende quotidiane come gli scioperi”. Molti dei nostri compagni si sono chiusi nella loro stanza per studiare Marx e Lenin, come una volta avevano studiato Confucio.
«Questa era la situazione un paio di mesi fa. Com’è possibile che la causa della rivoluzione, che ha già subìto un duro colpo con la caduta di Sun Yat-Sen, sia diventata improvvisamente una forza così forte? Al Nord, dove il partito è piuttosto debole e gode di consensi solo tra i ferrovieri, come può rappresentare una grande forza? (…)
«Il primo compito dei compagni cinesi è concentrarsi su ciò di cui è capace il movimento cinese. Compagni, dovete capire che in Cina non sono all’ordine del giorno né la vittoria del socialismo né l’instaurazione di una repubblica sovietica. Purtroppo in Cina nemmeno la questione dell’unità nazionale è stata ancora storicamente posta all’ordine del giorno. Quello che stiamo vivendo in Cina ricorda il Settecento in Europa, in Germania, dove lo sviluppo del capitalismo era ancora così debole da non aver ancora dato vita a un unico centro nazionale unificatore.
«Quando parli dei Tuchun, i governatori militari; quando proclami “Qui abbiamo Sun Yat-Sen e lì Wu Peifu”, cosa ci dice? Significa che il capitalismo sta cominciando a svilupparsi in tutta una serie di centri diversi. Con una popolazione di oltre 300 milioni, senza ferrovie, come potrebbe essere diverso? Abbiamo ampie prospettive, che dovreste sostenere con tutto il fuoco delle vostre giovani convinzioni comuniste. Nonostante ciò il nostro compito consiste nell’unificare le forze reali che si stanno formando nella classe operaia con due obiettivi: primo, organizzare la giovane classe operaia, e secondo, stabilire un giusto rapporto tra queste e le forze borghesi oggettivamente rivoluzionarie, al fine di organizzare la lotta contro l’imperialismo europeo e asiatico».
Ma, noi comunisti di sinistra avremmo obiettato, la questione dell’indipendenza del partito non dipende né dalla maturazione storica del contesto né dalla sua forza numerica, né dalla misura del suo “legame con le masse”.
Radek infatti non commentò quanto affermato dal delegato cinese sulla tattica di far entrare individualmente i comunisti nel Kuomintang, quando era proprio questo l’aspetto centrale della questione dei rapporti tra le forze rivoluzionarie in Cina. Tale tattica non andava certamente nella direzione di quel “giusto rapporto” tra il proletariato e la borghesia rivoluzionaria di cui aveva parlato Radek, perché, dal momento che i comunisti sarebbero andati a lavorare per il partito nazionalista borghese, si sarebbe imposta nei fatti la sottomissione del partito comunista e del proletariato cinese alla borghesia del Kuomintang.
Dall’intervento di Radek si comprende come la parola d’ordine di “andare verso le masse” derivava dalle mutate prospettive rivoluzionarie in Oriente rispetto al Congresso dell’I.C. di due anni e mezzo prima.
«Compagni, la situazione mondiale è cambiata dai tempi del Secondo Congresso. In quel congresso la nostra linea politica in Oriente era orientata verso immediati e ampi moti rivoluzionari. Questo non è stato esplicitato, ma tutti i delegati dell’Est lo hanno sentito. Per quanto riguarda l’attuale situazione mondiale, ci troviamo in giro per il mondo in un periodo in cui la rivoluzione sta raccogliendo le sue forze. Questo ha un impatto anche sulla situazione nei paesi dell’Est. Se vogliamo svolgere un ruolo rivoluzionario in questi paesi nel prossimo periodo, dobbiamo fissare l’obiettivo di compiere un vasto lavoro organizzativo, politico e intellettuale.
«Naturalmente le rivoluzioni dell’Est non aspetteranno che i nostri compagni in ogni paese abbiano imparato che rivoluzione non significa leggere e digerire le tesi dell’Internazionale Comunista, ma svolgere un lavoro rivoluzionario pratico tra le masse. Ma quando in Oriente si svilupperanno grandi eventi simili a quelli che si verificano oggi in Turchia, dove siamo deboli e disorganizzati, allora avverranno senza di noi e non saremo in grado di influenzarli in una direzione rivoluzionaria. Perciò la parola d’ordine di questo congresso sulla questione orientale deve essere quella di andare presso le masse martoriate dell’Est, lavorare per la loro educazione e creare solidi bastioni dell’Internazionale Comunista in Oriente che siano capaci di svolgere un lavoro pratico per la lotta davanti a noi e di influenzare le grandi masse. E poi, dopo aver raccolto attorno a noi gli operai, dobbiamo andare dai contadini e dagli artigiani e diventare i dirigenti di un futuro partito popolare».
Cosa intendesse Radek per un “futuro partito popolare” non fu chiarito, ma ciò che emergeva era una valutazione negativa della forza dei giovani partiti comunisti nelle colonie e, quindi, la necessità di “andare verso le masse”, tattica che si prestava a interpretazioni che andavano contro quanto con convinzione fu stabilito al Secondo Congresso, secondo cui i rapporti dell’I.C. con il movimento rivoluzionario delle colonie dovevano passare per i partiti comunisti, ritenuti l’avanguardia della classe operaia. Per contro, già in Cina battere la strada dell’ingresso dei comunisti nel Kuomintang nei fatti non avrebbe potuto far altro che compromettere la chiarezza ideologica del partito e la sua fermezza organizzativa.
L’Internazionale approvò delle Tesi sulla questione orientale. Queste Tesi precisavano correttamente i termini della questione agraria nei paesi arretrati, evidenziando la pavidità dei dirigenti borghesi dei movimenti nazionalisti a causa dello «stretto legame esistente fra la borghesia indigena e i proprietari terrieri feudali e feudal-borghesi», e chiarivano come la rivoluzione nei paesi arretrati non poteva prescindere dallo sviluppo del movimento rivoluzionario nelle campagne: «Soltanto la rivoluzione nelle campagne, il cui obiettivo è quello di espropriare le grandi tenute, può mettere in movimento le immense masse dei contadini; essa è destinata ad esercitare un influsso decisivo sulla lotta contro l’imperialismo». Continuavano: «Il movimento rivoluzionario nei paesi arretrati dell’Oriente non può avere successo se non fa affidamento sull’azione delle larghe masse contadine. Pertanto, i partiti rivoluzionari di tutti i paesi orientali devono formulare un chiaro programma agrario, rivendicando la completa abolizione del sistema feudale e dei suoi residui».
Le Tesi riconoscevano i progressi compiuti dal movimento sindacale e comunista nei paesi arretrati e, nonostante i loro limiti, la formazione di partiti proletari indipendenti praticamente in tutti i paesi d’Oriente.
Non mancava però una certa ambiguità nel chiarire i compiti dei partiti comunisti nei paesi arretrati. Ai giovani partiti comunisti delle colonie e delle semi-colonie era affidato un duplice compito:
«Battersi per la soluzione più radicale possibile dei compiti della rivoluzione democratico-borghese, che mira alla conquista dell’indipendenza politica; ed organizzare le masse operaie e contadine ai fini della lotta per i propri particolari interessi di classe».
«I compiti oggettivi della rivoluzione coloniale oltrepassano i limiti della democrazia borghese, non fosse perché una vittoria decisiva di questa rivoluzione è incompatibile con il dominio dell’imperialismo mondiale. In un primo momento, la borghesia e l’intelligenza indigene sono i campioni del movimento rivoluzionario nelle colonie, ma man mano che le masse contadine proletarie e semiproletarie giungono a prendervi parte, gli elementi borghesi e agrario-borghesi incominciano a voltare le spalle al movimento, nella misura in cui gli interessi sociali delle classi popolari occupano il proscenio (…)
«Questa lotta per l’influsso sulle masse contadine deve servire al proletariato indigeno come addestramento al ruolo di direzione politica. Soltanto dopo aver padroneggiato questo compito, e conquistato influsso sugli strati sociali a sé più prossimi, questo proletariato potrà prendere posizione contro la democrazia borghese».
Una formulazione molto infelice che si avvicina alla tattica menscevica della rivoluzione per tappe, contraddicendo quanto era stato stabilito al Secondo Congresso sull’atteggiamento verso la democrazia borghese, che prevedeva come fin da prima del prevalere della rivoluzione liberale bisognasse combattere l’influenza e il controllo del movimento borghese-democratico nazionalista sul movimento rivoluzionario dei contadini poveri e degli operai, cercando di sviluppare sentimenti di classe indipendenti nelle masse operaie delle colonie e formando partiti comunisti ad organizzare operai e contadini.
Infine, le Tesi lanciano per i paesi orientali la parola d’ordine del “fronte unico antimperialista” mettendola in chiaro parallelo con la analoga del “fronte unico proletario”, fra partiti, nei paesi a capitalismo maturo: «Nelle condizioni prevalenti in Occidente, dove il periodo di transizione è caratterizzato da un confluire organizzato di forze, la parola d’ordine proposta è quella del fronte unico proletario, ma nell’Oriente coloniale la parola d’ordine che deve essere messa in rilievo nel momento attuale è quella del fronte unico antimperialista. L’opportunità di questa parola d’ordine discende dalla prospettiva di uno scontro di lunga durata con l’imperialismo mondiale, che impone la mobilitazione di tutti gli elementi rivoluzionari. Questa mobilitazione è tanto più necessaria in quanto le classi dominanti indigene sono propense a concludere con il capitale straniero compromessi contrari agli interessi vitali delle masse popolari. E proprio come in Occidente la parola d’ordine del fronte unico proletario è servita e serve ancora a smascherare il tradimento socialdemocratico nei confronti degli interessi proletari, così la parola d’ordine del fronte unico antimperialista contribuirà a smascherare i tentennamenti dei vari gruppi nazionalistico-borghesi».
Al Quarto Congresso dell’Internazionale la nostra Corrente espresse in maniera netta il suo dissenso sulla posizione sul Fronte unico. Nell’intervento del rappresentante della Sinistra sulla relazione Zinoviev si affermava di accettare interamente le intenzioni di questa tattica, ma nello stesso tempo si disse: «La conquista delle masse non deve essere ridotta alle oscillazioni di un indice statistico. Essa è un processo dialettico, determinato anzitutto dalle condizioni oggettive sociali, e la nostra iniziativa tattica non può accelerarlo che in certi limiti, o, per meglio dire, a certe condizioni che noi consideriamo pregiudiziali. La nostra iniziativa tattica, vale a dire l’abilità di manovra, si basa sugli effetti che essa produce nella psicologia del proletariato, adoperando la parola psicologia nel senso più largo per riferirsi alla coscienza, allo stato d’animo, alla volontà di lotta della massa operaia. In questo campo bisogna ricordare che vi sono due fattori di primo ordine, secondo la nostra esperienza rivoluzionaria: una chiarezza ideologica completa del partito, e una continuità severa e intelligente nella sua struttura organizzativa».
La chiarezza della ideologia e la solidità della organizzazione sono i due fattori fondamentali per non compromettere, quando la situazione lo consente, l’accrescimento degli effettivi del partito e dei suoi simpatizzanti.
Nel Progetto di Tesi presentato dal P.C. d’Italia è definito in maniera chiara l’aspetto relativo alla questione dell’organizzazione. Vi si afferma che «gli statuti organizzativi, non meno della ideologia e delle norme tattiche, devono dare un’impressione di unità e di continuità», e che «è necessaria l’eliminazione di norme di organizzazione affatto anormali. Tali sono le fusioni di sezioni isolate dell’Internazionale con altri organismi politici, il fatto che taluna di queste possa essere costituita non sul criterio delle adesioni personali, ma su quello della adesione di organizzazioni operaie, la esistenza di frazioni o gruppi di organizzati su basi tendenziali nel seno della organizzazione, la penetrazione sistematica e il noyautage in altri organismi che abbiano natura e disciplina politica (il che si applica ancor più a quelli di tipo militare)».
Quest’ultimo aspetto era proprio quanto iniziava ad essere messo in pratica in
Cina con l’ingresso dei comunisti nel Kuomintang. La nostra Corrente aveva ben
chiaro che l’elevazione a sistema di tali anormalità avrebbero condotto a una
ricaduta nell’opportunismo. Il tragico epilogo della lotta rivoluzionaria in
Cina con la sanguinosa sconfitta proletaria del 1927 affonda le radici nelle
tattiche pericolose e negli errori organizzativi che iniziarono a delinearsi dal
IV Congresso e costituisce una ulteriore conferma della correttezza di tutte le
tesi difese dalla Sinistra sugli errori storici e tattici dell’Internazionale in
degenerazione.
9. – Il movimento nazionalista
Rapporto esposto alla riunione generale nel gennaio 2017 [RG127]
67. La non eterogenea comunità musulmana
Alla prima sessione del Congresso tenutasi a Bombay nel 1885 ad essere poco rappresentata, oltre alla componente bengalese, fu quella musulmana, con soli tre delegati. Questo perché i musulmani indiani erano poco rappresentativi di quelle nuove professioni e classi dalle cui file veniva la maggioranza dei delegati. Inoltre, il principale promotore del processo di occidentalizzazione di questi indiani islamici, ovvero Sayyid Ahmad Khan (1817-98) rifiutò in un primo momento di partecipare ai lavori del Congresso e successivamente, nel 1888, prese apertamente posizione contro di esso, fondando una nuova associazione la United Patriotic Association. Un’organizzazione non puramente islamica: a far parte di essa, infatti, entrò una congrua minoranza di grandi aristocratici indù, i Talukdar, proprietari di una vasta quantità di terre. Di fatto rappresentava una classe ben definita, espressione di quella nobiltà indiana filo-britannica, indipendentemente dalle credenze religiose dei suoi membri.
La decisione di Sayyid di rompere con il Congresso è spesso interpretata come la mossa d’apertura nella lunga lotta fra indù e musulmani, destinata a concludersi con la partizione dell’India a seguito dell’indipendenza e con la nascita del Pakistan nel 1947. Secondo Sayyid in India esistevano due nazioni: quella musulmana e quella indù.
Nonostante il prestigio di sir Sayyid, non era possibile pensare che la comunità islamica potesse parlare con un’unica voce, in primo luogo perché i musulmani non erano una classe sociale omogenea, allo stesso tempo perché profondamente divisi dal punto di vista etnico-linguistico, e anche religioso. Per quanto sparsi in tutto il subcontinente, la maggioranza dei musulmani indiani viveva in tre aree ben distinte: il Punjab, le Province Unite e il Bengala. Se i musulmani delle Province Unite rappresentavano una minoranza relativamente privilegiata, fortemente urbanizzata e di lingua urdu, nel Punjab e nel Bengala invece erano prevalentemente di estrazione rurale e formavano la maggioranza della popolazione. Ma mentre gli islamici del Punjab parlavano il panjabi ed erano piccoli proprietari, quelli bengalesi erano fittavoli e braccianti e parlavano il bengali. Inoltre erano anche divisi dal punto di vista religioso. La maggioranza era formata da sunniti, ma sciiti di varia estrazione erano presenti soprattutto lungo le coste occidentali e nelle stesse Province Unite. Un’ulteriore frattura che divideva trasversalmente sia i “modernizzatori” sia i leader religiosi tradizionali era data dal loro rapporto con il potere coloniale: alcuni vi si appoggiavano apertamente, altri sognavano invece di poter riprendere la lotta contro di esso in un futuro più o meno vicino, magari con la collaborazione di non indiani (come l’emiro dell’Afghanistan o il sultano turco) o di indiani non musulmani.
Quindi Sayyid può essere considerato come il portavoce e l’organizzatore di un’influente ma circoscritta parte della comunità indo-musulmana, rappresentata dagli ultimi prìncipi regnanti (il Nizam di Hyderabad), dagli aristocratici e dalla maggioranza della borghesia urbana delle Province Unite.
In questo scenario non sorprende come un influente gruppo di musulmani tradizionalisti raccolti intorno alla scuola di Deoband, nata in quella città nel 1865, nelle Province Unite (nell’attuale Stato dell’Uttar Pradesh) si schierò invece a fianco del Congresso. Fu in occasione della prima sessione del Congresso, infatti, che Rashid Ahmad Gangohi, all’epoca il capo riconosciuto di questa corrente religiosa, promulgò una fatwa, preparata per spianare la strada alla collaborazione fra deobandi e congressisti, dove si affermava chiaramente come, negli affari terreni, la collaborazione con gli indù fosse ammissibile. Non stupisce quindi che nel Congresso di Allahabad, cioè in contemporanea con la sua denuncia da parte di Sayyid, vi fosse una cospicua presenza di delegati musulmani, in particolare piccoli proprietari terrieri e burocrati.
Come nel caso di Sayyid, anche in quello dei deobandi ciò che aveva determinato
l’atteggiamento nei confronti del Congresso non era stata tanto la religione
quanto il rapporto con la classe dirigente coloniale. La politica di sir Sayyid
si era basata sull’alleanza con i britannici, quella dei deobandi sulla reazione
e lotta alla colonizzazione inglese dell’India.
68. Ridefinizione sociale all’interno del Congresso
Nel congresso che si riunì a Bombay nel 1885 un’elevata quota di delegati era costituita da esponenti delle nuove professioni: in particolare avvocati, più della metà, ma anche medici, giornalisti e insegnanti. Le altre classi sociali, compresi esponenti dei gruppi economicamente dominanti, rappresentavano la minoranza. Ciò nonostante alcuni grandi prìncipi vassalli, un certo numero di membri dell’aristocrazia maratha e alcuni industriali indiani diedero un contributo finanziario all’organizzazione delle prime sessioni.
A partire dal Congresso del 1887, tenuto a Madras, fu evidente che stavano affluendo nuove forze, sebbene i membri delle nuove professioni continuassero a rappresentare la maggioranza dei delegati. Queste erano rappresentate da un congruo numero di grandi proprietari terrieri, mercanti e banchieri. Inoltre incominciarono a essere presenti anche piccoli e medi proprietari terrieri, capi villaggio che rappresentavano caste indù contadine dominanti e capi religiosi musulmani, di fatto i rappresentanti di quelle classi sulla cui organica alleanza si era basato il British Raj.
Questo riassestamento sociale all’interno dell’ Indian National Congress era chiaramente il frutto della crescente pressione a cui queste classi erano state sottoposte in seguito al processo di centralizzazione avviato dallo Stato coloniale a partire dagli anni Settanta. Latifondisti e grandi mercanti, ma anche medi proprietari terrieri, esponenti delle caste contadine dominanti e capi religiosi non erano più in grado di far valere le proprie istanze attraverso la mediazione della burocrazia locale. Non tardarono quindi a comprendere che le annuali sessioni del Congresso rappresentavano uno dei pochi strumenti a disposizione per esprimere il proprio scontento. Formalmente le decisioni del Congresso venivano prese a maggioranza, attraverso la presentazione, discussione e approvazione (che, per lungo tempo, avvenne sempre all’unanimità) di mozioni sulle varie questioni. In realtà le mozioni presentate all’assemblea venivano selezionate, discusse e riformulate da un comitato di presidenza, il Subjects Committee. Era in questo comitato ristretto che le decisioni politicamente importanti erano prese, mentre all’assemblea non rimaneva che il compito democratico di ratificarle.
Se non va sottovalutato il ruolo di Hume nella prima fase del Congresso, occorre
ricordare il fatto che in quei primi decenni gli indiani che collaborarono con
lui, formando questa dirigenza, svolsero un ruolo decisivo non solo
nell’assicurare la sopravvivenza dell’organizzazione e nell’articolare una serie
di richieste politiche ad hoc, ma anche nell’elaborare una moderna ideologia
nazionalista. Questa venne basata su due punti principali: la critica economica
del legame di dipendenza coloniale dell’India nei confronti della Gran Bretagna
e la concezione di una moderna idea di nazione indiana.
69. Il Drain of wealth
L’analisi della natura predatoria che caratterizzava la dipendenza coloniale fu denunciata, ancora prima della fondazione del Congresso, da un parsi di Bombay, Dadabhai Naoroji (1825-1917) primo asiatico membro del parlamento britannico che, pur riconoscendo «i grandi meriti politici e sociali del Raj», evidenziò come questi fossero una faccia di una medaglia il cui rovescio era costituito da un ininterrotto drenaggio di ricchezza (drain of wealth). Secondo Naoroji questo trasferimento di ricchezza effettuato dal regime coloniale a favore dell’Inghilterra, comportava il progressivo impoverimento dell’India, ancor peggiore di quello causato dai regimi precoloniali che, quanto meno, spendevano i frutti delle loro razzie nel subcontinente. Oltre che da Naoroji quella che è conosciuta come la teoria del drain venne articolata soprattutto da Romesh Chunder Dutt, un funzionario pubblico indiano e da William Digby, un giornalista inglese.
Un ruolo fondamentale nella descrizione del drain e nella sua pubblicizzazione
fu poi giocato da colui che nel periodo fino alla Prima Guerra mondiale emerse
come il più eminente fra i dirigenti moderati del Congresso: Gopal Krishna
Gokhale (1866-1915), rappresentante indiano presso il Consiglio imperiale
britannico dal 1902 al 1908. Soprattutto a partire dai primi anni del nuovo
secolo, Gokhale, in una serie di interventi in occasione dell’approvazione dei
bilanci dello Stato coloniale – destinati ad ampia risonanza politica – mise in
luce come il drenaggio delle ricchezze indiane fosse un fenomeno non solo
profondamente negativo, ma continuativo, reso possibile dal fatto che il governo
dell’India non fosse responsabile nei confronti della popolazione che governava.
70. L’idea di nazione
Un altro punto intorno al quale si articolò l’ideologia degli esponenti del Congresso fu la creazione di una moderna idea di nazione, che incominciò a essere percepita solo gradualmente, a partire dagli anni Settanta, per poi generalizzarsi nel nuovo secolo. Uno scenario che spinse la direzione moderata ad articolare le proprie rivendicazioni politiche non come cittadini dell’impero, ma in quanto parte di una nazione. In un territorio così vasto come l’India sembravano però mancare quasi tutti quegli elementi oggettivi che, secondo l’ideologia del tempo, avrebbero dovuto caratterizzare un’identità nazionale. L’India, in effetti, come non si stancarono mai di ripetere gli inglesi, non era uniforme come razza, religione, cultura, e lingua. La storia stessa del subcontinente era contraddistinta solo da brevi periodi unitari e dall’esistenza di una serie di potentati in lotta tra loro. L’unico elemento oggettivo che caratterizzava la nazione era dato dagli evidenti confini naturali del subcontinente.
La risposta data dai primi teorici indiani dell’idea di nazione a questa scarsità di elementi oggettivi fu duplice. Surendranath Banerjea, profondamente influenzato dagli scritti di Giuseppe Mazzini, da lui fatti tradurre in bengali, enfatizzò l’importanza dell’elemento soggettivo, cioè del fatto che una nazione, in definitiva, veniva a sussistere quando gli abitanti di un determinato territorio rivendicavano l’appartenenza ad una comunità, in qualsiasi modo definita. Circa trent’anni prima, nel 1861, era stato proclamato il Regno d’Italia. In questa prospettiva, Banerjea esortò «tutte le sezioni della grande comunità indiana» a seppellire i «sanguinosi dissensi» del passato, a mettere da parte le differenze di classe e religiose, e a riconoscersi come parte integrante della «grande comunità indiana» innalzando, mazzinianamente, le proprie preghiere alla «comune Divinità».
Accanto all’enfasi sull’elemento soggettivo, sia Banerjea che Gokhale ponevano
l’accento sull’edificazione di un comune futuro unitario. Se il leader bengalese
concepiva la costruzione di questo futuro essenzialmente come politico, il
continuo progresso verso un sistema liberal-democratico, Gokhale, influenzato
dalle idee del suo maestro, metteva in risalto la necessità di costruire un
futuro comune articolato attraverso profonde riforme sociali ed economiche,
consapevole dell’effettiva arretratezza e delle infinite divisioni socio-religiose
di una generica ed interclassista popolazione indiana.
71. Le divisioni all’interno del Congresso
La benevola neutralità nei confronti del Congresso da parte dei vertici coloniali si era trasformata nel giro di pochi anni in esplicita ostilità. Le numerose questioni poste dal Congresso, nonostante la loro moderazione, furono interpretate al limite del sedizioso. Tuttavia il seguito sociale che il Congresso si era procurato fra i notabili indiani era un fenomeno a cui era necessario dare una risposta politica.
Questa arrivò nel corso dell’ultimo decennio del novecento con una serie di riforme amministrative ad hoc. La più importante fu l’Indian Council Act del 1892, una legge del Parlamento britannico che introdusse vari emendamenti alla composizione e al funzionamento dei consigli legislativi nell’India britannica comportando un’espansione dei Consigli Legislativi che collaboravano con il viceré e con i governatori delle presidenze. In particolare, la legge ampliò il numero dei membri dei consigli centrali e provinciali. Fu permesso agli indiani che facevano parte dei quadri direttivi dell’Imperial Civil Service (non più di una ventina su circa 900) di arrivare a ricoprire cariche importanti, sia nel settore amministrativo sia in quello giudiziario.
Tuttavia questi provvedimenti furono giudicati del tutto inadeguati dal Congresso e dallo stesso Hume, ma, per quanto limitati e insoddisfacenti, raggiunsero quanto meno l’obiettivo di aprire nuovi canali di collegamento fra i vertici coloniali e i notabili indiani. Dopo le riforme quest’ultimi si resero conto che la via più rapida per presentare le proprie doglianze al potere coloniale non erano più le assemblee annuali del Congresso, bensì i nuovi consiglieri, senatori, giudici e amministratori indiani, che potevano trattare in via ufficiale e su un piano di quasi parità con la classe dirigente coloniale. Come conseguenza, nella seconda metà degli anni Novanta, gran parte dei notabili abbandonò il Congresso, che sprofondò in un periodo di crisi politica.
L’unico possibile rimedio a questa debolezza sempre più evidente verteva in una strategia che mobilitasse, dietro agli ideali del nazionalismo, in generale trasversalmente settori più o meno ampi delle masse indiane. Condizioni oggettive di classe differenti e diversità culturali rendevano però difficile un impegno effettivo in questo senso da parte dei dirigenti del Congresso. Le masse indiane erano prevalentemente rurali e, alla fine dell’Ottocento, generalmente molto povere. Certamente questo era anche il risultato dello sfruttamento coloniale, ma, come si è visto, vi erano anche classi estremamente privilegiate, in particolare proprietari terrieri e grandi mercanti, che solo eccezionalmente erano inglesi. Tra i beneficiari del sistema coloniale vi erano molti di quegli stessi notabili sul cui appoggio il Congresso aveva contato e delle cui richieste politiche si era fatto carico. In sostanza per la dirigenza del Congresso farsi interprete in maniera adeguata delle esigenze delle masse contadine avrebbe significato contrapporsi alle classi privilegiate indiane. Una lotta di classe che però non era affatto fra le parole d’ordine di questa organizzazione, al contrario gli intellettuali nazionalisti che ben conoscevano la povertà economica e la discriminazione sociale, ritenevano che una mobilitazione delle masse avrebbe indebolito il movimento nazionalista, contrapponendo una parte della sterminata popolazione, gli sfruttati, ad un’altra, le classi dominanti indiane, quelle vecchie e le emergenti.
In sostanza, la perdita di contatto con alcune classi indiane e l’incapacità di costruire nuovi rapporti determinò, nella seconda metà degli anni Novanta, una perdita di peso politico da parte del Congresso.
In questo scenario si intensificarono diverse tensioni interne. Per la prima volta la vecchia direzione moderata venne sfidata da una nuova corrente, politicamente più radicale ma socialmente altrettanto conservatrice. I membri di questa nuova corrente furono etichettati, sia dai loro avversari indiani sia dagli inglesi, come gli “estremisti”. Anche loro si trovarono di fronte alla difficoltà di mobilitare un adeguato seguito, ma riuscirono ad aprirsi un varco ricorrendo all’utilizzo politico della religione. In pratica si affidarono a un linguaggio caratterizzato da metafore e parole d’ordine tratte dalla tradizione indù. La stessa India, ad esempio, venne identificata con la Dea Madre, mentre le festività religiose, alcune delle quali reintrodotte appositamente, diventarono il momento in cui gli ideali del nazionalismo erano predicati alle masse. Sebbene formalizzata solo negli anni Venti del secolo successivo, l’idea di nazione proposta da questa nuova corrente si differenziò da subito in modo decisivo rispetto a quella elaborata dai moderati. Secondo questi ultimi tutti i nativi dell’India erano indiani, indipendentemente da criteri di razza o religione; gli estremisti, invece, fecero coincidere in maniera via via più esplicita l’appartenenza alla nazione indiana con l’adesione all’induismo.
La strategia della nuova corrente mirava a riunificare dietro un comune disegno
politico i vari rami dell’induismo – riformatori e ortodossi – per poi
servirsene nel tentativo di costruire un movimento politico di massa.
72. Bal Gangadhar Tilak
Per quanto l’induismo politico diventasse sempre più popolare in quegli anni, almeno fra la piccola borghesia urbana indù e gli studenti, esso non risolse affatto il problema di dare un seguito di massa al nazionalismo. In effetti, l’insufficienza dell’induismo politico come strumento di mobilitazione delle masse è dimostrata dalla carriera di Bal Gangadhar Tilak (1857-1920), scrittore marathi considerato uno dei padri fondatori della nazione. Tilak fu il riconosciuto rappresentante degli estremisti e l’unico uomo politico che, prima dell’emergere di Gandhi, riuscì effettivamente a conquistarsi un ampio seguito tra le masse – almeno fra quelle della sua regione d’origine, il Maharashtra, verso le quali si indirizzava pubblicando diversi giornali nelle lingue indigene.
Anche Tilak era un conservatore, che si era servito della polemica sull’Age of Consent Bill (1891) per proiettarsi come il capo sia dei nazionalisti intransigenti, sia degli indù ortodossi. Nel 1894 trasformò la festività di Ganesh (o Ganapati) – il dio dalla testa d’elefante – da festa domestica a celebrazione pubblica in cui si tenevano processioni e festeggiamenti nel corso dei quali erano pronunciati discorsi con chiari risvolti politici. Prima che gli inglesi la proibissero, nel 1910, perché “malvagiamente sedizioso”, il festival di Ganapati si trasformò in uno strumento di mobilitazione politica a livello popolare, mobilitando anche classi non abitualmente influenzate dall’ideologia nazionalista del Congresso.
Tilak, in realtà, non era così ortodosso e le sue concezioni religiose furono, per lui, meno importanti del nazionalismo. Non c’è quindi da stupirsi del fatto che abbia costruito la propria popolarità e un seguito di massa non unicamente sull’uso politico dell’induismo, ma su un complesso di diverse strategie. Ad esempio fece riscoprire l’opera politica di Shivaji, all’epoca ormai largamente dimenticata. Una strategia che è stata spesso descritta come antimusulmana considerando che la carriera del maratha Shivaji si fondò sulla lotta contro i sultanati del Meridione e contro l’impero di Aurangzeb. Tilak – egli stesso un bramino – mirava a stabilire il proprio ascendente sia nei confronti dei Sardar – i membri dell’aristocrazia terriera del Maharashtra – sia dei prìncipi vassalli della regione, entrambi appartenenti in larga misura alla grande casta maratha. Lo sforzo di mobilitazione di Tilak, in definitiva, era rivolto a tutti gli abitanti del Maharashtra e non escludeva nessuno a priori, infatti lo stesso Shivaji aveva conferito concessioni terriere alle classi dominanti musulmane.
A parte il festival di Ganesh e la campagna in memoria di Shivaji, l’ascendente popolare di Tilak – che, a un certo punto della sua carriera, cominciò a essere chiamato dai suoi connazionali con il titolo onorifico di Lokmanya, che significa "popolare" – fu il risultato dello sviluppo di altre due linee strategiche. Una si sviluppò a favore dei contadini, che erano stati colpiti dalla grave carestia nel Deccan del 1896 che causò diversi milioni di morti, per lo più contadini poveri. La campagna in questione si concretizzò attraverso un’opera capillare volta a rendere i contadini del Deccan consapevoli dei loro diritti in base al “Codice per la carestia” e a difenderne gli interessi nei confronti del governo coloniale.
Un’altra manovra sviluppata da Tilak all’inizio del nuovo secolo fu stabilire
contatti con il nascente proletariato di Bombay. Qui Tilak si impegnò a tutelare
i diritti sindacali dei lavoratori, ma solo quelli che non dipendevano dal
padronato indiano, con cui il Lokmanya cercò allo stesso tempo di stabilire
buoni rapporti. In ogni caso questo impegno ebbe il risultato di far emergere un
certo ascendente di Tilak anche nei confronti della nascente classe operaia.
73. Altri dissidi tra i musulmani
Nel medesimo periodo in cui, nelle file del Congresso, si acuiva la sfida degli estremisti contro la vecchia classe dominante, anche tra quelli che venivano considerati musulmani occidentalizzati crescevano tensioni interne. Di fatto gli esponenti delle classi dominanti e superstiti dell’aristocrazia Moghul erano strettamente legati agli inglesi dal punto di vista politico.
Il grosso dei diplomati del college di Aligarh, scuola destinata alla diffusione della cultura inglese tra i musulmani, apparteneva a famiglie piccolo borghesi e ciò li predisponeva a un maggior radicalismo politico. Un potenziale che trovò alimento nell’insegnamento di Shibli Nomani (1857-1914), dal 1882 professore di arabo e di persiano ad Aligarh. Nomani, un progressista, non condivideva l’atteggiamento filobritannico di sir Sayyid Ahmad Khan (il fondatore della scuola) e richiamava gli studenti all’obbligo morale di far rivivere il passato glorioso del mondo islamico. Numani era stato tra i responsabili della diffusione fra i suoi studenti delle tesi politiche di un importante teologo riformatore che aveva più volte soggiornato in India tal Sayyid Jamal al-Din al-Afghani e che muoveva i primi passi verso l’elaborazione di un’ideologia che avrebbe dovuto conciliare laicismo e panislamismo. Al-Afghani in un primo momento auspicava, infatti, la nascita in Asia e in Africa di nazioni i cui cittadini fossero accomunati dalla medesima lingua e dal legame allo stesso territorio. Si trattava, quindi, di nazioni che sarebbero nate prescindendo dall’affiliazione religiosa dei loro membri. Ma l’area geografica in questione era di fatto caratterizzata da una forte presenza islamica. Nel corso del tempo ciò lo spinse a rivedere le proprie posizioni. L’Islam divenne quindi lo strumento attraverso il quale costruire una grande alleanza politica transnazionale e interclassista in funzione “antioccidentale”.
Dato che Nomani, a differenza di Tilak, aveva più fiducia nel ruolo dei potenti che in quello delle masse, egli indicava come naturale capo politico di questa grande alleanza il sultano di Costantinopoli. I sultani ottomani, infatti, rivendicavano il titolo di califfo, ovvero la carica che li rendeva capi riconosciuti di tutta la comunità dell’islam sunnita. Lo stesso al-Afghani ebbe poi un ruolo importante nel convincere Abdul Hamid, sultano dal 1876 al 1909, a giocare la carta panislamica.
Sayyid Ahmad Khan invece aveva sempre contestato con vigore la validità delle
pretese dei califfati del sultano e aveva difeso la politica inglese in
occasione sia dell’occupazione dell’Egitto (1882), sia della guerra turco-greca
del 1897. Nonostante questo, non vi è dubbio che le idee panislamiche in cui si
riconoscevano anche gli ulama di Deoband, città indiana che ospitava un
importante centro religioso, diventassero sempre più influenti fra i giovani
musulmani occidentalizzati.
74. Il movimento Swadeshi e tensioni comunitarie e di classe
In questa complessa situazione, caratterizzata dall’ascesa di correnti anti-britanniche sia nell’ambito del Congresso sia tra i giovani musulmani occidentalizzati, si inserì l’opera del governo di Lord Curzon, viceré dell’India dal 1899 al 1905. Curzon, in un’ ottica di efficienza e riduzione costi, varò una serie di provvedimenti che limitarono le concessioni fatte agli indiani negli anni precedenti, come la riforma della municipalità di Calcutta (1899) e quella delle università (1904). In entrambi i casi, gli organi di governo di tali istituzioni furono rimaneggiati in modo da far diminuire fortemente il numero e il peso dei membri eletti, ovvero degli indiani.
Ancora più controversa, e destinata a comportare violenti contraccolpi politici, fu la decisione, attuata nel 1905, di scorporare la parte orientale del Bengala dalla presidenza omonima e di unirla all’Assam, in modo da creare una nuova provincia con capitale Dacca. Una decisione che venne motivata da ragioni puramente amministrative. La grande provincia fu scissa esattamente nel mezzo, Bengala orientale e Assam formarono una provincia mentre Bengala occidentale, Bihar e Orissa un’altra. Prima della partizione era la più vasta circoscrizione dell’India britannica, con circa 80 milioni di abitanti. Lord Curzon non esitò a far presente ai musulmani del Bengala orientale che considerava quest’ultima una provincia musulmana.
Gli indù bengalesi, d’altro canto, presero atto di costituire in questa provincia una minoranza. I più politicizzati, che non avevano mancato di protestare contro il progetto quando era ancora in fase di elaborazione, si convinsero di trovarsi in presenza di un tentativo di indebolire il loro gruppo etnico, che di fatto era il più politicizzato del subcontinente. Scatenarono una cruenta rivolta nella quale il terrorismo fu lo strumento principale. Anche la parte moderata reagì e, sotto la guida di Surendranath Banerjea, lanciarono una campagna di boicottaggio contro le merci non indiane, a cui fece seguito il lancio di un movimento Swadeshi che mirava a promuovere la creazione di industrie e di attività economiche gestite da indiani, in concorrenza con quelle straniere, in particolare britanniche. Fu inoltre deciso di boicottare le istituzioni scolastiche inglesi, creandone nuove “nazionali”.
La reazione alla divisione del Bengala acuì, all’interno del Congresso le tensioni tra “moderati-liberali” e gli “estremisti-rivoluzionari”, che volevano inasprire la protesta, mentre i moderati riponevano comunque le loro speranze nei liberali inglesi che nel 1906 conseguirono un successo elettorale ed espressero un ministro per le Indie - John Morley - stimato dai dirigenti nazional-liberali indiani.
Il movimento ebbe un seguito che andò ben oltre le attese coinvolgendo gran parte della popolazione urbana di Calcutta, i cui interessi erano danneggiati dalla promozione di Dacca a capoluogo della nuova provincia e a porto concorrente. Ebbe l’appoggio anche dalla grande maggioranza dei proprietari terrieri del Bengala orientale, timorosi che la nuova provincia potesse implicare una revisione dell’imposta terriera, fissata dal permanent settlement del 1793. Come conseguenza vi fu un percepibile declino della vendita di merci inglesi in Bengala.
In realtà la provincia del Bengala orientale e dell’Assam era stata pensata per separare dalla presidenza del Bengala tutti i distretti dove i musulmani erano prevalenti. Questi ultimi, quindi, divennero la grande maggioranza degli abitanti della nuova provincia, dal momento che l’Assam era scarsamente popolato. Contemporaneamente la politica ufficiale, sia del governo dell’India sia del luogotenente-governatore del Bengala orientale e dell’Assam, divenne esplicitamente promuovere il reclutamento dei musulmani nella burocrazia e di appoggiare e favorire in ogni modo i pochi grandi proprietari terrieri musulmani dell’area dove, sebbene la classe contadina fosse musulmana, gli zamindar erano di solito indù. Questo spiega come il tentativo dei politici di Calcutta, appoggiato dai locali zamindar indù, di estendere il movimento di boicottaggio al Bengala orientale fu accolto con freddezza dalla locale classe contadina. Tale atteggiamento fu evidente per quei fittavoli in posizione relativamente agiata, i cui figli potevano aspirare alle posizioni che nella nuova provincia venivano loro offerte dalle autorità coloniali.
Nel corso del 1906 la freddezza si trasformò in tensione e questa sfociò in una
serie di incidenti fra indù e musulmani. All’emergere di una contrapposizione su
basi comunitarie fra gli indù e i musulmani del Bengala fece riscontro, a
livello panindiano, la creazione di un’organizzazione politica destinata a
contrapporsi al Congresso, rivendicando il ruolo di rappresentante di tutti i
musulmani indiani. Il 30 dicembre 1906 a Dacca venne ufficialmente fondata la
Ali-India Muslim League, Lega panindiana musulmana. Da quel momento in avanti,
la Lega si sarebbe presentata come il contraltare musulmano del Congresso,
arrogandosi la rappresentanza di tutti i musulmani indiani.
75. L’espulsione degli “estremisti” dal Congresso
Tra gli indù la lotta fra i “moderati” e la corrente capeggiata da Tilak divenne presto accanita, focalizzandosi su due richieste avanzate dagli estremisti. La prima era di modificare la costituzione del Congresso, inserendo fra i suoi obiettivi l’ottenimento di una forma di autogoverno uguale a quella goduta dai dominions bianchi. La seconda era di allargare il movimento di boicottaggio a tutta l’India. La risposta dei moderati fu proporre l’obiettivo di una forma di governo simile a quella dei dominions bianchi e l’allargamento a tutta l’India non del boicottaggio delle merci britanniche bensì del movimento Swadeshi, ovvero la promozione delle industrie indiane.
Nonostante i tentativi di mediazione, tali rapporti divennero così tesi che nel 1907 a Surat, all’inizio della sessione plenaria, i lavori del Congresso si dissolsero nel caos, in mezzo a violenti scontri fra i membri delle due correnti. A questo punto la maggioranza moderata, che contava circa 900 delegati su 1500, sotto la guida di Gokhale e di Pherozeshah Mehta (1845-1915), e con il pieno appoggio di Surendranath Banerjea, si riunì autonomamente e formalizzò l’espulsione degli estremisti.
La scissione del Congresso diede alle autorità coloniali la possibilità di intervenire con mano pesante. I principali dirigenti e i più attivi militanti della corrente estremista furono arrestati e, in genere, condannati a dure pene detentive. Tilak, processato per sedizione, fu condannato il 24 giugno 1908 a sei anni di carcere duro, da scontare in Birmania. Furono riattivate disposizioni, da lungo tempo dormienti, come la Regulation del 1818, che permetteva di deportare senza processo individui sospetti. Altre ne vennero introdotte ex novo, come l’Arm Acidel 1908, che comminava pene severissime a chiunque fosse complice di atti di terrorismo, o il Press Act del 1910, che puniva con l’imposizione di multe, con la confisca del giornale e con pene detentive i responsabili di articoli giudicati sediziosi. Come conseguenza, nella primavera del 1908, il “nuovo partito” estremista – ormai privo dei suoi capi – venne disperso e ridotto all’impotenza. Rimase ancora attivo un movimento terrorista, che fu presto completamente infiltrato dalle spie del Central Intelligence Department della polizia indiana, e che, per quanto potesse essere pericoloso a livello individuale per i singoli inglesi, era lungi dal rappresentare una minaccia reale per lo Stato coloniale.
Il Sud dravidico, invece, fu solo minimamente influenzato dal nascente
nazionalismo, che infatti vi rimase confinato in piccoli circoli di
intellettuali. Condizione a cui contribuirono una serie di fattori: un vasto
territorio in cui la scarsità dei centri urbani rendeva difficile la
comunicazione, la pluralità delle lingue, e in particolar modo la frattura
sociale tra le caste dei bramini e il resto della popolazione.
Abbiamo detto che nell’XI e XII secolo nascono o rinascono le città, in particolare nell’Italia e nelle Fiandre, ma anche nel nord della Francia, in Borgogna, in Provenza e nella Germania renana. In esse si insediano quei ceti pre-borghesi mercantili e di piccola nobiltà che si scontrano per poi fondersi e dare origine, intorno al XIII secolo, alla borghesia. Nell’Italia centro-settentrionale, sempre tra XI e XII secolo, si affermano i Comuni, i quali tendono a un’autonomia reale dall’Impero e all’autogoverno, in maniera più marcata rispetto alle altre regioni dell’ex Impero carolingio.
Insieme alle città e alla borghesia compaiono anche le “eresie”, in maniera incomparabilmente più evidente rispetto ai secoli precedenti del medioevo. Gli homines novi, come erano chiamati i borghesi, si confondevano talvolta o spesso, con i boni homines come erano chiamati gli eretici catari. Il cardinale francese Jacques de Vitry, viaggiando in Italia nel 1216, scrive: «Il Comune è come il leone di cui parla la Scrittura, che sbrana brutalmente, e anche come il dragone che si nasconde nel mare e vi spia per divorarvi (…) Ma ciò che c’è di più detestabile in queste babilonie moderne è che non esiste Comune in cui l’eresia non trovi i suoi fautori, i suoi manutengoli, i suoi difensori, i suoi credenti».
Tali concezioni religiose, eretiche e non, avevano quasi sempre alla base il millenarismo, con la sua attesa della fine dei tempi, il messianismo e il modello delle prime comunità cristiane, dove tutti i beni erano messi in comune. Queste concezioni non costituivano una ideologia utile alla borghesia, ma furono spesso fatte proprie anche da mercanti e borghesi. A questo possiamo dare due spiegazioni. La prima e più ovvia consiste nel dominio di una ideologia religiosa, che vedeva nel ritorno alle proprie origini l’unico rimedio possibile contro un presente “degenerato”, a causa della “degenerazione” della Chiesa e dell’Impero, istituzioni che avrebbero dovuto marciare sui binari della Provvidenza divina. Tale ideologia era spesso condivisa anche da borghesi e nobili, oltre che da contadini e plebe urbana. La seconda spiegazione, che più ci interessa, consiste nel fatto che la nascente borghesia sentiva confusamente il bisogno di una critica decisa all’intero sistema feudale, critica presente in tutte le concezioni millenaristiche e pauperistiche. In assenza di una propria ideologia, la borghesia si serviva di tali critiche, accettando insieme ad esse le concezioni di cui erano parte, eretiche o no. Tali ideologie, come sempre, erano inconsapevoli.
Il sogno-bisogno del comunismo
Patari, catari, valdesi, spirituali, fraticelli, micheliti, apostolici: queste le principali eresie tra XI e XIV secolo. Sulla nostra stampa abbiamo già parlato di “sogno-bisogno del comunismo”. Il comunismo diventa una possibilità reale solo con l’affermarsi del capitalismo, quando, dalla metà del XIX secolo, al sentimento comunista si unisce la ragione comunista, il nostro scientifico programma storico. Prima di allora il sentimento comunista, il sogno-bisogno di comunismo, presente fin dall’antichità in contrapposizione alle società di classe succedutesi nella storia, non poteva che prendere le forme del millenarismo, del messianismo, e dell’utopismo.
Quasi tutte le eresie non nascevano come tali e, finché restavano divergenze dottrinali, erano spesso tollerate. Non venivano più tollerate quando non obbedivano all’autorità del papa e dei vescovi, predicando e creando nuovi ordini religiosi senza il loro permesso. Nell’XI e XII secolo l’atteggiamento della Chiesa nei confronti degli eretici non era ancora univoco: nel Decretum Graziani del 1140, alla base del diritto canonico, e nella successiva Summa di Uguccione da Pisa, le misure contro gli eretici oscillavano tra la conversione, la confisca di tutti gli averi (misura sicuramente più diffusa), e nei casi più ostinati il carcere e la pena di morte. Nella Decretale del 1199, le cui prime parole sono Vergentis in senium saecoli corruptelam, traducibili con “la corruzione del secolo che volge alla fine”, papa Innocenzo III si richiama al diritto romano, ai codici di Teodosio e Giustiniano e alle pene allora riservate ai manichei. In tali codici, ripresi dal già nominato monaco Graziano nel suo Decretum, l’eresia viene assimilata a lesa maestà: il crimine contro l’imperatore diventa ora anche contro Dio ed è punito come eresia.
L’imperatore Federico II accentua il carattere repressivo della Vergentis per i suoi fini, e le norme da lui elaborate saranno poi accolte dalla Chiesa. Il rogo per gli eretici diventa ora più frequente che in passato, fino ad arrivare anche a quello dei cadaveri riesumati. Divennero più dure le pene per coloro che non denunciavano eretici a loro conoscenza, e che non partecipavano alle lotte o crociate indette dal papa o dai vescovi contro gli eretici, fino ad essere considerati tali, con tutte le conseguenze. È vero che talvolta il popolo minuto delle città e i contadini uccidevano e bruciavano i presunti eretici prima che la Chiesa si pronunciasse, ma è anche vero che le istituzioni cittadine partecipavano spesso senza alcuna voglia a queste iniziative vescovili e inquisitoriali. Questo a volte per simpatia verso gli eretici, ma soprattutto per il timore di veder limitare la propria autonomia a favore del vescovo, dell’Inquisizione e della Chiesa. Quanto all’Inquisizione, questa nasce nel 1184 con il concilio di Verona, presieduto da papa Lucio III e dall’imperatore Federico Barbarossa, con lo scopo di combattere patarini e catari.
I patarini
Le eresie di questi secoli erano molto più diffuse, anche geograficamente, di quanto generalmente si pensa. La più antica è la Pataria, che risale all’ XI e XII secolo. I patari, o patarini, nascono a Milano, in contrapposizione alla simonia (compravendita di cariche ecclesiastiche), al matrimonio dei preti e alla corruzione dell’alto clero, in particolare dei vescovi di Milano. La pataria si estese poi all’Italia settentrionale e oltre. Il basso clero veniva appoggiato dalla plebe, ma anche da artigiani e commercianti, e dalla piccola nobiltà che si contrapponeva alla grande nobiltà feudale, da cui in genere provenivano i vescovi.
Fino a che ebbero l’appoggio di alcuni vescovi, e anche papi, non erano considerati eretici. Ildebrando di Soana, cioè papa Gregorio VII, vide nel movimento un alleato nella sua riforma della Chiesa e nella lotta contro la corruzione degli ecclesiastici. Ma la visione di una Chiesa di poveri e uguali, ispirata al cristianesimo delle origini, non poteva essere accettata da una Chiesa espressione del mondo feudale e della sua classe dominante.
È evidente per noi comunisti che pretendere di eliminare la corruzione in una società di classe, senza eliminare i rapporti di classe che la determinano, è come svuotare il mare con un cucchiaio. Ciò non toglie che gli uomini di allora, a partire da quel papa, ci credessero. In questo le cose non sono molto cambiate: è tutt’oggi imperante la superstizione della legalità, la presunzione di eliminare la corruzione, le storture e le iniquità grazie alla legge e al diritto, ignorando i rapporti di classe che le generano e di cui sono solo il riflesso. Legge e diritto sono solo nomi nuovi che la classe dominante dà alla propria forza.
Quanto ai patari, con l’avvento di successivi papi e vescovi avversi alle riforme e alla moralizzazione della Chiesa, essi furono dichiarati eretici e finirono con lo scomparire. I più furono riassorbiti dalla Chiesa, una parte divennero catari.
Arnaldo da Brescia
Le idee di Arnaldo da Brescia, già allievo di Abelardo, erano affini a quelle dei patari. Quando arrivò a Roma, nel 1145, qui si era già affermato il potere del Comune, che aveva cacciato il pontefice. Le prediche di Arnaldo trovarono un grande favore presso il popolo minuto. Il potere era però nelle mani, più che degli artigiani e commercianti, della piccola nobiltà, a cui era utile la polemica anti-ecclesiastica e filo-imperiale di Arnaldo, per cui la sua scomunica nel 1148 non ebbe conseguenze.
Quando poi il papa nel 1155 lanciò l’interdetto sulla città di Roma questo provocò problemi a tutti, compresi i ceti popolari. Quando la piccola nobiltà che dirigeva il Comune, e anche i ceti proto-borghesi, decisero di riavvicinarsi al papa, Arnaldo fu sacrificato all’accordo tra il Comune e il papa, e tra l’imperatore e il papa: fu consegnato a quest’ultimo dall’imperatore Federico Barbarossa, fu bruciato sul rogo e le ceneri vennero disperse nel Tevere.
Scrive Mariateresa Beonio-Brocchieri Fumagalli nel suo “La Chiesa invisibile”: «Nel disegno dell’austero riformatore, il quale perseguiva l’ideale di una Chiesa povera e demondanizzata, si erano tracciate le linee di una sua radicale defeudalizzazione, di una soppressione alla radice dei legami fra l’istituzione religiosa e la istituzione feudale: e questi spunti antifeudali si erano ritrovati nelle lotte del comune romano, che era giunto a rovesciare, nei suoi sogni, il rapporto di forze che lo legava da un lato all’imperatore e dall’altro al papa».
I catari
I catari dall’XI al XIII secolo hanno rappresentato l’eresia più diffusa e più pericolosa per la Chiesa, con una propria Chiesa e dei propri vescovi. Erano detti anche albigesi, dalla città di Albi, nel sud della Francia. Erano molto diffusi nel sud della Francia e nel nord dell’Italia, ma anche oltre. Il ghibellino Farinata degli Uberti, di cui parla Dante nell’Inferno, era membro della Chiesa catara di Firenze, con meno membri di quelle del nord Italia, ma comunque di una certa importanza. Nella stessa città sono stati presenti gli spirituali francescani Pietro di Giovanni Olivi e Ubertino da Casale, che con le loro prediche hanno favorito la diffusione dei fraticelli. Anche gli apostolici, o dolciniani, se erano più diffusi nel nord Italia, erano comunque numerosi anche in tale città: sembra anche che avessero in Firenze i loro principali finanziatori. Ci sono state presenze catare anche a Viterbo, Rimini, Orvieto, come anche nelle Fiandre, in Inghilterra, Spagna e Germania.
Le dottrine dei catari si differenziavano notevolmente da quelle della Chiesa, e anche dalle altre dottrine considerate eretiche. Avevano una concezione dualistica influenzata dall’antico manicheismo, e dai contatti con gli affini bogomili dei Balcani. Tra i catari alcuni professavano un dualismo moderato, che poteva essere accettato dalla Chiesa, altri uno più radicale, con i principi del Bene e del Male della stessa importanza, come dire che Dio e Satana sono sullo stesso piano: una concezione che non poteva essere accettata. Per essi tutto ciò che è corpo e materia era il Male, quindi anche la proprietà, le ricchezze e il potere; Bene era solo l’anima e lo spirito, per cui molti di essi praticavano il digiuno, l’astinenza dalla procreazione, e alcuni anche il suicidio.
Concezioni simili, per cui il corpo e la materia sono il Male, o il Nulla, erano comunque diffuse anche in momenti e settori della Chiesa ufficiale. Papa San Gregorio Magno aveva definito il corpo «quell’abominevole veste dell’anima». San Luigi IX, re di Francia, aveva detto che «quando l’uomo muore, è guarito dalla lebbra del corpo». Agostino aveva detto che la materia è prope nihil, quasi nulla. A lui si richiamavano coloro che negavano valore alla materia.
Ma anche i sostenitori della tesi opposta: se la materia è quasi nulla, vuol dire che è comunque qualcosa. Se Dio ha assunto un corpo – dicevano – vuol dire che la materia ha una sua dignità, che non è il Nulla: il Nulla non può essere riferito a Dio. Così la pensava il filosofo francescano scozzese Duns Scoto, vissuto tra il 1265 o 1266 e il 1308: in lui questa interpretazione di Agostino si coniugava all’aristotelismo nel riconoscere una positività alla materia. La sua opera ha costituito un ponte verso il nominalismo di Ockham e la dissoluzione della scolastica.
Se le divergenze dottrinali con gli eretici erano importanti, ancora di più appariva il fatto di dare vita a una struttura ecclesiastica indipendente dalla Chiesa ufficiale. La visione di una Chiesa di poveri e uguali, in parte ereditata dai patari, aveva certamente una forte influenza sulle plebi urbane e rurali. I ceti mercantili e artigiani, e anche i piccoli nobili, vi trovarono un modo per affrancarsi dal potere della Chiesa, e talvolta anche dei re e dell’Impero. Per gli stessi motivi, a volte, ebbero anche l’appoggio della grande feudalità, come il conte di Tolosa Raimondo VI, che era anche duca di Narbona e marchese di Provenza. A causa della loro ostilità verso la Chiesa, i catari furono filo-imperiali e ghibellini, come pure in buona parte i patarini. Anche l’Impero, in un primo tempo, guardò ad essi con favore.
Data la diffusione dei catari e il pericolo che costituivano per la Chiesa, papa Innocenzo III nel 1208 indisse contro di loro una crociata, che si concluse con il loro sterminio. Si tramanda che dei soldati, nel sud della Francia, chiedessero al legato pontificio come fare a distinguere gli eretici dagli altri, e che la risposta fosse: «Uccideteli tutti, poi Dio riconoscerà i suoi». La frase probabilmente non è stata mai pronunciata, ma è significativa di uno sterminio che, secondo le stime più stringate dei legati pontifici, fu di 20.000 tra uomini, donne e bambini. I veri numeri furono sicuramente superiori, anche se inferiori al milione di cui parlarono i soldati crociati.
Ad avvantaggiarsi della crociata contro gli albigesi, oltre alla Chiesa, furono i re di Francia, che con Luigi IX, pochi decenni dopo, arrivarono a controllare il sud della Francia, grazie alla sconfitta e conseguente indebolimento della feudalità locale.
I valdesi
La stessa sorte dei catari fu subita dai valdesi, che erano presenti nel sud della Francia, dove cercavano di convertire i catari.
Valdo, o Valdesius, era un ricco mercante di Lione, nato tra il 1130 e il 1140 e morto tra il 1206 e il 1207. Un’anonima Chronica, di pochi anni successiva alla morte, dice che Valdo «aveva accumulato molto denaro per sé mediante l’iniquità del prestito a interesse». Ma nel 1173, all’età di circa 40 anni, lasciati i beni immobili alla moglie e il necessario per la dote alle figlie, dette tutto il suo denaro ai poveri e alle vittime della sua usura. La stessa fonte ci dice che già nel 1177 «iniziò ad avere compagni che, seguendo il suo esempio, elargendo ogni loro proprietà ai poveri, professarono spontaneamente la povertà. Poi, poco a poco, iniziarono a confessare, con ammonizioni pubbliche e private, i propri e gli altrui peccati».
I “Poveri di Lione”, poi chiamati valdesi, erano apprezzati dalla Chiesa per le loro prediche miranti a convertire i catari, e nel III Concilio ecumenico lateranense di Roma, nel 1179, venne approvata la loro confraternita. Il permesso di predicare era invece più difficile da ottenere, in quanto riservato al clero regolare. La povertà era apprezzata come pratica individuale, ma era pericolosa se presentata come esempio valido per tutta la Chiesa. Nel sopra nominato Concilio di Verona del 1184 fu promulgata la costituzione “ad abolendam”, dove leggiamo: «Decretiamo che siano colpiti da anatema perpetuo innanzitutto i Catari e i Patarini e coloro che, con falso nome, affermano mentendo di essere Umiliati o Poveri di Lione, Passagini, Giuseppini, Arnaldisti…».
I Poveri di Lione non erano ancora considerati esplicitamente eretici, o perlomeno non tutti; ma l’insistenza di Valdo nel voler predicare anche senza autorizzazione, e la conseguente ostilità del vescovo di Lione, li precipitò quasi subito nella condanna di eresia. Il gallese Walter Map, rappresentante del re inglese Enrico II plantageneto al concilio lateranense del 1179, comprese bene la situazione: «Costoro mai hanno dimore stabili, se ne vanno due a due a piedi nudi, vestiti di lana, nulla possedendo, ma mettendo tutto in comune come gli apostoli, seguendo nudi il Cristo nudo. Iniziano ora in modo umilissimo, perché stentano a muovere il piede; ma qualora li ammettessimo, ne saremmo cacciati».
Nel Liber contra Waldenses Haereticos dell’Anonimo di Passau, seconda metà del XIII secolo, leggiamo: «Non è difficile riconoscere gli eretici per i loro usi e i loro discorsi. Sono infatti di costumi ben ordinati e modesti; non si mostrano superbi nel vestire, perché non indossano abiti preziosi, né trasandati; non si dedicano ai commerci per evitare ogni occasione di mentire, di giurare e di frodare, ma vivono soltanto del lavoro delle loro mani come artigiani; anche i loro dottori sono tessitori o calzolai. Non si arricchiscono ma si accontentano del necessario. Sono anche casti, moderati nel mangiare e nel bere; non frequentano le taverne, né si danno alle danze o ad altre vanità; si trattengono dall’ira; lavorano sempre, o insegnano o imparano, e così pregano poco. Fingono di andare in chiesa, danno la loro offerta, si confessano, e assistono alla predica, ma per criticare il predicatore».
Anche qui troviamo molti artigiani e commercianti. Francesco di Assisi, nato circa 50 anni dopo, era a sua volta figlio di un ricco commerciante. Entrambi praticavano e predicavano la povertà. La principale differenza consisteva nel fatto che Francesco rimase nell’obbedienza al papa e alla Chiesa, mentre Valdo, tentando fino all’ultimo di evitarlo, se ne staccò, sostenendo che fosse più importante l’obbedienza a Dio.
Noi comunisti ci siamo comportati in maniera analoga: abbiamo tentato fino all’ultimo di opporci alla degenerazione staliniana del partito formale. Quando ciò non è più stato possibile abbiamo preferito restare fedeli al partito storico, per cui siamo stati dichiarati “eretici” da papa Stalin e dal suo vescovo Palmiro. Da lì è cominciata una lunga e difficile ricostruzione del partito formale, consistita innanzitutto nello sgomberare il terreno dalle macerie di una trionfante e ormai secolare contro-rivoluzione.
Tornando ai valdesi, anch’essi come i catari ebbero delle divisioni interne. I pochi sopravvissuti alle persecuzioni, nel XVI secolo si unirono alla riforma protestante. Le persecuzioni proseguirono, terminando solo con la rivoluzione francese e le successive “Lettere patenti” di Carlo Alberto nel 1848.
Gioacchino da Fiore
L’abate calabrese Gioacchino da Fiore era contemporaneo di Valdo: nato tra il 1130 e il 1135 e morto nel 1202. Rimase sempre nell’obbedienza alla Chiesa, per cui non fu dichiarato eretico, e la sua Congregazione florense venne riconosciuta dal papa nel 1196. Il IV Concilio lateranense del 1215 dichiarò eretiche alcune frasi contro Pietro Lombardo attribuite a lui erroneamente, come riconosciuto quasi subito dai vari papi. Le sue idee erano comunque lontane da quelle della Chiesa ufficiale, ed ebbero una grande influenza su eretici e non, e in particolare sui francescani spirituali.
Gioacchino parlava di tre età, o stati: l’età del Padre, l’età del Figlio, e l’età dello Spirito Santo. La prima età si identificava pressappoco con quella dell’antico testamento, la seconda, fino al 1260, con il vangelo, e la terza da quella data in poi, fino alla fine dei tempi descritta nell’Apocalisse di Giovanni. Il messianismo si unisce qui al millenarismo, generando una visione del tempo e della storia molto diversa da quella di Agostino di Tagaste. Agostino opponeva una Città di Dio a una Città terrena: in questa c’è la Chiesa, che è il riflesso della prima, ma tale dualismo scomparirebbe solo alla fine dei tempi, con il trionfo della Città di Dio. In questa visione la storia non esiste: con la venuta di Cristo tutto è compiuto, c’è solo un eterno presente che terminerà con la sua seconda venuta e l’Apocalisse. Il millenarismo non ha quindi bisogno del messianismo, dato che il messia è già venuto: il futuro e la storia non hanno più senso, dato che la speranza è divenuta realtà.
Neanche la scienza ha qui alcun senso. Se la verità è Dio, e Dio abita dentro l’uomo, è inutile conoscere il mondo esterno: l’uomo deve solo guardare dentro di sé. Il concetto di anima deve molto ad Agostino, come anche la coscienza, e pure la psicanalisi. Anche lui ha avuto dei meriti: dicendo che non esiste un “prima” della creazione, in quanto con essa Dio ha creato anche il tempo, ha intuito, a suo modo, la relatività del tempo.
Allo schema binario di Agostino si oppone quello ternario di Gioacchino, ispirato alla trinità. Non “tutto è compiuto” con l’apparizione di Cristo e della Chiesa: la “Chiesa carnale”, come la definisce, a causa dei suoi difetti (peccati), non ha la capacità di guidare gli uomini verso il “regno di Dio”. A questa seconda età, deve seguire una terza, quella della “Chiesa spirituale”, popolata da monaci e laici “santi”, dove non esistono gerarchie ecclesiastiche e imperiali, dove non esiste proprietà, dove tutti possono soddisfare i propri bisogni cooperando secondo le proprie inclinazioni e le proprie abilità: non secondo la nascita, la ricchezza, e il ruolo ricoperto nella struttura ecclesiastica o temporale.
Il mondo feudale non ha posto in questa prospettiva. Qui si riflette il bisogno di comunismo delle plebi urbane e rurali, in una visione che affascinava anche artigiani e mercanti, e a volte anche nobili ed ecclesiastici. Il “regno di Dio” si doveva dunque realizzare già nella storia, in quel “millennio sabbatico” in cui insieme alle altre differenze sarebbero scomparse anche quelle tra cristiani ed ebrei, e dopo il quale sarebbero arrivate le tribolazioni descritte nell’Apocalisse, e poi ancora il trionfo di Cristo e la fine dei tempi.
La visione di Agostino è propria delle classi sociali del tardo impero, di una società al tramonto che vede sé stessa come un eterno presente, perché non vede un futuro, che in effetti non ha. La visione di Gioacchino è frutto di un mondo feudale già in crisi, in cui le plebi, e anche i ceti proto-borghesi, attraverso il messianismo religioso si proiettano confusamente verso un futuro che non possono intravedere, ma che sentono fortemente.
Va detto inoltre che per Gioacchino le tre età, o stati, non hanno una semplice successione cronologica, ma si compenetrano: le ultime fasi di ogni età contengono i germi di quella successiva. Il presente contiene il futuro, il “regno di Dio” è già presente in coloro che operano per esso. Troviamo qui un’assonanza con la nostra concezione comunista, per cui il capitalismo genera e contiene il comunismo, comunismo che è già presente nel partito che opera per esso.
Sarebbe ridicolo parlare di dialettica riguardo a Gioacchino, ma ne possiamo attribuirgli una “scintilla”, nel senso in cui Agostino diceva che nell’uomo c’è una scintilla divina, senza per questo essere Dio. La concezione trinitaria dell’abate calabrese, la sua teologia, è la forma ideologica che assume una visione della storia riportata nel mondo reale, in cui c’è posto per l’agire umano; un agire che può modificare la realtà e realizzare il “regno di Dio” nel mondo, prima della “fine dei tempi”. La dottrina delle tre età richiama alla mente la dialettica triadica hegeliana, dove la storia è caratterizzata dall’affermarsi progressivo dello Spirito, che supera la forma precedente in un movimento ascendente di sintesi.
La teologia ebraico-cristiana resta alla base delle filosofie successive, come quelle di Kant e di Hegel. La fede in Dio si trasforma nella fede nella Ragione degli illuministi, e nella fede nel Progresso dei positivisti.
Secondo gli intellettuali della borghesia anche il marxismo, con la sua fede nel comunismo, sarebbe una sorta di religione, una sorta di eresia ebraico-cristiana. Sicuramente anche la nostra è una fede, a cui però si unisce la scienza: per la prima volta, col sorgere del capitalismo e la riflessione su di esso, al sentimento comunista si è unita la scienza, la ragione comunista, il nostro programma storico. I borghesi non possono che negare la nostra scienza, e fare del comunismo una caricatura dipingendoci come i millenaristi di cui abbiamo parlato: ne va della loro sopravvivenza come classe.
Domenicani e francescani
Gli Ordini mendicanti, cioè domenicani e francescani, detti anche frati predicatori e frati minori, sono stati riconosciuti dal papa rispettivamente nel 1217 e nel 1209. Lo spagnolo Domenico di Guzman (1170-1221) e Francesco di Assisi (1182-1226) praticavano e predicavano la povertà e l’assenza di proprietà per i singoli e per i propri Ordini. In questo non si distinguevano da coloro che erano considerati eretici: la “povertà apostolica” era propria della polemica riformatrice ed ereticale.
Gli Ordini mendicanti inizialmente non avevano rapporti con le classi feudali, e operavano nelle città, a contatto con le plebi, gli artigiani e i mercanti: tutti costoro mal sopportavano la ricchezza feudale dell’episcopato e dei monaci delle abbazie. Domenico e Francesco per i loro ascoltatori erano credibili nelle loro prediche contro gli eretici, praticando anch’essi la povertà evangelica. Papa Innocenzo III, che aveva istituito i due nuovi Ordini, ne comprese bene l’importanza per il rinnovamento e la stessa sopravvivenza della Chiesa. Dapprima furono i domenicani a predicare contro le eresie e a guidare l’Inquisizione, ma furono presto seguiti dai francescani.
Cesare Vasoli, nel suo testo “La filosofia medioevale”, scrive: «Così la Chiesa, che aveva per secoli modellato le sue classi dirigenti sul tipo delle istituzioni feudali, dotandole di una cultura che era sostanzialmente quella elaborata da Alcuino per i dignitari dell’Imperium, seppe operare una trasformazione intellettuale e organica di grande portata. Gli Ordini mendicanti furono al tempo stesso lo strumento e il “luogo” di realizzazione di una nuova linea politica e culturale adeguata tempestivamente alle esigenze storiche del tempo».
Con l’aiuto del papa questi assunsero il controllo degli istituti universitari, nonostante l’aspra opposizione dei maestri secolari. Inizialmente erano solo i domenicani a dare importanza allo studio, con il fine di contrastare le eresie. A Francesco i libri non interessavano, ma con i suoi successori le cose cambiarono presto. La fedeltà al papa e alla Chiesa era il presupposto della funzione esercitata dai due nuovi Ordini.
La povertà fu in seguito accantonata dicendo che il singolo non poteva avere proprietà, ma poteva averne l’Ordine, per tutte le esigenze connesse alla propria missione. In tal modo spesso avveniva che i frati vivessero agiatamente, pur potendo sostenere di non possedere nulla.
Spirituali, micheliti, fraticelli
Già Francesco d’Assisi e i suoi seguaci più rigorosi nel sostenere la povertà evangelica, detti zeloti o zelanti, si contrapponevano ad altri, chiamati semplicemente “La Comunità”, desiderosi di allentare il rigore riguardante la vita dei frati. Tra questi ultimi Elia da Cortona, in realtà nato ad Assisi, collaboratore di Francesco e ministro generale dell’Ordine dal 1232 al 1239.
Intorno alla metà del secolo molti francescani fecero proprie le idee e le profezie di Gioacchino da Fiore, vedendo in Francesco colui che iniziava l’“età dello Spirito Santo”, in cui la Chiesa non sarebbe più stata guidata dalle gerarchie ecclesiastiche ma da “uomini spirituali”. Furono quindi detti “spirituali”, in contrapposizione agli altri, detti “conventuali”. Molto vicino agli spirituali era Giovanni da Parma, ministro generale dell’Ordine dal 1247 al 1257. Sia gli spirituali sia i conventuali generalmente cercavano di mediare e di evitare lacerazioni.
Un frate vicino a Giovanni da Parma, Gerardo da Borgo San Donnino (attuale Fidenza) nel 1254 scrisse un testo ispirato a Gioacchino e apertamente in contrasto con la posizione della Chiesa. Quattro anni dopo Bonaventura da Bagnoregio, che ne aveva preso il posto di generale dell’Ordine, che manterrà fino alla morte nel 1274, istituì contro Giovanni un processo per eresia: venne assolto ma costretto al silenzio. Bonaventura fu anche colui che scrisse la Legenda Major, una vita di San Francesco considerata l’unica vera ed ufficiale. Tutte le altre furono distrutte. Oltre ad esser un predecessore di Andrej Vyšinskij, Bonaventura lo fu anche di Andrej Ždanov e del MinCulPop.
Nel 1282 furono condannate le tesi del provenzale “spirituale” Pietro di Giovanni Olivi, le cui idee gioachimite ebbero larga eco, a cominciare dai suoi discepoli Ubertino da Casale e Angelo Clareno. Papa Celestino V, e cioè Pietro da Morrone, concesse ai marchigiani Angelo Clareno e fra’ Liberato, con i quali era anche Jacopone da Todi, di staccarsi dai minori e formare un proprio Ordine, i “Poveri eremiti di papa Celestino”. Ma il nuovo papa Bonifacio VIII abolì il nuovo Ordine, e i suoi promotori si trovarono presto ad essere trattati come eretici: si definirono ora come “Fraticelli della vita povera”. Papa Clemente V, con il Concilio di Vienne del 1312, pur volendo tutelare l’unità dell’Ordine, non concesse nulla agli spirituali, che vennero ora perseguitati apertamente dai loro superiori locali. Papa Giovanni XXII, eletto nel 1316, chiuse la questione incaricando della repressione l’inquisitore Bernardo Gui. Nel 1318 gli spirituali furono dichiarati eretici e finirono spesso sul rogo: i primi quattro a Marsiglia nello stesso anno.
Diversa fu la vicenda di Michele da Cesena, ministro generale dal 1316 al 1328, che inizialmente aveva perseguitato gli spirituali. Al Capitolo di Perugia, nel 1322, difese le tesi dei francescani sulla povertà di Cristo e degli apostoli, come singoli e in comune; tesi rifiutate, con sottigliezze giuridiche, da papa Giovanni XXII. Papa Niccolò III nel 1276 aveva accettato riguardo ai francescani la povertà dei singoli e dell’Ordine, sostenendo che la proprietà dei beni fosse della Chiesa e che i frati ne avessero solo l’uso di fatto. Questa concezione era già stata sostenuta da Bonaventura, e contestata dagli spirituali in quanto legittimava la ricchezza della Chiesa. Papa Giovanni XXII sostenne che la tesi che Cristo e gli apostoli non avessero proprietà è eretica, in quanto erano proprietari delle loro povere cose. Il papa sospese Michele dalla sua carica, a cui però fu riconfermato dai francescani. Nel 1328 Michele definì il papa eretico. Il papa lo scomunicò assieme agli altri francescani Bonagrazia da Bergamo e Guglielmo di Ockham. Nessuno dei tre apparteneva agli spirituali. Tutti e tre trovarono rifugio presso l’imperatore Ludovico il Bavaro.
Dopo la scomunica la gran parte dei francescani abbandonò Michele. Quelli che gli restarono fedeli furono detti micheliti, o anche “Fraticelli d’opinione”, in quanto condividevano l’idea di povertà della Chiesa degli altri “fraticelli”, ma non la praticavano con lo stesso rigore. Comunque gli spirituali non costituivano un gruppo omogeneo, avevano concezioni diverse tra di loro, per cui i loro scritti furono talvolta usati dal papa per sostenere le proprie tesi, e per metterli gli uni contro gli altri.
Il Roman de la Rose
Il “Roman de la Rose” è formato da due parti nettamente diverse. La prima, composta tra il 1229 e il 1236 da Guillaume de Lorris, è un’allegoria della vita amorosa nella tradizione e nello spirito della lirica cortese. Dopo alcune aggiunte di un autore anonimo, tra il 1275 e il 1280 abbiamo una seconda parte ad opera di Jean Chopinel de Meung-sur-Loire. La narrazione allegorica assume ora il carattere razionalista proprio dell’autore, formatosi nella tradizione scolastica di Abelardo, Giovanni di Salisbury e Alano di Lilla: era molto vicino a quegli ambienti universitari dei maestri secolari in durissima polemica con gli Ordini mendicanti. Nel racconto ci sono ampie citazioni de “La Consolazione della Filosofia” di Boezio, e del “Policraticus” di Giovanni di Salisbury, insieme a molte altre: la scarsa originalità non ne diminuisce l’importanza. La vena comico-satirica e le manifeste allusioni erotiche in parte ne spiegano la diffusione tra borghesi, nobili ed ecclesiastici. Il neoplatonismo dell’autore approda ad una celebrazione della Natura, e con essa del sesso, in quanto si afferma che la Natura è “vicaria di Dio”, il quale le ha dato il compito di perpetuare la specie umana.
Il borghese Jean de Meung si richiama al millenarismo gioachimita e alla credenza in una “età dell’oro”, forgiando una visione certamente cristiana, ma più adatta ai borghesi e ai maestri secolari delle università. Questo per la critica veemente contro la corruzione degli ecclesiastici e degli Ordini mendicanti, ormai assimilatisi al resto della Chiesa; critica che investe i rapporti feudali, che la neonata borghesia sente come delle gabbie di cui vorrebbe allargare le sbarre, senza ancora considerare la possibilità di distruggerle. Il francescano “Falsembiante”, uno dei protagonisti del racconto, viene descritto come un lupo nascosto sotto la pelle di una pecora, e come il trasformista Proteo. Nella società mercantile che si viene sempre più affermando, il denaro, che tutto può comprare e corrompere, diviene sempre più l’equivalente di tutte le cose: è proteiforme esattamente come Falsembiante.
«Una volta, al tempo dei nostri primi padri e delle nostre prime madri, come testimoniano gli scritti degli antichi, ci si amava di puro e leale amore, e non per bramosia e desiderio di rapina, e la bontà regnava nel mondo (…) La terra allora non era coltivata, ma era come Dio l’aveva ornata, e portava spontaneamente ciò da cui ciascuno traeva sostentamento.
«Nessun re né principe aveva ancora strappato criminalmente il bene altrui. Tutti erano eguali e non avevano nulla in proprio; conoscevano bene la massima che l’amore e l’autorità non si fecero mai compagnia e non abitarono mai insieme; essi sono divisi da colui che domina.
«Giasone non aveva ancora costruito le sue navi e passato il mare per conquistare il vello d’oro (…) Tuttavia Inganno venne, lancia in resta, con Peccato e Disgrazia che non si curano di Sufficienza; Orgoglio, che la disdegna egualmente, apparve con il suo seguito: Cupidigia, Avarizia, Invidia e tutti gli altri vizi. Fecero uscire Povertà dall’inferno, dove era rimasta per tanto tempo che nessuno sapeva niente di lei. Maledetto sia il giorno esecrando in cui Povertà venne sulla Terra! (…) Ben presto quei maligni, forsennati di rabbia e di invidia nel vedere gli uomini felici, invasero tutta la Terra, seminando discordie, liti, controversie e conflitti, querele, dispute, guerre, maldicenze, odi e rancori; e siccome andavano pazzi per l’oro, fecero scavare la terra per trarre dalle sue viscere i tesori nascosti, metalli, pietre preziose (…) Appena il genere umano fu in preda a questa banda, cambiò la sua prima maniera di vivere; gli uomini non smisero di far il male; diventarono falsi e truffatori, si affezionarono alle loro proprietà, divisero perfino il suolo e per la divisione segnarono dei limiti, si combattevano fra di loro togliendosi quello che potevano; i più forti ebbero le parti maggiori (…)
«Allora si dovette cercare qualcuno che sorvegliasse le capanne, arrestasse i malfattori e rendesse giustizia a coloro che si lamentavano, e al quale nessuno osasse contestare l’autorità; allora si riunirono per eleggerlo. Scelsero fra loro un grande contadino, il più ossuto, il più tarchiato e il più forte che potessero trovare, e lo fecero principe e signore. Questi giurò di salvaguardare la giustizia e di difendere le loro capanne, se ciascuno personalmente gli avesse dato di che vivere sui propri beni, ed essi acconsentirono (…) Si dovette riunire di nuovo il popolo e imporre la taglia a ciascuno, per fornire dei sergenti al principe. Essi accettarono allora la taglia in comune, gli pagarono rendite e tributi e gli concessero vaste terre. Questa è l’origine dei re, dei principi terrieri (…) Da quel momento gli uomini ammassarono dei tesori. Con l’oro e l’argento, metalli preziosi e malleabili, fabbricarono vasellame, monete, fibbie, anelli, cinture; con il ferro resistente forgiarono armi, coltelli, spade, alabarde, lance e cotte di maglia per combattere i loro vicini. Nello stesso tempo innalzarono torri e palizzate e mura con pietre tagliate; fortificarono città e castelli e costruirono grandi palazzi scolpiti, poiché quelli che erano in possesso di ricchezze avevano paura che fossero loro rubate furtivamente o con la forza. Da allora furono molto più da compiangere quegli uomini sventurati, poiché non ebbero più alcuna sicurezza dal giorno in cui si appropriarono per cupidigia di ciò che prima era in comune come l’aria e il sole».
Il millenarismo e la vagheggiata età dell’oro non sono altro che il sogno di una società senza proprietà privata, senza classi, senza Stato, e senza re.
Lo storico Jacques Le Goff ne “La civiltà dell’occidente medievale” scrive: «Questo mito (…) sebbene mascherato e combattuto dalla Chiesa ufficiale, sconvolse gli spiriti e i cuori, rivelandoci la vera essenza delle masse popolari del medioevo, le angosce economiche e fisiologiche di fronte a questi dati permanenti della loro esistenza: la soggezione ai capricci della natura, alle carestie, alle epidemie; le rivolte contro un ordine sociale che schiaccia i deboli e una Chiesa beneficiaria e garante di questo ordine; i loro sogni: sogno religioso, ma che attira il Cielo sulla Terra e intravede la speranza solo al termine di terrori indicibili. Il desiderio lancinante che esso rivela di andare “in fondo all’ignoto per trovare cose nuove” non giunge a immaginare un mondo veramente nuovo. L’età dell’oro degli uomini del Medioevo altro non è che un ritorno alle origini. L’avvenire era dietro di loro. Camminavano voltando la testa indietro».
Le masse popolari di cui parla Le Goff si distinguevano già tra plebi rurali e urbane, e ceti mercantili e in parte artigiani che andavano costituendo la nuova classe borghese. La visione era comune solo parzialmente e apparentemente. Da lì la borghesia ha cominciato a prendere una strada diversa da quella delle classi subalterne, andando di conseguenza alla ricerca di una propria e nuova visione del mondo.
I dolciniani
I dolciniani furono così definiti, ma loro si chiamavano semplicemente apostoli.
Fondatore del movimento, nel 1260, fu Gherardo Segarelli, nato vicino Parma un ventennio prima. Le sue idee di pauperismo radicale, di influenza gioachimita, non si differenziavano da quelle dei francescani spirituali o di altri gruppi, eretici e no. Chiese di entrare nell’ordine dei francescani ma non fu accettato. Le notizie che abbiamo su di lui, di parte avversa, provengono dalla Cronica di Salimbene de Adam di Parma, francescano spirituale e gioachimita, che non poteva avere simpatie per chi tentava di sottrarre aderenti al proprio Ordine. Definisce Gherardo “idiota e illetterato”, facendo intendere che la sua eresia fosse dovuta più a ignoranza che a malvagità. Accusa i suoi seguaci di non praticare né l’obbedienza, né la povertà, né la castità. Poiché questi vivevano esclusivamente di elemosine, li critica adoperando le parole di Paolo di Tarso: «E quando eravamo con voi questo precetto vi davamo, che se uno non vuol lavorare, neppure deve mangiare».
Salimbene dice anche che Gherardo rifiutò di essere il capo dei suoi seguaci, sostenendo, con le parole di Paolo, che «ciascuno renderà ragione di sé stesso a Dio». Il cronista dice anche che gli apostolici si divisero in due fazioni che vennero anche alle mani, fazioni di cui poi non si è più sentito parlare.
Nel 1286 papa Onorio IV decreta lo scioglimento degli apostolici, e Gherardo finisce per la prima volta in prigione. La condanna degli apostolici viene rinnovata da papa Nicolò IV nel 1290. Con l’elezione di Bonifacio VIII nel 1294 quattro apostolici finiscono sul rogo e Gherardo torna in prigione. Finisce anche lui sul rogo nel 1300, altri suoi seguaci negli anni successivi.
La “setta” degli apostolici ebbe una grande diffusione, anche se spesso è difficile stabilirne i confini con altri eretici. Era diffusa in tutta la Lombardia, termine che allora designava quasi tutta l’Italia settentrionale, e in particolare a Novara, Trento, Bergamo, Modena, Bologna. Abbiamo poi notizia di dolciniani a Firenze, Foligno e in Spagna: qui fu processato per eresia il galiziano Pietro di Lugo, che si salvò la vita abiurando, nell’anno 1322.
Dolcino da Novara nacque intorno al 1250, divenne discepolo di Gherardo sembra nel 1291, e capo degli apostolici subito dopo la morte di questo. Nella zona tra Trento e il lago di Garda, dove si fermò a predicare, conquistò numerosi seguaci. Spostandosi poi tra il vercellese e la Valsesia sembra fosse accolto con simpatia dai valligiani.
Nel 1304 occupò militarmente la Valsesia, grazie al sostegno armato di Matteo Visconti, signore di Milano e ghibellino, in funzione anti-guelfa. Nel 1306, venuto meno tale sostegno, Dolcino con i suoi seguaci che, sembra fossero circa 4.000, si ritirò sul Monte Rubello, nel biellese. Contro di lui fu bandita una crociata da papa Clemente V e dal vescovo di Vercelli Raniero degli Avogadro. I dolciniani si fortificarono e fecero delle scorrerie nei dintorni per rifornirsi, il che alienò loro la simpatia dei valligiani. Nel 1307, dopo circa un anno di battaglie, assedio, freddo e fame, furono sconfitti e sterminati. Prima finirono sul rogo Margherita di Trento, compagna di Dolcino, e Longino di Bergamo. Poi fu la volta di Dolcino, dopo essere stato torturato.
Quasi tutte le notizie che abbiamo su Dolcino provengono dall’inquisitore Bernardo Gui e dal suo scritto titolato “La setta di coloro che dicono di essere dell’ordine degli Apostoli e affermano di osservare la vita apostolica e la povertà evangelica: quando e come iniziò, chi ne furono gli ideatori, quali gli errori”. Da questo leggiamo:
«Dolcino riuscì a raggruppare nella sua setta, da luoghi lontani e in vasta misura, molte migliaia di persone di ambo i sessi, soprattutto in Italia, Toscana e regioni limitrofe (…) Dichiara inoltre che avversari suoi e ministri del diavolo sono i chierici secolari insieme con molti del popolo, potenti e tiranni e tutti i religiosi, specialmente i Predicatori ed i Minori (…)
«Afferma poi che tutti coloro che lo perseguitano, insieme con i prelati della Chiesa, saranno entro breve uccisi e annientati».
Dolcino fece anche delle profezie. Nella sua visione di ispirazione gioachimita, la Chiesa avrebbe attraversato vari stadi: il penultimo è quello della ricchezza e della corruzione. Domenico e Francesco hanno avuto una funzione positiva per la loro rinuncia ai beni terreni e al potere temporale. Ora che anche i loro Ordini sono degenerati c’è solo un ultimo stadio, quello iniziato da Gherardo Segarelli nel 1260 (anno da cui parte anche “l’età dello Spirito Santo” di Gioacchino). Dolcino profetizzò che Federico d’Aragona, re di Sicilia, sarebbe diventato imperatore e avrebbe sterminato papa Bonifacio VIII e tutti gli ecclesiastici, e che i suoi Apostoli avrebbero quindi trionfato, riportando la Chiesa alla povertà e alla purezza delle origini.
Bernardo Gui elenca venti errori di Gherardo e Dolcino:
«... 2) Che la Chiesa romana è quella meretrice che rinnegò la fede di Cristo di cui parla Giovanni nell’Apocalisse.
«... 5) Che solo quelli che sono detti apostoli e appartengono a questa congregazione sono la Chiesa di Dio e si trovano nello stato di perfezione dei primi apostoli di Cristo e pertanto non sono tenuti a obbedire ad alcun uomo, pontefice o altri che sia, poiché la loro regola, che deriva senza mediazione da Cristo, è condurre una vita libera e perfetta.
«... 12) Che tutti i prelati della Chiesa romana di ogni grado dal tempo di San Silvestro in poi, che deviarono dal modo di vivere dei primi santi, sono prevaricatori e corruttori, eccettuato il monaco che fu chiamato papa Celestino».
Papa Silvestro è colui che, secondo la tradizione, accettò la donazione di Costantino e quindi la ricchezza e il potere temporale.
«... 18) Che una chiesa consacrata non vale come luogo di preghiera più di una stalla per cavalli o per porci».
Dante Alighieri, nel canto XXVIII dell’Inferno, profetizza la sorte di Dolcino, anche se lo scritto in realtà è successivo alla sua fine. Dante fa parlare Maometto, che attende Dolcino nel girone degli scismatici. Lo scisma era considerato un peccato più grave dell’eresia, in quanto divideva la Chiesa. Il fatto che Dolcino fosse considerato scismatico ancor più che eretico, e accomunato a Maometto, dimostra che anche dopo la sua morte fosse ritenuto un grave pericolo per la Chiesa.
La sua fine pressappoco coincise con quella del suo movimento, almeno per quanto ne sappiamo. Il teorizzato e praticato ricorso alla violenza e alle armi distingue i dolciniani dagli altri eretici. Anche altri, a cominciare da patari e catari, avevano talvolta preso le armi in aiuto alla fazione ghibellina e imperiale. È anche vero che per gli apostolici ciò derivò da un’esigenza di difesa e di assedio. Nessuno però aveva teorizzato e praticato la cosa così apertamente: gli spirituali, ad esempio, al rogo opponevano solo la fuga. Pur con una certa cautela, e senza esagerarne la portata, possiamo affermare che con Dolcino il profeta armato prende il posto dei precedenti profeti disarmati.
Dal testo della Brocchieri-Fumagalli:
«La setta non aveva regole né istituzioni di noviziato e la stessa esilità dell’impianto ideologico e la forza tutta emotiva della sua denuncia avevano permesso che uomini di diversa estrazione e cultura e anche di diversi ideali si raccogliessero insieme. L’individuazione del gruppo o della classe che costituì il successo della setta apostolica è controversa e non permette quindi un discorso approfondito sulla fisionomia sociale dei dolciniani. Il Violante nota che il dolcinianesimo non si può risolvere in un moto contadino, ma che molti degli appartenenti alla setta provenivano da quella “che con termine moderno chiameremmo borghesia urbana”, mentre nell’ultima fase aderirono non pochi nobili minori».
Il comunismo evangelico di Dolcino aveva inevitabilmente successo tra contadini e plebi urbane. Come in altre eresie, c’erano anche molti artigiani e commercianti, e anche dei nobili. Per i borghesi che seguivano Dolcino vale la spiegazione già data: alla condivisione di una ideologia religiosa dominante va aggiunta la necessità di combattere il mondo feudale. Combattere contro l’Impero, e soprattutto contro il papato, era sentito indispensabile per affermare l’esistenza e l’autonomia di questa nuova classe sociale.
Il tutto in maniera confusa: le classi sociali hanno scarsa o nessuna coscienza dei propri interessi e delle proprie azioni. Borghesia e classi subalterne combattevano la stessa battaglia contro le classi feudali dominanti. Ci vorranno secoli perché le classi subalterne, con la nascita del moderno proletariato, si separino nettamente dalla borghesia, ormai dominante, e dalle mezze classi.
Apocalittica Borghese
Il termine “apocalisse” deriva dal greco apocalipsis, che significa manifestazione, rivelazione, apparizione, scoprimento. L’Apocalisse di Giovanni, scritta alla fine del I secolo, aveva principalmente questo significato. Con i secoli successivi e il medioevo il termine ha enormemente accentuato gli aspetti di morte, paura e terrore.
Oggi la visione apocalittica è maggiore nella borghesia atea e razionalista che in coloro che hanno una credenza religiosa. I borghesi, atei o religiosi che siano, sentono l’odore di morte di una classe che non ha futuro, e non possono e non vogliono credere ad un futuro senza capitalismo, in cui la propria classe cesserà di esistere. “Il mondo non ha futuro” – essi dicono – perché non possono pensare e dire che è la loro classe a non averne. Da qui le loro nere, cupe, angosciose visioni del domani, popolato dagli incubi del disastro ambientale, nucleare, ecc.
Naturalmente tutto ciò per essi non è dovuto al sistema di produzione capitalistico, ma alla imperfezione o alla malvagità della natura umana. Anche la fantascienza crea mondi, al di là delle apparenze, molto simili a quello reale: neanche nella fantasia la borghesia sa concepire un mondo non plasmato dai rapporti di produzione capitalistici.
La speranza delle religioni tradizionali, già claudicante dagli inizi, si è trasformata in disperazione. Il “regno dei cieli” si è materializzato in un incubo. Il futuro è scomparso. La speranza, il “regno dei cieli”, il futuro, delle religioni e poi della borghesia rivoluzionaria, e più esattamente delle classi che hanno preceduto la nascita del proletariato, sono stati ereditati dai comunisti.
Il sentimento comunista e il suo incontro con la ragione comunista
Tutti questi gruppi, eretici e non, intrisi di millenarismo, messianismo e gioachimismo, possono farci sorridere per le loro visioni ideologiche, ma sono dalla nostra parte della storia, in nome del condiviso sentimento comunista. I nomi citati fanno parte di un elenco lunghissimo, che comprende anche molte donne, come Chiara di Assisi e Margherita di Cortona.
Il termine “compagni” deriva dal latino “cum panis”, e indica coloro che mangiano lo stesso pane alla stessa mensa. Tale termine era comunemente usato dai francescani.
È solo con la nascita del capitalismo e la riflessione su di esso, culminata nel Manifesto del Partito comunista del 1848, che il sentimento si unisce alla ragione e alla scienza comunista, dando origine al nostro programma storico. In nome del comune sentimento comunista, con i vari Valdo, Francesco e Dolcino, sediamo alla stessa mensa e condividiamo lo stesso pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo.
Lo stesso pane che il capitalismo trasforma in pietra. Quest’ultima non è solo
una metafora: è già accaduto che alla farina venisse mescolata della polvere di
marmo, per aumentarne il peso e venderlo a prezzo maggiore. La realtà del
capitalismo è peggiore di qualsiasi fantasia, ed è peggiore di qualsiasi
complotto i borghesi si inventino, per dare una facile spiegazione a ciò che
essi non sanno, non possono, e non vogliono comprendere.
Per demistificare il contesto in cui si è sviluppato il primo colonialismo, i suoi rapporti fondiari, lo sfruttamento del lavoro e il suo rapporto con la razza all’interno delle prime reti commerciali dell’era feudale e coloniale, dobbiamo brevemente esaminare le origini del capitalismo commerciale e dell’usura, la loro crescita all’interno delle città-stato italiane e come alimentò il colonialismo spagnolo e portoghese, dando il via all’era mercantile e coloniale che avrebbe gettato le basi per l’ascesa del capitalismo industriale nel XVIII e XIX secolo.
1. - Schiavitù e reti commerciali nell’età medievale
Il primo grande impero schiavista in Europa fu quello romano. Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente nel V secolo d.C., la disintegrazione dell’autorità imperiale centralizzata non pose fine alle strutture economiche e alle relazioni su cui si basava l’impero. L’Impero Romano aveva funzionato fondamentalmente come una rete commerciale-tributaria, attingendo ricchezza dalle province sotto forma di tasse in natura inviate al cuore del paese e profitti derivanti dagli scambi commerciali. Gran parte dei beni dell’impero era prodotta in vasti latifundia coltivati da schiavi, che per lo più producevano grano, vino e olio d’oliva per l’esportazione. Gli schiavi provenivano per lo più dalle continue guerre di espansione territoriale dell’impero, che riducevano in schiavitù gli eserciti sconfitti e la popolazione delle nuove terre conquistate.
Il fenomeno si sarebbe ridimensionato solo nel primo Medioevo, con le mancate conquiste militari, che ridussero la cattura di schiavi, al depopolamento e alla frammentazione politica, che implicò, dopo la caduta dell’Impero d’Occidente, un decadimento delle reti commerciali. Tuttavia la schiavitù rimase dove era possibile trovare schiavi e dove le grandi tenute a latifondo non erano state smembrate. In tutta l’Italia settentrionale e in Gallia i latifondi furono frammentati in proprietà più piccole, passando a sistemi di agricoltura contadina indipendente e comunitaria sotto i Merovingi, che confiscarono gran parte delle terre dell’antica élite romana. In alcune parti della Gallia e delle Alpi le comunità contadine libere mantennero una notevole autonomia fino all’inizio del Medioevo, con le corti manoriali che si affermarono gradualmente nel VI e IX secolo.
Nell’Impero Romano d’Oriente i latifondi persistevano in Grecia e in Anatolia, sotto il controllo di potenti proprietari terrieri e della Chiesa, con i contadini dipendenti che assumevano un ruolo maggiore solo per la diminuzione dell’accesso agli schiavi, e nell’Italia meridionale e in Sicilia fino al VI e XI secolo, fino alle conquiste normanne. Il Nord Africa mantenne il sistema anche dopo le conquiste islamiche del VI e VII secolo, sotto nuovi quadri giuridici. In Iberia i Visigoti non smantellarono le vecchie latifundia, ma crearono una versione ibrida che utilizzava schiavi e affittuari, integrando nel nuovo Stato la vecchia classe senatoria e aristocratica proprietaria terriera.
Le società altomedievali, sia del mondo cristiano sia di quello musulmano, continuavano a fare ampio ricorso alla schiavitù come elemento fondamentale delle loro economie, delle loro strutture sociali e della loro guerra, anche se non aveva più il ruolo centrale di un tempo.
Nell’Europa cristiana, specialmente nell’impero bizantino e in quello franco, gli schiavi erano impiegati nelle famiglie, nell’agricoltura, nelle miniere e nelle marine come rematori. Sebbene la dottrina cristiana scoraggiasse la schiavitù, consentiva quella dei non cristiani, musulmani o pagani catturati in guerra o acquisiti attraverso il commercio. Anche nel mondo islamico, compresa al-Andalus nella penisola iberica, la schiavitù era profondamente radicata nella società. La legge islamica consentiva la schiavitù a condizioni specifiche, che di solito riguardavano i prigionieri non musulmani.
Il commercio di schiavi collegava regioni diverse attraverso complesse reti che trascendevano i confini religiosi e culturali. Le potenze cristiane e musulmane partecipavano entrambe alla cattura e alla vendita di schiavi in tutto il Mediterraneo, lungo le rotte trans-sahariane e attraverso l’Europa settentrionale. I predoni vichinghi catturavano schiavi nell’Europa settentrionale e li vendevano ai mercati musulmani e bizantini, mentre i commercianti musulmani trafficavano prigionieri slavi, africani e cristiani in tutto il mondo islamico. Nonostante gli insegnamenti religiosi ponessero dei limiti su chi potesse essere ridotto in schiavitù e su come dovesse essere trattato, la domanda di manodopera e i profitti derivanti dal commercio degli schiavi spesso prevalevano sulle restrizioni morali e teologiche, tanto che la schiavitù nel primo Medioevo era un’istituzione profondamente radicata e ampiamente accettata, che plasmava il potere politico, i sistemi economici e le interazioni interculturali.
Come la schiavitù così furono mantenute dall’epoca romana molte delle sue pratiche commerciali, marittime e proto-industriali. Poiché il Mare Nostrum dei romani, il Mediterraneo, rimaneva l’arteria centrale per il commercio e la circolazione delle merci, il controllo sulla costruzione navale e sulla logistica marinara era fondamentale nel Medioevo. Dopo la caduta di Roma in Occidente, l’Impero Romano d’Oriente, o Bizantino, ereditò e ampliò questa rete marittimo-commerciale e le sue tradizioni cantieristiche.
I bizantini mantennero gran parte del sistema navale romano, ma lo innovarono sviluppando navi da guerra avanzate, come il dromone, galea veloce a vela latina, e sperimentando per primi cantieri controllati dallo Stato e la logistica navale. Il dromone rimase la nave da guerra dominante della marina romana orientale dal VI secolo circa fino all’inizio del XIII, quando era ancora la nave da guerra più sofisticata del Mediterraneo e uno strumento cruciale che permise ai bizantini di rimanere la potenza dominante nella regione per secoli, nonostante le continue perdite territoriali. Costantinopoli divenne non solo un centro politico ma anche per la costruzione di navi, dove i mezzi tecnici della produzione, l’accesso al legname, la manodopera qualificata e le finanze statali erano organizzati in modo efficiente. Con il declino del potere bizantino sotto la pressione dei califfati islamici e, successivamente, dei turchi selgiuchidi e ottomani, si aprì un vuoto nel dominio navale del Mediterraneo.
2. - Prima marineria
Questo vuoto permise l’ascesa di città-stato marittime come Amalfi, Pisa, Venezia e Genova, che ripresero l’eredità cantieristica di Roma e Bisanzio e la rivoluzionarono in una prima forma di produzione industriale.
Le Repubbliche marinare acquisirono importanza prima delle loro controparti dell’entroterra grazie al loro accesso diretto alle rotte commerciali e alla potenza navale. Genova e Venezia divennero dominanti attraverso l’espansione del capitale mercantile a lunga distanza, controllando le rotte marittime, i porti e le enclavi coloniali nel Mediterraneo orientale e nel Mar Nero. A partire dall’XI secolo, Genova iniziò a costruire la sua potenza navale sostenendo le prime Crociate, sfruttando successivamente la sua alleanza con gli Stati crociati e lo Stato Pontificio per espandere il suo impero commerciale e costruire il suo potere finanziario e i suoi sistemi bancari.
Venezia dal IX secolo, costruì lentamente una potente marina mercantile statale che proteggeva dalla pirateria il commercio romano nell’Adriatico. Nell’XI secolo iniziò a soppiantare la flotta bizantina, al punto che l’impero venne a dipendere dalla navigazione veneziana, una debolezza critica che avrebbe finito per consentire la conquista latina di Costantinopoli durante la quarta crociata nel 1204 d.C. e alla fondazione di colonie in Dalmazia, Creta e Cipro.
L’Arsenale di Venezia fu il primo impianto di produzione su larga scala in Europa ad applicare sistematicamente la divisione del lavoro, la standardizzazione dei componenti e la gestione centralizzata. Venezia fu all’avanguardia nello sviluppo della galea italica, più veloce e superiore al dromone, con una struttura modulare che poteva essere prodotta più rapidamente. Al suo apice l’Arsenale era in grado di produrre una galea completamente equipaggiata in un solo giorno. I metodi di produzione navale erano segreti di Stato strettamente controllati, che permisero agli italiani di mantenere un monopolio quasi totale sulla produzione di galee per un secolo. La cantieristica navale a Venezia era il motore economico della Repubblica, che vi impiegava migliaia di artigiani in una struttura di corporazioni privilegiate che ne limitava l’emigrazione e strettamente controllate dallo Stato. L’Arsenale disponeva di processi semi-industriali che consentivano un rapido ampliamento delle flotte militari e commerciali. Lo sviluppo dei mezzi di produzione nella costruzione navale era alla base del potere militare veneziano, della sua influenza economica e, in ultima analisi, del suo ruolo nel plasmare la politica regionale e globale.
Il potere economico veneziano era profondamente radicato in sistemi di lavoro forzato, che spaziavano dalla produzione del sale, all’estrazione mineraria, all’agricoltura e alla guerra sul mare. Il sale in quel periodo era necessario alla conservazione degli alimenti. Era anche uno dei prodotti più commerciati dalla Repubblica, base dei suoi proventi, prodotto in condizioni brutali a Chioggia, Cervia e nelle colonie di Creta e Cipro dove lavoratori, spesso schiavi, prigionieri o locali a contratto, raschiavano il sale dalle vasche di evaporazione. Venezia impiegava un gran numero di schiavi e detenuti anche nelle miniere, soprattutto in Dalmazia e nelle isole dell’Egeo, per estrarre risorse fondamentali per la costruzione navale e le forniture militari. Sulle sue galee, soprattutto in tempo di guerra, Venezia impiegava migliaia di rematori schiavi e criminali: stime suggeriscono che una galea da guerra disponesse di 100-150 rematori e che durante le grandi campagne navali la Repubblica mobilitasse flotte di 100 o più navi, con oltre 10.000 uomini in condizioni brutali, incatenati ai banchi.
Il ducato, coniato per la prima volta dalla Repubblica nel 1284, divenne rapidamente la principale valuta internazionale in Europa grazie alla purezza dell’oro, al peso costante e all’ascesa del dominio commerciale e navale di Venezia. In un’epoca in cui molte valute europee erano svalutate e politicamente instabili, il ducato assurse a standard affidabile nel commercio europeo e mediterraneo. La sua circolazione si estese ben oltre i domini di Venezia, raggiungendo il Nord Africa, il Levante e l’Asia centrale, e divenne l’unità di conto predefinita per mercanti, banchieri e tesorerie statali. La stabilità del ducato sostenne la trasformazione di Venezia in una delle potenze commerciali e finanziarie dominanti in Europa, creandovi i primi sistemi bancari internazionali.
3. - Nei Comuni italiani
Ben presto sorsero altre città-stato italiane che diedero vita allo sviluppo di un capitale commerciale e da prestito all’interno del mondo feudale, creando le basi per l’ascesa della classe borghese e l’espansione del colonialismo in Africa, Asia e poi nelle Americhe, gettando le fondamenta per la nascita del capitalismo moderno nel XVIII e XIX secolo.
L’ascesa dei Comuni italiani tra l’XI e il XIII secolo segnò una significativa rottura nell’ordine feudale europeo, quando le città di Italia cominciarono ad affermare la propria autonomia politica ed economica dai signori feudali tedeschi raggruppati sotto il Sacro Romano Impero. I Comuni erano città-stato governate da consigli eletti e associazioni di corporazioni rappresentanti il crescente potere delle classi mercantili e artigiane urbane, organizzate in associazioni giurate per proteggere il commercio, la proprietà e la produzione locale. Con la rinascita del commercio lungo le rotte mediterranee e alpine, città come Milano, Bologna e Firenze divennero centri di attività artigianale e commerciale, sostenute da sistemi di milizie urbane, regolamenti corporativi e un governo sempre più centralizzato. I Comuni rappresentarono la forma embrionale del dominio borghese, in cui la produzione per il mercato e l’accumulazione di capitale cominciarono a sostituire l’estrazione feudale della rendita in natura.
Nel XIII e XIV secolo i Comuni dell’entroterra come Firenze, Lucca e Siena divennero centri di manifatture urbane, in particolare nel settore tessile. Firenze in particolare sviluppò un sistema industriale di produzione di tessuti di lana che impiegava migliaia di lavoratori salariati con una divisione del lavoro altamente organizzata, regolata dalla potente corporazione dell’Arte della Lana. Questa prima forma di produzione capitalistica basata sulla trasformazione del lavoro in plusvalore attraverso la produzione di merci prefigurava i sistemi industriali che avrebbero poi dominato nei Paesi Bassi e in Inghilterra.
L’ascesa precoce di Firenze nella produzione tessile durante il XII e XIII secolo fu sostenuta in modo significativo dal capitale genovese e veneziano, che finanziò l’importazione di materie prime, agevolò il credito commerciale e fornì il trasporto marittimo verso i mercati esteri. I mercanti genovesi finanziavano spesso la importazione di lana dall’Inghilterra, la materia prima fondamentale per la produzione dei tessuti fiorentini, mentre i commercianti veneziani fornivano l’allume, essenziale per fissare i coloranti, dall’Asia Minore attraverso le loro colonie orientali come Focea. Tra il 1250 e il 1350 le flotte veneziane e genovesi trasportavano ogni anno migliaia di balle di tessuti fiorentini nei porti del Mediterraneo, con Venezia che da sola prima del XIV secolo rappresentava quasi il 30% del commercio estero di tessuti di Firenze. Le corporazioni fiorentine dell’Arte della Lana e di Calimala (dei mercanti) facevano affidamento sui crediti concessi dai banchieri genovesi per acquistare lana inglese alla Borsa di Calais e sulle navi veneziane per raggiungere i mercati del levante come Alessandria e Costantinopoli.
Ma dal XII al XIV secolo i mercanti e i banchieri fiorentini strinsero ampi legami via terra con l’Europa settentrionale attraverso vie di comunicazione che collegavano Roma alle fiere della Champagne, alle Fiandre e all’Inghilterra attraverso i passi alpini. Queste rotte aggiravano i porti marittimi dominati da Venezia e Genova, consentendo a Firenze di intraprendere il commercio a lunga distanza pur senza una flotta.
Questi corridoi sicuri erano essenziali per l’importazione della lana inglese, che passava per Calais e le Fiandre, e per l’esportazione dei tessuti, della seta e dei beni di lusso fiorentini verso i mercati del nord. Per proteggere questi corridoi Firenze investì in trattati diplomatici, partnership commerciali e reti finanziarie con le città lungo il percorso, in particolare Lione, Ginevra e Bruges, dove le banche fiorentine come quelle dei Bardi e dei Peruzzi stabilirono avamposti per facilitare il credito, le cambiali e il movimento delle merci. Tutti i Comuni come quello fiorentino stringevano alleanze militari con le città vicine, intraprendevano guerre di espansione e costruivano infrastrutture stradali per garantire il passaggio sicuro dei mercanti e delle carovane attraverso gli Appennini e verso la Pianura Padana.
L’élite mercantile di Firenze, nelle sue potenti corporazioni e consorzi bancari, rese la città un nodo fondamentale nella rete europea della produzione tessile e infine sviluppò un proprio capitale finanziario, che si concentrò nella banca più famosa e potente d’Europa, quella dei Medici.
A differenza delle Repubbliche Marinare, la cui ricchezza si basava sul controllo della circolazione attraverso la potenza navale, Firenze crebbe inserendosi in una rete di città dell’entroterra e mercati transalpini, affidandosi a convogli commerciali armati, alla regolamentazione delle corporazioni e a strumenti finanziari per dominare i flussi di merci. Queste rotte commerciali interne permisero così l’emergere di una borghesia industriale-finanziaria, il cui potere non si basava sul dominio territoriale, ma sul controllo del lavoro, del credito e dello scambio produttivo.
In contrasto con il sistema feudale ancora dominante nel resto d’Europa, le città-stato italiane facevano sempre più affidamento sull’agricoltura per il mercato, guidata dai proprietari terrieri che erano nello stesso tempo dei borghesi urbani i quali affittavano le terre ai contadini o impiegavano manodopera salariata. Queste regioni agricole, in particolare nella Pianura Padana e nella campagna toscana, si specializzarono in colture orientate al mercato come olio, vino, lino e cereali, spesso destinati al consumo urbano o all’esportazione. Il risultato fu una parziale mercificazione della terra e del lavoro nelle campagne, con affitti pagati in denaro anziché in natura e un crescente ricorso a contratti, servitù per debiti e lavoratori stagionali, che segnarono una transizione verso rapporti capitalistici nell’agricoltura. Il trasferimento del surplus rurale nei circuiti urbani di produzione e commercio differenziò ulteriormente i Comuni dalle corti feudali, gettando le basi per uno scambio di merci più avanzato.
Le prime rivolte proletarie nelle città-stato italiane, in particolare quella dei Ciompi a Firenze nel 1378, furono espressione diretta dell’antagonismo di classe all’interno dei fiorenti centri manifatturieri urbani. I Ciompi, composti da cardatori di lana e altri lavoratori non qualificati esclusi dalla rappresentanza delle corporazioni, presero temporaneamente il potere e costrinsero la classe mercantile dominante a concedere concessioni politiche e a riconoscere le loro richieste. Un potere che i Ciompi condividevano con alcune delle “arti minori”, e cioè con quelle più in basso nella scala sociale, i cui membri, pur riuniti in corporazione, non vivevano in maniera molto dissimile da salariati come i Ciompi e i tintori, privi di corporazione. Sebbene la rivolta fosse repressa nel giro di un anno, riuscì a ottenere aumenti salariali temporanei, un più ampio accesso alle corporazioni e una maggiore consapevolezza politica tra gli strati più bassi dei lavoratori. Disordini simili si verificarono in altre città manifatturiere come Siena, Bologna e Milano, dove artigiani e lavoratori tessili chiedevano periodicamente condizioni migliori e resistevano al dominio oligarchico. Come risultato di queste lotte, il costo del lavoro nei Comuni italiani rimase relativamente più alto e il sistema delle corporazioni, sebbene oppressivo di per sé, impose alcune tutele salariali e lavorative che limitarono lo sfruttamento incontrollato dei lavoratori.
Al contrario, nel settore tessile olandese, soprattutto a Leida e Haarlem, vigevano condizioni che consentivano un maggiore sfruttamento della manodopera e costi di produzione più bassi. Senza il retaggio delle forti rivolte delle corporazioni urbane e con l’aiuto di una organizzazione industriale sostenuta dallo Stato, i capitalisti olandesi potevano assumere immigrati, donne e lavoratori non qualificati a salari più bassi con una regolamentazione minima. Gli olandesi non avevano l’intralcio di compromessi politici radicati, retaggio della lotte fra corporazioni in Italia, il che consentiva un regime di lavoro più flessibile e orientato al profitto. Grazie al loro accesso privilegiato alle rotte marittime, ai collegamenti con i mercati del Baltico, del Mediterraneo e, infine, dell’Atlantico, i mercanti olandesi potevano produrre tessuti più economici e trasportarli facilmente in tutta Europa, superando gradualmente le città italiane, che rimanevano legate a una produzione su piccola scala e ad alto costo. Con l’ascesa del dominio spagnolo e la sua dipendenza dai suoi artigiani e dalle sue banche, gli olandesi avrebbero presto soppiantato l’Italia come potenza finanziaria mondiale.
4. - Le banche italiane e il colonialismo atlantico
L’ascesa della classe borghese mercantile non fu ottenuta inizialmente attraverso l’impianto della produzione in modo capitalistico, ma dalla rapina coloniale delle civiltà indigene dell’Asia e dell’Africa, dal saccheggio dei templi e ricchezze e dalla schiavitù dei loro popoli da parte dei portoghesi e poi degli spagnoli. Successivamente la conquista delle Americhe e la tratta degli schiavi portarono al rapido arricchimento delle classi mercantili dell’Europa occidentale. Se gran parte di queste ricchezze finiva alla aristocrazia terriera e alle monarchie che finanziavano le flotte, gettavano i semi della loro caduta come classe dominante.
L’era mercantilista del colonialismo significò essenzialmente pirateria spietata, banditismo organizzato e spoliazione di massa promossi da una intraprendente borghesia mercantile. Ma la borghesia sarebbe riuscita a conquistare il potere statale e a farsi classe sociale dominante solo in una fase successiva, dopo che aveva lentamente assunto il controllo della produzione manifatturiera, vincendo il protezionismo delle corporazioni e organizzandola su basi capitalistiche, come avvenne dapprima nelle Fiandre e in Inghilterra.
Il capitale mercantile precedette il capitale bancario, che a sua volta precedette il capitale industriale. L’attività bancaria nacque come strumento del capitale mercantile per agevolare le transazioni nel tempo, nello spazio e tra giurisdizioni diverse. Le banche sorsero nei porti di Genova, Venezia, Pisa e infine Firenze. Il sistema bancario non avrebbe potuto svilupparsi senza la supremazia navale. Le città-stato utilizzavano le flotte per proteggere le rotte commerciali del Mediterraneo dai rivali e dai pirati.
Nel XV secolo i Medici salirono al potere non combattendo la Chiesa, ma diventandone i banchieri. Il capitale mercantile si assicurò il suo posto finanziando l’autorità feudale. Come scrisse Marx nel Terzo volume de Il Capitale, «il capitale mercantile dipende sempre dal plusvalore proveniente dal capitale alla produzione». Pertanto sulla scena mondiale quella dei mercanti continuò a essere una classe secondaria rispetto ai signori feudali.
Nonostante il suo ruolo di capitale finanziario nel mondo occidentale, a differenza della Spagna e del Portogallo, l’Italia era politicamente frammentata, divisa in città-stato rivali. Non esisteva una monarchia unificata o un governo nazionale in grado di mobilitare investimenti statali a lungo termine, né una grande disponibilità di popolazione per stabilire un controllo coloniale su popolazioni indigene e su grandi estensioni di terre. Pertanto, le città-stato italiane perseguivano il dominio regionale e il commercio mediterraneo, non imperi e acquisizione di territori d’oltremare. Il capitale mercantile in Italia rimase racchiuso nelle mura cittadine, senza uno Stato nazionale unitario che lo difendesse.
Fu quindi la corona feudale spagnola a finanziare l’avventuriero genovese ed ex marinaio mercantile Cristoforo Colombo, che arrivò nelle Americhe nel 1492. La monarchia spagnola voleva rompere il monopolio portoghese sulle rotte commerciali orientali verso l’Asia, espandere il proprio dominio territoriale e arricchirsi col saccheggio coloniale. I regni iberici di Castiglia, Aragona e Portogallo erano impegnati in una rivalità feudale ma il Portogallo si era assicurato l’appoggio papale per le sue conquiste in Africa e in Asia. Il viaggio di Colombo fu l’occasione per la Spagna di rivendicare nuovi territori, minare l’egemonia commerciale portoghese e riaffermare il prestigio spagnolo dopo secoli di frammentazione e guerre.
Il viaggio di Colombo fu una mossa nella competizione tra Stati assolutisti per la supremazia globale, all’alba del mercato mondiale capitalista. Come scrisse Marx nel Primo volume de Il Capitale: «La scoperta dell’oro e dell’argento in America, lo sterminio, la schiavitù e la sepoltura nelle miniere della popolazione aborigena, l’inizio della conquista e del saccheggio dell’India e la conversione dell’Africa in una riserva di caccia per il commercio ai negri segnarono l’alba rosea dell’era della produzione capitalistica. Questi idilliaci procedimenti sono i momenti principali dell’accumulazione primitiva. Subito dopo seguì la guerra commerciale delle nazioni europee, con il globo come teatro (...) La schiavitù è una categoria economica della massima importanza. Senza schiavitù non c’è cotone; senza cotone non c’è industria moderna. È la schiavitù che ha dato valore alle colonie; sono le colonie che hanno creato il commercio mondiale, e il commercio mondiale è la condizione preliminare dell’industria su larga scala».
5. - La trasformazione agricola nella penisola iberica
Dopo il crollo dell’Impero Romano d’Occidente nel V secolo, la penisola iberica conservò molte delle strutture agricole e sociali ereditate dal dominio romano. Tra queste spiccava il sistema dei latifundia, vaste tenute di proprietà delle élite e coltivate da schiavi o contadini. Mentre durante il periodo visigoto (V-VIII secolo) il modello classico romano di schiavitù declinava, la struttura di base della concentrazione della proprietà terriera sopravvisse. Le grandi tenute continuarono a funzionare, ora sempre più dipendenti da coloni o da braccianti legati alla terra in condizioni di semi-servitù. Questa continuità rifletteva il potere duraturo delle élite terriere, che mantennero il dominio agricolo nonostante la disintegrazione del controllo politico romano. Nel Sud, l’ex provincia della Betica continuò ad essere un centro di produzione di olio d’oliva e cereali, con grandi tenute che costituivano il nucleo dell’economia rurale.
Con la conquista musulmana della penisola iberica, iniziata nel 711, queste strutture fondiarie non furono né abolite né completamente sostituite. Al contrario, sotto il dominio del califfato omayyade e delle successive dinastie musulmane locali, molte grandi tenute continuarono a funzionare, spesso ampliandosi e migliorandosi grazie all’introduzione di sofisticati sistemi di irrigazione (qanāt, acequias) e alla coltivazione di nuove colture come agrumi, cotone e riso. I governanti musulmani mantennero relazioni agrarie gerarchiche. Mentre alcune terre erano detenute direttamente dallo Stato o distribuite alle élite militari secondo il sistema dell’iqṭāʿ, vaste aree dell’Iberia meridionale continuarono a funzionare in modo molto simile a quelle dei loro predecessori romani, con i proprietari terrieri che supervisionavano il lavoro dei contadini musulmani, degli schiavi e dei lavoratori stagionali. I trattati agricoli dell’Al-Andalus, come quelli di Ibn al-‘Awwām, testimoniano le avanzate tecniche agronomiche sviluppate sotto questo sistema, ma rivelano anche la continua importanza della produzione basata sul latifondo.
Per Reconquista si intende il lungo processo con cui i regni cristiani dall’VIII al XV secolo conquistarono i territori musulmani nella penisola iberica. Essa accelerò il ritorno del modello latifondistico in termini esplicitamente cristiani e feudali. Man mano che le terre musulmane venivano confiscate, i monarchi cristiani le ridistribuivano secondo sistemi come il repartimiento (Castiglia e Aragona) e l’aforamento (Portogallo). Queste politiche concedevano grandi appezzamenti di terra ai nobili, agli ordini militari (come l’Ordine di Santiago o di Calatrava) e alla Chiesa cattolica. Ai beneficiari di queste proprietà veniva spesso concesso il controllo giurisdizionale sui contadini e il diritto di esigere tributi, manodopera o affitti. In molte zone, in particolare in Andalusia, Estremadura e Alentejo, le proprietà post-Reconquista assomigliavano molto ai latifundia romani, con enormi tenute lavorate da contadini musulmani (mudéjares), poi cristianizzati forzatamente (moriscos), schiavi o contadini cristiani senza terra. I prigionieri musulmani della guerra di Granada (terminata nel 1492) e delle battaglie precedenti furono ridotti in schiavitù su vasta scala e costretti ai lavori agricoli. In Portogallo, soprattutto nel Sud, la grande tenuta (morgado o latifúndio) divenne la forma agraria dominante, rispecchiando quanto avveniva in tutta la penisola.
Nel XVI secolo il sistema dei latifundia era stato completamente ristabilito e istituzionalizzato sia in Spagna sia in Portogallo. Le tenute erano legalmente garantite attraverso i mayorazgo (feudi ereditari) che impedivano la divisione della terra e rafforzavano i monopoli aristocratici. Il lavoro in queste tenute era sempre più diversificato: schiavi musulmani, servi cristiani e braccianti lavoravano tutti gli stessi appezzamenti, a seconda della regione e del raccolto. Il predominio delle grandi tenute soffocò l’innovazione agraria in molte zone e creò forti divisioni di classe nella vita rurale.
Pertanto il sistema dei latifondi in Iberia non scomparve con l’Impero Romano, ma si evolse attraverso le fasi visigota, islamica e feudale cristiana, raggiungendo una rinnovata forza sulla scia della Reconquista. Questo sistema divenne il pilastro strutturale della ricchezza interna delle corone spagnola e portoghese, fornendo cereali, bestiame, olio d’oliva e altri prodotti di base necessari per sostenere gli Stati militari e amministrativi in espansione.
La Reconquista infatti non fu solo una campagna territoriale e religiosa, ma anche una lunga scuola pratica di organizzazione militare, di sfruttamento del lavoro e di amministrazione agricola. I signori cristiani impararono a gestire le grandi tenute confiscate ai proprietari terrieri musulmani e a organizzare la forza lavoro composta da vari popoli soggiogati: mudéjares, moriscos e schiavi africani. Queste esperienze costituirono il modello logistico e ideologico per la successiva espansione oltremare. Le istituzioni di gestione delle proprietà, del lavoro forzato e della proprietà terriera create in Iberia sarebbero state successivamente esportate quasi senza soluzione di continuità nelle colonie. Non è un caso che i sistemi dell’encomienda e dell’hacienda nelle Americhe e delle fazendas in Brasile rispecchiassero i latifundia iberici tanto per dimensioni quanto per funzionamento. Le élite iberiche sapevano già come trarre profitto dalla servitù di massa e dall’agricoltura di tipo coloniale, perché lo avevano fatto per secoli nella loro terra natale.
6. - La potenza navale portoghese
Parallelamente a questo consolidamento agrario, si assistette all’ascesa della potenza navale portoghese. Dopo la Reconquista, il Portogallo emerse come un piccolo regno relativamente povero di risorse, con un territorio limitato e pochi mercati interni rispetto al vicino iberico, la Castiglia. Geograficamente confinato al margine atlantico dell’Europa, il Portogallo non disponeva delle ricchezze agricole né della manodopera necessarie per espandersi via terra. Questi limiti materiali lo spinsero verso l’espansione marittima. Riconoscendone il potenziale, la corona portoghese, soprattutto sotto il principe Enrico il Navigatore, investì massicciamente in un progetto statale di esplorazione, costruzione navale e addestramento alla navigazione che mirava a sostituire le rotte commerciali controllate dai musulmani e ad accedere direttamente alle ricchezze dell’Africa e dell’Asia.
Alla base di questo progetto era il monopolio mantenuto dalla corona portoghese delle conoscenze per la navigazione nell’Atlantico, sulla navigazione, le mappe e il disegno delle navi, considerati segreti di Stato. Tutte le scoperte importanti, le coste, i venti, le correnti oceaniche, l’ubicazione dei porti i punti di riferimento venivano immediatamente segnalati alla corona e documentati, le mappe erano conservate in archivi reali rigorosamente controllati, i capitani delle navi e gli equipaggi erano tenuti al segreto. Mentre altre potenze stampavano e vendevano mappe, il Portogallo ne limitava la diffusione. I cartografi ebrei espulsi da altri paesi furono accolti in Portogallo, che assunse molti esperti navali stranieri. Questo monopolio permise ai marinai portoghesi di spingersi ogni anno più lontano lungo la costa africana con crescente sicurezza.
La caravella, sviluppata in questo contesto durante gli anni ’30 del XV secolo, incarnava questa sintesi. Imbarcazione agile, progettata appositamente per navigare ai venti e alle correnti difficili dell’Atlantico, la caravella era leggera, veloce e manovrabile, con un pescaggio ridotto, ideale per l’esplorazione costiera. L’uso delle vele latine, adattate dalle imbarcazioni mediterranee e arabe, le permetteva di navigare controvento, un vantaggio cruciale per il ritorno dai viaggi lungo la costa occidentale africana. Con la caravella i navigatori portoghesi raggiunsero l’Africa occidentale, il Capo di Buona Speranza, l’India e infine il Brasile, assicurandosi vaste reti commerciali. I portoghesi avevano attinto ampiamente dalle conoscenze marittime italiane, in particolare dalle tradizioni genovesi e veneziane. La cantieristica italiana influenzò il disegno dello scafo e delle attrezzature, mentre i navigatori italiani introdussero strumenti fondamentali come i portolani, la bussola e gli strumenti celesti. Gli esploratori e i cartografi genovesi erano spesso assunti direttamente dal Portogallo, contribuendo con la loro esperienza alla crescente impresa atlantica. Questa fusione di tecniche mediterranee ed esperienza atlantica permise ai portoghesi di superare i loro rivali europei nell’espansione oltremare.
Il deliberato investimento del Portogallo nella conoscenza marittima, nelle infrastrutture e nella segretezza gli permise di dominare l’esplorazione dell’Atlantico per quasi un secolo prima delle altre potenze europee. Quella che era iniziata come una risposta ai limiti geografici divenne uno dei progetti di espansione intrapresi da uno Stato di maggior successo nella storia mondiale. Lisbona fu presto un centro nevralgico delle reti di conoscenza transmediterranee, combinando i metodi feudali di conquista iberici con il capitalismo mercantile italiano.
7. - Gli Stati africani e la tratta degli schiavi
L’Africa in questo periodo era un continente di grande diversità politica, dove grandi Stati coesistevano con vaste regioni abitate da società ancora nel comunismo primitivo. Gran parte dell’Africa subsahariana rimaneva organizzata attraverso sistemi basati sulla parentela, il lignaggio o il clan, senza un governo centralizzato. Queste società senza Stato, comuni nelle regioni boschive, nelle zone pastorali e negli altipiani meno accessibili, si governavano attraverso il consenso comunitario, le tradizioni orali e i capi locali. Praticavano la proprietà comune della terra, la distribuzione collettiva dei beni, in assenza di una gerarchia di classe ben definita, e in genere non avevano eserciti permanenti o burocrazie formali.
I primi regni e imperi africani emersero più tardi rispetto a quelli europei, mediorientali o asiatici, in diverse regioni con vari livelli di centralizzazione politica e sviluppo economico. Nell’Africa occidentale, imperi come il Ghana (700-1240 d.C.), il Mali (1230-1600) e il Songhai (1464-1591) svilupparono Stati complessi con corti reali, sistemi fiscali, eserciti professionali e vaste reti commerciali collegate al mondo islamico attraverso le piste transahariane. Nella valle del Nilo, Stati cristiani e musulmani come la Nubia, Axum e, più tardi, l’Etiopia avevano lingue scritte, un’architettura monumentale e religioni di Stato. Nell’Africa centrale e meridionale, Stati come il Kongo, il Grande Zimbabwe e Mapungubwe controllavano le rotte commerciali e svilupparono élite dominanti, ma spesso con strutture politiche più fluide. Questi Stati erano ancora circondati o confinavano con comunità senza Stato o semi-centralizzate, spesso oggetto di espansione, tributi e schiavitù. Nel XV secolo circa il 60-70% della massa continentale africana era occupata da società senza Stato con il 50-60% della popolazione. La mappa dell’Africa nel XV secolo era quindi un mosaico di potenti regni circondati da vaste zone di società decentralizzate, con interazioni caratterizzate da scambi commerciali, guerre e alleanze mutevoli.
I regni africani svilupparono complesse gerarchie di classe ed espansero la loro influenza schiavizzando i membri delle società senza Stato o frammentate dell’interno. Queste popolazioni schiavizzate, prive di centralizzazione politica o di eserciti organizzati, erano oggetto di razzie e vendute in cambio di oro, cavalli, tessuti e, più tardi, armi da fuoco, prima al mondo islamico poi principalmente agli europei. La schiavitù divenne un motore economico centrale per molti dei primi Stati africani, sia come fonte di manodopera sia come merce commerciabile, che contribuì a consolidare e far progredire il loro potere, mentre combattevano innumeri guerre con le tribù e i clan circostanti che resistevano alla loro espansione.
Fu innanzitutto l’espansione dell’Islam in Africa settentrionale e orientale a partire dal VII secolo a creare un vasto sistema commerciale integrato, che aumentò significativamente la domanda di schiavi africani. Sotto i califfati omayyade (661-750) e abbaside (750-1258), e successivamente sotto vari sultanati islamici, un fiorente commercio di prigionieri africani si estese attraverso il Sahara, il Mar Rosso e l’Oceano Indiano. Secondo alcune stime, tra il 650 e il 1600 d.C. oltre 5 milioni di africani furono condotti attraverso queste rotte orientali, destinati ai mercati di Egitto, Arabia, Persia e India.
Con l’ascesa dell’Impero Ottomano nel 1299, e soprattutto dopo la conquista dell’Egitto e dell’Hijaz nel 1517, gli Ottomani presero il controllo dei principali centri di commercio di schiavi nel Nord e nell’Est dell’Africa. L’Impero Ottomano dominava il Mar Rosso e controllava città portuali cruciali come Suakin e Massaua, nonché parti del Sudan e della Somalia. Gli Ottomani istituzionalizzarono la schiavitù, utilizzando schiavi africani nella loro burocrazia imperiale, negli harem e nell’esercito. Gli eunuchi neri provenienti dall’Africa orientale ricoprivano ruoli di rilievo nella corte imperiale ottomana, mentre altri erano costretti ai lavori forzati nelle piantagioni o al servizio militare. Gli schiavi africani erano tassati, venduti e arruolati come parte del più ampio sistema economico ottomano. Secondo alcune stime, oltre un milione di schiavi africani furono trasportati in Medio Oriente tra il XVI e il XVIII secolo, molti dei quali provenienti da territori controllati o influenzati dagli Ottomani in Sudan, Etiopia e sulla costa orientale del continente. Nello stesso tempo i primi Stati africani utilizzavano i proventi della vendita degli schiavi per acquistare cavalli, spade e, infine, armi da fuoco, contribuendo a rafforzare i propri eserciti permanenti e ad espandere i propri sistemi regionali di rapporti di proprietà e dominio di classe.
In questo periodo l’accesso degli europei all’interno dell’Africa era limitato dal controllo musulmano delle rotte commerciali, con le potenze islamiche in uno stato di guerra costante con gli Stati cristiani. I portoghesi furono i primi ad aggirare questo blocco grazie alle loro vie marittime. Nel 1430 i portoghesi stabilirono contatti con la Senegambia, poi nel 1488 doppiarono il Capo di Buona Speranza. In Africa orientale conquistarono Kilwa e Mombasa nel 1505, affermando il loro dominio navale nell’Oceano Indiano e facendo irruzione nelle reti schiavistiche esistenti. Con la creazione di fortezze e stazioni commerciali in luoghi come Sofala (in Mozambico) e Zanzibar, i portoghesi ottennero l’accesso ai mercati degli schiavi e alle risorse naturali precedentemente monopolizzate dai commercianti musulmani e ottomani. Cominciarono a dirigere gli schiavi verso i mercati atlantici, in particolare verso le piantagioni di São Tomé, Capo Verde e infine del Brasile, creando le prime strutture della tratta transatlantica degli schiavi.
Questo cambiamento di padroni non fece che intensificare la schiavitù degli africani apolidi. I regni africani tanto dell’Africa occidentale quanto di quella orientale continuarono a schiavizzare le comunità più deboli e non centralizzate per soddisfare la domanda straniera. L’Impero Songhai (1464-1591 circa), ad esempio, integrò il lavoro schiavo nella sua economia, mentre i regni dell’Africa orientale come gli Yao e i Makua divennero in seguito i principali fornitori di schiavi sia per i commercianti arabi sia per quelli europei. Le società apolidi, prive di sistemi di scrittura, organizzazione militare e alleanze straniere, furono sistematicamente prese di mira. Tra il 1500 e il 1800, gli storici stimano che oltre 10 milioni di africani furono trafficati attraverso le rotte trans-sahariane, del Mar Rosso, dell’Oceano Indiano e transatlantiche. In Africa, le società di classe in ascesa, basate sul commercio e sulle conquiste, vennero a costituire una duratura struttura di sfruttamento interno da cui le potenze coloniali, islamiche e cristiane, avrebbero tratto profitti per secoli.
Nonostante la loro potenza navale, i portoghesi non tentarono di sottomettere i potenti regni africani. Gli Stati dell’Africa occidentale e orientale erano troppo popolosi, organizzati militarmente e politicamente complessi per essere facilmente sottomessi. Anche i tentativi di catturare in proprio gli schiavi si rivelarono difficili. Il Portogallo optò invece per un approccio pragmatico, stabilendo avamposti commerciali fortificati lungo la costa (come Elmina, São Jorge da Mina e l’isola del Mozambico) per assicurarsi l’accesso ai mercati africani senza costose campagne militari nell’entroterra.
Piuttosto che occupare direttamente territori del continente, il Portogallo si indirizzò verso la costituzione di colonie di piantagioni su isole al largo della costa come São Tomé, Capo Verde e Madeira, dove gli schiavi africani coltiveranno lo zucchero da esportare in Europa. All’inizio del 1500 queste colture erano altamente redditizie, incentivando l’espansione della tratta degli schiavi. I regni africani, ormai profondamente legati all’economia atlantica, intensificarono la cattura di schiavi utilizzando armi europee: un maggior numero di schiavi portava più armi, che a loro volta consentivano ulteriori razzie. Col tempo i portoghesi e altre potenze europee avrebbero spostato questo commercio nelle Americhe, in particolare in Brasile, dove nei tre secoli successivi furono inviati milioni di africani ridotti in schiavitù.
Se all’inizio del 1500 i primi Stati africani controllavano solo il 40-50% del continente, all’inizio del 1800 ne controllavano circa il 60-70%, con sviluppo di classi sociali e relazioni di proprietà, arricchendosi attraverso lo sfruttamento interno della manodopera schiava e come merce di esportazione, per finanziare le continue guerre di espansione dei propri Stati nei territori dei popoli che vivevano ancora in condizioni di comunismo primitivo.
Nel 1441, i capitani portoghesi catturarono degli africani nel fiume Senegal e li portarono a Lagos. A metà del XV secolo il Portogallo importava già migliaia di schiavi a Lisbona, dove nel 1550 ne costituivano il 10% della popolazione. Dal 1500 iniziarono a trasportare schiavi africani in Brasile, che sarebbe diventata la più grande colonia di schiavi della storia mondiale. Tra il 1441 e il 1600, i portoghesi trasportarono tra i 130.000 e i 160.000 schiavi africani. Nel 1600 il Portogallo sbarcò nelle Americhe tre quarti di tutti gli schiavi africani. I portoghesi iniziarono a perdere il loro dominio sulla tratta transatlantica a metà del XVII secolo, quando gli olandesi, gli inglesi e i francesi stabilirono i propri porti negrieri e le proprie piantagioni coloniali. Sebbene il Portogallo continuasse a importare schiavi in Brasile fino al 1850, la tratta atlantica degli schiavi fu sempre più controllata da altre potenze europee, in particolare dagli inglesi nel XVIII secolo.
Ciononostante, tra l’inizio del 1500 e il 1850, i portoghesi importarono in Brasile circa 4,9-5,5 milioni di schiavi africani, di gran lunga la quota maggiore fra i paesi attivi nella tratta transatlantica. Questi schiavi erano impiegati principalmente nelle piantagioni di zucchero lungo la costa atlantica del Brasile, in regioni come Bahia, Pernambuco e, successivamente, nelle piantagioni di caffè nel sud-est. Nonostante questo imponente sistema, il potere coloniale del Portogallo fu alla fine superato dalla Spagna, che controllava un impero molto più vasto in termini di territorio, ricchezza in argento (proveniente soprattutto da Potosí e dal Messico) e popolazione. A differenza della Spagna, il Portogallo non disponeva della manodopera, della burocrazia e della potenza militare necessarie per conquistare vasti imperi nell’entroterra. Il suo impero, come quello delle città-stato italiane che lo avevano preceduto nel Mediterraneo, rimase costiero e orientato al commercio, basandosi su porti fortificati piuttosto che su un controllo territoriale. Sebbene il Brasile portoghese fosse importante dal punto di vista economico, soprattutto per lo zucchero e successivamente per l’oro, la popolazione limitata del Portogallo, la dipendenza dal capitale straniero e le frequenti occupazioni straniere (come durante l’Unione Iberica, 1580-1640) fecero sì che non potesse mai eguagliare la dimensione globale e la forza amministrativa dell’Impero spagnolo.
8. - Ascesa e caduta del sistema coloniale spagnolo
Con l’unificazione di Castiglia e Aragona e la conquista definitiva di Granada nel 1492 la monarchia spagnola rivolse immediatamente la sua macchina da guerra dalla Reconquista alla espansione imperiale. Lo Stato spagnolo, ora ricco di terre e con una potente nobiltà addestrata a sfruttare e a reprimere, dispiegò il suo apparato militare e ideologico cattolico oltreoceano. Riconoscendo l’importanza di sviluppare una potenza navale, gli spagnoli imitarono presto il modello portoghese e intrapresero un programma centralizzato dallo Stato per sviluppare le proprie capacità marittime. In questo modo si legò sempre più alle città-stato italiane, che offrivano finanziamenti, vendevano risorse tecniche, scientifiche, geografiche e commerciali per le sue ambizioni coloniali e per sostenere le sue continue guerre in Europa. Insieme ai banchieri italiani, la Chiesa cattolica avrebbe santificato la conquista delle Americhe, proprio come aveva fatto durante le guerre contro l’Islam nella penisola iberica e come aveva fatto in precedenza durante le crociate nel Levante, guerre religiose che in realtà aveva crude motivazioni economiche. I conquistadores erano spesso ex cavalieri della Reconquista o loro discendenti, e le relazioni sociali che imponevano nelle colonie rispecchiavano quelle che avevano imposto in patria.
La conquista spagnola delle Americhe fu resa possibile da una combinazione di superiorità militare, un surplus di popolazione proveniente dalla penisola iberica e la capacità dello Stato di mobilitare e proiettare la propria forza oltre l’Atlantico. A differenza dei portoghesi, che si concentravano sui posti di commercio costieri e sulle rotte marittime, gli spagnoli utilizzarono la loro fanteria disciplinata, le armi da fuoco e la cavalleria, affinate in secoli di guerre contro gli Stati musulmani, per lanciare spedizioni nell’entroterra e occupare vasti territori. La Corona spagnola, recentemente unificata, aveva un surplus di soldati, coloni e avventurieri, molti dei quali veterani disoccupati, pronti a rivendicare terre e lavoro nel Nuovo Mondo. Ciò permise alla Spagna di sconfiggere militarmente e smantellare potenti imperi come quello azteco (1519) e quello inca (1533), conquistando le loro capitali e governando attraverso una combinazione di forza, alleanze con i rivali indigeni e burocrazia coloniale.
Dopo questa rapida conquista, la Spagna esportò nelle Americhe il suo modello di proprietà terriera latifondistica, adattandolo al sistema delle haciendas. Come le grandi tenute iberiche, le haciendas erano vaste proprietà rurali concesse dalla Corona ai conquistadores, ai coloni e agli ordini religiosi. Queste tenute erano dedite all’agricoltura estensiva e producevano beni di prima necessità come grano, mais, bestiame e vino per il consumo locale e regionale. Le haciendas si basavano sul lavoro coatto, che includeva lavoratori indigeni sottoposti ai sistemi dell’encomienda, del repartimiento e, successivamente, del peonaggio per debiti. Le haciendas erano organizzate principalmente per il consumo interno e non per l’esportazione, come invece avverrà nelle piantagioni successive.
Le piantagioni seguiranno la tradizione delle haciendas e dei latifondi, in quanto organizzate attorno a grandi appezzamenti di terra concessi alle élite dalla Corona spagnola. Le piantagioni e le miniere spagnole richiederanno forme di lavoro più intense e brutali. Nei Caraibi, nella costa dell’America centrale e in alcune parti del Sud America, gli spagnoli fonderanno piantagioni di zucchero inizialmente lavorate da indigeni ridotti in schiavitù. Tuttavia gli alti tassi di mortalità, il collasso demografico e le successive riforme legali (come le Nuove Leggi del 1542) limiteranno la disponibilità di manodopera indigena. Di conseguenza, gli spagnoli si rivolgeranno sempre più alla tratta degli schiavi africani, soprattutto nelle zone delle piantagioni e nei centri urbani. Nelle regioni minerarie come Potosí (Bolivia) e Zacatecas (Messico), l’estrazione dell’argento, che richiedeva un intenso impiego di manodopera, si baserà su un mix di lavoro forzato degli indigeni (il sistema della mita) e schiavi africani, in particolare dove le popolazioni native erano state decimate. Dal 1501, la Spagna importerà schiavi africani nei Caraibi per fornire manodopera alle piantagioni di zucchero. Tra il 1501 e il 1600, circa 100.000 africani saranno importati nelle colonie spagnole, principalmente tramite navi portoghesi e genovesi. A metà del 1800 gli spagnoli avranno importato tra 1,5 e 2 milioni di schiavi dall’Africa per le loro colonie, principalmente nei Caraibi.
Questo passaggio in alcune regioni alla schiavitù africana segnò una trasformazione dell’economia coloniale spagnola, da un’economia basata sulla conquista e sul tributo, organizzata attorno alle haciendas per il consumo interno, ad una legata al capitalismo globale e alla tratta degli schiavi nell’Atlantico. Mentre le haciendas mantenevano un’economia semi-feudale chiusa, le piantagioni e le miniere si collegarono ai mercati internazionali, producendo zucchero, argento e altre materie prime molto richieste. Così il retaggio di sfruttamento della terra e di lavoro in stile latifondista si trasferì quasi immutato nel Nuovo Mondo, dove fu applicato nelle piantagioni prima alle popolazioni indigene e poi, sempre più, agli schiavi africani.
Dalle miniere spagnole furono portate in Spagna circa 16.000-18.000 tonnellate di argento e 185 tonnellate d’oro, l’equivalente di 200-400 miliardi di dollari odierni. Dal 1540 in poi, enormi quantità di argento furono estratte dalle miniere grazie al lavoro forzato delle popolazioni indigene e degli africani e spedite in Europa. Alla fine del XVI secolo, il 60-80% della produzione mondiale di argento passava attraverso la Spagna.
Mentre la Spagna schiavizzava le popolazioni indigene e gli africani per lavorare nelle piantagioni di zucchero e nelle miniere d’argento nelle Americhe, la monarchia accumulava una ricchezza senza precedenti che avrebbe cambiato per sempre l’economia mondiale. Infatti, nonostante l’enorme accumulo di ricchezza, l’ordine feudale arretrato in Spagna era molto inefficiente e dipendeva in ultima analisi dal capitale finanziario straniero e dalla produzione artigianale per la sua sopravvivenza. Si stima che tra il 30 e il 50% dell’argento e dell’oro estratto dagli spagnoli finì nelle mani dei banchieri genovesi e italiani per pagare i debiti delle guerre imperialiste e delle avventure coloniali. Allo stesso modo, si stima che in questo periodo il 10-15% del suo oro e del suo argento finisse ai corsari olandesi e inglesi.
La Spagna con la sua ricchezza coloniale non sviluppò le forze produttive. La monarchia utilizzava l’argento per finanziare le guerre contro i Paesi Bassi, la Francia e l’Impero Ottomano. L’argento passava rapidamente dalla Spagna nelle mani di mercanti e finanzieri italiani, olandesi e francesi. La Spagna dichiarò più volte il fallimento dello Stato: nel 1557, nel 1575, nel 1596, nel 1607. Rimase un paese agricolo, governato da un’aristocrazia terriera ostile alla produzione borghese. L’industria ristagnò, soprattutto perché l’ordine aristocratico, minacciato dalla borghesia in ascesa, condusse campagne repressive che portarono all’espulsione degli artigiani. L’afflusso di lingotti d’oro aumentava l’offerta di moneta a livello globale, provocando un’inflazione in tutta Europa, un fenomeno noto come rivoluzione dei prezzi. I prezzi aumentarono, in particolare quelli dei cereali e dei manufatti. La borghesia, soprattutto nelle regioni non spagnole, trasse vantaggio dalla vendita delle sue merci in un mercato monetizzato e inflazionato.
(Continua al prossimo numero)
Il P.C.d’I. condivise pienamente e applicò le risoluzioni del I Congresso del Profintern. Anzi, le anticipò essendo già arrivato a quelle conclusioni. Riportiamo qui per esteso l’articolo “Direttive dell’azione sindacale del PC”, pubblicato su “Il Comunista” del 7 agosto 1921, esemplare per chiarezza e accuratezza di analisi:
«1. Situazione internazionale sindacale
«La sistemazione nei quadri internazionali del movimento operaio italiano – problema a cui il Partito comunista fin dal suo sorgere ha dedicato la massima attenzione – non è certo ancora raggiunta, né si può dire che abbia fatto grandi passi coi congressi nazionali della Confederazione del lavoro e del Sindacato ferrovieri. Non tutti i grandi organismi proletari italiani hanno ancora preso posizione chiara dinanzi al fondamentale dilemma: Mosca o Amsterdam? In seguito ai risultati del Congresso internazionale dei Sindacati rossi, si dovranno avere immancabilmente in Italia i congressi nazionali della Confederazione, dell’Unione sindacale, del Sindacato ferrovieri, e tutti questi organismi dovranno definire la loro posizione in base alle chiare basi organizzative poste a Mosca.
«Il Partito comunista constata che le risultanze conosciute del congresso sindacale internazionale confermano la tattica da esso adottata in materia sindacale e compendiata nell’appello lanciato tempo addietro per l’unificazione delle organizzazioni operaie italiane. Appena sarà ritornata la sua delegazione sindacale, il Partito comunista convocherà un convegno sindacale per definire il suo lavoro circa la questione internazionale, e rivolgerà alle masse organizzate la sua parola circa l’atteggiamento da prendere nei congressi degli organismi nazionali operai.
«2. L’offensiva dei dirigenti confederali contro i comunisti
«Il Partito comunista deve però dire la sua parola ai lavoratori e ai suoi membri che militano nelle organizzazioni economiche su vari problemi importantissimi del momento attuale, riflettenti soprattutto le direttive della massima organizzazione operaia italiana: la Confederazione Generale del Lavoro, nella quale i comunisti formano la forte e combattiva opposizione all’indirizzo dei dirigenti.
«Nella recente riunione del Consiglio direttivo della Confederazione è stato adottato un deliberato che prelude all’apertura anche in Italia di una campagna che i dirigenti dei sindacati ancora dominati dal riformismo hanno adottato in molti paesi, sentendosi feriti direttamente dalla tattica sindacale dei comunisti. Mentre questi sono per l’unità sindacale e il lavoro nell’interno dei sindacati contro i capi di destra, costoro minacciano di attuare la scissione operaia escludendo i comunisti dalle organizzazioni. Il Comitato esecutivo confederale ha avuto i poteri d’attuare queste espulsioni di organizzazioni o di gruppi dall’organismo confederale.
«Il chiaro obiettivo dei mandarini della Confederazione, i quali si accorgono come la nostra offensiva faccia loro perdere terreno ogni giorno e prepari la liberazione del proletariato italiano dalla loro influenza addormentatrice, è di sabotare la formazione d’una maggioranza comunista nelle organizzazioni da loro dirette.
«Il Partito comunista raccoglie in pieno la sfida lanciatagli in tal modo da coloro ch’esso ritiene i peggiori nemici della causa proletaria. Esso conferma anzitutto pienamente e incondizionatamente, anche dinanzi alla situazione creata dal deliberato confederale, la sua tattica di rimanere nella Confederazione, e di lavorare per attrarvi tutte le organizzazioni di sinistra; e tale dichiarazione deve servir di norma a tutti i compagni che dall’atteggiamento dei bonzi traessero l’avventata conclusione che convenga predisporsi alla scissione sindacale. I comunisti non se ne vogliono andare e non se ne andranno dalle file delle organizzazioni confederali. Essi dichiarano arbitrario ogni atto tendente ad escludere dalle file del sindacato, non chi ne violi la disciplina specifica nella lotta contro i capitalisti, ma chi nel seno di esso agiti date direttive e dati metodi di lotta politica proletaria.
«Se alcuno deve essere eliminato dalle file dell’organizzazione è chi ne rinnega nel fatto il principio fondamentale della lotta di classe, e costui va cercato appunto tra coloro che hanno votato a Roma quel deliberato, di cui la stampa capitalista ampiamente e logicamente si è rallegrata. Il Partito comunista dichiara che i suoi aderenti lotteranno con tutti i mezzi, nessuno escluso, contro quello che deve essere ritenuto un atto arbitrario e un tentativo di sopraffazione, cioè contro lo sfratto anche di un solo comunista dalle file dell’organizzazione dei suoi compagni di lavoro.
«Ulteriori misure potranno essere caso per caso indicate dai Comitati sindacali comunisti. La massima pubblicità sarà data dalla stampa del Partito agli episodi di questa lotta, additando al disprezzo dei lavoratori coscienti le gesta reazionarie dei capi sindacali su questo terreno.
«3. La politica di “pacificazione” dei dirigenti confederali
«I comunisti restano nella Confederazione, e vi restano per esercitare a fondo la loro funzione di spietata critica alla politica dei dirigenti. Nessuna occasione deve essere trascurata per invitare le masse a disapprovare le trattative e gli accordi coi fascisti, che per i comunisti hanno valore di tradimento della causa proletaria. Dovunque gli organizzati e organizzatori comunisti dichiareranno e spiegheranno chiaramente che la Confederazione del Lavoro non può e non deve disciplinarmente impegnare i suoi iscritti a direttive d’ordine politico, che potrebbero risultare dalle sue intese con coloro che finora hanno impunemente posto a sacco le sedi proletarie.
«Se la Confederazione è “alleata” al partito socialista, lasci a quest’ultimo la cura di dirigere in questo campo l’attività di quegli organizzati che sono iscritti o simpatizzanti socialisti. In realtà i dirigenti confederali, che nell’ultima loro riunione si sono espressamente occupati perfino della politica parlamentare, sono divenuti i dittatori dello stesso partito socialista, che stanno trasformando in un partito laburista legato alla loro politica di collaborazione e di corporativismo.
«I comunisti, che restano nella Confederazione, vi stanno per spezzare questa politica rovinosa e per liberare le masse da questa dittatura controrivoluzionaria, lavorando alla penetrazione dello spirito comunista nei sindacati. Malgrado gli atteggiamenti dei dirigenti confederali, i comunisti contano sull’ausilio dei lavoratori organizzati nella lotta aperta contro le bande della reazione. Questa parola dev’essere portata in tutte le adunanze proletarie.
«4. Crisi economica e disoccupazione
«Una direttiva unica deve essere data alla propaganda ed all’azione dei comunisti in questo campo. La critica più aspra dev’essere opposta all’indirizzo sancito in materia dagli organi confederali, e dev’essere denunziata la loro acquiescenza alle imposizioni dei capitalisti. La chiusura delle aziende, l’insufficienza delle provvidenze governative in materia di sussidi e di concessioni di lavori pubblici, l’illusione di poter ottenere più efficaci interventi dallo Stato per via parlamentare e collaborazionista, come si propongono i dirigenti confederali, l’arrendevolezza di questi dinanzi all’offensiva dei padroni contro i concordati conquistati dai lavoratori, sono tutti elementi che devono essere messi da noi nella loro vera luce, spiegando che, secondo la nostra tattica rivoluzionaria, una soluzione radicale di questi problemi non esiste che nella conquista del potere da parte del proletariato, che la evidente insolubilità di essi deve essere utilizzata per condurre appunto le masse a questa convinzione ed intensificare tra esse la preparazione rivoluzionaria, mentre i riformisti, per evitare questo, illudono i lavoratori affermando che esista la possibilità di migliorare le difficoltà della crisi presente nell’ambito del regime attuale. E’ importante mostrare che i dirigenti confederali, con tale politica, mentre nulla realizzano di concretamente utile alle masse, pongono la loro tesi collaborazionista e pacifista non solo al di sopra dell’interesse della rivoluzione, ma anche contro gli interessi immediati dei lavoratori, rinunziando, per non turbare le loro manovre e intese politiche con gruppi borghesi, all’impiego della forza sindacale del proletariato per la battaglia contro l’offensiva padronale, che potrebbe venire ingaggiata quando si fosse veramente decisi a spingerla a fondo, sul terreno politico. Ciò sarà possibile solo sloggiando i disfattisti dalla dirigenza delle masse proletarie organizzate; e questi argomenti devono venire impiegati per attrarre i più larghi strati dei lavoratori nella lotta contro i dirigenti confederali. Per la questione dei disoccupati, il Partito comunista lancerà tra breve un apposito appello. Dal nostro punto di vista questa diviene una questione squisitamente politica. Si deve svolgere la critica dei palliativi che propongono i riformisti. Lo Stato borghese, cui essi si rivolgono, non può provvedere alla tragica situazione delle folle dei senza lavoro che con misure inefficaci e aventi carattere di una grama beneficenza. Dal punto di vista di classe, una sola soluzione può essere agitata, il principio della sostituzione del sussidio con la corresponsione dell’intiero salario al disoccupato legittimo in ragione del numero dei membri della sua famiglia. Questo principio, stadio elementare verso l’economia socialista, mentre è incompatibile con l’esistenza del potere borghese, sarebbe una realizzazione immediata del potere proletario, che intaccando a fondo i privilegi del capitale, stabilirebbe l’eliminazione di qualunque disparità di trattamento tra i lavoratori, sulla base dell’obbligo sociale del lavoro.
«5. Tattica nelle agitazioni economiche
«I riformisti sono soliti avvalersi di un argomento specioso contro i nostri compagni che lavorano nei sindacati, quello cioè che noi non avremmo la possibilità di fare, e non faremmo in realtà, nei conflitti sindacali, nulla di praticamente diverso da essi. Bisogna rispondere che i comunisti non si sognano di negare le conquiste contingenti della lotta sindacale nel campo della contrattazione delle condizioni di lavoro, che non escludono che sia problema tattico da risolversi volta per volta quello della convenienza di accettare o meno le proposte dei padroni, di spingere ad oltranza o di arrestare ad un certo limite gli scioperi. Né i comunisti pretendono di possedere una ricetta per poi vincere infallibilmente le agitazioni di carattere economico. Ciò che li distingue dai riformisti e dai socialdemocratici è la propaganda rivoluzionaria che essi traggono occasione di esplicare da ogni episodio della lotta economica, il loro costante sforzo di creare nei lavoratori una coscienza politica e di classe.
«Inoltre i comunisti devono provare che il fatto che i grandi centri della rete dell’organizzazione proletaria siano in mano ad amici larvati della borghesia o ad avversari della preparazione rivoluzionaria, che considerano come il massimo pericolo l’allargarsi delle agitazioni e il loro investire tutta la vita sociale e politica del paese, lega le mani ai lavoratori organizzati e ai loro organizzatori anche dove questi seguono le direttive comuniste. Siccome i comunisti sanno di non poter realizzare i loro scopi se le grandi masse sono ancora dominate dall’influsso dei capi sindacali, essi considerano al primo piano della loro lotta rivoluzionaria la necessità di sloggiare costoro, posizione per posizione, dalla organizzazione proletaria.
«Tutta l’attività sindacale dei comunisti si basa su questa constatazione: che nell’epoca attuale di convulsionaria crisi del regime borghese non è più sufficiente la semplice attività tradizionale dei sindacati, che vedono la loro azione divenire sempre più difficile man mano che la crisi si inasprisce. Per affrontare i problemi della vita quotidiana operaia, occorre poter controllare nel suo insieme il funzionamento della macchina economica, per concretare le misure che possono combattere le conseguenze del suo dissesto. È illusorio che l’attuale sistema politico porga al proletariato il mezzo di esercitare una qualsiasi influenza sull’andamento di questi fenomeni, da cui pur dipendono le sue sorti e le sue condizioni di esistenza; e tutti i problemi si riducono a quello unico di sostituirsi, con un grande sforzo rivoluzionario di tutto il proletariato, alla classe dei suoi sfruttatori, che, detenendo il potere, impediscono qualunque mitigazione delle dolorose conseguenze del capitalismo, in quanto impediscono ogni limitazione dei privilegi dei capitalisti. I sindacati devono dunque divenire le falangi dell’esercito rivoluzionario, imbevendosi dello spirito politico comunista, e lottare, inquadrati dal partito di classe, per la conquista del potere, per la realizzazione della dittatura proletaria.
«Il Comitato Esecutivo
«Il Comitato Sindacale».
Altro esempio di chiarezza e di pieno accordo con il Profintern è l’articolo de “Il Comunista” del 28 agosto 1921, titolato “Comunisti e socialdemocratici dinanzi alla crisi sociale”, da cui leggiamo la parte finale:
«I postulati comunisti sono terribilmente modesti. Si tratta non di chiedere ma solo di difendere alcuni punti. È vero. I riformisti, ad ogni modo, ancora più modesti, non vogliono nemmeno difendere lo stato attuale delle condizioni di vita delle masse. Ma noi comunisti pensiamo che la necessità di passare, dalla lotta dei gruppi con valore esclusivamente immediato e contingente, all’azione generale che si volga all’obiettivo rivoluzionario del mutamento del regime, emerge, non più da nostre dottrine, ma dai fatti stessi, in questa situazione decisiva in cui il capitalismo “non può” nemmeno in apparenza nulla concedere, e i suoi manutengoli riformisti perdono la possibilità di magnificarne la capacità di ulteriore sviluppo benefico per il proletariato.
«E se i modesti punti stabiliti dai comunisti sono tali che, data la crisi della società borghese, è impossibile che i capitalisti accettino di rispettarli, vuol dire che è giunto il momento in cui il proletariato non deve più scegliere tra due metodi di iniziativa tattica: lotte parziali per guadagnare a poco a poco dei miglioramenti o lotta generale e decisiva per emanciparsi definitivamente dallo sfruttamento capitalistico, ma deve scegliere tra l’immiserimento, l’abbruttimento, l’annientamento, la morte, o la lotta generale contro il regime vigente e il potere capitalista.
È segno questo che ormai il principale ostacolo alla battaglia finale emancipatrice delle masse non sta nelle possibilità che offre la situazione, ma nella accorta complicità dei socialdemocratici col capitalismo, che viene definito necessario per lungo tempo ancora, non solo quando il suo sviluppo può esser più o meno artificialmente prospettato come progressivo agli effetti dei vantaggi per i lavoratori, ma persino quando innegabilmente esso precipita nei vortici della crisi che ne annunzia l’impossibilità di sopravvivere come regime.
«Il Sindacato, che è organo di resistenza per definizione, che può spingere oltre le sue conquiste o salvaguardare le già raggiunte, ma che, quando indietreggia, perde la sua ragione d’essere o si dissolve – e tutta la storia dell’azione di classe questo dimostra – nelle situazioni che rendono inevitabile l’indietreggiamento senza spezzare i limiti stessi del sistema del salariato diviene organo rivoluzionario, o perisce. Si inquadra nella lotta contro il regime borghese, o scompare nel dissolvimento di ogni forza difensiva e offensiva delle masse. Non può neppure sopravvivere come debole strumento dell’inganno proletario nelle mani dei fedeli amici del capitalismo che sono i mandarini riformisti, poiché la massa, se le sarà attraversata la via della lotta che sola può sottrarla allo spettro della fame e della miseria, ricadrà nell’individualismo e diserterà le inutili organizzazioni economiche. Noi siamo a questo svolto. Vogliono le masse organizzate del proletariato seguire la via del precipizio sotto la direzione dei riformisti, o intendono accogliere l’invito del Partito Comunista per l’azione generale e decisiva? Ai lavoratori d’Italia la risposta».
Data l’importanza di tale questione, leggiamo ora un altro articolo di esemplare chiarezza, apparso su “Il Comunista” del 28 ottobre 1921, dal titolo “Il fronte unico”:
«Il Partito comunista sostiene in questo momento nella difficile situazione in cui si trova il proletariato italiano la necessità della “unità proletaria” e la proposta del “fronte unico” proletario per l’azione contro l’offensiva economica e politica della classe padronale. Questo atteggiamento, perfettamente coerente coi principi e coi metodi del Partito e della Internazionale Comunista, non viene però sempre chiaramente inteso da tutti e neppure da tutti i militi del Partito, e gli si dà talvolta un valore diverso da quello vero, deformandolo in modo da venire in urto con tutto l’armonico insieme della tattica del nostro Partito.
«Per bene intendere la questione, senza cadere in semplicistiche e dannose interpretazioni e attitudini, basta rifarsi ai fondamenti del nostro concetto e del nostro metodo di azione proletaria. Il comunismo rivoluzionario si basa sull’unità della lotta di emancipazione di tutti gli sfruttati, e nello stesso tempo si basa sull’organizzazione ben definita in Partito politico di quella “parte” di lavoratori che hanno migliore coscienza delle condizioni della lotta e maggiore decisione di lottare per la sua ultima finalità rivoluzionaria, costituendo quindi l’avanguardia della classe operaia. Dimostrerebbe di nulla avere inteso del programma nostro chi trovasse una contraddizione tra l’invocazione all’unione di tutti i lavoratori e il fatto di staccare una parte di essi dagli altri, organizzandoli in partito con metodi che differiscono da tutti quelli degli altri partiti, e anche quelli che si richiamano al proletariato e si dicono rivoluzionari, poiché in verità quei due concetti non hanno che la stessissima origine.
«Le prime lotte che i lavoratori conducono contro la classe borghese dominante sono lotte di gruppi più o meno numerosi per finalità parziali e immediate. Il comunismo proclama la necessità di unificare queste lotte, nel loro sviluppo, in modo da dare ad esse un obiettivo e un metodo comune e parla per questo di unità al di sopra delle situazioni locali, delle frontiere nazionali o di razza. Questa unità non è una somma materiale di individui, ma si consegue attraverso uno spostamento dell’indirizzo dell’azione di tutti gli individui e gruppi, quando questi sentono di costituire una classe, ossia di avere uno scopo e un programma comune.
«Se dunque nel Partito vi è solo una parte di lavoratori, tuttavia in esso vi è l’unità del proletariato, in quanto lavoratori di diverso mestiere, di diverse località e nazionalità vi partecipano sullo stesso piano, con le stesse finalità e la stessa regola di organizzazione. Una unione formale federativa di sindacati di categoria, o magari un’alleanza di partiti politici del proletariato, pur avendo maggiori effettivi di quelli del partito di classe, non raggiunge il postulato fondamentale della unione di tutti i lavoratori, perché non ha coesione e unicità di scopi e di metodi.
«Tuttavia i comunisti affermano che la organizzazione sindacale – primo stadio della coscienza e della pratica associativa degli operai, che li pone contro i padroni, sia pure localmente e parzialmente, appunto perché soltanto uno stadio ulteriore di coscienza e di organizzazione delle masse le può condurre sul terreno della lotta centrale contro il regime presente, appunto in ragione del fatto che raccoglie gli operai per la loro comune condizione di sfruttamento economico, e col loro riavvicinamento a quelli di altre località e categorie sindacali li avvia a formarsi la coscienza di classe – l’organizzazione sindacale deve essere unica, ed è assurdo scinderla sulla base di diverse concezioni del programma di azione generale proletaria. È assurdo chiedere al lavoratore che si organizza per la difesa dei suoi interessi quale sia la sua visione generale della lotta proletaria, quale sia la sua opinione politica; egli può non averne nessuna o una errata, ciò non lo rende incompatibile con l’azione del sindacato, da cui trarrà gli elementi del suo ulteriore orientamento.
«Per questo i comunisti, come sono contro la scissione dei sindacati quando la maggioranza degli aderenti o le furberie dei capi opportunisti danno loro una direttiva poco rivoluzionaria, così lavorano per la unificazione delle organizzazioni sindacali oggi divise, e tendono ad avere in ogni paese una unica centrale sindacale nazionale. Qualunque possa essere l’influenza dei capi opportunisti, la unità sindacale è un coefficiente favorevole alla diffusione della ideologia e della organizzazione rivoluzionaria politica, e il partito di classe fa nel seno del sindacato unico il suo miglior reclutamento e la migliore sua campagna contro i metodi errati di lotta che da altre parti si prospettano al proletariato. I comunisti italiani sostengono l’unità proletaria perché sono convinti che nel seno di un unico organismo sindacale si farà con maggior rapidità e successo il lavoro di orientamento del proletariato verso il programma politico dell’Internazionale Comunista.
«Mentre, sullo stesso piano della Internazionale Sindacale Rossa, i comunisti italiani lavorano per l’unificazione degli organismi sindacali del proletariato italiano, essi sostengono altrettanto energicamente, anche prima di raggiungere questa unità organizzativa, a cui non poche difficoltà si frappongono, la necessità dell’azione di insieme di tutto il proletariato, oggi che i suoi problemi parziali economici dinanzi all’offensiva dei padroni si fondono in uno solo: quello della comune difesa. Ancora una volta i comunisti sono convinti che, mostrando alle masse che unico è il postulato e unica deve essere la tattica per poter fronteggiare la minacciata riduzione dei salari, la disoccupazione e tutte le altre manifestazioni di offensiva anti-operaia, si renderà più agevole il compito di dimostrare che il proletariato deve avere un programma unico di offensiva rivoluzionaria contro il regime capitalistico, e che questo programma è quello tracciato dalla Internazionale Comunista: lotta condotta dal partito politico di classe contro lo Stato borghese, per la dittatura del proletariato.
«Dal “fronte unico” del proletariato sindacalmente organizzato contro l’offensiva borghese sorgerà il fronte unico del proletariato sul programma politico del Partito Comunista, dimostrandosi nell’azione e nell’incessante critica di esso insufficiente ogni altro programma. Unità sindacale e fronte unico proletario contro l’offensiva attuale della borghesia sono tappe che il proletariato deve percorrere per il suo allenamento a lottare secondo gli insegnamenti della storia sulla via dell’avanguardia comunista tracciata. Unità sindacale e fronte unico proletario il Partito Comunista li sostiene appunto per far trionfare il suo programma, ben differenziato da tutti gli altri che vengono prospettati al proletariato, per mettere in evidenza maggiore la sua critica ai tradimenti della socialdemocrazia, e anche agli errori sindacalisti e anarchici.
«Grossolano equivoco è scambiare la formula dell’unificazione sindacale e del fronte unico con quella di un blocco di partiti proletari, o della direzione dell’azione delle masse, in casi contingenti o in movimenti generali, da parte di comitati sorti da un compromesso tra vari partiti e correnti politiche – immaginare che esse comportino una tregua da parte dei comunisti alla rampogna contro i socialdemocratici, e alla critica di ogni altro metodo di azione che faccia smarrire al proletariato la chiara visione del processo rivoluzionario.
«Sarebbe ridicolo per i comunisti nostrani – come per tanto tempo si è fatto da ogni lato e con danno enorme per la preparazione rivoluzionaria del proletariato – correre a ogni piccola o grande occasione a fare omaggio a qualcosa, a qualche organismo, a qualche atteggiamento, a qualche finalità che, con la ultra-filistea frase, si pone “al di sopra dei partiti”.
«I comunisti non “nascondono” mai il loro partito, la loro milizia politica, la loro disciplina inviolabile. Queste non sono cose di cui essi debbano arrossire, in nessun caso; poiché non le ha dettate l’interesse personale o una mania di omertà politica, ma solo il bene della causa proletaria; poiché non sono una concessione fatta ad esigenze poco confessabili di “divisione” del proletariato, e sono invece all’opposto il contenuto stesso dell’opera di unificazione del proletariato nel suo sforzo di emancipazione. Unità sindacale e fronte unico sono il logico sviluppo e non una forma coperta di pentimento dell’opera dei comunisti italiani nel costituire e nel rafforzare l’arma della lotta rivoluzionaria, il loro partito severamente definito e delimitato nella dottrina, nei metodi, nella disciplina organizzativa, e volto nell’interesse della unificazione rivoluzionaria della lotta del proletariato contro tutte le deviazioni e tutti gli errori».
La scarsa chiarezza, poi diventata ambiguità e poi ancora aperto tradimento, presente nell’Internazionale Comunista su tale tema, si era già manifestata nel gennaio 1921 con la famosa “lettera aperta” del VKPD (Vereinigte Kommunistische Partei Deutschland, Partito Comunista Unificato di Germania), su iniziativa di Levi e con l’appoggio di Radek, inviata alle organizzazioni sindacali e a tutti i “partiti operai” tedeschi. Prima ancora, nel maggio 1920, il C.E. dell’Internazionale, rispondendo a una lettera dell’Independent Labour Party, aveva risposto favorevolmente alla possibilità da questo evocata di restare all’interno del Labour Party. La stessa ambiguità si rese più evidente nelle Tesi del Comitato esecutivo sul fronte unico, del 18 dicembre 1921, dove al punto 20 leggiamo: «Mentre lancia la parola d’ordine del fronte unico dei lavoratori e permette accordi delle singole sezioni dell’Internazionale comunista coi partiti e le associazioni della Seconda Internazionale e della Internazionale Due e Mezzo, è chiaro che l’Internazionale comunista non può rifiutarsi di concludere accordi di questo genere anche su scala internazionale. L’Esecutivo dell’Internazionale comunista ha fatto una proposta all’Internazionale di Amsterdam in rapporto all’azione di soccorso per la fame in Russia. Ha ripetuto questa proposta in relazione al terrore bianco e alle persecuzioni degli operai spagnoli e jugoslavi».
Nello stesso senso andava l’“Appello degli Esecutivi dell’IC e dell’ISR per il fronte unico proletario” del 1° gennaio 1922, che così iniziava: «Proletari e proletarie di tutti i paesi! Gli Esecutivi dell’Internazionale comunista e dell’Internazionale sindacale rossa si sono occupati in tre sedute della situazione mondiale e della situazione del proletariato internazionale, e si sono persuasi che questa situazione esige l’unione di tutte le forze del proletariato internazionale, la creazione di un fronte unitario di tutti i partiti che si basano sul proletariato senza riguardo ai contrasti che li separano, purché siano disposti a combattere insieme per i bisogni immediati e indifferibili del proletariato».
Qui iniziano le divergenze reali tra il P.C.d’I e l’Internazionale. In una lettera del 28 gennaio 1922 del C.E. del P.C.d’I al C.E. dell’Internazionale Comunista leggiamo: «Siamo d’accordo con tutto quanto dite nella lettera del 28 sulla tattica del fronte unico in Italia. Non condividiamo invece i vostri punti di vista sulla tattica applicata in Germania e sul suo allargamento alla scala internazionale (…) Dopo avervi segnalato questa situazione non ci resta che dichiarare ancora una volta il nostro spirito illimitato di disciplina alle decisioni dell’Internazionale».
Infatti tali errori e ambiguità non erano ancora tradimento, mossi dalla illusione di poter invertire con manovre fra partiti la tendenza al riflusso del movimento operaio. La controrivoluzione poi ne farà dei principi e strumenti, per giustificare la sua ideologia interclassista e gradualista. Del comunismo rimarrà un vestito bello e rosso a coprire un corpo mostruoso, a nascondere al proletariato mondiale la realtà del capitalismo e della controrivoluzione.
7. Il Profintern tra il 1° e il 2° congresso
Intanto l’Internazionale Sindacale di Amsterdam continuava nella sua linea di collaborazione di classe e una feroce campagna anticomunista, sia con l’espulsione di singoli e gruppi dai sindacati sia con la scissione sindacale ogni volta che i proletari si ponevano decisamente sul terreno di classe.
Tra il febbraio e l’aprile del 1922 si tennero: a Mosca il Consiglio Centrale allargato del Profintern; a Berlino la Conferenza delle tre Internazionali politiche; a Roma il Congresso dell’Internazionale di Amsterdam.
Al Consiglio Centrale allargato del Profintern, tra febbraio e marzo 1922, parteciparono delegazioni da oltre una ventina di paesi, oltre a delegati dell’Estremo Oriente in qualità di invitati. Il Partito Operaio Norvegese, avendo dichiarato di accettare le 21 condizioni di Mosca, senza congresso o scissione, era entrato in blocco nella Terza Internazionale. Al contrario la Confederazione Sindacale Norvegese era rimasta nella Internazionale gialla, nonostante la stragrande maggioranza dei proletari si sentisse solidale con quella rossa di Mosca. Una strana posizione che ricordava quella italiana del 1919/20.
I capi sindacali norvegesi avevano proposto alle due Internazionali, la rossa e la gialla, una comune azione contro l’offensiva capitalista. La prima risoluzione del Consiglio Centrale del Profintern si ispirò all’iniziativa norvegese, considerata un tentativo, a livello internazionale, del fronte unico del proletariato, conforme «ai passi fatti dall’Ufficio Esecutivo dell’ISR, che aveva già, a parecchie riprese, invitato il Comitato Direttivo di Amsterdam a intraprendere un’azione comune su alcune questioni attuali, senza che tuttavia queste richieste fossero comprese e accolte». Nonostante ciò il Profintern si dichiarò disponibile a partecipare a una conferenza congiunta delle due Internazionali e affidò ai norvegesi il compito di elaborare un progetto base per azioni comuni.
La seconda risoluzione riguardò l’unità del fronte proletario in risposta all’offensiva capitalista. Il Profintern si poneva l’obiettivo di «agire di concerto con tutte le organizzazioni operaie, quali che siano le loro opinioni politiche» pur di realizzare «un fronte unico sul terreno della difesa degli interessi economici della classe operaia», per obiettivi condivisibili da tutti: la lotta contro la riduzione dei salari, contro il prolungamento della giornata di lavoro, contro l’intensificazione dello sfruttamento delle donne e dei fanciulli, etc. Ma anche questi elementi obiettivi di lotta trovarono l’energica opposizione di Amsterdam che negava il suo sostegno a tutto ciò che avrebbe potuto compromettere l’uscita dalla crisi del capitalismo.
La terza risoluzione riguardava “L’Opera di scissione di Amsterdam”. Uno degli effetti dell’atteggiamento di Amsterdam e delle confederazioni nazionali ad essa aderenti, tese all’asservimento totale del proletariato alle necessità del capitalismo, era l’abbandono dei sindacati da parte di milioni di lavoratori esasperati. Al contrario il Profintern incitava i proletari ad entrare e restare nei sindacati, e combattere instancabilmente per la loro trasformazione in organizzazioni rivoluzionarie.
La quarta risoluzione prendeva in esame il rapporto tra l’ISR e gli anarco-sindacalisti. Si precisava che l’ISR riuniva sotto le sue bandiere lavoratori anarco-sindacalisti, comunisti o politicamente neutri e ammoniva che la formazione di una internazionale anarco-sindacalista sarebbe stata di fatto un attentato all’unità proletaria.
La quinta risoluzione si riferiva ai “Comitati di propaganda internazionale”. Ad essi veniva affidato il compito di «fare tutto ciò che [era] in loro potere per salvaguardare l’unità di organizzazione delle Federazioni internazionali e per l’ammissione in esse di tutte le organizzazioni sindacali senza eccezione».
La sesta ed ultima risoluzione riguardava “i rapporti del Comitato Esecutivo”. Venivano approvate tutte le misure prese dal C.E. per il fronte unico proletario; riconosciuta la necessità di un organo centrale dell’ISR, indispensabile arma di organizzazione e propaganda; prospettata una intensificata attività fra le masse proletarie dell’Estremo Oriente e la energica difesa degli interessi della gioventù operaia.
Le ambiguità riguardo all’atteggiamento nei confronti dell’Internazionale di Amsterdam, e di conseguenza riguardo alla parola d’ordine del “fronte unico”, sono invece assenti nella esemplare “Risoluzione del I Plenum sui compiti dei comunisti nei sindacati”, del 4 marzo 1922:
«1. L’esecutivo allargato conferma che, in generale, nessuna modifica deve essere apportata alle risoluzioni del III Congresso relative alla questione sindacale. La loro applicazione durante questi sei mesi ha dimostrato di nuovo che le direttive erano giuste e conformi allo scopo. Se questa sessione si occupa della questione sindacale lo fa al solo scopo di attirare l’attenzione dei comunisti sulla necessità di rendere più concreto il loro lavoro in seno ai sindacati, e di adattarlo alle condizioni particolari dei diversi paesi e settori industriali.
«2. In seguito all’offensiva crescente del capitale, il movimento sindacale attraversa attualmente in tutti i paesi una grave crisi, che si manifesta con un calo del numero degli iscritti e con una diminuzione delle risorse finanziarie. D’altra parte la miseria crescente provoca nelle grandi masse una spinta elementare alla lotta – base del fronte unico – contro l’attacco capitalistico, nonché un desiderio di farla finita con la tattica dilatoria dei capi riformisti, che aveva tolto ai sindacati la loro forza combattiva, e di difendere per mezzo di azioni specifiche, senza i capi riformisti e sopra le loro teste, i diritti elementari della classe operaia.
«3. Questa situazione del movimento sindacale internazionale favorisce al massimo lo sviluppo ulteriore e l’approfondimento dell’azione tendente a conquistare i sindacati e ad estendere l’influenza comunista fra le masse. Se vogliono battersi per l’Internazionale sindacale rossa, i comunisti che sono parte del movimento sindacale devono abbracciare questo fondamentale punto di vista.
«4. In alcuni paesi l’ISR costituisce soltanto una tendenza interna delle vecchie organizzazioni; in altri ha conquistato la maggioranza effettiva, e in altri ancora le stesse centrali sindacali. In tale situazione, il compito dei comunisti nei sindacati in cui l’ISR costituisce solo una tendenza è quello di riunire in un solido nucleo, all’interno di ogni sindacato e a livello nazionale e internazionale, tutti gli operai che hanno la ferma volontà di intraprendere e di condurre fino in fondo la lotta contro la borghesia. Là dove invece abbiamo la maggioranza degli operai rivoluzionari con noi, il nostro compito consiste nel lottare per l’adesione della loro centrale nazionale all’ISR.
«5. Nel prossimo futuro i comunisti dovranno estendere la loro influenza all’interno dei vecchi sindacati riformisti, combattere la politica scissionista dei capi di Amsterdam, e applicare esattamente e coscienziosamente la tattica del fronte unico al movimento sindacale. Per quanto insignificante sia la minoranza all’interno dei sindacati o delle leghe, i comunisti devono lavorare in queste organizzazioni, perché la minoranza stessa non le abbandoni e condurvi una lotta in favore del programma e della tattica della minoranza. L’adesione all’ISR delle minoranze sindacali che sono obbligate a restare nelle vecchie organizzazioni può essere soltanto morale: ma esse dovranno provarla con l’applicazione pratica delle risoluzioni del primo congresso dei sindacati rivoluzionari e con l’attuazione della tattica dell’ISR stessa.
«6. È dovere dei comunisti fare in modo che i sindacati autonomi aderenti all’ISR rimangano nei loro segretariati di categoria internazionali, o che entrino a farne parte nel caso che ancora ne siano fuori. Poniamo di fronte al proletariato internazionale, chiaramente e apertamente, questo problema: restiamo nelle federazioni sindacali internazionali e aderiamo organicamente all’ISR soltanto quando avremo conquistato ai suoi principi la maggioranza degli iscritti. Gli operai di ogni paese devono decidere nei loro congressi sindacali nazionali quale programma e quale tattica corrispondono agli interessi della classe operaia: quelli dell’Internazionale di Amsterdam o quelli dell’ISR. Solo in questo modo le grandi masse potranno constatare da che parte stanno gli scissionisti che impediscono la formazione di un’unica forza rivolta contro il padronato. Solo in questo modo le masse sapranno riconoscere negli uomini di Amsterdam i puntelli della borghesia, coloro che difendono la democrazia borghese contro la dittatura del proletariato, ma sono sempre pronti a calpestare la democrazia proletaria ogni volta che i comunisti – sul terreno e con i metodi di quest’ultima – cercano di conquistare la maggioranza nei sindacati per farne non più degli organi ausiliari della borghesia ma degli strumenti di lotta.
«7. Le correnti fautrici della liquidazione dell’ISR, emerse in taluni partiti, sono il frutto di una serie di malintesi e della falsa speranza di un ritorno a sinistra dei capi di Amsterdam. Esse devono essere condannate severamente e categoricamente. Gli uomini di Amsterdam continueranno ad esitare, e se si volgeranno a sinistra sarà solo nella misura in cui si accrescerà l’influenza dei partiti comunisti, e in cui aumenterà la presa organizzativa e ideologica dell’ISR sul movimento sindacale di tutti i paesi. I comunisti non devono contare su un ritorno a sinistra dei capi sindacali, ma fondare la loro tattica sul sentimento necessariamente rivoluzionario delle masse. Nella misura in cui si accentueranno le opposizioni sociali, in cui crescerà l’influenza dei partiti comunisti e dell’Internazionale comunista, in cui si svilupperà l’ideologia rivoluzionaria in seno alla classe operaia, i tentativi dell’Internazionale di Amsterdam volti ad ammantare di fraseologia rivoluzionaria i propri atti riformisti e la sua fuga di fronte ad ogni lotta, compresa quella per le necessità più immediate, diventeranno più frequenti.
«8. I partiti comunisti e l’IC, che hanno preso l’iniziativa di creare l’ISR, sono tenuti a continuare il loro lavoro, rafforzando e sviluppando le organizzazioni che abbracciano non solo gli elementi comunisti, ma anche quelli sindacalisti, apolitici e rivoluzionari».
Ma, nello stesso marzo 1922, in contrasto con quanto appena letto, c’è un “Contributo del Presidium dell’Esecutivo al progetto di programma del Partito comunista d’Italia”, dove al punto 4, sul fronte unico, leggiamo:
«È dovere di un partito comunista tentare d’intraprendere la lotta per gli interessi comuni del proletariato in collaborazione con altri partiti operai, per obbligare questi ultimi a unirsi al fronte comune».
8. La conferenza di Berlino delle tre Internazionali politiche
Riprendendo la proposta avanzata dal KPD con la famosa lettera del dicembre 1921, Friedrich Adler, dirigente dell’Internazionale Due e Mezzo di Vienna, invitava la Seconda e la Terza Internazionale a un incontro preliminare avente un o.d.g. formulato in due punti: 1) situazione economica in Europa e azione di classe; 2) lotta del proletariato contro la reazione.
Di fronte a questa iniziativa il P.C.d’I espresse immediatamente un parere nettamente negativo, sia per iscritto sia dando precise disposizioni ai delegati italiani all’Esecutivo Allargato, proponendo invece la riunione delle centrali sindacali di qualunque tendenza con rappresentanza proporzionale delle varie frazioni politiche militanti al loro interno. Però né il Komintern né Lenin furono del nostro parere e la Terza Internazionale aderì all’invito di Vienna.
Il 1° aprile 1922 si tenne a Berlino la prima seduta delle tre Internazionali, con l’aggiunta del Partito Socialista Italiano, non appartenente a nessuna delle tre. Friedrich Adler aprì i lavori con un discorso buono per tutte le occasioni, parlando della necessità dell’unione del proletariato internazionale, affermando che in fondo le tre Internazionali poggiavano su un terreno comune e avevano uno scopo comune: la difesa del proletariato.
Clara Zetkin lesse la dichiarazione della Terza Internazionale, molto blanda e accomodante. Era stato lo stesso Lenin a consigliare moderazione. «È assolutamente irragionevole – scrisse – rischiare di far fallire una opera pratica di enorme importanza per prendersi il gusto di insultare una volta di più dei mascalzoni che insultiamo e insulteremo mille volte di più in altra sede».
Il Komintern per la realizzazione del fronte unico proletario proponeva un
congresso pan-socialista allargato alle Internazionali sindacali di Mosca e di
Amsterdam, e aperto a tutte le organizzazioni di classe, basato sul seguente
ordine del giorno:
a. Difesa contro l’offensiva padronale;
b. Lotta contro la reazione;
c. Lotta contro nuove guerre;
d. Aiuti per la ricostruzione della Repubblica sovietica russa;
e. Abolizione del trattato di Versailles e ricostruzione dei paesi devastati
dalla guerra.
Se l’intervento dell’Internazionale di Vienna fu opportunista e quello del
Komintern estremamente moderato, Vandervelde, rappresentante della Seconda
Internazionale, sputò tutto il suo veleno contro il comunismo, la Terza
Internazionale e la repubblica sovietica. Vandervelde bocciò tutte le proposte
avanzate dai delegati della Terza Internazionale, non attaccò il capitalismo,
attaccando invece la Russia sovietica e l’Internazionale comunista. Riguardo
alla necessità di un fronte unico operaio per la lotta contro la reazione,
affermò che non possono marciare fianco a fianco per lo stesso scopo
perseguitati e persecutori: naturalmente i persecutori erano i bolscevichi,
colpevoli di non garantire, nella repubblica dei soviet, “i più elementari
diritti” ai controrivoluzionari. Vandervelde pose quindi alla Terza
Internazionale queste perentorie condizioni:
a. Rinuncia alla tattica di istituire frazioni sindacali;
b. Nomina di una commissione per esaminare la situazione in Georgia;
c. Liberazione dei prigionieri politici e svolgimento di un processo contro i
detenuti accordando il diritto di difesa e di controllo al socialismo
internazionale.
Il processo a cui ci si riferiva era quello contro i terroristi
socialisti-rivoluzionari.
Nel tentativo di non rompere un impossibile fronte unico delle tre Internazionali, i delegati di Mosca accettarono di sottostare al diktat della Internazionale di Londra e, andando oltre a quelli che erano i loro poteri, davano assicurazione che nel processo di Mosca contro i 47 socialisti-rivoluzionari sarebbero stati ammessi tutti i difensori che gli imputati avessero richiesto e che, in ogni caso, sarebbero state escluse condanne a morte. Riguardo poi alla Georgia si garantiva che il caso sarebbe stato esaminato in una futura conferenza internazionale.
(Continua nel prossimo numero)
Riproduciamo qui tre testi relativi alle origini del Partito Comunista di Cina
del periodo descritto nel capitolo pubblicato in questo numero: la seconda metà
del 1922, con il 2° congresso del partito a luglio, il Plenum ad agosto e i 4°
congresso dell’Internazionale a novembre.
Il primo è la Risoluzione del 2° congresso “Sul movimento sindacale e il PC”. I
giovanissimi comunisti cinesi vi espongono molto correttamente e compiutamente
la concezione marxista della natura e della funzione dei sindacati nel
capitalismo e quale sia il loro rapporto reciproco con il partito comunista.
Sono esposti e seguenti “principi”
- Il conflitto di interessi fra operai e capitalisti è inconciliabile è ogni
stabile mediazione è impossibile.
- La funzione del sindacato è proteggere e lottare per la difesa contingente dei
lavoratori.
- L’adesione al sindacato non è condizionata dalle opinioni politiche.
- Una più favorevole legislazione e miglioramento nelle condizioni del lavoro
sono possibili solo tramite la pressione della classe sul governo e sui
proprietari.
- Il sindacato non è una corporazione, nessun datore di lavoro vi può entrare; è
un’unità di lotta, non un’istituzione di mutua assistenza.
- Il sindacato rivendica la parità di retribuzione per lo stesso lavoro
indipendentemente da differenze di razza, sesso, etnia, età, religione e forza
fisica.
- La classe operaia deve farsi rappresentante delle istanze economiche anche dei
lavoratori poveri non ancora proletarizzati.
- È necessario tendere a una unica organizzazione sindacale di classe,
centralizzata e disciplinata, superando ogni autonomia locale, aziendale e di
categoria e mestiere. Il comitato di fabbrica non deve essere indipendente dal
sindacato: la organizzazione in fabbrica non è l’ideale del sindacato.
Quindi, per quanto riguarda il partito:
- L’obiettivo finale del movimento operaio è rovesciare il sistema capitalista.
- Il PC è l’avanguardia del proletariato e ha nel programma il rovesciamento del
capitalismo; nel sindacato i lavoratori ricevono un’educazione su come lottare “nello
spirito del comunismo”; marciano verso gli stessi obiettivi del PC ma, come in
una guerra, l’esercito ha un’avanguardia che è seguita dalla forza principale
dell’esercito.
- Il PC deve prestare attenzione a tutte le attività dei sindacati, che deve
guidare “con onestà e coraggio”. Il PC deve avere gruppi efficaci nei sindacati,
in tutti i comitati di fabbrica e in tutte le organizzazioni sindacali, con
poche eccezioni.
- I comunisti, quando operano nei sindacati organizzati dal Kuomintang, dai
partiti politici non governativi o dalle organizzazioni cristiane, non istigano
i lavoratori ad abbandonarli, dimostrando che solo il PC è l’avanguardia dei
lavoratori e il loro partito politico.
- Sul piano internazionale il PCdC deve sospingere i sindacati ad aderire al
Profintern.
- Il movimento operaio in Cina si deve impegnare nel movimento politico
nazionale e liberale, ma vi deve occupare una posizione dominante, che consenta
alla classe non gli obiettivi politici degli opportunisti ma la sua propria
propaganda rivoluzionaria e la sua vittoria finale.
Il secondo documento che riproduciamo sono le “Istruzioni per il rappresentante
nel Sud della Cina del Comitato Esecutivo dell’Internazionale Comunista”.
La nota alla edizione in lingua inglese precisa: «Questa è l’istruzione che
Maring riportò in Cina – nell’agosto 1922 – e che costituì la base delle
discussioni a Hangzhou sull’ingresso dei comunisti nel KMT. Secondo Maring,
l’istruzione fu redatta da Radek sulla base delle dichiarazioni di Maring sulla
Cina. Vedi la lettera di H. Maring a G. Zinoviev, N. Bukharin e K. Radek, 20
giugno 1923, Archivi Sneevliet, n. 231 (...) La versione russa inizia con “Sulla
base della relazione di Maring”».
Qui già si riconoscono evidenti tralignamenti dalla sana concezione del processo
di formazione dei partito comunisti.
- La formazione del partito in Cina si fa dipendere a) dalla “educazione di
elementi ideologicamente indipendenti”, approccio evidentemente culturalista e
idealista; b) il partito “crescerà di pari passo con la divisione tra elementi
borghesi, piccolo-borghesi e proletari”, come se non esistesse già una completa
e comprovata dottrina marxista e una Internazionale Comunista e la formazione
della organizzazione del partito fosse da rimandare a un un meccanico attendere
una certa situazione sociale contingente e locale.
- Per far procedere in Cina “la divisione tra elementi borghesi, piccolo-borghesi
e proletari” si dà l’indicazione ai comunisti di confondersi nel Kuomintang a “elementi
borghesi, piccolo-borghesi e proletari”.
- Nel Kuomintang si “porterà avanti la propaganda per le idee della lotta contro
(...) gli sfruttatori”, nello stesso partito in cui albergano gli “sfruttatori”.
- Infine, “per la lotta contro l’imperialismo straniero deve essere creata
un’organizzazione speciale di propaganda”, chiara anticipazione del fronte unico
fra partiti.
Il terzo documento è un articolo di Maring (Sneevliet), “Il risveglio delle
masse lavoratrici cinesi”, pubblicato in cinese il 22 novembre 1922.
Vi si fa un esauriente bilancio delle lotte operaie nell’anno in corso,
mostrando la grande combattività e tendenza all’organizzazione della classe in
Cina. Una presenza robusta del proletariato che, per altro, contraddice le
motivazioni addotte per trattenere la libera e indipendente formazione del
partito comunista.
Fra l’altro il compagno rileva come i padroni accusassero gli “agitatori rossi”
di fomentare le agitazioni. Invece invitano il KMT a “picchiare sugli scioperi”.
Ingenuamente Maring ritiene, “a mio parere”, che “il KMT non si rende conto
dell’importanza del risveglio degli operai cinesi”. E che quindi “ha trascurato
l’istruzione delle masse”. Paventa che “se il movimento nazionalista si oppone
alle masse lavoratrici (...) queste creeranno il proprio movimento politico e
romperanno completamente i rapporti con il KMT”, ritenuto questo deprecabile.
Fa infine una previsione: “I dirigenti del KMT presteranno sicuramente maggiore
attenzione a esprimere estrema simpatia per le masse lavoratrici”. Che tipo di
simpatia il borghese Kuomintang esprimerà per le masse lavoratrici lo dimostrerà
tragicamente nei fatti del 1927.
Secondo congreso del Partito Comunista di Cina, luglio 1922
Risoluzione sul Movimento sindacale e il PC
Il movimento operaio cinese è ancora agli albori e non riesce a liberarsi dai vincoli imposti dalle vecchie corporazioni e dalle organizzazioni artigiane. Allo stesso tempo, le lotte della classe operaia non sono altro che movimenti individuali [per migliorare] le condizioni specifiche di un determinato mestiere o di una particolare fabbrica; non sono movimenti universali.
Le organizzazioni dei lavoratori non sono né forti né sicure; i lavoratori organizzati sono pochi. È compito fondamentale del PCC studiare attentamente questa situazione, concentrare, espandere e guidare correttamente questo movimento.
In linea con l’attuale situazione lavorativa in Cina, le esperienze delle nostre attività passate e le lezioni del movimento operaio in Europa nel recente passato, dovremmo utilizzare i seguenti principi come politiche fondamentali per il movimento operaio.
1) La lotta della classe operaia e dei lavoratori poveri per liberarsi dalla rapina e dallo sfruttamento della borghesia deve essere portata avanti insieme alla lotta per gli interessi dell’elemento più progressista e dei combattenti più capaci tra i lavoratori poveri: il proletariato. Pertanto, nel suo movimento operaio, il PCC deve concentrare le sue energie sul movimento per organizzare gli operai dell’industria, come i ferrovieri, i marinai e i lavoratori dell’industria manifatturiera e tessile,
2) Perché è stato fondato il sindacato? Il sindacato è un’istituzione che protegge e lotta per gli interessi immediati dei lavoratori. Poiché il lavoratore è il creatore di tutti i beni, il lavoratore dovrebbe godere dei beni prodotti. Questa verità è il punto di partenza del vero sindacato
3) Il sindacato dovrebbe rendersi conto che il capitalista e i lavoratori non hanno niente in comune. Il loro conflitto di interessi è inconciliabile, tanto che il sindacato dovrebbe non solo evitare di mediare tra gli interessi dei capitalisti e quelli dei lavoratori, ma intensificare tali lotte. Una lotta deve seguire l’altra e tra una lotta e l’altra l’organizzazione sindacale diventerà più forte e più sicura, in modo da prepararsi per un’altra lotta. È necessario conservare la maggior parte delle quote associative del sindacato come fondi di sciopero, ma allo stesso tempo i lavoratori devono evitare di combattere in una situazione di svantaggio.
4) Il sindacato deve fare tutto il possibile per impegnarsi nel movimento per migliorare le condizioni dei lavoratori; deve fare tutto ciò che può portare a riforme nel quadro del capitalismo. Allo stesso tempo dobbiamo far avanzare rapidamente il sindacato verso l’obiettivo finale del movimento operaio, che è un movimento per rovesciare il sistema capitalista basato sugli schiavi salariati e cambiare radicalmente la società secondo i principi comunisti.
5) Quando il sindacato si impegna nel movimento per migliorare le condizioni economiche dei lavoratori, deve avanzare nel movimento per la legislazione del lavoro. Dobbiamo anche far capire al sindacato che l’adozione di una legislazione sul lavoro e il miglioramento delle condizioni di lavoro dipendono entrambi da una forte organizzazione del sindacato. Se vogliamo che la legislazione sul lavoro e il miglioramento delle condizioni di lavoro si concretizzino realmente nel capitalismo, abbiamo bisogno di lavoratori sufficientemente forti da esercitare pressione sul governo e sui proprietari delle fabbriche.
6) A volte i nostri compagni suggeriscono che il sindacato non si coinvolga nei movimenti politici: questa è una tendenza dei sindacati anarchici e costituisce un errore molto grave. Ciò indebolirà il movimento sindacale e lo manterrà per sempre in una posizione illegale. I sindacati devono lottare per l’indipendenza della nostra nazione e per i diritti politici e la libertà dei nostri cittadini (compreso il movimento per il suffragio universale e l’abolizione della legge penale contro gli scioperi). Devono anche occupare posizioni importanti nel fronte democratico unito; solo queste azioni sosterranno i lavoratori fino alla vittoria finale. Ma, allo stesso tempo, il significato di queste lotte consente al proletariato la sua propria propaganda rivoluzionaria. Non dovrebbe essere utilizzata per gli obiettivi politici degli opportunisti. Pertanto, dobbiamo impedire che i lavoratori non proletari guidino i sindacati, che devono essere guidati dal proletariato.
7) Naturalmente i sindacati possono lottare contro singoli capi o datori di lavoro, ma devono trattare e resistere ai datori di lavoro come classe; possono anche resistere al sistema dei contratti, così come al sistema in base al quale i capi opprimono i lavoratori a discrezione. I sindacati si espanderanno solo quando ogni singolo movimento assumerà un significato universale divententando una vera azione di classe.
8) Ci sono due compiti più importanti che il sindacato deve fare tutto il possibile per realizzare: il primo riguarda i contratti collettivi; il secondo è la parità di retribuzione per lo stesso lavoro. I contratti individuali sono lo strumento di sfruttamento dei datori di lavoro. Utilizzando questo strumento i datori di lavoro possono assumere e licenziare i lavoratori a loro piacimento, manipolando così il prezzo del lavoro. Il sindacato deve fare quanto può per lottare per la seguente condizione: il datore di lavoro non è autorizzato a trattare e concludere con i singoli lavoratori alcuna delle disposizioni relative all’assunzione e al licenziamento e ad altri benefici e obblighi. Solo il sindacato può rappresentare i lavoratori nella firma dei contratti con i datori di lavoro. È inoltre uno dei mezzi più astuti e crudeli dei capitalisti per dividere i lavoratori in categorie separate – in base alla razza, all’età e alla forza fisica – e determinare la loro retribuzione in base a queste categorie. I capitalisti possono usare questo metodo non solo per derubare più avidamente i lavoratori deboli e giovani, ma anche per dividere la classe operaia in diversi gruppi con interessi diversi, in modo che possano odiarsi e competere tra loro. In queste circostanze, il sindacato deve cercare di lottare per la parità di retribuzione a parità di lavoro. Non importa se il lavoratore è straniero o cinese, maschio o femmina, un giovane forte, un ragazzo o un vecchio, deve ricevere la stessa paga purché svolga lo stesso tipo di lavoro. Nessuno può negargli una paga simile per motivi di differenze biologiche e sociali. Allo stesso tempo, però, non dobbiamo confonderci: la cosiddetta parità di retribuzione per lo stesso lavoro non significa tagliare i salari più alti per allinearli a quelli più bassi, ma aumentare i salari più bassi per portarli allo stesso livello di quelli più alti. Questi sono i due compiti fondamentali del sindacato. Il successo del primo aumenterà la fiducia dei lavoratori nel sindacato e attirerà un gran numero di loro ad aderire al movimento; il successo del secondo impedirà ed eliminerà i conflitti reciproci tra i lavoratori, in modo da realizzare l’unità e l’armonia di classe.
9) Il carattere del sindacato non deve essere identico a quello della corporazione. Nessun datore di lavoro può entrare nel sindacato, ma tutti i lavoratori che percepiscono un salario devono iscriversi al sindacato, indipendentemente dal sesso, dall’età, dal credo religioso, dalla regione, dall’origine etnica, dalla nazionalità, dalle opinioni politiche o dalle competenze. Pertanto, i sindacati non dovrebbero avere procedure come quote associative troppo elevate e indagini preliminari selettive per limitare l’iscrizione dei lavoratori. Solo questo permetterà al sindacato di diventare un’unione delle masse della stessa classe.
10) Le attività principali del sindacato sono la lotta contro i capitalisti e il governo; l’aiuto reciproco e i legami affettivi sono solo obiettivi secondari, perché il sindacato.
11) La struttura del sindacato è tale da consentirgli di diventare molto rapidamente un’organizzazione molto unita, con un potere centralizzato e disciplinati sindacati di settore industriale. I sindacati di settore dei lavoratori industriali non devono essere suddivisi internamente in gruppi “autonomi” in base ai diversi mestieri, perché diventerebbero gruppi frammentati che impedirebbero al sindacato di condurre le lotte.
13) La migliore organizzazione di base del sindacato è il comitato di fabbrica. I lavoratori di ogni fabbrica di ogni settore organizzano un comitato di fabbrica come loro unità di base, e poi organizzano un sindacato di categoria. Tuttavia, il comitato di fabbrica è esclusivamente un’organizzazione dei lavoratori; non deve mai essere composto da un misto di datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. Allo stesso tempo, il comitato di fabbrica non dovrebbe essere indipendente dal sindacato.
14) Ma i sindacati [di base[ sono solo una parte della struttura del sindacato di categoria e non sono da considerare come l’ideale del sindacato. I veri sindacati dovrebbero costituire l’armonia e disciplina della classe, oltre ad essere parte della struttura del sindacato di categoria e avere obiettivi rivoluzionari. Devono unire tutta la classe operaia e non permettere mai alcun infortunoso conflitto tra gli interessi particolari di una fabbrica o tra i lavoratori e gli interessi del sindacato di categoria. Dovrebbero anche mediare tra gli interessi di un sindacato di categoria e quelli della classe operaia dell’intero paese.
15) Dovrebbe esserci un’organizzazione unificata di tutti i sindacati rivoluzionari nel mondo per combattere il capitalismo mondiale. Questa organizzazione unificata dei sindacati rivoluzionari mondiali è il Profintem. Il PCC deve organizzare i sindacati per riunirsi sotto la bandiera del Profintern in conformità con i principi di cui sopra. Allo stesso tempo, la classe operaia cinese deve evitare conflitti di interesse con la classe operaia mondiale. Ad esempio, aumentare i salari dei lavoratori cinesi impedirebbe ai capitalisti stranieri di assumere manodopera cinese a basso costo per sostituire la manodopera straniera costosa.
16) La differenza tra il PC e il sindacato è che il PC è un’ organizzazione di elementi proletari con coscienza di classe provenienti da tutte le classi; è l’avanguardia del proletariato e ha un programma di partito prestabilito: è un partito politico proletario il cui obiettivo è il rovesciamento del capitalismo. Il sindacato è un’organizzazione di tutti i lavoratori (indipendentemente dalle loro opinioni politiche); nel sindacato i lavoratori ricevono un’educazione su ”come lottare nello spirito del socialismo e del comunismo” e marciano verso gli stessi obiettivi del PC; ma è un’organizzazione influenzata da tutte le classi. Proprio come in una guerra l’esercito ha un’avanguardia, che è seguita dalla forza principale dell’esercito. Si può dire che il PC costituisca il cervello e i lavoratori il corpo. Pertanto, in qualsiasi tipo di movimento operaio, il PC deve essere l’“avanguardia” e il “cervello”. Deve prestare attenzione a tutte le attività del sindacato e deve guidare con onestà e coraggio il movimento sindacale.
17) Per guidare i sindacati e diventare l’avanguardia del proletariato, il PC deve avere gruppi forti ed efficaci nei sindacati, in tutti i comitati di fabbrica e in tutte le organizzazioni sindacali, con poche eccezioni.
18) Quando operano nei sindacati organizzati dal Kuomintang, dai partiti politici non governativi o dalle organizzazioni cristiane, i comunisti non devono istigare i lavoratori ad abbandonare i sindacati esistenti. La nostra tattica è quella di costruire la nostra forza gradualmente nei sindacati in cui hanno maggiore forza e alla fine rovesciare la posizione di direzione del Kuomintang, dei partiti non governativi o delle organizzazioni cristiane, in modo da conquistare noi stessi la posizione di dirigenza.
19) Per lottare per gli interessi attuali dei lavoratori, noi comunisti dovremmo sempre cooperare con il Kuomintang, con i partiti non governativi e persino con le organizzazioni cristiane. Ma dobbiamo anche dimostrare e spiegare sempre ai lavoratori che solo il PC è l’avanguardia dei lavoratori e il loro partito politico.
Risoluzioni aggiuntive:
La risoluzione precedente riguarda il movimento sindacale dei lavoratori di importanti industrie. È la parte più importante. Di seguito sono elencate alcune risoluzioni secondarie:
1) Le cooperative di consumo dei lavoratori sono organizzazioni che difendono gli interessi dei lavoratori; il PC deve prestare attenzione e operare in questo tipo di organizzazioni.
2) Il PC dovrebbe anche penetrare e lavorare all’interno delle organizzazioni di gilde relativamente progressiste per cacciarne i datori di lavoro; potremmo quindi unirci ad altre gilde simili per carattere o che utilizzano le stesse materie prime per formare un sindacato.
3) Il PC dovrebbe anche penetrare e lavorare all’interno di quelle gilde, gruppi,
club e scuole molto conservatrici nelle quali la borghesia ha stabilito legami
per ingannare il popolo; dovremmo organizzare piccoli gruppi al loro interno.
Istruzioni per il rappresentante dell’ECCI nel Sud della Cina
H. Maring (agosto 1922)
I) Tutta l’attività del rappresentante a-s.o deve basarsi sulla risoluzione del II Congresso del Comintern sulla Questione Coloniale.
II) Il Comitato Esecutivo considera il partito Guomindang un’organizzazione rivoluzionaria che mantiene il carattere della rivoluzione del 1912 e che cerca di creare una repubblica cinese indipendente. Pertanto, il compito degli elementi comunisti in Cina deve essere il seguente: a) l’educazione degli elementi ideologicamente indipendenti, che dovrebbero costituire il nucleo del futuro partito comunista cinese: b) questo partito crescerà di pari passo con la crescente divisione tra elementi borghesi, piccolo-borghesi e proletari. Fino a quel momento, i comunisti sono obbligati a sostenere il partito Kuomindang e in particolare l’ala del partito che rappresenta gli elementi proletari e i lavoratori manuali.
III) Per l’adempimento di questi compiti i comunisti devono organizzare gruppi di seguaci comunisti nel Guomindang e anche nei sindacati. Questi gruppi devono formare un esercito che porti avanti la propaganda per le idee della lotta contro l’imperialismo straniero e per la creazione di una Repubblica Popolare Cinese, per l’organizzazione della lotta di classe contro gli sfruttatori stranieri e cinesi.
IV) Per la lotta contro l’imperialismo straniero deve essere creata un’organizzazione speciale di propaganda. Questa organizzazione deve cercare di sviluppare il proprio lavoro in tutto il paese sulla base di un programma d’azione non solo contro l’oppressione giapponese aperta, ma anche contro la politica ipocrita dell’imperialismo britannico e americano e per l’alleanza con la Russia sovietica, per l’associazione con gli elementi rivoluzionari del Giappone. Questa organizzazione deve essere istituita, se possibile, d’accordo con il Guomindang, ma deve essere totalmente indipendente da questo partito perché il Guomindang, responsabile del governo meridionale, ha di volta in volta evitato un conflitto con gli elementi imperialisti,
V) L’adempimento del compito principale dei comunisti in Cina, l’organizzazione delle masse lavoratrici, in questo momento possibile solo sotto forma di creazione di sindacati, incontra ostacoli a causa dell’attuale forma di organizzazione delle anacronistiche gilde, basate sul localismo. La difficoltà maggiore nella lotta contro queste gilde è il fatto che non esistono solo per l’aiuto reciproco, ma sono anche organizzazioni per il culto degli antenati o delle divinità locali. Per quanto riguarda questa superstizione religiosa delle masse, la lotta contro le corporazioni questo senso deve essere evitata e l’attenzione dei lavoratori deve essere concentrata sul fatto che queste organizzazioni non sono abbastanza forti per adempiere al loro compito economico e che per questo motivo devono essere istituiti dei sindacati.
VI) La centralizzazione dei sindacati dovrebbe essere realizzata in
corrispondenza con i centri industriali in cui esistono già dei sindacati. La
soluzione del problema se devono essere organizzate organizzazioni industriali o
di mestiere dipende totalmente dalle condizioni locali.
Sneevliet (Maring), Xiangdao n. 1, 22 novembre 1922
Il risveglio delle masse lavoratrici cinesi
Quest’anno ciò che ha attirato maggiore attenzione è la grande attività dei lavoratori. Nei moderni centri industriali di tutto il Paese le masse lavoratrici si sono sollevate per chiedere un miglioramento delle loro miserabili condizioni di lavoro. Sebbene non abbiano una loro organizzazione e nonostante gi stranieri si ricorrano a misure severe per reprimerli, si sono verificati frequenti scioperi di grande e piccola entità.
All’inizio di quest’anno i marinai del Guangdong hanno organizzato uno sciopero. Ciò ha causato di nuovo terrore in chi si preoccupa per lo sviluppo del movimento operaio. Questo ora ha già un’organizzazione sindacale estremamente vasta. Naturalmente, il governo britannico di Hong Kong, ha aiutato i capitalisti e ha vietato le attività del suddetto sindacato di Hong Kong, pensando di poter causare la dispersione dello sciopero. Al contrario, l’opposizione ha suscitato l’aiuto degli elementi patriottici cinesi. Quando la Compagnia di navigazione ha reclutato crumiri da altri luoghi, altri operai delle industrie si sono sollevati per aiutare i marinai.
Proprio è quando tutto il mondo capitalista sta tagliando i salari e obbliga a condizioni di lavoro disumane per imporsi, i marinai della nostra nazione hanno improvvisamente iniziato una lotta e hanno ottenuto vittoria completa. Il giorno in cui il Sindacato dei Marinai ruppe ogni remora e della grande manifestazione dei lavoratori di Hong Kong fu un duro colpo per il governo britannico di Hong Kong.
Dopo questo importante evento l’opposizione all’arrogante saccheggio capitalista si diffuse immediatamente in tutto il paese. Ben presto, la China Zhaoshang Steamship Company rifiutò di aumentare i salari. I marinai di Shanghai, dopo aver appreso dall’esempio dei loro colleghi del Guangdong, lanciarono un grande sciopero. In seguito ci fu una grande attività da parte di tutti i lavoratori ferroviari. Gli scioperi dei ferrovieri sulle linee Pechino-Hankou, Pechino-Suiyuan, Canton-Hankou e Pechino-Fengtian furono tutti vittoriosi.
In particolare Hankou ha dimostrato a sufficienza che il mondo del lavoro pensa già in modo nuovo e con nuovo spirito. Questo importantissimo centro dell’industria moderna è stato teatro di grandi scioperi dei siderurgici, degli operai delle fabbriche di munizioni e dei tiratori di risciò. Sebbene le loro organizzazioni fossero molto giovani, essendo state costituite solo durante lo sciopero, riuscirono tutte a ottenere la vittoria. Anche i minatori di Pingxiang, che si erano sollevati per chiedere un miglioramento delle condizioni di vita, ebbero successo. A Shanghai i portatori di risciò, i lavoratori più duramente sfruttati, le lavoratrici delle fabbriche di seta, i tessili e delle fabbriche di tabacco organizzarono scioperi per chiedere aumenti salariali e per opporsi ai maltrattamenti.
Più recentemente è scoppiato l’importantissimo sciopero nelle miniere di Kailuan. Questo sciopero ha davvero attirato l’attenzione di tutta la popolazione del Paese. Gli studenti di Pechino hanno espresso calorosamente la loro simpatia nazionalista nei confronti degli scioperanti. Hanno raccolto fondo per gli scioperanti e gli studenti di Tangshan hanno avviato un boicottaggio delle lezioni per aiutare i minatori. Durante questo grande movimento di sciopero abbiamo visto, da un lato che l’esercito britannico, nel reprimere gli scioperi, ha dato prova della concezione del console britannico di “rispetto della sovranità cinese”, dall’altro che la simpatia dell’opinione pubblica per lo sciopero è aumentata rispetto al passato.
Ora i lavoratori della nazione hanno creato nuove organizzazioni. I ferrovieri stanno pianificando e preparando il collegamento e l’unificazione di tutti i sindacati ferroviari. I minatori di Pingxiang hanno già un sindacato di 20.000 membri. A Hankou i lavoratori dell’Hubei hanno costituito una federazione con oltre 20.000 membri. Nell’Hunan tutti i sindacati stanno formando una federazione del lavoro.
Tuttavia, per quanto riguarda le organizzazioni dei lavoratori di Shanghai, in particolare quelle osteggiate dai consoli stranieri, i capi dello sciopero non solo sono stati oggetto di circolari di denuncia ma sono anche stati condannati al carcere. Inoltre i funzionari cinesi sono istigati a esercitare pressioni estreme sui lavoratori. Alcuni giovani che hanno guidato gli scioperi sono già stati arrestati e portati davanti al tribunale e condannati a tre mesi di carcere. Dopo i tre mesi sono stati nuovamente arrestati e portato davanti a un funzionario cinese e rinchiusi senza processo. Questo è successo più di due mesi fa e non sappiamo cosa succederà. Al sindacato tessile di Shanghai “Pudong”, l’insegna [sic] è stata vietata dai funzionari cinesi. Il risultato è stato che gli operai della fabbrica anglo-americana hanno indetto uno sciopero per opporsi al comportamento dei funzionari.
Non è esagerato affermare che gli operai delle industrie moderne del nostro paese si sono risvegliati. Non sembrano più gli stessi schiavi di un tempo. A Hong Kong, Hankou, Shanghai e Tangshan si sono verificati scioperi di solidarietà per aiutare altri lavoratori a opporsi al capitalismo, dimostrando così di avere già una coscienza di classe. I lavoratori sono già diventati una nuova forza nella società cinese e in futuro potranno occupare un posto estremamente importante non solo tra i saccheggiatori e i saccheggiati, ma potranno anche diventare una grande forza politica. Naturalmente, sappiamo che il proletariato moderno cinese è estremamente giovane, ma nei centri industriali sopra citati ha dimostrato la sua grande importanza. La sua organizzazione si è sviluppata e si è centralizzata. Quello che diciamo non è una vanteria. Sappiamo che la Cina sta ancora subendo la distruzione di una guerra senza fine tra i Signori della Guerra. Nel Nord, una buona organizzazione dei lavoratori ferroviari può già frenare il selvaggio corso delle operazioni militari e aiutare quei pochi dirigenti a unificare il paese e lavorare per la libertà e il movimento nazionale.
Molti giornali stranieri in Cina nutrono l’intenzione di creare una sorta di opposizione nell’opinione pubblica alla coscienza dei lavoratori. È una cosa molto naturale. Sebbene sappiano chiaramente che nei paesi industrialmente sviluppati del mondo moderno i lavoratori presto si sono uniti e organizzati per la lotta, spesso sostengono che gli scioperi sono causati dalle attività segrete di agitatori rossi. Questi agitatori rossi sarebbero generalmente dietro tutti i tipi di movimenti di sciopero. Inoltre dicono che la creazione di fabbriche cinesi viene a costituire un paradiso per gli operai, dove il padrone usa amorevole gentilezza per attirare uomini, donne e bambini in questo paradiso. I sindacati proclamano scioperi e danneggiano la vita gioiosa dei lavoratori in questo paradiso. L’unica causa è la malizia degli agitatori. Pertanto, dicono che questi elementi cattivi sono al soldo del partito estremista. Questi giornalisti stranieri, partigiani del saccheggio della manodopera cinese e delle materie prime da parte dei capitalisti stranieri, pensano chiaramente che il partito estremista russo abbia creato questi disordini. Ad esempio i ferrovieri sulla Pechino-Hankou hanno usato denaro per sostenere lo sciopero di Tangshan, ma questo avrebbe coinvolto personalmente il rappresentante russo a Pechino. Poiché i giornali stranieri diffondono le notizie in questo modo, conquistano la società dei giovani intellettuali cinesi e inoltre, cercano di infuenzare i lavoratori ribelli. Perorano il compromesso tra i lupi e le pecore, e Shanghai ne è un esempio lampante.
Nell’ultimo mese, i giornali stranieri hanno scoperto un nuovo tipo di “complotto”. Non solo gli agitatori rossi sono dietro gli scioperi, ma anche i dirigenti del KMT sarebbero responsabili di aiutare i lavoratori (lo hanno riportato il Peking Times e il Tientsin Times). Il noto giornale inglese di Shanghai, da un lato chiede alla borghesia cinese di rompere con il partito nazionalista e afferma che questo partito ha già stretti rapporti con il Partito Comunista, mentre dall’altro lato consiglia a Sun Yat-sen di distruggere il nuovo spirito tra le masse lavoratrici. Secondo loro, il piano migliore di Sun Yat-sen è quello di ripristinare la sua posizione precedente alla promulgazione del piano per un’alleanza sino-russa-tedesca. Il North China Daily Herald accorda a Sun una buona posizione e riconosce la sua influenza tra i lavoratori cinesi e di conseguenza vuole che faccia propaganda contro gli scioperi. Se Sun Yat-sen diventasse un picchiatore di scioperi tornerebbe a essere un beniamino degli inglesi.
Ma, a nostro parere, il KMT cinese, pur non rendendosi forse ancora conto dell’importanza del risveglio degli operai cinesi, non può impegnarsi in attività che si oppongono ai lavoratori. Se lo facesse, i capi del KMT perderebbero perderebbero la fiducia degli elementi più forti nella lotta per l’indipendenza nazionale.
Inizialmente il KMT ha prestato troppa attenzione a concentrare tutte le sue forze nell’organizzazione militare e ha trascurato l’istruzione delle masse. A causa di questo tipo di politica, il KMT non ha avuto un buon successo. Quest’anno, il 10 ottobre, le classi intellettuali di Pechino, durante la grande riunione per commemorare la rivoluzione hanno dimenticato di menzionare il padre rivoluzionario del rovesciamento della dinastia Qing, Sun Yat-sen.
Se il popolo del movimento nazionalista si oppone alle masse lavoratrici o trascura la lotta delle masse lavoratrici per resistere agli sfruttatori, ciò produrrà sicuramente risultati molto negativi. Il movimento nazionalista rivoluzionario incontrerà un ostacolo estremamente grande e le masse lavoratrici creeranno il proprio movimento politico e romperanno completamente i rapporti con il KMT.
Quando i dirigenti del KMT si renderanno conto e capiranno il loro compito, presteranno sicuramente maggiore attenzione a esprimere estrema simpatia per le masse lavoratrici. Queste masse sono l’avanguardia della lotta per la libertà del popolo cinese.