|
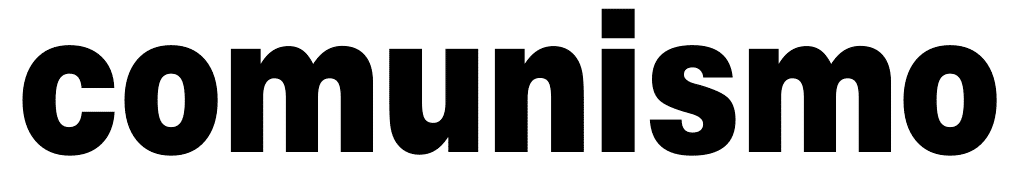 |
n. 92 - novembre 2021 - Anno XLIII aggiornato al 20 dicembre 2021 |
|
|
||||||||
|
||||||||
|
Solo due anni fa il problema più grave dell’economia capitalistica era il basso livello dei prezzi, anzi, la tendenza a un abbassamento progressivo: dalla disinflazione alla deflazione.
E pensare che per definizione fra i compiti delle Banche Centrali uno dei principali è proprio il controllo dell’inflazione, che doveva non certo sparire ma rimanere contenuta entro stretti margini. Addirittura nel 2016 le manovre dell’allora Governatore della BCE, oggi a capo del Governo della Repubblica Italiana, apparivano inefficaci a far circolare nella Comunità Europea quel tanto di liquidità per aumentare, secondo le ricette degli economisti borghesi di tutte le scuole, quel minimo di inflazione necessaria per garantire il fisiologico movimento di produzione e consumo guidati dalla circolazione monetaria.
Perché, sempre secondo le stesse ricette, i fondamenti teorici che spiegano i processi inflattivi sono sostanzialmente riconducibili a pochi capisaldi. E su questi le Banche Centrali prendono i loro provvedimenti.
Uno è dato da una sorta di “autoavveramento” dell’inflazione; ciò a dire che ancorare le aspettative di inflazione ai livelli previsti, ove questi non si riescano a raggiungere o mantenere, può provocare proprio un effetto “trascinamento” che la fa impennare. Ovvero che non si può agire da parte delle Autorità Monetarie con decisione e tempestività quando essa comincia a presentarsi, perché questo può innescare l’effetto che si vorrebbe controllare, in una sorta di “rimbalzo” psicologico. Tutta una questione di “sentiment”, come si dice in gergo, con tanto di grafici e valutazioni empiriche che ne descrivono gli andamenti. Come dire che un “al lupo al lupo” farebbe sì che il lupo appaia davvero.
Un altro fattore, più analitico, correla la “curva di Phillips” al fenomeno inflazione: un grafico, desunto da dati rilevati, evidenzierebbe il rapporto inverso tra disoccupazione e inflazione. Ovvero, maggiore è l’occupazione, più cresce l’inflazione. Da questo grafico ci si aspetterebbe l’andamento nel tempo futuro dell’inflazione, o meglio di una delle sue componenti. La piena occupazione sarebbe quindi, alla fin fine, un elemento negativo. Viva allora l’esercito di riserva, che permette di mantenere stabile il livello dei prezzi (e tendenzialmente abbassa pure il livello del costo del lavoro), e al macero “Salario, prezzo e profitto” di Marx, che afferma che i salari dipendono, entro ampi limiti, dal rapporto di forza fra le classi
Da alcune scuole economiche borghesi veniva presa in considerazione l’eccessiva circolazione monetaria come innesco del ciclo inflattivo. Anche se la teoria non considerava i bruschi picchi di aumento come causa diretta, andamenti crescenti sul lungo periodo potevano esserlo. In ogni caso le politiche monetarie e fiscali, espansive o restrittive, che aumentano o riducono l’offerta di moneta, e quindi la sua circolazione, avrebbero dovuto essere un argine contro le turbolenze sui prezzi.
Nel passato la modifica della base monetaria ottenuta tramite l’acquisto o la vendita di titoli di Stato da parte delle banche centrali, le operazioni sul tasso di interesse pagato dal sistema bancario per ottenere liquidità dalla banca centrale, le manovre sul coefficiente di riserva obbligatoria, ovvero le riserve che le banche devono detenere presso la banca centrale, le verifiche sui flussi finanziari erano tutti provvedimenti per il controllo, diretto o indiretto, dei contrastanti fenomeni, inflattivi o deflattivi.
Altra causa poteva essere il deficit dei governi; un aumento del debito statale si riverserebbe sui prezzi in generale. Infine ci si può aspettare che aumenti per condizioni specifiche su materie prime o altre perturbazioni sui mercati particolari, inducano un aumento generalizzato dei prezzi.
Paradossalmente nel contesto post pandemico attuale, e a quanto pare non tanto post, il lungo ciclo deflattivo ha cambiato di segno, e sono venute ad avverarsi tante di quelle condizioni elencate, quasi tutte insieme.
In realtà già prima della pandemia si potevano avvertire tensioni inflattive che una condizione deflattiva generalizzata faceva non trasparire, tutte però di tipo esogeno rispetto alle condizioni proprie del processo produttivo capitalistico. In altre parole le dinamiche imperialistiche inducevano effetti in contrasto con il clima deflazionistico che si era determinato con la grande crisi del 2008.
Ad esempio i dazi imposti nel 2018 su molte produzioni cinesi avevano comportato subito un aumento dei prezzi all’importazione, compensati da un andamento deflattivo in altri settori. Alla vigilia della pandemia, le tensioni sui mercati dell’energia fossile mostravano un andamento altalenante, dove soltanto il grande aumento delle scorte americane di petrolio da scisti permetteva di contenere i prezzi.
Questo prima che il processo capitalistico fosse investito dagli effetti della pandemia, evento che ha profondamente cambiato il quadro economico mondiale. L’epidemia Covid, che pure ha dato inizialmente un effetto fortemente deflattivo, una volta che si sperava fosse per terminare ha messo in moto condizioni per una ripresa inflattiva.
Il processo è per la maggior parte dei casi riassumibile secondo uno schema preciso. Il primo passo è la stasi della domanda, conseguenza ovvia delle condizioni di contenimento della pandemia con il blocco e l’isolamento sociale. Ne è seguito, man mano, il forte rallentamento della produzione, talvolta il suo arresto, e il conseguente utilizzo delle riserve in magazzino, scarse per il modo di produrre secondo i criteri del just in time, secondo i quali sarebbero le oscillazioni della “domanda” a disciplinare la produzione, che quindi non potrebbe come in passato accumulare le scorte. Alla domanda seguirebbe per necessità l’adeguamento dell’offerta, in una perfetta sintonia con il just in time aziendale; per quel che è richiesto, con il minimo di produzione le riserve di magazzino possono quasi azzerarsi. E questo è quel che è successo.
Parallelamente si contrae anche la richiesta di trasporto di merci, materie prime, semilavorati. I trasporti marittimi sono quelli più colpiti da questa condizione asfittica, gli armatori preferiscono tenere alla fonda le navi, e i vuoti container rimangono inutilizzati sulle banchine. Del pari rallenta anche il trasporto via terra.
La fase di ripresa dei consumi mette nuovamente sotto pressione tutto il sistema di produzioni e trasporti. Questa crisi da sovradomanda, ovviamente non solo di merci finite ma di tutte le componenti della filiera produttiva, inceppa nuovamente traffici e produzioni, prima per difetto, ora per eccesso. E la risposta del modo capitalistico di produrre e consumare è una sola possibile: aumento dei prezzi, spinta inflazionistica.
Naturalmente questo schema generale non spiega tutte le dinamiche del fenomeno che ora vediamo imporsi a scala mondiale, apparentemente opposto, nelle grandezze monetarie, alla nostra concezione, e previsione, della crisi generale del capitalismo come crisi deflattiva.
Altre cause di crescita dei prezzi sono indotte da penuria intrinseca ed estrinseca. Nel caso dei semiconduttori, la produzione, essenzialmente localizzata nel sud‑est asiatico, Cina, Corea del sud, Taiwan, da cui pare giungere il 90% dei microchip, non si è ridotta durante la pandemia, come per altri prodotti. La loro enorme richiesta nei più svariati settori si è scontrata con un’offerta insufficiente per alcuni di questi comparti, rimasti totalmente privi di scorte per i “principi” produttivi moderni.
Alla ripresa gli effetti della politica just in time hanno bloccato molti tipi di produzioni: la ricostituzione delle scorte non è un processo rapido e comporta il rapido innalzamento dei prezzi. Inoltre giocano pesantemente le dinamiche di approvvigionamento delle speciali materie rare da cui partire: in questo caso fanno premio gli scontri tra produttori per il loro controllo ed utilizzo.
Naturalmente queste tensioni, quando non siano conflitti aperti, si riflettono sui prezzi che crescono inizialmente in modo molto veloce, salvo stabilizzarsi nel tempo attorno al loro valore, il prezzo della loro riproduzione media sociale. Si tratta evidentemente di un processo inflattivo che rimane definito per un certo periodo, più o meno lungo. Questa è una tendenza generale nel mondo capitalistico per tutte le materie prime che sono alla base delle nuove tecnologie, sulle quali si decide il futuro delle nuove produzioni di massa.
Oscillazioni più o meno marcate dei prezzi sono dovute anche ai meccanismi della speculazione finanziaria che accompagnano il mondo borghese fin dal suo affermarsi sul mondo, riflesso perfetto delle dinamiche dell’imperialismo. La speculazione finanziaria ha aggiunto del suo alla crescita dei prezzi delle materie prime, rendendoli un investimento fortemente remunerativo, paragonati ad esempio ai rendimenti bassissimi dei titoli di Stato, insieme alla speculazione sui titoli “derivati” a quelli legati. Ironia del capitalismo, proprio le oscillazioni al ribasso legate ai futures sul petrolio ne avevano causato in altri tempi un crollo vertiginoso del prezzo.
In effetti, relativamente alle materie prime, ferro, rame e gli altri metalli di impiego ormai stabilizzato, ad esclusione di quelle definite “energetiche”, i loro prezzi nei primi tempi della pandemia erano crollati del 70%; la Cina, grande consumatrice, ne ha fatto ingenti scorte, col vantaggio di aver messo sotto controllo l’epidemia con quattro mesi di anticipo. I prezzi sono poi cresciuti violentemente alla ripartenza e a soffrirne maggiormente sono stati gli altri paesi industrializzati con i magazzini pressoché vuoti: quindi scarsità di acciaio, rame e così via, con la crisi dei trasporti che ha fatto il resto.
Di particolare rilevanza nel caso dei prezzi dei combustibili, in particolare petrolio e gas naturale, è lo scontro tra produttori e grandi consumatori. Le altre concause pesano in modo poco rilevante sul loro aumento. “Transizione verde”, misure contro il “cambio climatico” e così via, sono spiegazioni deboli che evidenziano un aspetto secondario della fiammata inflazionistica attuale. Il carbone, prodotto che avrebbe dovuto esser bandito dal consumo su larga scala, prezza oltre 200 dollari, a fronte dei 50 di solo un anno fa.
Il capitalismo ha fame di petrolio per il suo funzionamento, anche se durante il primo periodo della pandemia la produzione avanzava a ritmi ridotti. Ma ora sono le catene di fornitura che viaggiano molto più lentamente, e in questo caso non è solo un problema di trasporti a ripresentare una possibile crisi energetica. La Russia lo fa con il gas, la Cina non solo con la componentistica, ma anche con i fosfati, fondamentali per la produzione di fertilizzanti. I livelli di scorte di gas in Europa sono molto scarsi, e non bastano a risolvere questa condizione gli estratti americani dalle sabbie di scisto, come è accaduto prima della pandemia.
C’è chi attribuisce la responsabilità della presente condizione inflazionistica anche alla liquidità immessa con le politiche monetarie non convenzionali per evitare il crollo indotto dalle crisi debitorie. In realtà non vediamo operare questa grande disponibilità di liquido, puramente fittizia, nel processo in atto sui mercati. È una constatazione di ciò che sta accedendo. Le Banche centrali ad oggi continuano con le loro politiche espansive, perché è prioritario sostenere in ogni modo la pur debole ripresa dopo la stretta della pandemia. Ripresa che, nelle entusiastiche dichiarazioni di molti analisti, sembra essere quella che risolverà la crisi strutturale evidenziata nel 2008. Il peso della stratosferica massa del debito privato e sovrano degli Stati, che per la nostra dottrina nasce dal processo reale di produzione e consumo, non può essere messo tranquillamente da una parte senza che i suoi effetti non si manifestino più.
Reputiamo questo intervallo inflazionistico un evento limitato nel tempo, frutto di una brusca ripresa dopo una crisi essenzialmente esogena, fuori e non correlata cioè dall’andamento catastrofico del capitalismo. Quanto limitato non è al momento possibile dirlo, né ci interessa per quanto abbiamo da studiare e comprendere nella nostra prospettiva rivoluzionaria. Ma siamo certi che la deflazione da fase terminale del lunghissimo ciclo capitalistico riprenderà la sua corsa.
8. Terrorismo fra le classi
Capitolo esposto nella riunioni generali dal gennaio 2020 al settembre 2021
La Lega proletaria mutilati e reduci di guerra
Sulla sconfitta del proletariato i nostri nemici borghesi fanno propria la sentenza di Brenno: “Vae victis!”, il nostro grido invece sarà “Gloria victis!” (gloria ai vinti), perché, con il poeta, noi possiamo affermare: «Odio di Dei, Promèteo / arridi ai figli tuoi / solcàti ancor dal fulmine / pur l’avvenir siam noi».
Nel corso dei nostri rapporti, a sfatare la favola che il presunto dogmatismo e volontario isolamento del PCd’I avrebbe determinato il suo distacco dalle masse rendendo sterile la sua azione pratica e lasciato libero il campo alla reazione fascista, tra le altre cose abbiamo accennato all’attenzione riposta dal partito sulla “Lega proletaria mutilati e reduci di guerra”. Vogliamo ora ripartire da lì.
La Lega, aderente alla confederazione Generale del Lavoro, era nata nel 1919 ad opera di un gruppo di reduci di guerra rivoluzionari come mezzo di agitazione tra le vittime della guerra per organizzarle e guidarle verso la lotta rivoluzionaria per l’abbattimento della società borghese.
Nei giorni a cavallo tra giugno e luglio tenne a Milano il suo primo congresso. Assieme agli obiettivi di carattere rivendicativo, quali pensioni di guerra, indennità, assistenza medica etc., il congresso espresse posizioni politiche di segno intransigente: «Contro l’avvelenamento patriottico delle giovani generazioni nelle scuole»; contro «la guerra, e insieme con essa gli odii e le rivalità fra le nazioni che dobbiamo affratellare nell’Internazionale»; per la «dittatura del proletariato» (“Avanti!”, 4 luglio 1919]).
Dobbiamo pure ricordare che la Lega aveva immediatamente dato la sua adesione alla Terza Internazionale.
E, a dimostrazione della sua posizione nei confronti dello Stato borghese e del suo governo, possiamo ricordare la decisione di «rivolgere invito ai proletari ex combattenti di tenersi pronti per rispondere adeguatamente alle continue e crescenti provocazioni degli scherani di Nitti» (“Avanti!”, 11 aprile 1920).
Oppure: «Il C.C. uniformemente a quanto fu stabilito nel congresso di Firenze tenuto il 20 u.s (...) ha emanato apposita circolare riservata con le ulteriori istruzioni alle dipendenti federazioni. Tutte le Sezioni debbono strettamente attenersi alle disposizioni che verranno dalle Federazioni, osservando una rigorosa disciplina nell’applicazione di esse. Tutti al proprio posto. Le Federazioni esigano dalle dipendenti Sezioni categoricamente l’applicazione delle disposizioni che emaneranno assicurandosi che sono state osservate e segnalando al C.C. nominativamente l’avvenuta applicazione» (“Avanti!”, 27 ottobre 1920). Il tono della circolare non lascia dubbi sul fatto che le “istruzioni” fossero di carattere militare.
Scriveva “Il Comunista” del 20 febbraio 1921: «La lega proletaria combattenti è, oggi, per la volontà dei suoi componenti, una organizzazione rivoluzionaria. I giovani che la compongono sono in gran parte politicamente orientati verso il comunismo [...] La Lega proletaria, anche per le sue ragioni sentimentali di esistenza, è un organo capace di polarizzare i giovani reduci sinceramente rivoluzionari. Ha nel suo seno gli strazi sanguinanti di un dolore sofferto per una causa non sentita [...] È un organo capace di sobillare le masse ancora incerte, di sospingerle alla passione di un sacrificio assai grande compiuto per la redenzione della classe oppressa».
E nel numero del 3 marzo dello stesso giornale si legge: «Il compito precipuo della Lega Proletaria deve consistere soprattutto nell’opera di educazione militare del proletariato [...] Educazione militare, nel senso di preparazione spirituale e tecnica del proletariato all’adempimento del suo più alto, più arduo e più nobile dovere verso la Rivoluzione e verso l’Umanità: il dovere militare rivoluzionario».
PSI e bonzi sindacali riuscirono a dirottare questa chiara impostazione di
classe e rivoluzionaria sul terreno del collaborazionismo con lo Stato borghese
e della cosiddetta “neutralità politica”. Ma contro la degenerazione di una
organizzazione nata con scopo dichiaratamene rivoluzionario, il Partito chiamò a
raccolta i comunisti appartenenti alla Lega Proletaria affinché all’interno di
ogni federazione organizzassero gruppi comunisti per l’attuazione del seguente
programma:
«1 – Stretta subordinazione della Lega al Partito comunista, unica ed esclusiva
sezione in Italia della Internazionale comunista alla quale la Lega proletaria
aveva dato sua entusiastica adesione fin dall’anno scorso.
«2 – Azione energica della Lega proletaria per sviluppare l’azione del Bureau
internazionale degli ex combattenti, secondo le decisioni del congresso di
Ginevra.
«3 – Allargamento delle basi della Lega, sì da comprendere tutti gli ex militari
e i militari, senza alcuna distinzione.
«4 – Propaganda risoluta e tenace per fare comprendere agli ex militari la
necessità assoluta di prepararsi a diventare i combattenti dell’esercito
rivoluzionario contro le malsane degenerazioni della vigliaccheria
socialpacifista».
Nello stesso numero di giornale con l’articolo “L’Educazione Militare” veniva
messo in evidenza quale, secondo il nostro partito, avrebbe dovuto essere il
compito della Lega Proletaria, e quale era, ed era sempre stato, al contrario,
l’atteggiamento del Partito socialista in proposito:
«Secondo i comunisti, il compito precipuo della Lega Proletaria deve consistere
soprattutto nell’opera di educazione militare del proletariato [...]
«Il “vecchio glorioso” Partito socialista italiano si chiudeva, dinanzi al
problema militare, in un atteggiamento idiota che voleva essere agnosticismo ed
era semplicemente ignoranza e vigliaccheria [...]
«Il vecchio socialismo apologizzava la diserzione – il gesto molto semplice e
molto comodo di chi, incapace di lottare e di resistere, si squaglia lasciando i
compagni negli impicci.
«I comunisti proclamano che i lavoratori non debbono disertare dalle file
dell’esercito borghese, ma penetrarvi e rimanervi, colle orecchie e cogli occhi
bene aperti e coi nervi a posto; debbono imparare il maneggio delle armi e la
tecnica militare; debbono imparare più che possono di arte militare e di scienza
militare, debbono accettare, anzi tendere a conseguire i gradi nell’esercito
borghese per potere diventare domani i soldati, gli ufficiali dell’esercito
proletario dopo aver fatto saltare, nel momento decisivo, l’apparato di quello
borghese.
«I vecchi socialisti coltivavano amorosamente la vigliaccheria delle masse
ripetendo il grido idiota [...] “Giù le armi!” Con questa propaganda, i
socialdemocratici rendevano un eccellente servizio alla borghesia e preparavano
le ignominiose disfatte del proletariato davanti alla baldanza fascista. I
comunisti dichiarano che questa propaganda socialpacifista costituisce il più
abbietto e il più turpe tradimento controrivoluzionario del proletariato [...] È
indubitabile – per chi non sia un imbecille o un agente della borghesia – che il
proletariato non potrà conquistare il potere senza una salda organizzazione
militare [...]
«La Lega proletaria deve fare una attiva propaganda tra coloro che sono stati
militari [...] affinché conservino e sviluppino le loro attitudini militari;
deve curare la loro educazione militare, sì da trasformarli in altrettanti
soldati dell’esercito internazionale proletario.
«Essa non deve predicare il pacifismo, ma la necessità dell’azione militare
rivoluzionaria, non l’individualistica insofferenza di ogni disciplina e di ogni
regola, ma la preparazione alla rigida disciplina rivoluzionaria. La storia
insegna che solo attraverso una severa autodisciplina le classi possono
conquistare e conservare il potere».
Questo sarebbe dunque il partito “settario” che, per paura di contaminarsi, si
sarebbe “chiuso in sé stesso”?
La linea del fronte della guerra di classe
E quali sarebbero le organizzazioni o i partiti che avrebbero effettivamente contrastato l’avanzata e la vittoria del fascismo? I socialisti massimalisti? gli anarchici? i sindacalisti rivoluzionari?
Ne "Il Comunista", organo centrale del PCd’I, del 3 marzo 1921 si legge: «L’intesa tra fascismo e stampa borghese forma una vera e propria organizzazione d’assalto contro il comunismo. La stampa riceve i bollettini... dalle sedi fasciste o li formula nella stessa maniera in cui formulavano i bollettini gli stati maggiori dell’esercito dopo una azione bellica: l’avversario ricacciato e disperso; molti cadaveri avversari lasciati sul terreno, molti feriti avversari, molti prigionieri avversari. Dall’altra parte alcune ecchimosi, qualche contusione, forte entusiasmo. E poi tutto un contorno di esaltazione del coraggio dell’aggressore e la squisita viltà dell’assalito. Ma noi possiamo affermare che le perdite avversarie, negli scontri quotidiani, sono ben maggiori di quelle che risultano dai bollettini. L’omertà avversaria non è sufficiente a nasconderci la verità».
“Il Comunista”, 6 marzo 1921: «Per alcuni mesi la cronaca ha registrato una serie di offensive delle guardie bianche borghesi, denominate in italiano fascisti, contro le persone e gli istituti proletari. La resistenza era quasi nulla e l’impeto degli assalitori cresceva ogni giorno, estendendo i propri obiettivi con sempre maggiore audacia. La compiacenza borghese era a buon diritto vivissima [...] Gli avvenimenti di questi ultimi giorni hanno modificato lo stato d’animo dei contendenti [...] Il proletariato, dopo un periodo di smarrimento di cui la causa è tutta nelle opere del riformismo e del massimalismo pagliaccio che lo hanno finora dominato, [...] rialza sensibilmente il suo morale attraverso una serie di vigorose risposte alle azioni dell’avversario [...] In Puglia tutto un incendio di una massa rivelatasi mille volte migliore dei suoi dirigenti, che sono tra gli arnesi peggiori del socialismo bagolone, travolge la importazione dei metodi fascisti; in mille episodi delle stesse provincie in cui i bianchi spadroneggiavano la riscossa proletaria si delinea sicura; a Firenze la insurrezione armata delle masse oppone violenza a violenza con una decisione meravigliosa; a Trieste, all’ennesimo bestiale rogo delle sedi proletarie rispondono le fiamme del cantiere San Marco, e i prodotti accumulati per milioni di valore pel profitto capitalistico ardono senza che possa salvarli la forza armata della polizia né la insulsa manovra socialdemocratica di tenere i lavoratori comunisti fuori dalle officine, nella tradizionale posizione eunuca delle braccia incrociate [...] Noi registriamo con gioia un bollettino di guerra in cui – finalmente! – le perdite dell’avversario hanno superato le nostre».
In altro articolo dello stesso numero di giornale si legge: «Abbiamo detto e ripetiamo che gli episodi di questi giorni non possono considerarsi isolatamente, staccati gli uni dagli altri, ma collegati da una linea immaginaria che è pure la linea del fronte ove si combatte la guerra di classe. Questa linea frontale è dal punto di vista strategico assai infelice, ma tenderà sempre più a correggersi. Nella guerra guerreggiata [...] tutti i mezzi sono buoni alla bisogna».
«Noi siamo solidali col metodo scelto dai lavoratori comunisti per combattere
l’unico suo nemico: la classe borghese. Siamo noi che abbiamo sostenuto, in
linea di principio, il mezzo violento per fiaccare la violenza avversaria. Le
masse rivoluzionarie hanno sentito la necessità di questo metodo e sono con noi
nel seguirlo. Dinanzi al proletariato rivoluzionario italiano il Partito
Comunista appare come il dirigente della lotta antiborghese».
Le tre giornate rosse di Viareggio
Per dare una prova di quale fosse la temperatura sociale e la determinazione del proletariato negli anni del dopoguerra riportiamo un episodio di guerra civile, di una insurrezione del proletariato seppure scaturita da un episodio del tutto estraneo alla contesa di classe. Per la cronaca dei fatti ricorriamo a quanto riportato dall’“Avanti!” dei giorni 4, 7, 8 e 11 Maggio 1920.
Era la domenica 2 maggio 1920, a Viareggio si disputava una partita di calcio tra la squadra locale e quella di Lucca. Al termine nacque una rissa tra giocatori e tifoserie. Uno dei carabinieri presenti sparò, colpì l’arbitro, che morì all’istante. I carabinieri furono allora circondati dalla folla inferocita. Ci si impadronì della caserma della Marina e del Poligono di tiro, impossessandosi di quante armi contenevano. La truppa fu fatta ritirare. La caserma dei carabinieri fu assalita con bombe a mano, sassate, fucilate e fu tenuta in assedio per due giorni. La città era nelle mani della popolazione.
La stazione ferroviaria fu invasa; tagliati i fili telegrafici e telefonici, bloccati i treni. In quei due giorni non passò un treno da Viareggio, eccezion fatta per i “treni rossi”, organizzati per fare affluire i proletari ai funerali della vittima.
Già nella serata gli sbocchi delle vie provinciali e ferroviarie erano guardati da pattuglioni di cittadini armati. Le trincee, le barricate costruite sulle vie e sui ponti, le calate del porto, il molo, la spiaggia erano custoditi da guardie rosse armate. Immediatamente venne proclamato lo sciopero generale.
Alle prime ore del mattino seguente, per mettere Viareggio in stato d’assedio, camion di soldati affluirono da Pisa, Lucca, La Spezia. Ma lo stato d’assedio non avvenne perché i soldati subito fraternizzarono con i rivoltosi ai quali cedevano le loro armi: fucili, munizioni, mitragliatrici. I giovani in grigio-verde erano ospitati nelle famiglie proletarie; alcune trattorie li rifornivano di viveri. Le truppe, disarmate, preferivano fermarsi alla Camera del Lavoro anziché tornare in caserma.
Oltre all’esercito furono inviate delle torpediniere dal mare. Ma sbarcati gli ufficiali per intimare la resa furono fatti prigionieri dai commissari del popolo e dai soldati. Furono poi rilasciati dopo che ebbero preso l’impegno di dare ordine alle navi di ripartire.
Giunse il generale Nobili a patteggiare la liberazione del generale Castellazzo, preso in ostaggio dagli insorti. Gli ufficiali di terra dovettero cedere le armi, quelli di mare contrattarono la liberazione accettando la ritirata.
In un trafiletto dell’”Avanti!” dell’8 maggio si leggeva di quanto era accaduto a Genova nei giorni precedenti. Alla stazione di Genova al treno diretto a Viareggio era stato aggiunto un vagone di guardie regie, «ma i ferrovieri si rifiutarono di proseguire recandosi in commissione dal capo stazione ad esporgli i motivi dell’abbandono del posto. Dopo una vivace discussione, cioè dopo più ore di fermata il treno poté proseguire, ma il plotone delle regie guardie dovette rientrare nelle proprie caserme, rinunciando al viaggio. I passeggeri, specialmente i militari, applaudirono all’energico contegno tenuto dai ferrovieri».
La vittima, l’arbitro Augusto Morganti, non apparteneva a nessun partito politico, ma questo non impedì che gli venissero tributati i “funerali rossi”. Da tutte le zone del pisano e della Versilia arrivarono con i “treni rossi” migliaia di lavoratori. Dopo i funerali, in piazza Municipio fu tenuto un imponente comizio.
Il giorno 11 il deputato socialista Luigi Salvatori scriveva sull’ “Avanti!”: «Il popolo sotto la spinta di una emozione può diventare eroico (la rivoluzione prima di essere “cosa” è “passione”) e sotto una unità di visione può rendere gigantesche, oltre che verosimili, quelle forze che all’osservatorio dei giorni quieti apparivano normali o modeste».
Anche in questa occasione però i dirigenti della Camera del Lavoro non si smentirono. È vero che fin dalla notte del giorno 2 fu proclamato lo sciopero generale, decidendo però che non uscisse dal perimetro di Viareggio, che non interessasse gli operai di Carrara, di Massa, della Versilia. In solidarietà con il proletariato di Viareggio scese comunque spontaneamente in sciopero Livorno, nella quale il console inglese annotò: «La città è stata per due giorni quasi completamente in mano ai rivoltosi».
Ma di questo avremo occasione di parlare in seguito.
Istinto proletario dei ferrovieri
L’”Avanti!” del 4 giugno riportava queste due brevi ma significative corrispondenze da Lucca. La prima: «Transitava dalla nostra stazione un carro carico di motori di aeroplani diretti a destinazione sospetta. I bravi ferrovieri, accortisi di ciò e nella tema che fosse destinato alla Polonia per la guerra contro i compagni russi, staccarono il carro relegandolo in un binario morto. Ora i motori di aeroplani sono dimenticati e sul carro è stato scritto a caratteri cubitali: Materiale bellico, vietata la partenza».
Il secondo dice: «Avvertiamo i compagni ferrovieri che per Savona Marittima sono partiti i carri 2906587 - 178390 che trasportano munizioni. Per la Spezia è partito il carro 126004, pure carico di munizioni. Ostacoliamo con tutti i mezzi il tentativo liberticida della borghesia intesista contro la Repubblica dei Soviet».
Nella stessa data quest’altra comunicazione da Lodi: «Questa notte è partito per
Milano con un vagone carico di dinamite, portante il numero 220110, diretto a
Domodossola, il treno 0758 proveniente da Porto Civitanova. Sarà probabilmente a
Milano questa notte alla stazione di Porta Romana».
Nel napoletano
Nella narrazione delle rivolte proletarie contro il fascismo partiremo dal Sud Italia riportando un trafiletto de ”Il Comunista” dal titolo “Parti invertite”, datato 22 maggio 1921.
«Abbiamo più volte avuta l’impressione che nell’Italia meridionale, dove è tanto
meno sviluppato il movimento proletario, la reazione alle violenze del fascismo
si delineasse più fortunata ed efficace. Molti fatti svolti prima e durante le
elezioni confermano tale giudizio. I funerali dell’operaio ucciso a Napoli il 1°
maggio dai fascisti costituirono una formidabile manifestazione rossa, dando
l’indice di una reazione sentimentale davvero impressionante.
«Il sanguinoso episodio della domenica elettorale ha dato altre conferme di
quanto scriviamo. Tre “camions” di arditi in pieno assetto di guerra,
potentemente armati e munizionati fecero una scorribanda per i comuni vesuviani.
Giunsero di sorpresa a Ponticelli, San Giovanni, Portici, Resina, Torre del
Greco; ovunque fulmineamente aggredirono, ferirono, uccisero, ma dovunque furono
accolti da una fiera resistenza, ebbero dei feriti ed anche un morto, benché la
notizia non sia ufficiale.
«Per la topografia delle località le vetture della morte dovevano ripassare per
la medesima strada per riguadagnare Napoli. Sul loro percorso però, lungi dal
seminare il terrore avevano sollevato la furia vendicatrice dei proletari. Dai
tetti, dalle finestre, nelle vie, lavoratori, muniti di tutte le possibili armi,
li attendevano decisi a vendicare i loro compagni. A Resina essi percorsero
l’unica deviazione possibile, ma preveduta da quei compagni comunisti. I
“camions” furono attorniati da una folla di operai, ed i briganti stavano per
essere sopraffatti e massacrati, benché riuscissero con gli ultimi colpi a
trucidare ancora un nostro compagno. Fu soltanto in questo momento che le
ingenti forze di P.S. lanciate alla loro ricerca li rintracciarono, li
arrestarono terrorizzati e li salvarono.
«Il “Mattino” organo ormai fascista, descrive il trucco a cui ricorsero i
funzionari di pubblica sicurezza per trasportare i diciannove delinquenti
attraverso Portici e San Giovanni rigurgitanti di operai armati e decisi a tutto.
Gli arditi vennero adagiati sotto i sedili dei “camions” carichi di guardie
regie, e passando costoro simulavano di chieder notizie degli arditi agli stessi
comunisti che li attendevano!
«Sono stati adunque questa volta i briganti bianchi ad essere tutelati, salvati,
a ricorrere ad un trucco ridicolo ed ignobile per sfuggire alla santa
indignazione avversaria. Il fatto è talmente eloquente che noi rinunziamo a
farlo seguire da altre considerazioni, accogliendolo come un inizio di quella
che sarà la tremenda riscossa dell’ira delle masse».
In Puglia
“Il Soviet” del 23 maggio 1920 mandava un richiamo ai compagni di Bari. Il giorno 30 si sarebbe tenuto il 1° convegno delle sezioni e dei gruppi comunisti della provincia e il principale degli argomenti posti all’ordine del giorno avrebbe riguardato la permanenza o meno nel Partito socialista. Vi si legge: «Vero è che a Bari e provincia il socialismo è diventato sinonimo di affarismo, e che è reso del tutto impossibile il vivere assieme con gente che nel socialismo non vede che il proprio tornaconto. Ma – coraggio o compagni – ancora un po’: e poi ognuno per la propria strada [...] Se i compagni di terra di Bari desiderano davvero che il nostro movimento abbia vita ed omogeneità d’intenti, fa uopo che tutti siano disciplinati alle deliberazioni prese. [Ci si riferisce al congresso di Firenze della Frazione Comunista Astensionista, ndr] E poi abbiamo ancora un compito da svolgere in seno al partito. C’è tutta un’opera di propaganda e di persuasione ancora da compiere fra i compagni stessi delle diverse sezioni. Perché voler fin da ora rinunciare a quest’opera e alla possibilità di accrescere le nostre forze?».
La Puglia dell’epoca era una regione prevalentemente agricola con pochi centri industriali, presenti soprattutto nel capoluogo. La terra apparteneva a un ristretto numero di proprietari. Di contro, la maggior parte dei lavoratori erano braccianti, giornalieri, bifolchi,
mandriani e pastori, senza un lavoro che potesse garantir loro una continuità e sicurezza economica, anche se misera. Un’altra caratteristica della Puglia era l’urbanizzazione: i braccianti non vivevano nelle campagne ma in agglomerati urbani dai quali giornalmente si spostavano per raggiungere i campi.
Terminata la guerra i lavoratori pugliesi si ritrovarono più o meno nelle medesime condizioni del proletariato di tutta Italia. Anche in Puglia una prima forma di lotta dei braccianti agricoli fu quella di procedere comunque al lavoro nelle terre tenute incolte dai proprietari, per poi richiedere, a fine giornata, la paga per l’opera svolta.
Si ebbero occupazioni delle terre e soprattutto un fiorire di leghe di braccianti, favorito, oltre che dalla grande massa di giornalieri, dal loro concentramento in agglomerati urbani.
Le lotte dei braccianti contro la disoccupazione e contro il caroviveri, nel cosiddetto biennio rosso, interessarono molti centri urbani pugliesi come Taranto, Cerignola, Bari e Andria. In quest’ultima città, ad inizio dicembre 1919, uno sciopero assunse aspetto insurrezionale. Ne “La Stampa” di Torino del 4 dicembre si legge: «In piazza Municipio e in via Bassi gli scioperanti, caricati dalla truppa, hanno esploso vari colpi di rivoltella. Nelle adiacenze della piazza gli scioperanti hanno impegnato con la forza un nutrito fuoco di moschetteria con lancio di petardi. Vi sono oltre cento persone tra feriti e contusi».
Andria era un grosso centro che accoglieva una concentrazione agricola di circa 40 mila contadini.
Il 30 novembre la Camera del Lavoro aveva proclamato uno sciopero generale con manifestazione «in rispondenza a un fenomeno del tutto obiettivo, il bisogno cioè di ben 30.000 contadini che sono chiusi in una grande città rurale e sono in preda della disoccupazione più forte e più tremenda. Questi contadini [...] avevano rivolto alle autorità municipali, prefettizie e governative domande per poter attenuare i loro bisogni con del lavoro [...] Questa massa di contadini aveva visto ridotta la sua giornata dalle parecchie lire di un tempo a sole tre lire, assolutamente insufficienti per poter soddisfare i bisogni della numerosa figliolanza [...] La nostra popolazione si nutre solo di pane e di pasta, ma non può avere né l’uno né l’altra e, se vuole averne, la deve pagare ad una lira e mezzo o due lire al chilo» (intervento parlamentare dell’on. Vella del 12 dicembre 1919, Resoconto stenografico).
In risposta il prefetto aveva inviato alla Camera del lavoro un telegramma in cui si concedevano lavori per un ammontare di 10 mila lire, vale a dire 30 centesimi per scioperante. La massa, indignata da questa concessione inadeguata al bisogno della grave ora, scese in piazza, impose la chiusura immediata di negozi, scuole, uffici pubblici. Fu affrontata dalla pubblica sicurezza e dai carabinieri e, senza intimazioni di sorta, incominciò la fucileria. Ma i proletari erano preparati e risposero adeguatamente al fuoco.
Nel suo intervento parlamentare il socialista Vella ammetteva una grande verità: «I tragici fatti di Andria devono essere imputati, più che alla nostra predicazione, alla vostra azione che sobilla più che la nostra propaganda». Certo era che il Partito Socialista si guardava bene dal sobillare le folle contro padroni e Stato!
Nel luglio del 1919 la Camera del lavoro di Bari aveva proclamato lo sciopero generale ad oltranza contro il caroviveri. Nelle giornate di sciopero sia a Bari sia in altri centri si assistette ai primi scontri e all’organizzazione della difesa dei quartieri popolari. Come in ogni altra parte d’Italia anche in Puglia, di fronte all’avanzata violenta del proletariato, la borghesia non si fece scrupolo di far uso delle già note squadre dei mazzieri e di procedere alla formazione di nuove, arditi o fascisti che fossero. Già dal 1919 ex ufficiali in congedo, giovani nazionalisti, intellettuali e studenti avevano fondato a Bari il “Fascio di difesa nazionale”, e, a seguire, quello “di combattimento”. Ma, come vedremo, fu la forza pubblica che compì la più violenta e spietata repressione antiproletaria.
Nel 1920 fu sempre l’aumento dei prezzi dei beni di consumo e la scarsità di pane e farina ad essere il movente delle sommosse popolari. Non di rado la rabbia si scatenava contro i palazzi comunali, come accadde a Bitonto, Altamura, Andria, Palo del Colle e a Minervino Murge. All’inizio dell’anno i primi a scioperare furono i ferrovieri; il governo reagì assumendo dei volontari; a Bari il Comitato nazionale di assistenza civile il 22 gennaio comunicò al Ministro dei trasporti De Vito che stava provvedendo all’arruolamento di personale volontario in sostituzione dei dipendenti in sciopero.
L’”Avanti!” dell’8 giugno 1920 riportava la seguente breve corrispondenza: «Andria, 4 [...] Dall’assemblea generale dei lavoratori della terra è stato proclamato lo sciopero di classe per le tariffe della mietitura. Appena giunto l’ordine della federazione di Bari, squadre di ciclisti rossi si sono sparpagliati per le campagne, invitando i lavoratori a sospendere i lavori. Lo sciopero è completo. I contadini di Andria danno così una bella prova di solidarietà, rispondendo “Presente!” e sono in prima linea».
L’apice della tensione si raggiunse a Bari quando a seguito di un ulteriore aumento del costo del pane le lavoratrici della manifattura tabacchi, seguite dai compagni maschi, diedero vita a una violenta manifestazione. Sullo stesso numero del quotidiano socialista si ha questa corrispondenza: «Tutte le operaie e gli operai della Manifattura Tabacchi hanno abbandonato il lavoro e si sono portati in massa in Piazza della Prefettura, dove intanto convenivano le masse dirette dalla città vecchia. A tutti questi si sono aggiunti numerosi altri operai disoccupati e scioperanti cosicché in un momento la vasta piazza fu gremita di popolo che, prima dinanzi al Municipio e poi presso la Prefettura strepitava, fischiando [...] Poi i dimostranti, cresciuti di numero si sono divisi. Una parte ha preteso ed ottenuto la chiusura di tutti i magazzini e spacci e gli altri hanno bloccato il palazzo delle Poste dove si è dovuto sospendere il lavoro [...] Sono stati fermati per la via tutti i tram della società Elettrica, che hanno dovuto ritirarsi nei depositi; si ebbero cariche e non poche colluttazioni». Vennero presi d’assalto due ristoranti (e un terzo fu salvato dall’intervento della truppa) «donde se ne scacciarono gli avventori, mettendo a soqquadro i locali e servendosi di tutto quanto offriva la cucina [...] Sono stati chiusi tutti gli uffici privati e gli istituti bancari. La città è deserta [...] A mano a mano lo sciopero si è esteso a tutte le categorie lavoratrici cosicché siamo allo sciopero generale [...] Le guardie regie operano cariche facendo uso dei calci dei fucili [...] Gli animi sono eccitatissimi. Continua intanto lo sciopero dei ferrovieri [...] Questa sera gli scioperanti si riuniranno a comizio per deliberare sulla ulteriore azione da espletare e per fissare, se del caso, la durata dello sciopero».
Sfogliando l’”Avanti!” dei giorni successivi si leggono notizie di questo tipo.
9 giugno - «Gli scioperanti, che si muovevano in colonna per le varie strade della città, tumultuando e gridando la loro protesta, ebbero numerosi scontri con le guardie regie e con i carabinieri, i quali operarono ripetutamente cariche per disperdere la folla [...] Verso sera gli sgherri regi dettero prova della loro belluina violenza. Senza alcun motivo sulla folla inerme [...] gl’infami caricarono i dimostranti con colpi di moschetto. Si ebbero parecchi feriti di cui due in gravi condizioni. Un operaio è stato colpito con una baionettata ed è gravissimo [...] Gli sbirri regi vollero infierire con bestiale violenza sui dimostranti abbandonandosi ad una caccia spietata di violenza e di brutalità [...] Gravissimo fermento regna in mezzo alla massa lavoratrice che è decisa a fare rispettare la propria volontà ad ogni costo».
10 giugno - «La situazione è tutt’ora gravissima [...] La ragione deve attribuirsi ad una piccola manifestazione socialista composta da una cinquantina di persone, in mezzo alle quali erano molti ragazzi di appena 15 anni [...] È subito accorsa la forza pubblica in grande numero, che subito dispose un vero e proprio assedio contro il piccolo nucleo asserragliato dentro una casa in costruzione. Cominciò allora un combattimento impari tra assediati e la forza pubblica [...] La forza scaricava contro la casa cariche di fucileria e gli operai rispondevano con colpi di pietra [...] Vi sono stati molti feriti, anche gravi».
11 giugno - «Lo sciopero generale continua ed oggi è stato proclamato lo stato d’assedio [...] Gli sgherri regi scorrazzano per le vie, gettando il terrore ovunque. I feriti sono moltissimi. Una donna è rimasta colpita alla scapola sinistra e versa in gravissime condizioni. Il numero degli arrestati oggi è sceso [leggasi “salito”, ndr] fino all’inverosimile. La forza sta abbandonandosi alla più pazza e bieca reazione [...] L’esasperazione della folla è violentissima contro l’inaudita ferocia della polizia e dei carabinieri».
13 giugno - «I rivoltosi che si erano ieri asserragliati nella casa in piazza Santa Barbara, durante la notte hanno solidificato la loro fortificazione, con rifornimenti di pietre portate da donne della città vecchia. Verso le 9,30 si è iniziato un nuovo combattimento mediante una fitta sassaiola dalla parte degli assediati ed una continuata fucileria da parte delle guardie e dei carabinieri [...] Verso le 10 è stata organizzata la espugnazione della fortezza [...] La forza iniziò un fuoco ininterrotto da ogni parte. Contemporaneamente si faceva avanzare un’autoblindata che subito veniva paralizzata da due grosse pietre lanciate che, lacerando il tender, piegavano le mitragliatrici. Dopo un momento di indecisione [i] militi ubbriachi ed urlanti come belve [...] penetrano entro la casa mentre dai moschetti partono scariche tremende contro i pochi assediati. Avvengono scene selvagge, lotte corpo a corpo, fra i rivoltosi che si difendono fino alla disperazione, e gli sgherri regi che si abbandonano ad una ferocia inaudita [...] Anche la piazza Chiurla viene occupata e subito presidiata da autoblindate e da mitragliatrici in azione».
Il quotidiano socialista si dilunga poi a documentare gli arresti, le perquisizioni, e in generale le violenze perpetrate dalla forza pubblica nei confronti del proletariato. Lo sciopero generale, iniziato il 7 giugno a seguito del decreto governativo sull’aumento del pane, cessava l’11 dopo il ritiro del decreto. I ferrovieri dello Stato di tutto il compartimento di Bari, quelli della Calabro-Lucana e gli elettricisti continuavano lo sciopero. «Mentre si sedava la rivolta popolare in città, lo sciopero dei ferrovieri continuava ad oltranza, per alcune linee ferroviarie resistette fino all’inizio di luglio» (F. Salandra, Bari roccaforte dei rivoltosi).
Durante il 1920 certamente non fu la sola Bari ad insorgere, violente sommosse scoppiarono in tutta la Puglia tanto che sarebbe troppo lungo fare l’elenco delle città e dei paesi interessati.
Abbiamo ricordato come i braccianti lavorassero nei campi anche senza la richiesta dei proprietari per poi richiederne la paga. Una tale imposizione a volte portava a scontri armati, come si verificò nei comuni di Bisceglie, Andria, Canosa e altrove. Non possiamo non ricordare l’eccidio nelle campagne di Gioia del Colle. I fondiari avevano disconosciuto i concordati precedentemente stabiliti con l’ufficio di collocamento e la commissione arbitrale. Lo scopo che si ripromettevano era il ritorno alle 11 ore di lavoro con contemporanea riduzione dei salari. «I contadini disoccupati furono messi allora nella condizione di andare a lavorare arbitrariamente nelle campagne, perché non era logico né umano che si fossero lasciati affamare» (“Puglia Rossa”, 11 luglio 1920).
La sera del primo luglio un centinaio di braccianti, dopo avere lavorato nelle vigne di tal Girardi Natale, si avvicinarono alla masseria per chiedere il compenso del loro lavoro. Ma ad attenderli vi erano «molti proprietari armati di fucili e rivoltelle e provvisti di doppia cartucciera con munizioni [...] e con essi anche alcuni cacciatori non proprietari, assoldati per la circostanza [...] Il Girardi Natale, senza perdere tempo, ordinò a gran voce: Fuoco! [...] Si udirono centinaia di colpi di arma da fuoco [...] un fuoco di fila vasto e nutrito [...] I contadini spaventati, e moltissimi di essi sanguinanti, si dettero ad una fuga precipitosa; ma vennero inseguiti alle spalle con le fucilate e lasciarono sul terreno sei morti [...] I feriti furono quaranta, dei quali due gravemente. Dal numero dei colpi sparati si arguisce che i proprietari trincerati nella masseria e nelle adiacenze di essa erano più di cinquanta».
Giunta la notizia, immediatamente ogni attività cittadina e di campagna si fermò; lo sciopero fu generale per quattro giorni. Ma i braccianti non si limitarono allo sciopero, si armarono e si misero alla caccia dei proprietari, che nel frattempo si erano dati alla latitanza. Non tutti però fecero in tempo a mettersi in salvo, nella nottata uno venne scovato nella campagna e fu immediatamente linciato; la mattina seguente la stessa sorte toccò ad altri due. Il settimanale socialista, interpretando i sentimenti di vendetta del proletariato, non aveva esitato a scrivere: «Quei morti ci comandano di accelerare il passo, di passare dalla marcia alla corsa! [...] Poiché bisogna ascendere per una via di sangue, non sia questo solamente sangue di lavoratori, ma anche loro: soprattutto del loro bisogna far scorrere! Con gli assassini facciamoci assassini. Coi briganti facciamoci briganti. Armiamoci! Ne abbiamo diritto. I nostri morti vogliono essere placati».
Nel 1921, come nel resto d’Italia, anche in Puglia l’utilizzo dello squadrismo da parte degli agrari divenne sistematico. I primi obiettivi furono le amministrazioni comunali socialiste e comuniste, le sedi delle organizzazioni proletarie e le figure politiche di spicco. Scriveva l’“Avanti!” del 26 febbraio 1921: «Abbiamo l’attentato contro il sindaco di Barletta compagno Violante, l’assalto ed il tentato incendio delle Camere confederali del lavoro di Bari, nuove minacce contro il compagno deputato Vella [...] una premeditata fucileria contro povere madri e spose di Spinazzola [...] e infine l’assassinio dello sventurato contadino diciannovenne Marcise a Bari ed il tentato incendio e saccheggio della Camera del lavoro di Minervino».
I proletari pugliesi non praticavano gli insegnamenti di pace e rassegnazione predicati da Turati e Matteotti, erano di tutt’altra pasta: diversi erano i fascisti che avevano lasciato questo mondo, tra i quali noti e ricchissimi agrari, villini incendiati, masserie completamente distrutte, capi di bestiame avvelenati; squadre di lavoratori perlustravano e “bonificavano” le colline delle Murge.
Il partito comunista aveva indetto per la domenica del 20 febbraio 1921 una manifestazione nazionale; quale oratore per la città di Bari era stato nominato Nicola Bombacci. A questa notizia, il pomeriggio precedente una squadra di fascisti si recava alla stazione ferroviaria e dissero a un gruppo di ferrovieri, tra i quali era il consigliere provinciale D’Agostini, che non avrebbero permesso a Bombacci di parlare a Bari e, in caso contrario, D’Agostini avrebbe risposto con la vita la violazione dell’ordine fascista. Ne nacque un acceso diverbio, i fascisti vennero accerchiati dai ferrovieri e solo grazie all’intervento della guardia regia poterono allontanarsi incolumi.
«La notizia dell’incidente avvertì i lavoratori della necessità di trovarsi alla stazione. In parecchi stabilimenti fu abbandonato il lavoro [...] poi, armati di bastoni e di randelli, in corteo e al canto di Bandiera Rossa si recarono alla stazione dove alle ore 21 giunse il compagno Bombacci» (“L’Ordine Nuovo”, 23 febbraio). Avendo il sindaco revocato la già accordata disponibilità del teatro Piccinini, il comizio si tenne in piazza. Mentre Bombacci parlava «intervenne un gruppo di fascisti per interrompere il comizio; ma male incolse loro perché la folla dei lavoratori si scagliò contro di essi che si ebbero una solennissima bastonatura». Nel corso della giornata si registrarono serie di altri incidenti, sia nella città vecchia sia nella nuova. “L’Ordine Nuovo” chiudeva la cronaca della giornata con queste parole: «In complesso la manifestazione comunista riuscì splendidamente, i fascisti hanno ricevuto una lezione di cui si ricorderanno per un pezzo. Infatti all’ospedale ce ne sono parecchi feriti da bastonate e uno da una coltellata».
Nei giorni successivi i fascisti per rifarsi delle batoste ricevute provocarono in diverse zone della Puglia episodi di violenze e di minacce.
I lavoratori erano già scesi compatti in lotta quando le organizzazioni sindacali indissero lo sciopero generale provinciale dal 23 al 26 febbraio. «In questi due giorni si registrarono incidenti a Minervino, dove i contadini invasero masserie, distrussero vigneti e uccisero tre agrari, a Spinazzola, con lo sciopero guidato dai comunisti, e a Cerignola, dove in seguito agli incidenti, il 10 aprile del 1921 fu arrestato Di Vittorio. A Bari lo sciopero fu organizzato in maniera unitaria dalle due Camere del lavoro e iniziò già la sera del 23 febbraio, in seguito all’uccisione dell’operaio Nicola Armenise per mano dei fascisti [...] Lo sciopero durò diversi giorni e da parte delle autorità vi fu il sentore che sarebbero stati giorni di scontri violenti, e per fronteggiarli furono inviate da Roma 100 guardie regie di rinforzo e, molto probabilmente dal porto di Brindisi, una nave da guerra» (Salandra, cit.).
Certo, sarebbe entusiasmante narrare in modo più dettagliato le eroiche gesta compiute in quei giorni dal proletariato di Puglia. Per ora ci basti dire che la classe lavoratrice scese in lotta compatta e determinata a usare violenza contro violenza. Tali furono le solenni lezioni date ai fascisti tanto che dovettero dichiarare apertamente la resa: il Consiglio direttivo dei fasci di combattimento baresi votava il seguente codardo ordine del giorno: «Mentre deplora l’opera dei fascisti ex‑combattenti, richiama la massa dei propri organizzati alla disciplina del lavoro e ad una feconda propaganda di pacificazione, ammonendo che non attraverso le violenze, ma mercé il concorso e lo sforzo di tutti i suoi figli la Patria potrà attraversare la crisi che la travaglia e raggiungere i suoi radiosi destini».
Scriveva “L’Ordine Nuovo” del 27 febbraio 1921: «Il proletariato agricolo
pugliese ha mostrato agli operai ed ai contadini del nord come si deve colpire».
A Trieste
Sulla stampa del nostro partito abbiamo già approfonditamente relazionato sulle tradizioni del proletariato triestino e giuliano, valido esempio di internazionalismo proletario prima della Grande Guerra e di ardore comunista dopo Livorno. È bene ricordare che al congresso di Livorno 1921 la maggioranza assoluta dei delegati giuliani aderirono alla mozione di Imola.
Questo forte proletariato doveva, nei piani della borghesia indigena e dello Stato “redentore”, essere posto nella impossibilità di nuocere. Cosa di meglio, tanto per cominciare, che privarlo del suo organo di stampa, il glorioso “Lavoratore” che dal 1895 ne era stato la guida?
La distruzione del "Lavoratore" di Trieste è un episodio non differente dai moltissimi altri delle lotte fra fascisti e comunisti negli anni del primo dopoguerra. Non a caso la nostra "Rassegna Comunista" nell’articolo di presentazione del suo primo numero, il 30 marzo 1921, scriveva: «La reazione bianca [...] ha contribuito ad una netta differenziazione fra i comunisti d’occasione e le giovani forze del nuovo partito. I primi hanno rivelata tutta la vacuità dei loro atteggiamenti, il secondo ha dato prova di essere già in grado di agire come un centro di accolta delle energie proletarie, che con contrattacchi decisi hanno posto fine alle serie di facili successi dell’avversario. I socialisti hanno ripudiata ogni solidarietà con queste azioni delle masse – hanno perseguita in ogni circostanza, con tradizionale cretinismo parlamentare, la prova che erano stati i lavoratori ad “essere provocati”, ad essere trascinati fuori della legalità, ad essere picchiati anziché picchiare – hanno auspicata la tregua di classe, la pace civile, l’evolversi pacifico dell’attuale crisi sociale [...] A Roma i fascisti si adunano ufficialmente – mentre le nostre bandiere salutano l’immolazione generosa di Lavagnini – a commemorare le vittime fasciste del comunismo, e sembrano così commettere ancora alle forze ufficiali dello Stato borghese la lotta contro un avversario meno comodo di quelli che sistematicamente rinculano rinnegando pietosamente ogni proposito offensivo».
Una dettagliata cronaca di come si svolsero i fatti che portarono alla totale distruzione del prestigioso organo politico del proletariato giuliano la si può leggere nel numero del 10 settembre de “Il Lavoratore”, quando il giornale comunista riapparve grazie alle vigorose energie e alla tenace volontà dei comunisti triestini.
I fascisti, al servizio degli industriali triestini, vedevano nel "Lavoratore" il maggiore nemico degli interessi padronali. Decisero così di sopprimerlo per la seconda volta, tanto più che non mancavano i malcelati incitamenti della stampa borghese che non riusciva a battere la concorrenza del giornale proletario per la innegabile superiorità tecnica di questo. Lo stesso “Avanti!” dell’11 febbraio 1921 scriverà che «Il “Popolo” [giornale borghese filofascista, ndr] di Trieste usciva ieri sera con parole di aperta istigazione a usare ogni violenza contro i comunisti e contro il loro giornale».
Il pretesto occasionale per dare un carattere di rappresaglia all’attacco e a al preordinato saccheggio del “Lavoratore” non tardò a presentarsi: l’uccisione di un carabiniere che, dopo aver festeggiato il carnevale, in borghese e ubriaco, si aggirava nottetempo in un rione popolare cantando inni fascisti e profferendo minacce.
«Già nelle prime ore della sera del 9 febbraio si ebbe sentore di un colpo di mano in grande stile che sarebbe stato progettato, anzi deciso dai fascisti contro il giornale. Non uno ma parecchi compagni venivano in redazione per esortarci a stare in guardia e a prendere le necessarie misure di difesa [...] La voce del possibile attacco si sparse istantaneamente nei circoli operai. Tutti i compagni volevano correre a difendere il loro giornale [...] Molti giovani vollero rimanere ad ogni costo, non si sentivano l’animo di staccarsi dal giornale che era per loro qualcosa di sacro e che vedevano seriamente minacciato».
Nel frattempo i fascisti, sotto lo sguardo compiacente della polizia, scorrazzavano indisturbati per la città terrorizzando la popolazione. In gruppi di venti o trenta entravano nelle osterie e nei ritrovi proletari e, con pistole alla mano, perquisivano i presenti e bastonavano coloro ai quali veniva trovato addosso un distintivo, una tessera o qualsiasi altra cosa che potesse associarli a una organizzazione sovversiva. Nei pochi casi in cui la forza pubblica interveniva era per arrestare non gli aggressori ma gli aggrediti.
Il giorno seguente, 10 febbraio, verso le undici e mezzo, una squadra di circa 30 fascisti, armati di tutto punto e provvisti di leve, mazze e picconi, mosse all’assalto. Le 4 Guardie Regie poste a difesa dell’edificio, dopo una simulata breve opposizione, lasciarono campo libero agli assalitori. I fascisti avanzarono fino alle porte dell’edificio, ma il lancio di due bombe da parte dei comunisti fu sufficiente a far dileguare gli aggressori, che, a velocità vertiginosa si dispersero per rientrare nelle loro tane.
«Il “Lavoratore” era presidiato da nostri compagni decisi a difendersi, a difendere il loro giornale. Ed i fascisti non entrarono. La presenza compiacente, l’aiuto passivo delle guardie regie non era dunque sufficiente? La forza pubblica intervenne allora, non in difesa degli aggrediti, ma contro di loro» (“Il Comunista”, 20 febbraio).
Subito dopo il tentato assalto fascista, dalla questura venne telefonato al giornale avvertendo che, entro un quarto d’ora, la polizia avrebbe perquisito gli uffici del “Lavoratore” e che gli occupanti non avrebbero dovuto opporre resistenza. Ma si trattò di una ben strana perquisizione, tutte le adiacenze del giornale furono occupate dalla forza pubblica, lo stesso questore diresse personalmente le operazioni di assedio. Contemporaneamente, dalla parte del giardino, contro l’edificio del “Lavoratore” venivano lanciate numerose bombe. «Improvvisamente una voce tonante giunse fino a noi: “Arrendetevi, Arrendetevi!” [...] Colpi secchi, battuti sul portone e il grido stentoreo: “In nome delle legge, aprite!”».
“Il Lavoratore” fu occupato e quanti trovati all’interno dei locali tratti in arresto. Dei bestiali trattamenti a cui furono sottoposti i compagni (una minuziosa narrazione può essere letta nel citato numero del 10 settembre) non parliamo: i metodi di brutale malvagità instaurati dalla polizia italiana nella Venezia Giulia avevano subito fatto rimpiangere a quelle popolazioni l’“odiato” dominio degli Asburgo.
Dopo l’occupazione della forza pubblica e l’arresto di tutti gli occupanti le porte furono spalancate alla irruzione vandalica dei fascisti che, sotto l’ala protettrice della questura, ritrovarono il coraggio perduto nel primo assalto. L’opera distruttrice, iniziata nella tipografia, dove i macchinari furono frantumati a colpi di mazza e piccone, non ebbe termine che quando il fuoco, appiccato alle carte, propagatosi a tutto l’edificio aveva preso proporzioni tali da minacciare l’incolumità degli stessi assalitori. A questo punto guardie regie e fascisti uscirono a contemplare lo spettacolo. Ai pompieri sopraggiunti venne impedito di azionare gli idranti per spegnere l’incendio. Soltanto quando le fiamme minacciarono di propagarsi alle case vicine fu permesso di mettere in azione le pompe. Ma l’opera dei vigili del fuoco non valse a nulla, del “Lavoratore” non rimase che un cumulo di rovine: soltanto lo scheletro dei muri maestri resistette alle fiamme.
Se l’opera congiunta di Stato e fascisti aveva appagato il desiderio degli industriali triestini, non fece però vacillare la fede del proletariato che ancor di più si strinse attorno alla bandiera del partito comunista e, a prezzo di immensi sacrifici, dal 10 settembre successivo “Il Lavoratore” riprendeva le sue pubblicazioni ancora più forte e agguerrito a fianco di tutte le battaglie del proletariato della Venezia Giulia.
Il giorno successivo l’incendio l’“Avanti!” scriveva: «Ai comunisti di Trieste, balordamente, ingiustamente, camorristicamente arrestati, i sensi della nostra solidarietà!». Ma che se ne potevano fare i comunisti della solidarietà di un partito la cui «protesta vuole essere quella di uomini civili e moderni, per la desiderabile nobiltà delle lotte politiche ed economiche [... per ... ] la pacifica ma potente ascensione continua della classe lavoratrice»?
Perfino Anna Kuliscioff poté ridicolizzare i socialisti: «I fatti dell’incendio delle Camere del Lavoro e della redazione del “Lavoratore” provano che non fu torto un capello agli incendiari e ai saccheggiatori, i quali certo non sono ignoti alla pubblica sicurezza. Che gioco fa dunque il vostro Giolittone? Da una parte è tutto amico di voialtri, dall’altra lascia libero lo sfrenarsi delle più bestiali violenze contro tutti voi senza distinzioni di nuances socialiste».
Il partito comunista, di fronte ad un così grave atto di violenza portato a compimento dal nemico di classe, non denunciò le violate “libertà” di organizzazione e di stampa, “costituzionalmente garantite”, nemmeno denunciò la brutale violenza scatenata sui nostri compagni o la naturale collusione fra Stato e fascismo. Tanto meno vennero lanciati appelli ai sentimenti democratici della pubblica opinione. Nel dare annuncio della distruzione del ”Lavoratore”, l’organo centrale del partito, “Il Comunista”, del 13 febbraio scriveva:
«Coloro che si attendono da noi espressioni di alta meraviglia o di indignazione per l’assalto alla sede del Lavoratore di Trieste dalla guardia bianca e per la distruzione del nostro giornale, si disinganneranno di fronte alla nostra serenità dolorosa. Il rammarico per il danno materiale subìto e per la sorte dei nostri compagni non ci commuove al punto da farci perdere la visione esatta degli avvenimenti dei quali siamo spettatori ed attori [...]
«I compagni comunisti di Trieste hanno dimostrato in questi ultimi giorni di avere largo consenso nella massa lavoratrice. A questa noi rivolgiamo una parola virile. Non ricerchiamo le cause del doloroso episodio in un gesto casuale: interpretiamo l’avvenimento senza staccarlo dalla cornice storica nella quale esso deve rimanere. Il giuoco delle responsabilità non è il nostro giuoco.
«Due nemici mortali non misurano i colpi, si affrontano in campo aperto, ove lo possono; e dove ciò non sia possibile si insidiano gettando i lacci per colpire di sorpresa l’avversario. La tattica di guerra è tattica di astuzia come di forza. Alla organizzazione avversaria, formidabile perché creata dalla classe che ha nelle mani il potere statale, si affretti e vi si contrapponga l’organizzazione proletaria armata, di tutto il proletariato comunista. Di fronte a questa necessità che è oggi salvazione della vita dei lavoratori, e che sarà domani la vasta formazione d’assalto delle masse rivoluzionarie, ogni suggerimento pacificatore deve essere interpretato come intenzionalmente rivolto a tradire la causa proletaria. La guerra civile infuria. Essa non può concludersi che con la vittoria completa del proletariato. Ma per vincere bisogna combattere. Gli episodi hanno le fluttuazioni delle battaglie. La guerra civile continua più aspra e più dura. Lavoratori comunisti di Trieste, lavoratori comunisti d’Italia, non disperate dell’avvenire: preparatevi a conquistarlo con sacrificio e con dolore! Domani la vostra vendetta sarà inesorabile!».
La risposta del proletariato triestino non tardò ad arrivare. Leggiamo su “L’Ordine Nuovo” del 15 febbraio: «La strage, compiuta nelle tarde ore della notte, non venne conosciuta dai lavoratori se non al mattino. Prima ancora che gli organismi sindacali avessero avuto tempo di riunirsi il proletariato abbandonò compatto i cantieri e le officine. Nel porto cessò completamente ogni lavoro, i trams cessarono di circolare, ogni attività produttiva della città si arrestò. Molti negozi si chiusero. Per timore di rappresaglie da parte degli operai la truppa venne consegnata».
Terminato lo sciopero a Trieste, gli operai dei cantieri navali di Monfalcone continuarono l’astensione dal lavoro a dispetto delle direttive della locale Camera del Lavoro. Questo determinò duri scontri ed altrettanto duri pestaggi di fascisti, tanto che furono costretti a chiedere l’intervento dei camerati di Trieste. Ma anche dopo aver ricevuto i rinforzi la loro situazione non migliorò di molto. Agli assalti a mano armata dei fascisti gli operai rispondevano con lanci di bombe a mano e feriti più o meno gravi si registrarono da ambo le parti.
Intanto a Trieste forze dell’ordine e fascisti non aspettavano che un pretesto per assalire e distruggere la Camera del Lavoro. L’occasione fu data dall’uccisione di un fascista nei pressi di Pola: il 28 febbraio fu assaltata e data alle fiamme la Camera del Lavoro di Trieste. Ancora una volta gli operai immediatamente misero in atto una spontanea astensione dal lavoro bloccando tutte le attività cittadine.
Ma il proletariato triestino non si limitò a scioperare, tentò un contrattacco: se il fuoco dei borghesi aveva distrutto il giornale comunista e la Camera del Lavoro, il fuoco doveva portare distruzione ai loro interessi. Un trafiletto dell’“Avanti!” del 2 marzo ci descrive bene quello che accadde: «Alle ore 9, data la situazione, la commissione interna del cantiere San Marco si riunì per deliberare. Frattanto un gruppo di operai occupò gli accessi del cantiere, sprangando le porte e disarmando il posto delle guardie di finanza. Gli operai incendiarono il grandioso legnamificio, il cantiere, i magazzini generali, due officine meccaniche, il deposito delle materie infiammabili. Il direttore del cantiere telefonò alla forza pubblica. Accorsero carabinieri, guardie regie e reparti della brigata Sassari, guardie di finanza con mitragliatrici ed autoblindate. Avvenne uno scambio di fucileria nutrito, fino alle ore 11, fra forza pubblica e operai asserragliati nella direzione del cantiere».
Negli scontri persero la vita un maresciallo e una guardia di finanza. Malgrado l’opera dei pompieri il cantiere continuò a bruciare per tutta la giornata, il giorno successivo non si era ancora del tutto spento. I danni furono calcolati approssimativamente tra i 15 ed i 20 milioni.
Il “Corriere della Sera” nella sua corrispondenza ci informa che «accorrevano anche i pompieri, ma non potevano cominciare il loro lavoro che molto tardi perché dalla parte della strada gli accessi al cantiere restavano sbarrati da barricate e da nuclei di operai armati [...] Gli uffici del cantiere furono completamente devastati [...] il palazzo della Direzione fu invaso e messo a sacco, mentre tutti gli uffici, il mobilio, gli incartamenti e gli arredamenti furono distrutti. Una vera battaglia si ebbe nell’edificio della Direzione [...] da tutte le finestre si sparò sulle guardie e i soldati [...] Giunti sul posto numerosi reparti della brigata Sassari, l’edificio fu circondato completamente e la fucileria cessava poco dopo le undici». La corrispondenza non mancava di notare che «è rimasto assodato che un nucleo dei più scalmanati giovani comunisti distribuì ai compagni, largamente, fucili e rivoltelle, accumulati di nascosto nel cantiere».
Nel pomeriggio, nel popolare quartiere di San Giacomo, si ebbe uno scontro a fuoco tra fascisti e comunisti; successivamente i fascisti, con lancio di bombe, assalirono la Banca Lubiana. «Alle ore 22,30, mentre i fascisti percorrevano lo stradale di Moncuzzo, dall’alto del colle di San Giusto vennero lanciate contro di essi due bombe. Uno solo del gruppo fascista rimase illeso, chi più chi meno, gli altri furono tutti feriti. Più tardi due bombe vennero lanciate contro il giornale borghese l’“Era Nuova”» (“L’Ordine Nuovo” dello stesso giorno).
Come si vede, il proletariato, da Bari a Trieste, non solo non rispondeva all’appello del “siate buoni, siate santi”, incessantemente rivoltogli dai più prestigiosi santoni del partito socialista, ma dava seguito, invece, alle indicazioni del giovane partito comunista di «accettare la lotta sullo stesso terreno su cui la borghesia scende; di rispondere con la preparazione alla preparazione, con l’organizzazione all’organizzazione, con l’inquadramento all’inquadramento, colla disciplina alla disciplina, colle armi alle armi».
Anche la borghesia, da un capo all’altro d’Italia, di fronte a un proletariato che risolutamente scendeva sul terreno della lotta violenta, vilmente si appellava alla pace sociale. Con il titolo “la borghesia triestina chiede la pace”, il 6 marzo “L’Ordine Nuovo” pubblicava una corrispondenza da Trieste del giorno 4: «I fascisti hanno distrutto la sede delle organizzazioni operaie e della Camera del lavoro di Trieste. Il proletariato triestino ha risposto a questa nuova offesa della reazione e borghese incendiando la falegnameria del cantiere San Marco [...] E la controreazione proletaria ha potuto registrare tosto un successo. La stampa borghese e nazionalista, quella che, con a capo “L’Era Nuova”, ha generato in questi luoghi il fascismo illudendosi di poter far sparire di un colpo solo il movimento proletario, si è impaurita di fronte alla energica difesa degli operai ed ha gridato ieri dalle colonne dei suoi giornali il suo basta mendicando “pace, pace per carità di patria”. Fin che il proletariato stava zitto; fin che i fascisti potevano incendiare e distruggere liberamente e impunemente le sedi delle istituzioni proletarie e le vittime di questa reazione potevano contarsi soltanto nelle fila del proletariato, la stampa borghese cantava ogni giorno il suo inno di guerra. Guerra al proletariato, guerra a tutte le idee sovversive, guerra senza quartiere per “il bene della patria”. Oggi, perché un solo incendio, appiccato per reazione contro le gesta fasciste, ha prodotto nelle tasche borghesi un danno di venti milioni, oggi si chiede pace; “pace per carità di patria”».
Quando borghesia e fascisti avevano creduto di avere definitivamente fiaccato lo spirito di rivolta del proletariato si accorsero che questo, dopo avere ripudiato i dirigenti socialdemocratici, rispondeva agli attacchi con gli stessi metodi e le stesse forme insegnategli dai fascisti. Ai continui agguati, rispondeva con agguati; agli incendi con incendi: i camion fascisti presi a fucilate dai militari di leva, l’uccisione del fascista nell’imboscata di Canfanaro, l’incendio del cantiere San Marco, il combattimento presso il cantiere con la morte del maresciallo e dell’agente della guardia di finanza, i lanci di bombe contro i fascisti, l’incendio della villa Fransin, etc., etc.
Così terminava la corrispondenza da Trieste: «Prendiamo nota noi e prenda nota la borghesia che il proletariato aspetterà con le armi al piede sempre pronto a rispondere nei modi convenienti».
1 maggio 1917: Tutte le grandi e partecipate manifestazioni furono ovunque caratterizzate dalla richiesta della pace, del pane e della terra, oltre alla riduzione generalizzata della giornata lavorativa e alla protezione del lavoro delle donne e dei fanciulli.
La richiesta della fine della guerra focalizzò tutte le manifestazioni soprattutto dopo la dichiarazione ufficiale del 18 aprile del ministro degli esteri del Governo Provvisorio Miljukov che garantiva agli Stati dell’Intesa il rispetto di tutti i precedenti accordi dello zarismo sul proseguimento della guerra.

13 maggio (secondo il calendario occidentale): Ipocrite smentite ufficiali del governo provvisorio, Miljukov e il ministro della guerra Gučkov sono rimossi, ma senza che gli imperialisti dell’Intesa rinuncino ai loro intenti.
14 maggio: Il Soviet di Pietrogrado, nonostante l’opposizione minoritaria dei bolscevichi, vota una risoluzione per la formazione di un nuovo Governo Provvisorio.
17 maggio: Trotski rientra in Russia.
18 maggio: Si insedia il nuovo Governo Provvisorio con l’ingresso come ministri di dirigenti menscevichi e social-rivoluzionari: 6 contro 10 rappresentanti della borghesia.
Kerensky, degli S‑R, è vicepresidente del Soviet di Pietrogrado, al tempo stesso membro del Comitato Esecutivo e ora diviene anche ministro della guerra.
Allo scopo di ridare compattezza ed efficienza a ciò che rimane dell’ex esercito zarista, Kerensky cerca di consolidare il fragile accordo raggiunto dopo il Febbraio tra i soldati al fronte e gli ufficiali, e tra i comandanti superiori e il nuovo governo, che sta vistosamente deludendo le aspettative dei soldati, per lo più di origine contadina, interessati alla spartizione delle terre.
È sostituito al comando in capo il generale Alexeev con Brusilov, nel tentativo di ristabilire la precedente rigida disciplina, di fatto abolita: è riformulata la “Dichiarazione dei diritti” che i soldati si erano conquistati a febbraio con la famosa ordinanza n° 1 del Soviet di Pietrogrado. Sono trasferite dalle retrovie al fronte le unità considerate inaffidabili, contagiate dalla propaganda bolscevica. Quattro reggimenti di prima linea sono sciolti per essersi rifiutati di entrare in azione in forza delle loro prerogative previste dall’ordinanza n°1. L’istigazione alla disobbedienza agli ordini è resa passibile di essere messa sotto processo; sono ripristinate alcune punizioni, compresi i lavori forzati e la soppressione degli aiuti alimentari alle famiglie dei condannati per diserzione e rifiuto di ubbidienza.
Queste disposizioni dimostrano la volontà del Governo Provvisorio di continuare la guerra.
Plekhanov dichiara di sostenerla, secondo lui divenuta non più imperialista ma giusta e necessaria per la difesa della Russia. Lenin condanna duramente il ”difensismo rivoluzionario”, “espressione dell’ondata piccolo-borghese che sommerge quasi tutto”.
Questa politica induce lo spostamento verso le posizioni bolsceviche, sulla pace senza annessioni e sulla requisizione delle proprietà fondiarie, di molti soldati che non vogliono continuare la guerra, anche quelli delle unità di retrovia e della gran massa dei feriti in via di guarigione che temono di essere rimandati al fronte.
30 maggio: Il Soviet di Kronštadt assume i pieni poteri dell’isola-fortezza avendo deliberato una risoluzione di non riconoscimento del Governo Provvisorio. È il primo Soviet, prevalentemente composto da militari e marinai altamente specializzati, ad attuare “tutto il potere ai soviet”.
1° giugno: Il Comitato Esecutivo vota una delibera per la costituzione nelle imprese industriali di Commissioni di Controllo operaie per sovraintendere all’organizzazione della produzione e alla sua regolarità, ai rapporti tra lavoro e impresa e, in una fase successiva, ai suoi aspetti finanziari. Si riunisce anche il Comitato Agrario Nazionale, istituito dal Governo Provvisorio per preparare la tanto attesa riforma agraria. Sono le prime risposte alle richieste della rivoluzione di febbraio, rimanendo ancora irrisolta quella della guerra.
3 giugno: Si apre a Pietrogrado il primo congresso dei soviet in rappresentanza di 8 milioni di soldati, 5 milioni di operai e 4,2 milioni di contadini, che durerà fino al 24 di quel mese.
L’Organizzazione militare bolscevica, rafforzatasi progressivamente per l’arrivo di nuovi soldati nella guarnigione, propone al partito di indire una grande manifestazione di protesta contro la guerra e contro il Governo Provvisorio, da effettuarsi durante i lavori del congresso dei soviet. Le parole d’ordine sarebbero state l’opposizione alla nuova campagna militare contro i tedeschi e gli austroungarici, ormai nota, e il trasferimento di tutti i poteri ai soviet, anche se ancora controllati dai partiti socialisti moderati. La data è fissata dal partito per il 10 giugno.
9 giugno: Al congresso, la maggioranza menscevica e S‑R, che ha appena votato una delibera a sostegno del governo provvisorio, vedendo nella manifestazione la condanna della sua politica, ne decreta il divieto per i successivi 3 giorni e invia emissari nei quartieri operai e nelle caserme per cercare di dissuadere a parteciparvi. Il CC bolscevico revoca la manifestazione.
13 giugno: La sezione operaia del Soviet di Pietrogrado approva con 173 voti a favore contro 144 una dichiarazione, proposta da Lenin e sostenuta dai bolscevichi, per il trasferimento di tutti i poteri ai soviet. Negli stessi giorni le elezioni al consiglio municipale del quartiere industriale di Vyborg assegnano ai bolscevichi 37 seggi su 63; nel resto della città però i partiti socialisti moderati sono ancora prevalenti.
16 giugno: La Rada di Kiev rivendica l’autonomia dell’Ucraina.
18 giugno: Il Congresso dei Soviet indice per quel giorno una manifestazione a sostegno del governo e della imminente campagna in Galizia, nella illusoria convinzione che una rapida vittoria su quel fronte avrebbe condotto alla fine della guerra da una posizione favorevole e rafforzato il prestigio del Governo Provvisorio. Il partito e l’Organizzazione militare comunista risposero dando l’indicazione di cacciare i ministri capitalisti, di opporsi all’imminente campagna militare e di trasferire tutto il potere ai soviet, segnando l’insanabile opposizione fra i due indirizzi. Questo a Pietrogrado: nel resto della Russia e al fronte la situazione era ben diversa, più favorevole agli S‑R e ai menscevichi.
L’Organizzazione militare bolscevica preme per un’azione immediata; ha preparato piani per impadronirsi dei servizi pubblici più importanti, dei depositi di armi e munizioni e l’arresto dei ministri capitalisti. Il CC bolscevico infine interviene a trattenerli, considerando l’azione prematura.
Il generale Brusilov dà inizio all’affrettata campagna nella Galizia, che avrebbe dovuto salvare la rivoluzione di Febbraio, il prestigio della Russia e mantenere gli accordi con gli alleati dell’Intesa, e ora con gli Usa, nel proseguire la guerra.
Ma il malcontento delle truppe, che non vogliono più combattere, gli effetti della propaganda bolscevica contro la guerra, le pessime condizioni dei rifornimenti alimentari e del materiale bellico, onerosamente fornito dalla Francia, sconsigliano una operazione di più vasta portata e costringono a un’azione rapida e risolutiva.
Come ormai consolidata tattica moderna di guerra, è pianificato un intenso e concentrato bombardamento preventivo sulle difese avversarie, considerando che le forze di artiglieria sono rimaste fedeli ai comandi, per poi penetrare con cavalleria e fanteria nelle linee nemiche. A suo favore, dal febbraio 1917 il comando tedesco aveva trasferito la maggior parte dell’artiglieria e delle truppe migliori sul fronte italiano, in appoggio agli alleati austroungarici, e su quello francese per una potente offensiva che avrebbe dovuto risolvere le sorti della guerra, lasciando a difesa del fronte polacco le truppe della riserva e delle milizie territoriali e di frontiera austroungariche. Sulla carta Brusilov ha quindi un considerevole vantaggio: le tre armate russe più quella rumena contano quasi il doppio degli uomini e dell’artiglieria tedeschi.
Riassumendo da Trotski: si prevede un attacco dell’armata principale in direzione di Leopoli nel settore sud occidentale, mentre le altre armate avrebbero funzione di appoggio nel settore occidentale e nel settentrionale. Però le unità non sono ancora in posizione alla data stabilita e Brusilov, sollecitato da Kerensky che preme per l’azione, decide allora di rinunciare a qualsiasi strategia unitaria e cede l’iniziativa ai comandanti al fronte, che avanzino quando pronti. Kerensky, abile oratore, fa la spola lungo il fronte per esortare i soldati al combattimento.
L’offensiva inizia il 18 giugno solo sul fronte sud occidentale. Una preparazione di artiglieria di inaudita potenza ha sconvolto le difese avversarie, consentendo alla cavalleria e ai neoformati battaglioni speciali d’assalto del generale Kornilov di avanzare senza rilevanti perdite fino ai primi obiettivi assegnati di Halicz e Kalusz. Debole è la resistenza austroungarica, più consistente quella tedesca.
La sera stessa Kerensky telegrafa al Governo Provvisorio esaltando il successo dell’esercito russo. Plekhanov lo definisce il “giorno della resurrezione per il nostro paese e per la democrazia del mondo intero”. Il ministro menscevico Tsereteli al Congresso dei soviet proclama: “Si apre una nuova pagina nella storia della grande rivoluzione russa. I successi del nostro esercito rivoluzionario devono essere salutati non solo dalla democrazia russa, ma da tutti coloro che combattono l’imperialismo”.
La democrazia patriottica apre tutte le chiuse! La Borsa di Parigi lo festeggiò con il rialzo di tutti i titoli russi. Ma nelle città russe, e specialmente a Pietrogrado, scoppiano disordini tra manifestanti pacifisti e sostenitori patriottici.
Nei giorni successivi la maggior parte dei soldati di fanteria, le cui Commissioni di delegati hanno discusso gli ordini degli ufficiali, si rifiutano di proseguire e iniziano le diserzioni e le rivolte. Delle 15 divisioni presenti sul fronte settentrionale ben 10 non si muovono all’ordine d’attacco. Nella sola V armata 13.000 soldati che hanno rifiutato l’ordine sono deferiti ai tribunali militari.
28 giugno: Inizia la Conferenza delle organizzazioni militari bolsceviche, che sostiene di poter contare su più di centomila soldati tra le retrovie e il fronte. Aderiscono all’organizzazione, soprattutto a Pietrogrado, migliaia di soldati senza partito.
Mentre al fronte l’esercito russo muove per quella che sarà la sua ultima offensiva, nelle città russe, e in particolare a Pietrogrado, è un continuo susseguirsi di infuocati comizi, grandi manifestazioni e scioperi contro l’ulteriore razionamento dei viveri e la guerra, animati da tutte le organizzazioni politiche. Queste spesso si scontrano in armi con i partiti patriottici della borghesia e dei proprietari terrieri.
3 luglio: A Pietrogrado un’altra spontanea manifestazione antigovernativa partita da un reggimento di mitraglieri, dove forte è la presenza bolscevica, invia suoi delegati negli altri reggimenti e nelle officine per invitare ad un’azione di forza contro le nuove misure adottate dal governo, in particolare sullo scioglimento delle unità a causa del loro orientamento politico.
Parte di questi delegati si reca al palazzetto della Kshesinskaia, sede del Comitato Centrale del partito bolscevico, chiedendo che emani l’ordine della presa del potere. Questo però valuta che la situazione rivoluzionaria a Pietrogrado non corrisponde a quella del resto della Russia, non tale da consentire l’estendere all’intero paese la presa del potere nella capitale. Ritiene quindi prematura una simile azione e invita i soldati a rimandarla.
Nella notte alcuni reparti militari e operai scendono comunque in piazza con le armi, si muovono i marinai di Kronštadt. Il comitato bolscevico decide di mettersi alla testa del movimento cercando di dargli un carattere organizzato ma pacifico affidando il servizio d’ordine all’Organizzazione militare bolscevica tramite le neo formate guardie rosse.
Il Governo Provvisorio, dal canto suo, affida al comandante la guarnigione di Pietrogrado, generale Polovzev, il compito di riportare l’ordine nella città e richiama truppe cosacche di rinforzo. Il Comitato Esecutivo vieta la manifestazione e dichiara traditori e nemici della rivoluzione i trasgressori dell’ordinanza.
4 luglio: Un imponente corteo di circa 500.000 fra operai, soldati e marinai si dirige verso il palazzo di Tauride, sede del Soviet, reclamando la presa del potere al grido di: “Tutto il potere ai soviet”. Sul finire della pacifica manifestazione due sparatorie partono dalle finestre di alcuni palazzi: una contro i mitraglieri e gli operai, un’altra contro i marinai di Kronštadt, che provocano la morte o il ferimento di oltre 400 manifestanti.
La città è dichiarata in stato d’assedio, i cosacchi e i cadetti della scuola ufficiali iniziano gli arresti, le uccisioni dei bolscevichi, la devastazione della sede del partito, la redazione della Pravda, la tipografia. È emanato l’ordine di arresto di Lenin, denunciato come agente tedesco contro la Russia, e i vertici del partito. Questi entrano in clandestinità.

6 luglio: Grazie al suo efficiente sistema di trasporti i rinforzi dell’esercito tedesco sono pronti a sferrare una decisa controffensiva, che genera il totale sbandamento della punta avanzata russa, i cui soldati si rifiutano di combattere e abbandonano in massa le posizioni e unità. Il comandante in capo del fronte sud occidentale, con l’assenso dei Commissari e dei Comitati, dirama l’ordine di sparare sui fuggiaschi.
I comandi si rendono conto di non aver più potere sulle truppe, come risulta dal rapporto del comando della II armata inviato d’urgenza al governo: «Nello stato d’animo delle truppe che hanno recentemente avanzato grazie agli eroici sforzi della minoranza, si è verificato un capovolgimento brusco e disastroso. Lo slancio dell’offensiva è stato rapidamente annullato. La maggior parte dei reparti si trovano in uno stato di crescente disgregazione. Non è ormai più il caso di parlare di autorità e di subordinazione, gli ammonimenti e la persuasione hanno perduto ogni valore: vi si risponde con minacce e persino con sparatorie».
I soldati non vogliono più la guerra, vogliono tornare a casa e spartirsi le terre.
8 luglio: Inizia l’attacco anche sul fronte Nord.
9 luglio: Attacco sul fronte rumeno. Ma in Galizia crolla completamente il fronte, che nei due giorni successivi arretra di 240 chilometri segnando l’ingloriosa fine dell’offensiva Brusilov, voluta da Kerensky, con la perdita di 60.000 uomini e molto materiale. Questa avrà importanti effetti in tutta la Russia disperdendo le illusioni su una possibile “difesa della patria”.
Nella coalizione governativa, che comprende rappresentanti della destra borghese, esplodono le divergenze di aspettative. Prendendo a pretesto le concessioni all’Ucraina si dimettono i rappresentanti dei cadetti e del capo del governo, il principe Lvov. Kerensky diventa primo ministro di un nuovo governo, che gode del pieno appoggio del Comitato Esecutivo dei Soviet, formato da cadetti, menscevichi e S‑R. Di fatto la componente bolscevica nei Soviet viene eliminata, o perché in clandestinità o perché agli arresti, come Trotski.
Kerensky, convinto che la spinta rivoluzionaria dei Soviet si sia esaurita con il fallimento delle manifestazioni dei giorni precedenti, accentra su di sé le cariche e le funzioni essenziali per la difesa degli interessi della piccola e della grande borghesia russa. Fa trasferire lo zar con la famiglia nella residenza dell’ex governatore di Tobolsk, l’antica capitale della Siberia occidentale: gli serve vivo come garanzia pretesa dall’Inghilterra. A comandante supremo delle forze armate nomina, in sostituzione di Brusilov, il generale Kornilov, che ristabilisce la pena di morte al fronte, introduce i tribunali militari campali e la censura militare preventiva. Sono inoltre proibiti vari giornali considerati antigovernativi e permesse diverse spedizioni punitive contro centri e organizzazioni “pericolose”.
Kornilov
Si forma un instabile equilibrio di potere tra Kerensky, che si propone come insostituibile elemento di compromesso tra le opposte istanze sociali della rivoluzione di Febbraio. Per questo ha assolutamente bisogno del sostegno dei Soviet. Kornilov rappresenta la controrivoluzione che pretende di arrestare tutto quel movimento storico e politico eliminando, in particolare, ogni traccia dei Soviet e dei bolscevichi. Entrambi aspirano ad instaurare una dittatura personale.
26 luglio: In condizioni di semi legalità si tiene a Pietrogrado, fino al 3 di agosto, il sesto Congresso, il secondo di quell’anno, del partito bolscevico, che ormai conta già 240.000 membri raggruppati in 162 organizzazioni, il triplo rispetto ad aprile.
L’analisi della situazione creatasi dopo i fatti di inizio luglio evidenzia due punti chiave: il potere sta sfuggendo dalle mani dei menscevichi e degli S‑R per passare in quelle della borghesia controrivoluzionaria a causa dell’impotenza dell’organo centrale dei Soviet, che al momento giusto si era rifiutato di prendere il potere. Ora non è più possibile un passaggio pacifico e indolore di tutto il potere ai Soviet e occorre prepararsi alla lotta rivoluzionaria per la completa liquidazione della dittatura controrivoluzionaria. Al Congresso l’organizzazione guidata da Trotski aderisce al partito bolscevico. È eletto un nuovo CC.
13 agosto: Il nuovo governo Kerensky indice a Mosca, lontano dalle masse in agitazione di Pietrogrado, una Conferenza di Stato durata due giorni a cui sono invitati oltre 2.000 rappresentanti delle classi dirigenti, imprenditori, politici e militari, per discutere sul futuro della democrazia russa. Sono invitati i rappresentanti dei Soviet favorevoli al compromesso col governo, ma ne sono esclusi i bolscevichi. Risulta una assise piena solo di retorica e roboanti discorsi. Il proletariato di Mosca, sotto indicazione dei bolscevichi, risponde con un grande sciopero di protesta con 400.000 partecipanti a bloccare la città. Analoghi scioperi sono organizzati in altre città.
Kornilov, appoggiato dalle classi controrivoluzionarie e dagli ambasciatori di Inghilterra e degli Stati Uniti, esce allo scoperto presentandosi come l’uomo forte che può salvare il destino della Russia con i suoi cosacchi, l’introduzione della pena di morte anche nelle retrovie, il divieto di assemblea dei soldati al fronte, la restrizione dei poteri dei Commissari politici tra le truppe, la censura sui giornali distribuiti ai soldati, la dissoluzione dei reparti militari più rivoluzionari, la militarizzazione delle ferrovie e di tutte le industrie per la produzione militare. Non fa mistero di voler eliminare tutti i bolscevichi e svilire i Soviet. Si contrappone così a Kerensky.
Rientrato al quartier generale russo a Mogilev, in Bielorussia, organizza una congiura per instaurare una dittatura militare.
20 agosto: I bolscevichi trionfano nelle elezioni municipali col 33% dei voti, ben oltre il 20% ottenuto nelle elezioni di quartiere di maggio. Il governo intanto rinvia le elezioni dell’Assemblea Costituente dal 30 settembre al 25 novembre.
22 agosto: Si conclude disastrosamente la battaglia terrestre di Riga, città chiave del Baltico dove si era ritirato il grosso della flotta russa del Nord, ben protetta dal mare dalle difese naturali del golfo e da terra dalle fortificazioni trincerate sulla riva settentrionale del fiume Dvina, su ottime posizioni naturali.
Questa disfatta fu dovuta a tre fattori concomitanti: Kornilov, forse
intenzionalmente, non aveva predisposto alcun piano efficace di difesa per poi
rigettare sui bolscevichi la responsabilità della caduta della città, tanto che
è accusato da Kerensky di averla lasciata cadere senza combattere. I soldati
russi posti alla sua difesa, mal equipaggiati e armati, dove forte era la
presenza dei bolscevichi non oppongono una valida resistenza, per lo più si
rifiutano di combattere e si ritirano di fronte all’impetuosa avanzata del
nemico. Infine qui veniva attuata una nuova tattica militare, già da tempo
sperimentata su scala minore e con incerti risultati sul fronte occidentale,
volta a superare la staticità della guerra di trincea per fluidificarla in
guerra di movimento, in assenza, ancora per poco, di efficaci mezzi corazzati
necessari per le rapide avanzate.
La nuova tattica di guerra
Il generale tedesco Oskar von Hutier, comandante della VIII armata germanica sul fronte orientale, coadiuvato dal comandante generale dell’artiglieria Bruchmüller, è incaricato di conquistare le fortificazioni della città, che reggevano dopo ben due anni di infruttuosi attacchi costati perdite di uomini e mezzi lanciati negli assalti alle trincee nemiche. La nuova tattica, qui collaudata per la prima volta su vasta scala, frutto di una sommatoria collettiva di esperienze, intuizioni ed esperimenti sui campi di battaglia, messi in atto in scala ridotta specialmente dai comandanti tedeschi a partire dalla metà del 1916, si basava su quattro punti basilari:
1. La sorpresa: occultare il possibile lo spostamento delle truppe d’assalto e della riserva, mentre prima, si cercava di impressionare il nemico con gli spostamenti delle truppe e delle artiglierie.
2. Concentrazione di fuoco su alcuni punti avversari, mentre prima si effettuavano lunghi bombardamenti preventivi, anche di più giorni, che spesso sortivano scarsi effetti, mentre rendevano impraticabile il terreno su cui dovevano poi avanzare le truppe, le artiglierie leggere e gli incerti mezzi motorizzati. Vi sarebbe stato invece un bombardamento intenso ma concentrato, al massimo di 5 ore, di cui le prime 2 con proiettili a gas e diretto principalmente sulle artiglierie avanzate. I successivi bombardamenti, spostando le artiglierie o i tiri, dovevano aprire e coprire l’avanzata delle truppe d’assalto, colpendo con precisione gli ostacoli che man mano queste incontravano. Si rendeva estremamente necessario il coordinamento col movimento delle truppe e assoluta precisione di tiro in modo che lo sbarramento di fuoco precedesse soltanto di alcune decine di metri la linea delle unità d’assalto. Le ricognizioni aeree con documentazione fotografica risultarono fondamentali per il calcolo dei tiri.
3. Infiltrazione: l’attacco della fanteria non è più sviluppato su un esteso fronte allargato, ma le nuove truppe d’assalto, specializzate e addestrate al combattimento ravvicinato (le Sturmtruppen), incuneandosi nei varchi ottenuti dal precedente bombardamento, dovevano penetrare il più possibile nelle retrovie nemiche aggirando le postazioni troppo resistenti al loro assalto veloce, ignorando quanto avveniva ai loro fianchi, compito riservato alle truppe del secondo assalto. Qui era la rischiosa novità: si rinunciava al consolidato principio per cui un’unità lanciata all’attacco non può spingersi in profondità senza assicurarsi un’adeguata protezione sui fianchi per non essere accerchiata e tagliata fuori dalle proprie linee in caso di un efficace contrattacco. Disponendo di numerosi piccoli gruppi altamente specializzati si ottenevano altrettante penetrazioni fino alla seconda e terza linea che disarticolavano le difese avversarie dando alle retrovie avversarie l’impressione che tutto il primo fronte fosse crollato, e potendo anche neutralizzare le batterie nemiche e i posti di comando.
4. Velocità: diventava la prerogativa essenziale della manovra; il passo dell’avanzata era dato dall’unità più veloce, non dalla più lenta, che doveva in ogni modo impegnarsi per non rimanere indietro.
L’esperienza critica di questa tattica applicata su una scala significativamente
ampia permise la riorganizzazione dei piani d’attacco germanici, la cui validità
fu pienamente confermata dall’offensiva austro-germanica sul fronte italiano due
mesi dopo, il 24 ottobre 1917, in quella che sarà la dodicesima battaglia
dell’Isonzo, terminata con il generale sfondamento del regio esercito italiano
su quel fronte, tristemente ricordato come la disfatta di Caporetto. L’anno
successivo sarà applicata in Francia, dove i risultati saranno ancora più
sbalorditivi: la V Armata britannica distrutta e la penetrazione tedesca di
oltre 55 chilometri.
La battaglia di Riga
Nei giorni precedenti l’attacco di Riga, l’intera 8a armata di Hutier era stata concentrata in modo discreto presso Chavli, ad adeguata distanza dal teatro delle operazioni, ma sufficiente per trasferirla velocemente al momento opportuno.
Il piano e lo sviluppo della battaglia furono divisi in un attacco principale e uno diversivo per impegnare l’esercito russo su due fronti e impedire trasferimenti di truppe russe di rinforzo sul fronte principale.
Ore 4,00: per 2 ore gli obici di Bruchmüller scagliano 20.000 granate a gas sulle posizioni dell’artiglieria e sulle seconde linee della fanteria russa. Tremende miscele di gas urticanti e asfissianti investono e causano forti perdite tra i cannonieri russi, con insufficiente dotazione di maschere antigas e di bassa qualità e non addestrati al loro uso.
Ore 6,00: inizia il bombardamento dei cannoni a più lunga gittata, degli obici pesanti e di 300 mortai da trincea di vario calibro.
Ore 9,00: il fuoco dell’artiglieria raggiunge il massimo, specialmente di fronte alla penisola fluviale di Uxküll, dove era previsto l’attraversamento della Dvina.
Ore 9,10: le squadre d’assalto germaniche passano per i varchi aperti dai genieri nei reticolati sulla sponda meridionale del fiume e spingono le barche nella corrente per attraversare a remi, coperti dalla rada nebbia mattutina ma soprattutto dal fuoco di sbarramento dell’artiglieria e dei fumogeni, i 300‑400 metri che li separano dalle prime file delle trincee russe sulla sponda opposta del fiume.
Il momento cruciale della battaglia dura qualche decina di minuti dopo di che i razzi verdi di segnalazione indicano l’avvenuta conquista della prima linea russa, ottenuta con bombe a mano e armi leggere.
Ora l’artiglieria allunga il tiro per coprire l’ulteriore avanzata della fanteria mentre altre batterie battono, secondo i piani prestabiliti, le vie di comunicazione e i villaggi circostanti dove erano stati individuati punti di comando e concentrazione di truppe russe. Nel frattempo i genieri lavorano a realizzare tre ponti sulla Dvina per il passaggio delle punte avanzate di 9 divisioni di fanteria.
La 12a armata russa del generale Parski, sorpresa e frastornata, non riesce a reagire con prontezza e in modo adeguato e già verso sera appare chiaro che l’ultimo grande scontro campale sul fronte orientale è a completo favore delle forze germaniche che hanno ottenuto un brillante successo senza perdite eccessive: complessivamente 4.500 uomini contro 25.000 russi, tra cui gran numero di prigionieri.
La conquista di Riga è un importante successo strategico per i tedeschi perché concede loro il controllo della base navale e della flotta russa lì bloccata, quello marittimo sul golfo di Finlandia e un formidabile avamposto per un eventuale attacco terrestre su Pietrogrado, aggredibile ora da terra e dal mare, qualora l’esercito russo possa costituire ancora una reale minaccia. È invece un duro colpo per le alleate forze reazionarie russe, autocratiche e borghesi, che intendevano continuare la guerra.
Nei giorni successivi il grosso dell’armata russa per evitare l’accerchiamento arretra per una fascia tra i 15 e 50 chilometri, mentre le truppe di Hutier e Bruchmüller due giorni dopo sfilano in parata nel centro di Riga.
La nuova tattica fu allora poco impiegata perché il fronte russo cedette in modo molto più rapido e completo del previsto, per l’insieme delle cause che abbiamo anticipato, ma confermò la validità dei piani dei comandi militari per superare la staticità della guerra di trincea, che gli storici militari hanno paragonato ad una gigantesca operazione d’assedio.
25 agosto: Kornilov, dal quartier generale russo a Mogilev, dove si trovava per organizzare una resistenza a un eventuale attacco tedesco su vasta scala, ordina al fidato generale Krymov di marciare su Pietrogrado e metterla sotto assedio. Preleva 3 divisioni di cavalleria più la nota per efferatezza “divisione selvaggia” di cosacchi montanari musulmani del principe Bagration. Distoglie forze importanti per una eventuale resistenza ai tedeschi nell’intento di prendere il potere e liquidare fisicamente i bolscevichi e riportare un Romanov sul trono.
Emette un proclama: «Io, generale Kornilov, dichiaro che il Governo Provvisorio, sotto la pressione della maggioranza bolscevica, agisce in completo accordo con i piani dello Stato maggiore tedesco, nel momento stesso in cui si prepara uno sbarco nemico sulla costa di Riga, distrugge l’esercito e sconvolge dall’interno il paese». Si autoproclama salvatore della patria.
Ma la sua richiesta di pieni poteri rivolta a Kerensky non ottiene la risposta desiderata. Kerensky, che fino a quel momento ha condotto un pericoloso doppio gioco tra destra reazionaria e Soviet, capisce che Kornilov, conquistata Pietrogrado, avrebbe destituito anche menscevichi e S‑R. Quindi dichiara il generale reo di alto tradimento e ne ordina l’arresto.
Mentre Krymov muove verso Pietrogrado emerge subito che Kerensky e il suo governo provvisorio non dispongono di truppe con cui difendersi e che la difesa della capitale può essere garantita solo dalle forze rivoluzionarie del Soviet e dai reparti della Guardia Rossa bolscevica alla guida degli operai e dei soldati. Kerensky infine autorizza il Soviet ad armare gli operai, a legalizzare nuovamente la Guardia Rossa, sciolta dopo i fatti di luglio e liberare i bolscevichi imprigionati, tra cui Trotski.
Si costituisce il Comitato Militare Rivoluzionario (Revkòm) per la difesa della città. In pochi giorni raduna 25.000 uomini adeguatamente armati mentre gli operai delle fabbriche di armi e munizioni riprendono alacremente il lavoro per produrre quanto necessario, specialmente cannoni.
L’azione decisiva per fermare l’avanzata dei cosacchi di Krymov è attuata dai ferrovieri sostenitori dei bolscevichi che rallentarono la corsa dei treni cosacchi verso Pietrogrado, deviandoli su direzioni secondarie e binari morti, e dagli impiegati delle poste e dei telegrafi che intercettano i dispacci del quartier generale di Kornilov per informarne il Comitato di Pietrogrado.
Mentre le truppe di Krymov perdono tempo prezioso per l’azione dei sabotatori bolscevichi che hanno rimosso i binari, numerose squadre di emissari del Soviet, caucasici e correligionari passati nelle file rivoluzionarie e nelle Guardie rosse, si recano verso i treni deviati per convincere i cosacchi a desistere dall’avanzata. Pronunciano parole magiche: fine della guerra, ritorno alle case, riforma agraria, spartizione delle terre.
Per fermare quell’esercito, dissoltosi in pochi giorni in mille rivoli senza dare ascolto agli ufficiali, non fu sparato nemmeno un colpo, ad eccezione di quello di Krymov per suicidarsi.
Fallisce il complotto della destra controrivoluzionaria e la completa rottura del rapporto di fiducia e obbedienza tra i soldati e gli ufficiali del passato regime.
Kerensky assume il comando supremo dell’esercito, il generale Duchonin viene nominato suo Capo di stato maggiore e sostituisce alcuni ministri.
Nel resto del paese e nelle campagne continuano le rivolte, le requisizioni delle terre, anche se represse dalle truppe governative, la formazione di comitati e Soviet per la gestione delle fabbriche, in un generale movimento rivoluzionario mosso dagli operai e dai contadini che si riconoscono sempre più nel programma bolscevico.
Lo comprovano le elezioni per i Soviet, che finora avevano visto il predomino degli S‑R di Kerensky. A Mosca in luglio agli S‑R era andato il 51% dei voti; ai cadetti il 17%; ai menscevichi il 12% e ultimi ai bolscevichi l’11%. In quelle d’inizio ottobre la situazione si capovolge: i bolscevichi raccolgono il 51%; i cadetti restano al 16%; gli S‑R crollano al 14%, i menscevichi al 4%. L’esecutivo del Soviet di Mosca passa quindi ai bolscevichi.
A Pietrogrado il Soviet della flotta disconosce il potere del nuovo Governo Provvisorio. Netta sconfitta alle elezioni degli S‑R e dei menscevichi. La sezione operaia del Soviet nomina una dirigenza bolscevica e approva una mozione a favore del potere sovietico con 510 voti contro 414 contrari e 67 astenuti. In seguito a ciò i rappresentanti menscevichi e degli S‑R si dimettono dall’Esecutivo del Soviet, che passa sotto il controllo dei bolscevichi. Trotski è nominato presidente del Soviet di Pietrogrado.
Passa sotto il controllo dei bolscevichi la maggior parte dei Soviet di tutta la Russia, che rivendicano il potere.
15 settembre: Il Governo Provvisorio, preoccupato per i possibili risultati a lui sfavorevoli nelle elezioni, già rinviate, per l’Assemblea Costituente, e nella ricerca di un sostegno del Comitato Esecutivo dei Soviet, indice a Pietrogrado una Conferenza Democratica di 1.200 delegati a cui non sono invitate le associazioni padronali e i partiti borghesi, ma una rappresentanza delle cooperative, degli organi consultivi dei governatorati locali, gli zemstvo, e delle associazioni locali. Risultano 532 S‑R, 530 menscevichi, 55 social-popolari e 17 non iscritti ad alcun partito; i bolscevichi sono soltanto 134.
Scopo principale della Conferenza sarebbe discutere se il prossimo governo debba essere a base “socialista”, dei rappresentanti dei gruppi invitati, o comprendere anche i partiti borghesi, con l’esclusione dei cadetti che avevano sostenuto Kornilov. La Conferenza esprime il tentativo del Governo di impedire il passaggio del potere ai Soviet.
20 settembre: I bolscevichi non abbandonano la Conferenza e non si rivolgono alle masse per spingerle all’insurrezione, come ha indicato Lenin. In due delle molte lettere inviate in quei giorni (“Sui compromessi” e successive note e su “Marxismo e insurrezione”) denuncia che la Conferenza sta coinvolgendo i delegati per la formazione di un governo solamente più radicale.
In particolare in “Marxismo e insurrezione”, inviata al CC, spiega la differenza tra il periodo di luglio e prima dell’avventura di Kornilov, in cui l’insurrezione sarebbe stata un errore, perché i bolscevichi non avendo sufficiente forza non sarebbero stati in grado di conservare il potere e l’esercito e la provincia avrebbero marciato contro Pietrogrado. Ora, dopo Kornilov, la situazione si è capovolta e bisogna agire scegliendo con cura il momento per l’insurrezione perché la soluzione della crisi non è nella Conferenza ma nei quartieri proletari e nelle caserme di Pietrogrado e di Mosca.
Nella successiva lettera, “La crisi è matura”, indirizzata al CC del partito, dopo un’ulteriore analisi della rapida evoluzione dei rapporti di forza, del tergiversare del CC in attesa delle elezioni dell’Assemblea Costituente, di quanto avviene nel movimento proletario negli altri paesi belligeranti e degli ammutinamenti in quegli eserciti, conclude perentorio e minaccioso:
«Non prendere il potere oggi, “attendere”, chiacchierare al Comitato Esecutivo Centrale, limitarsi a “lottare per l’organo” [dei Soviet], a “lottare per il Congresso” significa perdere la rivoluzione. Visto che il CC ha perfino lasciato senza risposta le mie richieste insistenti in questo senso dopo l’inizio della Conferenza Democratica, che l’organo centrale del partito sopprime nei miei articoli i brani che rilevano questi stridenti errori dei bolscevichi, come la decisione disonorevole di partecipare al Preparlamento, la concessione di un posto ai menscevichi nel presidium del Soviet ecc. ecc. io devo considerare questi fatti come una manifestazione “sottile” del desiderio del CC di non discutere neppure la questione, un discreto accenno a chiudermi la bocca e un invito a ritirarmi. Sono perciò costretto a chiedere di uscire dal CC, cosa che faccio riservandomi libertà di agitazione nella base del partito e nel congresso del partito. Perché è mia convinzione profonda che se noi “attendiamo” il Congresso dei Soviet e lasciamo passare il momento attuale, noi perdiamo la rivoluzione».
A questo punto, nonostante l’assoluto divieto, per motivi di sicurezza, del Comitato Centrale del partito, Lenin lasciò la Finlandia e senza informarlo si trasferì a Vyborg, presso Pietrogrado.
In particolare nelle “Lettera al comitato centrale” e nei “Consigli d’un assente” dei giorni immediatamente successivi dà chiarissime indicazioni strategiche per precisi punti su come impostare l’insurrezione di Pietrogrado. Conclude: «Il successo della rivoluzione russa e della rivoluzione mondiale dipende da due o tre giorni di lotta».
7 ottobre: I bolscevichi escono dal Preparlamento sostenendo in questo modo l’impossibilità di una pacifica soluzione parlamentare della crisi; si avvicina l’insurrezione.
Si forma un nuovo governo Kerensky con la partecipazione dei cadetti. Allo scopo di consolidare il suo incerto potere cerca di allontanare da Pietrogrado le truppe rivoluzionare inviandole verso il fronte col pretesto di una imminente invasione tedesca dopo la caduta di Riga.
L’Esecutivo dei Soviet, ancora controllato dagli S‑R e dai menscevichi, convoca per il 2 novembre il secondo Congresso panrusso, ulteriormente poi rinviato. I Congressi delle varie unità militari si schierano contro il nuovo Governo Provvisorio e reclamano il passaggio dei poteri ai Soviet.
Allo scopo di coordinare l’uso della forza armata si costituisce a Pietrogrado il Comitato Militare Rivoluzionario (CMR) formato dal comando militare della circoscrizione e dall’organizzazione militare bolscevica. Funzionerà come stato maggiore della rivoluzione, la cui direzione politica è assunta dal Comitato Esecutivo di Pietrogrado che ne stabilisce compiti e funzioni. Viene stilato un censimento delle unità più fidate, delle armi, delle munizioni e dei viveri e una stima delle varie necessità per coordinare l’azione militare.
20 ottobre: È emesso dal ministro della giustizia un nuovo ordine di cattura per Lenin, dopo che voci ne segnalano la presenza a Pietrogrado.
22 ottobre: Il CMR, in risposta al tentativo di Kerensky di allontanare le truppe rivoluzionarie da Pietrogrado, nomina propri commissari in tutte le unità della guarnigione e di fatto assume il controllo di quasi tutte le forze armate della capitale baltica, disarmando il Governo provvisorio, pur senza alcuno scontro diretto. Trotski presenta la nomina come necessaria a concretizzare il passaggio di tutti i poteri al Soviet e difenderli dall’attacco del Governo, in combutta con le forze reazionarie che intendono sabotare il Congresso pan russo dei Soviet.
23 ottobre: Il CC bolscevico stabilisce la data dell’insurrezione che, secondo Lenin, dovrà avvenire prima dell’inizio del Congresso dei Soviet, perché, essendo questo troppo numericamente consistente e composto da diverse tendenze politiche, non sarebbe in grado di giungere a una rapida e univoca decisione. Si tratta di fare «in modo che quest’ultimo, indipendentemente dalla sua composizione, venga posto di fronte a una situazione nella quale la conquista del potere da parte dei lavoratori appare già un fatto compiuto». La reale rivoluzione democratica degli operai e dei contadini giustamente sgombra il campo dalla democrazia formale.
Occorre rovesciare Kerensky per impedire al governo di utilizzare contro la rivoluzione le truppe lealiste distolte dal fronte.
Le organizzazioni militari della Guardia Rossa in tutta la Russia potevano disporre di un massimo di 150.000 armati in 62 città che, oltre ai 20‑25.000 di Pietrogrado, erano di 12.000 a Mosca, 5.000 a Kiev, 3.500 a Charkov, 2.600 a Saratov e 1.000 a Novgorod, più tutti i raggruppamenti nei centri minori nei villaggi e nelle campagne.
28 ottobre: Il partito a Pietrogrado dà inizio all’organizzazione dell’insurrezione. Ne affida la direzione ad un triumvirato composto da Antonov-Ovseenko capo del CMR, ex ufficiale di fanteria con un avventuroso passato di organizzatore di sommosse militari dalla Polonia alla Siberia e clamorose evasioni da diversi carceri, da Podvojskij, compagno di vecchia data che aveva già partecipato ai moti del 1905, e da Čudnovskij. Fanno altresì parte del gruppo: Eremeev, Blagonravov e Sadovsky. Nessuno di loro ha una consolidata esperienza di comando di unità militari. Le loro sono per lo più formate da elementi eterogenei e differentemente armati.
I volontari della Guardia Rossa sono armati di fucili, pistole e qualche mitragliatrice, organizzati in squadre di 10 uomini, in plotoni di 4 squadre, in compagnie di 3 plotoni e in battaglioni di 3 compagnie. I battaglioni di un distretto cittadino formano una divisione.
Le fabbriche più grandi hanno già le loro divisioni autonome e l’istruzione all’uso delle armi, che prima avveniva di nascosto ora nei cortili delle fabbriche, nei giardini e nei viali, segno che il vecchio Stato è ormai morente e sotto i suoi occhi ne sta sorgendo uno nuovo che attende solo l’atto dell’insurrezione per sostituirlo.
Il CMR considera i reali rapporti di forza nella capitale così sintetizzati da Trotski: «È vero che dalla parte degli operai c’era la stragrande maggioranza della guarnigione, ma una minoranza era contro gli operai, contro l’insurrezione, contro i bolscevichi. Questa piccola minoranza era composta dagli elementi più qualificati dell’esercito: il corpo degli ufficiali, gli junker, i battaglioni d’assalto e forse anche i cosacchi. Questi elementi non si poteva conquistarli politicamente: bisognava batterli».
31 ottobre: Nel palazzo dello Smolny, sede dei Soviet, si tiene la riunione dei delegati di reggimento e di compagnia della regione di Pietrogrado, che si pronunciano per l’insurrezione armata.
Un manifesto diffuso dal CMR accusa il Governo Provvisorio e il comando generale della guarnigione di aver rotto i buoni rapporti con la guarnigione rivoluzionaria e il Soviet di Pietrogrado e di essere diventati strumenti della controrivoluzione. Esorta inoltre i soldati della capitale a difendere l’ordine rivoluzionario e all’obbedienza agli ordini del solo Comitato Militare Rivoluzionario.
Zinoviev e Kamenev, i quali avevano sempre votato contro l’insurrezione nelle precedenti riunioni del CC, tramite un’intervista su un giornale esterno al Partito, la “Novaja Žizn”, rendono nota la loro opposizione all’insurrezione; altri addirittura pubblicano fantasiosi e dettagliati piani e date. Lenin risponde con la “Lettera ai membri del partito bolscevico” accusandoli di tradimento e ne chiede l’espulsione.
In tutta la Russia sono giorni di continui congressi e assemblee delle varie organizzazioni militari e dei comitati di fabbrica.
4 novembre: la “Giornata del Soviet di Pietrogrado” è una grande manifestazione di operai e soldati che conferma l’adesione delle nutrite avanguardie della città alle parole d’ordine bolsceviche. Ovunque nella città si parla dell’insurrezione che appare imminente.
5. Il primo congresso dei comunisti
e delle organizzazioni rivoluzionarie
dell’Estremo Oriente
Capitolo esposto alla riunione generale del settembre 2020
5.1 La questione orientale al 3° congresso dell’Internazionale
Il Terzo Congresso dell’Internazionale Comunista, svoltosi tra il giugno e il luglio del 1921, fu caratterizzato dalla constatazione da parte dell’avanguardia del comunismo mondiale che l’ondata rivoluzionaria che aveva fatto seguito alla guerra andava raffreddandosi, permettendo alla borghesia di riprendere l’offensiva, sia nel campo economico sia in quello politico. Inoltre appariva evidente che la formazione di partiti comunisti sulle corrette basi del marxismo rivoluzionario non era stata sufficiente per strappare larghi strati del proletariato dall’influenza dei partiti opportunisti, che avevano svolto un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’ordine borghese.
Data tale situazione, i lavori del Congresso si concentrarono prevalentemente su come conquistare al comunismo le masse proletarie sottraendole alle influenze dei partiti opportunisti, imprescindibile tappa per il successo dell’azione rivoluzionaria. Tale questione riguardava i partiti comunisti in Europa e in America, dove si lottava direttamente per la conquista del potere da parte del proletariato e della sua dittatura, da non dividere con altre classi sociali. Per questo motivo, la “questione orientale”, relativa alla lotta rivoluzionaria nei paesi coloniali e semicoloniali, non ebbe un posto di primo piano nei lavori del Congresso, provocando tra l’altro l’energica protesta di alcuni delegati.
In ogni caso, la corretta impostazione della lotta rivoluzionaria nei paesi dell’Oriente affermata al Secondo Congresso restava valida e confermata dal Terzo. Ad esempio, nelle “Tesi sulla situazione mondiale e sui compiti del Comintern” adottate al Congresso si afferma:
«Il vigoroso sviluppo capitalistico in Oriente, soprattutto in India e in Cina, ha creato colà basi sociali nuove per la lotta rivoluzionaria. La borghesia di questi paesi ha rafforzato i suoi legami col capitale straniero, e ne è così divenuta un importante strumento di dominio. La sua lotta contro l’imperialismo straniero, la lotta di un concorrente molto debole, ha sostanzialmente carattere fiacco e debole. La crescita del proletariato indigeno paralizza le tendenze rivoluzionarie nazionali della borghesia capitalistica, ma nello stesso tempo le enormi masse contadine trovano dei dirigenti rivoluzionari nella avanguardia comunista cosciente. Il combinarsi dell’oppressione militare da parte dell’imperialismo straniero, dello sfruttamento capitalistico da parte della borghesia locale e straniera, e la sopravvivenza della servitù feudale, creano delle situazioni favorevoli perché il giovane proletariato delle colonie si sviluppi rapidamente e prenda il posto che gli spetta alla testa del movimento rivoluzionario contadino. Il movimento popolare rivoluzionario in India e in altre colonie è ora divenuto parte integrante della rivoluzione mondiale allo stesso modo dell’insurrezione del proletariato nei paesi capitalistici del Vecchio e del Nuovo Mondo».
L’Internazionale ribadiva così alcuni punti fermi che avrebbero dovuto guidare la lotta rivoluzionaria nei paesi arretrati. Prima di tutto era affermata l’impotenza della borghesia indigena nel condurre la lotta rivoluzionaria, perché legata da interessi economici al capitale straniero, potente legame materiale che la rendeva docile nei confronti dell’imperialismo straniero e incapace di condurre una reale lotta nazionale, a cui si aggiungeva la paura di non poter fermare un movimento sociale che avrebbe certamente infranto anche il suo dominio di classe.
Il secondo punto ribadito era il ruolo del proletariato di guida del movimento rivoluzionario contadino. Nei paesi arretrati il proletariato, sebbene ancora debole numericamente, può essere l’unica classe in grado di mettersi alla guida delle masse contadine nella lotta per la rivoluzione nazionale borghese. Infine viene affermato, punto fermo della rivoluzione comunista mondiale, il necessario legame della lotta democratica-rivoluzionaria nelle colonie e semi-colonie, che vedeva il giovane proletariato indigeno alla testa di enormi masse contadine, con la rivoluzione monoclassista del proletariato dei paesi capitalisticamente sviluppati.
Lo stalinismo produrrà altre tesi riguardanti il procedere della rivoluzione nei paesi arretrati, che capovolgeranno l’originaria e corretta prospettiva dell’Internazionale. Tale inversione di lettura storica e di dottrina fu il riflesso nella politica nelle colonie della controrivoluzione in Russia, che esigeva la subordinazione del movimento comunista mondiale allo sviluppo e difesa del suo capitalismo nazionale e borghese.
Ma nel 1921, sebbene al Terzo Congresso dell’Internazionale già emergessero i
primi segnali di deviazioni tattiche, prontamente segnalati dalla Sinistra
comunista, riguardo la tattica nei confronti dei vecchi partiti della Seconda
Internazionale, la linea generale non subiva scostamenti dalla corretta
impostazione marxista. Solo quando la controrivoluzione avrà trionfato a Mosca
l’Internazionale Comunista diventerà uno strumento per il perseguimento di
determinati obiettivi della politica estera dello Stato russo.
5.2 I rischi della politica estera sovietica in Cina
Il nostro partito ha sempre ritenuto errata la tesi secondo cui già nel periodo successivo alla guerra civile la politica internazionale dello Stato russo fosse asservita alle esigenze dello sviluppo capitalistico interno. Il piano della NEP consisteva in concessioni e compromessi economici col capitalismo interno e internazionale, indispensabili ad evitare la fame in una Russia arretrata e sconvolta da anni di guerra, ma senza concedere nulla sul terreno politico e sulla prospettiva della rivoluzione mondiale. Le concessioni e i compromessi economici dovevano essere del tutto provvisori, necessari allo sviluppo della produzione in Russia, per permettere ai bolscevichi di mantenere il potere in attesa del prossimo assalto rivoluzionario in Europa. La politica estera dello Stato dei Soviet era orientata da una parte alla firma di trattati commerciali, dall’altra ad assicurare la sicurezza contro attacchi esterni.
Mentre ad occidente i tentativi rivoluzionari del proletariato erano stati sconfitti, la Russia sovietica era riuscita a sopravvivere agli attacchi delle armate bianche e degli eserciti stranieri, e si accingeva a concludere vittoriosamente la guerra civile. Se l’ondata rivoluzionaria mondiale subiva una battuta d’arresto, tra il 1921 e il 1922 l’avanzata dell’Armata Rossa verso Est permetteva alla Russia sovietica di consolidare le sue posizioni negli ex territori zaristi in Estremo Oriente, con la prospettiva di una proiezione verso il Pacifico.
La presenza in Estremo Oriente dello Stato comunista aveva già ottenuto un importante risultato nella Mongolia Esterna, che in passato aveva fatto parte dell’impero dei Qing ed era allora rivendicata dal governo cinese. Qui l’Armata Rossa, sotto la guida di Ungern-Sternberg, aveva sbaragliato quello che restava dell’ultima forza bianca in Siberia. Così nel luglio del 1921 si costituì un governo mongolo sotto la diretta protezione dei bolscevichi, alla presenza dell’Armata Rossa e di consiglieri sovietici. La sconfitta dei bianchi e la ritirata dei giapponesi permisero alla Russia di consolidare la sua influenza sulla Mongolia Esterna e, tra la fine del 1921 e l’inizio del ’22, la firma di un trattato tra il governo sovietico e quello mongolo.
In Mongolia, al programma bolscevico, appoggiato dai comunisti locali, di nazionalizzazione delle terre e delle miniere e di abolizione dei privilegi degli ordini religiosi e dei nobili, si oppose la vecchia casta religiosa, che nella lotta contro l’influenza sovietica assunse una posizione filocinese. Tale opposizione venne sconfitta e repressa.
I successi comunisti in Mongolia, se compromettevano le relazioni con il governo cinese, consentivano una sua azione più incisiva verso la Cina, che ora, a differenza dei primi anni del governo rivoluzionario in Russia, poteva andare oltre le proclamazioni di principio.
L’interesse dei comunisti per la Cina doveva tenere in considerazione il contesto politico del paese, mancante di un forte potere centrale, diviso fra le potenze straniere, che manovravano i diversi Signori della guerra l’uno contro gli altri. Il comunismo avrebbe potuto trarre dei vantaggi dagli antagonismi tra le opposte forze politiche e militari, ma ciò non era esente dal pericolo di deviare dalla linea rivoluzionaria internazionale. Il rischio della politica comunista in Cina – di appoggiarsi su alcuni raggruppamenti borghesi, e anche Signori della guerra, che si presumeva assumessero un atteggiamento favorevole allo Stato sovietico o svolgessero un ruolo nella lotta contro le potenze straniere – poteva entrare in contrasto col perseguimento della politica rivoluzionaria, la quale si sarebbe potuta appoggiare solo sul proletariato e sulle masse rivoluzionarie indigene.
Fin dalla vittoria rivoluzionaria in Russia i bolscevichi avevano tentato di stabilire legami con Sun Yat‑sen, capo del populismo e del nazionalismo cinese. Dal 1917 Sun Yat‑sen aveva formato un governo a Canton per resistere al dominio dei Signori della guerra che controllavano il governo di Pechino. Ma il potere di Sun Yat‑sen era comunque garantito dalle armi dei Signori della guerra del Sud, intenti a difendere il loro potere dalle interferenze dei rivali del Nord.
Nei primi anni Venti una certa attenzione fu rivolta verso il generale Wu Pei‑fu, Signore della guerra con base nella Cina centrale, tra i capi del clan Zhili. Alla fine dell’estate del 1920 Wu Pei‑fu era riuscito ad imporsi sulla cricca militare che controllava il governo di Pechino, provocando la cacciata del governo Anfu, altra organizzazione armata di orientamento filo‑giapponese
Ciò era valutato positivamente a Mosca in quanto avrebbe potuto comportare un orientamento meno sfavorevole verso la Russia sovietica, mentre l’ostilità al Giappone, e al suo protetto Zhang Zuolin, capo militare che controllava la Manciuria, ne facevano se non un potenziale alleato, un interlocutore col quale accordarsi per una reciproca neutralità.
Wu Pei‑fu e il suo clan avevano cercato appoggi anche tra la classe operaia, non disdegnando gesti di propaganda rivolti verso i lavoratori e promesso la “protezione del lavoro” nei punti del proprio programma politico. In particolare l’attenzione di Wu Pei‑fu era rivolta alle ferrovie che si erano molto sviluppate nella Cina centrale e il cui controllo aveva una grande importanza strategica, soprattutto in vista di una imminente crisi militare per il controllo del governo di Pechino, così come avvenne nel corso del 1922.
Wu Pei‑fu non disdegnò di cercare l’appoggio dei comunisti locali, i quali ritennero di poter sfruttare queste rivalità tra fazioni conservatrici per rafforzare l’organizzazione tra i ferrovieri. Ma inserirsi nei contrasti tra i militaristi era solo un’illusione e costituì una pericolosa manovra gravida di conseguenze tragiche. Il massacro dei ferrovieri ad opera della soldataglia di Wu Pei‑fu nel febbraio del 1923 sarà il chiaro monito per i proletari cinesi che non potevano avere come alleati che i milioni di contadini affamati di terra. L’espediente di servirsi di una cricca militarista contro un’altra, se poteva dare dei risultati nell’immediato, rischiava di compromettere lo sviluppo del movimento rivoluzionario. Anche se momentaneamente in lotta tra loro, ogni fazione sarebbe scesa a patti con la nemica, sia essa interna che straniera, pur di unire le forze contro il proletariato e le masse contadine insorte.
Queste manovre, rischiose all’inizio degli anni Venti, quando ancora i vertici del comunismo mondiale guidavano il movimento proletario nella prospettiva della rivoluzione internazionale, diverranno un cosciente tradimento nel momento in cui la controrivoluzione staliniana subordinerà la lotta rivoluzionaria nel mondo intero agli interessi della Russia borghese, imponendo in Cina che il partito del proletariato si alleasse con la borghesia, sottomettendo il partito comunista e il movimento rivoluzionario alla guida del Kuomintang.
Questo, dopo essersene servito, provvederà alla sanguinosa liquidazione delle
organizzazioni del proletariato cinese.
5.3 La Conferenza di Washington
Le rivalità tra i Signori della guerra in Cina erano anche il prodotto del più vasto scontro inter-imperialistico per il controllo del Pacifico. La prima guerra mondiale aveva determinato un nuovo assetto politico in Europa, lasciando la situazione nell’area del Pacifico quasi immutata. In realtà proprio le conseguenze della guerra in Europa, con i nuovi rapporti di forza tra gli imperialismi, rendevano l’area del Pacifico uno dei principali fronti della contesa.
All’epoca tre erano le potenze mondiali che aspiravano all’egemonia nel Pacifico. La Gran Bretagna per mantenere la supremazia su tutti i mari aveva la necessità di imporsi anche nel Pacifico. La sua forza si basava su una potente flotta, ma anche sulla sicurezza delle sue linee di comunicazione verso l’Oriente, la cosiddetta “Rotta imperiale”, garantita dal possedimento di una serie di basi e dal controllo di nodi strategici: Gibilterra, Malta, Porto Said, Aden, Ceylon, Singapore. Ma erano emerse altre due grandi potenze rivierasche sul Pacifico: gli Stati Uniti e il Giappone. Quest’ultimo aveva prontamente approfittato della sconfitta tedesca per accaparrarsi i suoi territori in Cina e le altre colonie tedesche nel Pacifico: le isole Caroline, le Marshall e le Marianne, arrivando così ad insinuarsi tra i possessi degli Stati Uniti delle Hawaii e nelle Filippine.
Da parte loro, gli Stati Uniti erano usciti molto rafforzati dalla prima guerra mondiale e ormai potevano ambire alla supremazia mondiale. Ma avevano bisogno di una potente flotta da guerra per imporsi sugli imperialismi rivali. Già durante la prima guerra mondiale, soprattutto dal 1916 in poi, avevano portato avanti un consistente riarmo navale, che continuò al termine della guerra. Anche Gran Bretagna e Giappone, per far fronte alla minaccia dal riarmo americano, risposero con l’accrescimento delle proprie flotte da guerra. A pochi anni dalla fine della guerra mondiale le principali potenze imperialiste iniziarono una corsa agli armamenti che superava di gran lunga il riarmo navale antecedente la guerra, facendo intravedere l’imminente scoppio di un altro conflitto.
L’antagonismo più acuto era dato dalla contesa anglo-americana per la supremazia sui mari. In tale contesto la Gran Bretagna appoggiava il Giappone, rivale nel Pacifico degli Stati Uniti. Da parte sua il Giappone, allarmato dal rafforzamento navale degli Usa e dal tentativo di stabilire una loro base sulle coste cinesi, si scontrava con la politica americana della “Porta aperta” verso la Cina, il cui fine era impedire ogni pretesa giapponese sul grande paese.
Gli Stati Uniti quindi, temendo la possibile alleanza tra Gran Bretagna e Giappone, proposero una tregua degli armamenti per qualche anno. Così nel luglio 1921 fu annunciata una conferenza sul disarmo e sui problemi del Pacifico da tenersi a Washington verso la fine dell’anno.
In vista della Conferenza, l’Internazionale aveva emanato una serie di tesi in cui si smascheravano i rapaci interessi delle potenze capitalistiche, affermando l’impossibilità di una soluzione delle loro rivalità.
Analizzando la situazione della Gran Bretagna era evidenziato come la crescente concorrenza economica con gli Stati Uniti portasse a una crescita della corsa agli armamenti, che avrebbe condotto a una nuova guerra mondiale. Ma la prossima guerra avrebbe visto la Gran Bretagna in una posizione più esposta, rispetto al conflitto appena concluso, principalmente per due motivi. Primo perché non poteva contare sulle colonie, in quanto queste, pur avendo partecipato al conflitto mondiale, avevano altre esigenze: l’Australia temeva la crescita dell’influenza giapponese, e quindi non era favorevole ad un’alleanza col Giappone, mentre il Canada, per ragioni economiche e per la vicinanza geografica, era interessato a mantenere buoni rapporti con gli Stati Uniti. Secondo perché in caso di guerra avrebbe potuto avere come avversaria la Francia che, dopo la sconfitta tedesca, cercava di dominare l’Europa continentale: era possibile un’alleanza Francia-Stati Uniti in funzione anti‑britannica. Si afferma nelle Tesi: «Questa situazione costringe il governo inglese a cercare di arrivare a un’intesa con gli Stati Uniti. Lo scopo di quest’intesa è la formazione di un trust capitalistico anglo-sassone. Gli Stati Uniti sarebbero il centro di gravità di questo trust mentre il Giappone dovrebbe farne le spese».
Del Giappone era evidenziata la posizione di debolezza che lo spingeva a un accordo con l’imperialismo britannico contro gli Stati Uniti: «I risultati della guerra minacciano di privare i Giapponesi dei frutti della loro vittoria. La sconfitta della Germania e la scomparsa della Russia come elemento imperialistico che poteva unirsi al Giappone in imprese di saccheggio, riducono il Giappone a fare assegnamento sulla sola Inghilterra per un aiuto contro gli Stati Uniti».
Ma secondo la valutazione dell’Internazionale tale prospettiva non era realizzabile perché, alla fine, messa di fronte alla scelta tra Giappone e Stati Uniti, la Gran Bretagna sarebbe finita tra le braccia del rivale americano. «Gli Stati Uniti vedono nella Cina e nella Russia dei mercati per soddisfare la loro enorme necessità di espansione economica, e dei territori da conquistare all’investimento di capitale americano. La posizione di monopolio di cui godono gli Stati Uniti nella loro posizione di creditori mondiali e, inoltre, la competitività dell’industria americana nei confronti non soltanto dell’industria giapponese ma anche di quella inglese, spingono gli Stati Uniti a contrastare tutti i privilegi imperialistici che gli Stati imperialisti più vecchi, Francia, Inghilterra e Giappone hanno acquisito in passato in Cina, o quelli che potrebbero acquisire in Siberia. Gli Stati Uniti, «sotto lo slogan della “porta aperta” in Cina (...) stanno cercando di fare indietreggiare il Giappone (...) Questa politica minaccia gli interessi inglesi, anche se in misura molto minore di quelli giapponesi. Non soltanto perché l’Inghilterra è un osso più duro che il Giappone per la concorrenza americana, ma anche perché la questione del Pacifico, vitale per il Giappone, non è che una delle preoccupazioni dell’Inghilterra. Perciò il Giappone può contare sull’Inghilterra solo fino ad un certo punto. Costretta a scegliere tra Giappone e Stati Uniti, l’Inghilterra parteggerà per quest’ultimi. Perciò la Conferenza di Washington rappresenta un tentativo degli Stati Uniti per strappare al Giappone con mezzi diplomatici i frutti della vittoria».
In ogni caso, nessun accordo poteva eliminare le basi delle rivalità inter-imperialistiche tra le potenze presenti a Washington, a cui andava aggiunto il profilarsi del conflitto con i paesi capitalistici sconfitti, ma anche con i popoli coloniali e, infine, con la Russia sovietica «che rappresenta una breccia nel sistema degli Stati capitalisti». Per cui: «L’Esecutivo dell’Internazionale Comunista afferma che la Conferenza di Washington non ci porterà né al disarmo né a una stabile pace tra le nazioni, e che essa rappresenta semplicemente un tentativo di conciliare gli interessi dei grandi predoni imperialisti anglo-sassoni a spese del predone più debole, il Giappone, della Cina, e della Russia sovietica». In sostanza, la valutazione dell’Internazionale sugli accordi di Washington era che non avrebbero certamente fatto diminuire le contraddizioni tra gli imperialismi, anzi, proprio Versailles prima e Washington ora affrettavano l’avvicinarsi della prossima guerra.
A Washington, infine, le cinque principali potenze marittime dell’epoca (Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone, Francia e Italia) conclusero un accordo per la limitazione degli armamenti navali fissando una proporzione tra le cinque marine militari più grandi del mondo e determinando il tonnellaggio globale di ciascuna flotta in base a dei coefficienti: 5 Gran Bretagna; 5 Stati Uniti; 3 Giappone; 1,7 Francia; 1,7 Italia.
Il principale risultato degli accordi di Washington riguardava l’attenuazione della rivalità anglo-americana per la supremazia navale, obiettivo raggiunto attraverso un compromesso nel quale ciascuno dei briganti otteneva un vantaggio. I paesi europei, Gran Bretagna, Francia e Italia, usciti “vittoriosi” dal conflitto, erano favorevoli a una limitazione degli armamenti navali perché versavano in una situazione critica dal punto di vista economico e sociale, mentre in generale l’intera Europa era uscita sconfitta rispetto all’America. La Gran Bretagna non poteva contare sull’appoggio dei Dominions per il riarmo. Comunque, otteneva la rinuncia, almeno momentanea, del programma americano di supremazia navale. Da parte loro gli Stati Uniti erano soddisfatti per la fine dell’alleanza anglo-giapponese, inclusa in termini non ufficiali nel trattato. Mentre il Giappone, benché avesse accettato lo status di potenza di terzo rango per quanto riguarda la marina, era avvantaggiato dal fatto che aveva da schierare la sua flotta solo sul fronte del Pacifico, a differenza degli Stati Uniti impegnati sui suoi due oceani e la Gran Bretagna che addirittura aveva da garantire la sicurezza delle sue immense linee di comunicazione in tutti i mari del globo.
Anche se a Washington gli imperialisti trovarono un compromesso sulla limitazione degli armamenti navali, questa intesa non poteva eliminare le loro rivalità; gli accordi di Washington erano soltanto una tregua temporanea che permetteva ai principali paesi imperialisti di prepararsi al meglio per la prossima guerra.
Le vere questioni dalle quali scaturivano i contrasti in Estremo Oriente, soprattutto lo sfruttamento della Cina, non furono affrontate in maniera risolutiva, né d’altronde sarebbe stato possibile farlo con la diplomazia. Le potenze imperialistiche si impegnarono a rispettare lo status quo nelle loro colonie e possedimenti sotto mandato nel Pacifico, e garantirono, ipocritamente, l’integrità della Cina sulla base della “Porta aperta”, il che permetteva a tutti i briganti imperialisti di banchettare attorno alla debole Cina.
Tutte le potenze che si erano accordate a Washington, più che la rivalità inter-imperialistica avevano da temere il proprio proletariato, che ancora non era stato domato e sosteneva la Russia sovietica, nel 1922 ancora non diventata un baluardo della controrivoluzione mondiale.
Per la Russia sovietica, non invitata alla Conferenza, se da un lato un qualsiasi accordo tra le potenze capitalistiche era una minaccia alla sua sicurezza, dall’altro avrebbe potuto trarre vantaggi dalle rivalità inter-imperialistiche e in particolare dalla contesa tra Stati Uniti e Giappone, che avrebbe favorito il ritiro di quest’ultimo dalla Siberia e un indebolimento della sua presa sulla Cina.
Le potenze imperialiste avevano escluso la Russia sovietica dalla partecipazione alla Conferenza di Washington, impedendole così l’utilizzo dello strumento diplomatico. Ma la Russia era allora uno Stato comunista, che orientava la politica estera verso l’obiettivo della rivoluzione mondiale. La sua risposta agli accordi tra i briganti imperialisti fu una chiamata alle armi di tutti gli sfruttati dell’Estremo Oriente e del mondo intero.
Capitolo esposto alla riunione del gennaio 2015
4. Dai sultanati alla fine del medioevo
23 - Il sultanato di Delhi
Con Sultanato di Delhi si intende lo Stato esistito dal 1206 al 1526 nel territorio corrispondente a una grande porzione settentrionale del subcontinente indiano, governato da dinastie turche e pashtun, prima di essere sostituito dall’impero Moghul.
I sultani erano chiamati Mamelucchi, dal nome della prima dinastia che regnò dopo la morte di Muhammad di Ghur e fino al 1290. I Mamelucchi vennero successivamente sconfitti dalla dinastia Khalji, che precedentemente aveva governato il Bengala e che estese il suo dominio nel meridione indiano. Nel 1347 le province del Sud dell’India divennero indipendenti e costituirono il Sultanato di Bahmani, successivamente suddivisotra il sultanato del Deccan e il Regno di Vijayanagara.
Nei suoi primi quarant’anni di vita il sultanato di Delhi, in modo del tutto analogo a quanto avveniva nel contemporaneo sultanato d’Egitto, fu una monarchia retta da un’oligarchia militare, composta dai membri di quella che era stata la famiglia di schiavi di Muhammad di Ghur, appartenenti alla tribù turca degli Ibari.
Delhi divenne per un secolo la capitale del nuovo impero, in posizione strategica sulle strade lungo il Gange e quelle che portavano nel Malwa e nel Deccan.
Il sultanato si trovò ad affrontare diverse cruciali insidie. La prima fu quella dei principi Rajput che, nonostante le numerose e severe sconfitte militari e cacciati dalle grandi pianure coltivate per zone montuose o semidesertiche, continuarono una tenace resistenza antiturca. Gli esempi delle grandi fortezze Rajput di Ranthanbhor e di Chitor, più volte conquistate e altrettanto perdute dai sultani, ne sono una prova.
Ancora più pericolosa delle ostilità esterne fu quella interna, perpetrata dai vari ceti intermedi tra la classe dominante turca e quella dei coltivatori della terra. Oltre le esteriori differenze etniche e religiose, questa nuova aristocrazia, costituita principalmente da indù, tendeva a sottrarsi al controllo dei sultani in un conflitto d’interessi in merito alla spartizione dell’eccedenza agricola.
I conquistatori turchi, concentrati nei centri urbani, dato il loro esiguo
numero riscuotevano le imposte attraverso questi intermediari, spesso
appartenenti alla classe dominante preislamica, o da elementi provenienti dalla
sterminata classe contadina, che nel tempo avevano acquisito un potere nel
villaggio.
24 - La minaccia dei mongoli
Ma da quando Gengis Khan, nel 1221, aveva compiuto una rapida incursione nel Punjab, le invasioni delle popolazioni mongole furono di gran lunga la prima emergenza che i sultani di Delhi dovettero affrontare e alla quale dovettero subordinare ogni altro obiettivo. Tale minaccia indusse a rinunciare, seppur momentaneamente, alla politica di espansione a sud, e a sostenere una rigorosa politica centralizzatrice volta a mobilitare le risorse necessarie a mantenere un grande esercito.
Nello stesso periodo in cui Muhammad Ghuri intraprendeva vincenti campagne militari nel Nord dell’India, un conquistatore di nome Temujin Borjigin imponeva il proprio controllo su di un’ampia confederazione di tribù di lingua mongola. Nel 1206, anno in cui nacque il sultanato di Delhi, la dieta dei rappresentanti delle tribù sottomesse proclamò Temujin capo supremo, col titolo di Gengis Khan: sovrano universale.
Anche dopo di lui i mongoli continuarono ad estendere il proprio dominio nel tredicesimo secolo, attaccando con successo l’Europa Orientale, conquistando la Cina, aggredendo Vietnam e Giappone e, infine, annettendo Persia e Mesopotamia dove, nel 1258, distrussero Baghdad passando a fil di spada l’intera popolazione e condannando a morte per fame l’ultimo califfo abbaside.
I mongoli, come i turchi, combattevano a cavallo, impugnando come arma principale l’arco composito. Si erano dati un comando rigorosamente centralizzato. L’esercito era strutturato in distaccamenti, più flessibile rispetto a tutti gli eserciti dell’epoca. Disponeva di una efficace cavalleria, ciascun cavaliere disponeva almeno tre o quattro cavalcature, Marco Polo scrisse di averne viste fino a diciotto, rendendo estremamente rapidi gli spostamenti sulle grandi distanze.
Quando, nel 1241, i mongoli attaccarono l’Europa distrussero ogni esercito con cui vennero a contatto, divisi in due armate operanti in Polonia e in Ungheria, uno a nord e l’altro a sud dei Carpazi: un sistema strategico che i generali europei furono in grado di eguagliare solo nel XIX secolo.
Questo era il nemico che i sultanati indiani dovettero affrontare. L’impegno economico atto a costruire una possente macchina da guerra non fu vano. Dopo decenni di battaglie dagli esiti alterni, nel 1292 i mongoli attaccarono in forze ma furono duramente sconfitti a Sunan dal sultano Shah Firuz, fondatore della dinastia dei Khalji. Nel 1299 un esercito mongolo di duecentomila uomini tentò di nuovo ma fu sconfitto, così come 4 anni dopo quando non riuscirono ad impadronirsi del campo militare fortificato.
Queste fondamentali vittorie furono ottenute anche per l’apertura di nuove rotte commerciali tra i sultanati e il Medio Oriente, che permisero di importare cavalli nonostante i passi a nord‑ovest fossero bloccati dai mongoli. L’India infatti aveva instaurato un florido commercio marittimo con la Persia, che continuò anche quando quest’ultima passò sotto il controllo dei mongoli.
Il pericolo per il sultanato cessò definitivamente nel 1308, dopo ulteriori e
fallimentari spedizioni mongole fermate dai successori di Firuz. A Delhi
migliaia di prigionieri furono fatti massacrare dagli elefanti e, come piange la
tradizione mongola, con le loro teste fu alzata una piramide fuori della città.
25 - L’esercito, l’economia, l’amministrazione
Queste vittorie, che valsero ad Ala-ud-Din la fama di uno dei più importanti condottieri nella storia dell’India, furono possibili grazie a una efficiente amministrazione centralizzata. Inoltre, l’impresa contro i mongoli, all’apice della loro terrificante potenza militare, non solo assicurò la sopravvivenza del sultanato, ma fu decisiva per avviare un insieme di significative trasformazioni del sistema politico e alcuni adattamenti sul piano economico.
Se in un primo momento l’unico appoggio della classe dirigente sultaniale offerto ai coltivatori era stata la protezione da razziatori e conquistatori esterni, i sovrani iniziarono ad investire nella costruzione di pozzi, favorendo la produzione agricola. Allo stesso tempo una consistente quota di ricchezza prodotta dal grande settore rurale venne trasferita ai ceti urbani.
Seguendo una consuetudine tipicamente turca, i sultani, oltre a tenere una porzione di terre per sé, ne distribuivano una parte ai capi militari, i quali, a loro volta, le suddividevano tra le loro prime linee. In realtà quel che si possedeva non era la terra ma il diritto della imposta su di essa, chiamata iqta. In questo modo si legavano i militari al potere centrale del sultano. L’antica prassi delle donazioni di terre ai brahmani e ai templi fu estesa ai militari, i quali garantivano la riscossione territoriale delle imposte. Ma la concessione della riscossione dell’iqta non era ereditaria, e neppure permanente, impedendo così il formarsi di un potere autonomo di una aristocrazia. Dinamica che delineava il modo di produzione asiatico.
La costruzione di un apparato militare sempre più efficiente, concentrato interamente nelle mani del sultano, aveva un duplice obiettivo: tenere a bada la minaccia mongola e rendere impossibile ogni sfida interna al potere del monarca. Priorità che si realizzarono tramite una serie di disposizioni politico-amministrative che rendevano agile la mobilitazione ed il mantenimento di tutto l’apparato militare.
I predecessori di Ala-ud-Din avevano basato il loro governo principalmente sulla forza dell’esercito e sul controllo di poche ma fondamentali città e fortezze. Traevano le risorse finanziarie dal bottino delle incursioni militari all’esterno, dalle tasse imposte sui mercati di Delhi, dalle imposte terriere sull’area circostante la capitale e dal tributo dei re sottomessi. Ma l’imposta fondiaria e il tributo non erano sempre pagati con regolarità. La popolazione rurale era per la maggior parte di religione indù, mentre i musulmani vivevano nelle città, grandi e piccole. Qui intere caste di artigiani avevano talvolta abbracciato la fede islamica per sfuggire alle discriminazioni risalendo dalla loro bassa condizione castale. I pochi musulmani fuori delle grandi città vivevano in piccoli centri amministrativi fortificati chiamati gasba.
La produzione agricola era controllata dalle tradizionali aristocrazie indù, i capi dei villaggi, dai quali il sovrano di fatto dipendeva poiché attraverso di loro controllava la popolazione contadina. Per limitare la forza di questi intermediari, sempre più ricchi e potenti, e in particolare per mantenere economicamente un esercito efficiente, Ala-ud-Din ordinò un nuovo catasto di tutta la terra e fissò un’aliquota uniforme, la metà del raccolto, imposta a tutte le classi rurali.
Inoltre, per rafforzare la vitale centralizzazione, furono emanate le seguenti
ordinanze.
– I prezzi di tutte le derrate alimentari dovevano essere fissi, un alto
ufficiale era incaricato di vigilare, attraverso una rete di spie, che nei
mercati di Delhi fossero applicati i prezzi di legge.
– Il commercio e il trasporto del grano erano controllati dal governo centrale,
i lavoratori addetti al trasporto dovevano risiedere con i familiari lungo il
fiume Yamuna, in luoghi prestabiliti, a una determinata distanza l’uno
dall’altro, in modo da garantire un rapido trasporto del grano nella capitale.
– A tutti i contadini e commercianti fu proibito l’accumulo di scorte così da
prevenirne la vendita al mercato nero.
Tuttavia questi provvedimenti, come molte delle misure fiscali, riuscirono ad
essere rispettati solo nelle regioni non lontane da Delhi.
26 - Verso Sud
In India, come altrove, iniziò un periodo segnato dall’introduzione di nuovi mestieri e di importanti innovazioni tecniche: la manifattura della carta, il filatoio circolare importato dall’Iran (la Charkha, amata da Gandhi e che oggi compare al centro della bandiera indiana), il filatoio a pedale e la macchina cardatrice ad arco. Sempre dall’Iran fu introdotto il telaio verticale per la produzione di tappeti. Inoltre, grazie a una serie di migliorie nell’industria delle costruzioni, come l’uso della calce e quello dell’arco e della cupola, gran parte della popolazione urbana abbandonò le case di legno per quelle di mattoni.
Dopo la fulminea conquista di gran parte del Nord dell’India, i sultani furono tentati più volte di spingere i propri vittoriosi eserciti in direzione del meridione, oltre i monti Vindhya, la catena che separa la pianura gangetica dall’altopiano del Deccan. Il grande dispendio di risorse ed energie che avrebbe richiesto il contenere il pericolo mongolo non costituiva il solo fattore deterrente a frenare i sultani nella corsa verso il Sud. Se la conquista di quei territori avrebbe potuto essere relativamente facile, non lo sarebbe stato il loro mantenimento, che avrebbe comportato la istituzione di nuove province nonché lo stanziamento e il finanziamento di nuove truppe. Queste inoltre, data la grande distanza dalla capitale, avrebbero potuto non tardare a mettere in discussione l’autorità del sultano.
Tuttavia, con il passare del tempo, la ricchezza di quei territori e la debolezza degli eserciti dei loro Stati si rivelarono una tentazione irresistibile per la classe dominante a Delhi. A più riprese le truppe del sultano penetrarono in profondità, fino a raggiungere l’estrema punta meridionale della penisola indiana: Capo Comorin, oggi Kanyakumari, una città sui tre mari, l’Arabico, l’oceano Indiano e il golfo del Bengala.
Ma quelle lunghe scorribande erano tese non tanto alla conquista bensì al saccheggio e, laddove possibile, all’imposizione di un rapporto tributario. Gran parte dell’India si trovò così sotto il controllo diretto o sottomessa ai signori di Delhi. Rimanevano esclusi il regno indù dell’Orissa, che sopravvisse a tutti gli assalti musulmani fino al 1568 d.C, quello di Kampili, un piccolo regno sulle rive del fiume Tungabhadra (nell’odierno Stato meridionale del Karnataka) e i territori Pandya i quali, dopo essere stati depredati, erano riusciti a riconquistare l’indipendenza.
Nel 1327 la capitale fu spostata da Delhi a Devagiri, l’attuale Daulatabad, nel
Maharashtra, più centrale, per meglio assicurare i territori del Sud sotto il
potere del sultanato.
27 - Tamerlano e la fine del sultanato di Delhi
Dalla metà del Trecento il sultanato si indebolì a causa di una serie di insuccessi in campo economico e militare. Una delle ultime spedizioni non fu sconfitta in battaglia ma dalla peste. Riconosciuto il fallimento del dominio del Sud, si decise di riportare a Delhi la capitale.
Dopo numerosi tentativi di pacificare l’area e restaurare l’autorità centrale, il Bengala si rese indipendente nel 1338, e nel 1345 lo stesso accadde per ciò che rimaneva dei possedimenti sultaniali nel Deccan.
È in questo scenario che le porte dell’India si aprirono alla marcia devastatrice di un nuovo grande condottiero turco proveniente dal centro dell’Asia: Timur lo Zoppo, conosciuto dagli europei come Tamerlano. Asceso al trono di Samarcanda, oggi in Uzbekistan, nel 1369, si lanciò in una serie di grandi incursioni destinate a devastare la Persia, l’Anatolia, l’Afghanistan, la Mesopotamia e la Russia meridionale.
Tamerlano, che si professava islamico, attaccò l’India cingendo il manto del Ghazi, il guerriero della fede, proclamando la Jihad, la guerra santa. Il fatto che i sultani di Delhi e la maggior parte dei principi regnanti nel Nord fossero essi stessi musulmani nelle guerre che si proclamano di religione conta poco. Nel 1397 le avanguardie di Tamerlano penetrarono nel Punjab. Il 17 dicembre 1398 davanti a Delhi 90.000 cavalieri si scontrarono con l’esercito del sultano Nasir composto da 10.000 cavalieri, 40.000 fanti e 120 elefanti corazzati. La battaglia si risolse in una disfatta per le forze del sultanato: per tre giorni i soldati di Timur saccheggiarono la città.
Alcuni mesi dopo, quando Timur abbandonò il subcontinente, il Nord dell’India
era sprofondato nel caos. Le vittorie di Tamerlano avevano posto fine
all’autorità statale di Delhi che si frammentò in diversi sultanati. Questi
sopravvissero come potenze regionali sino alla totale conquista nel 1526 da
parte dei Moghul.
28 - La fine del medioevo tra crisi demografica e agraria
Ci troviamo qui di fronte alla fase conclusiva del medioevo, non solo in India ma in gran parte del mondo civilizzato. Una depressione demografica ed economica era stata causata da una epidemia di peste e da una consistente recessione agricola. Nel 1330 la pestilenza era dilagata dalla provincia cinese dello Hupei in gran parte del mondo, nei successivi venticinque anni trasportata dai mercanti e dagli eserciti sulle vie marittime e terrestri. In Europa si manifestò a partire dal 1346 e la sconvolse fino al 1353, nello stesso anno in cui completò la devastazione in Cina. Il conseguente crollo demografico comportò un generale declino di tutte le attività economiche e dei commerci a lunga distanza.
Dopo le devastazioni iniziali, l’egemonia mongola sull’Asia aveva creato una sorta di enorme unica entità statale, all’interno della quale era relativamente facile spostarsi e muovere merci dal Mediterraneo fino alla Cina, sia via terra sia per le rotte marittime. Un sistema postale e una rete stradale si spingevano dalla Cina al Turkmenistan, dalla Persia alla Russia, agevolando il commercio che portò, per esempio, in Europa dalla Cina la polvere da sparo, la bussola e la stampa.
Questo aperto mercato scomparve dopo il 1368 quando i mongoli si ritirarono dalla Cina. È verosimile che i morti di peste, in popolazioni non numerose come quelle mongole, non potessero essere rimpiazzati a differenza di quanto poteva essere per i ben più numerosi cinesi. Da allora lo stato di guerra permanente fra i nomadi delle steppe e la dinastia Ming venne a bloccare le vie carovaniere fra l’Estremo Oriente e il bacino del Mediterraneo.
Ma già prima della diffusione del morbo si erano manifestati i sintomi di una grave crisi agraria di lungo periodo. La causa non è attribuita a mutamenti climatici, come capitato in precedenza, ma all’eccessivo sfruttamento della terra, depauperata degli elementi nutritivi. Le aree più colpite erano quelle in cui l’agricoltura era stata praticata più a lungo ed intensamente. Una diminuzione di fertilità si ebbe fra la metà del trecento e l’inizio del cinquecento in alcune importanti aree come la valle del Nilo e il bacino del Tigri e dell’Eufrate, che tra l’altro non erano state colpite gravemente dalla peste. Anche la recessione verificatasi nella pianura gangetica durante il regno di Muhammad ibn Tughlaq – Sultano di Delhi dal 1325 al 1351 – è probabilmente riconducibile alla medesima causa.
L’unica soluzione quindi, date le tecniche agrarie dell’epoca, era la messa a coltivazione di terre vergini. Questo fu possibile in Europa, dove la catastrofe demografica delle popolazioni nomadi flagellate dalla peste aveva liberato vaste estensioni di terra coltivabile, di cui il maggiore esempio sono le distese ucraine.
Quindi, dopo l’invasione di Tamerlano sul Nord del subcontinente si abbatterono due flagelli, uno demografico l’altro economico, aventi origini sia endogene, l’incapacità dei sultani di fermare l’invasione di Timur, sia esogene, la diminuzione dei commerci e un generale crollo della circolazione monetaria in tutto il mondo.
Per altro quella crisi a livello mondiale contribuì a schermare il subcontinente, per oltre un secolo, da invasioni provenienti dall’Asia centrale.
Al quadro generale qui delineato sfuggono gli Stati meridionali, in particolare
l’estremo Sud, grazie al mantenuto snodo di traffici della penisola del Deccan e
della produzione agricola, grazie alla messa a coltura di nuove terre a
discapito delle ancor numerose popolazioni tribali colà presenti. Queste furono
più o meno forzatamente integrate e inserite in una posizione subordinata
all’ordine castale. Il lungo processo di colonizzazione fu portato avanti
soprattutto ai danni dei popoli di lingua telugu. È questa l’etnia dei fondatori
di quello che, dalla metà del Trecento fino alla metà del Cinquecento, emerse
come uno tra i più potenti Stati indiani: l’impero di Vijayanagara.
29 - Impero di Vijayanagara
Il regno Vijayanagara trasse origine dalle conseguenze politiche che seguirono le campagne di Ala-ud-din. Intorno al 1330 diversi capi indù, già costretti a riconoscere la sovranità del sultanato, si ribellarono contro il governatore di Kampili, una delle cinque province in cui il Deccan e l’India meridionale erano stati divisi. Il regno, fondato nel 1336, comprendeva l’India meridionale e l’altopiano del Deccan. Si manterrà fino al 1646, ma già nel 1565 aveva perso molta influenza, dopo la sconfitta ad opera di una alleanza dei sultanati del Deccan.
Al regno Vijayanagara la costante minaccia incombente da nord e la sua politica espansionistica rendevano necessario un grande esercito centralizzato e permanente. Questo era imponente, si stimano fino a 2 milioni di soldati, reclutati tra le diverse classi sociali. Le sole truppe personali del re Krishna Deva Raya, ad esempio, erano composte da più di 100.000 soldati, 20.000 cavalieri e quasi 1.000 elefanti da guerra.
Grandi e importanti nel regno le città. La capitale, una delle più grandiose metropoli del tempo, vantava dentro 7 cinte di mura gran numero di palazzi, templi, bazar.
Il regno era diviso in cinque province, ciascuna con un comandante supremo e un governatore, ma in uno Stato fortemente centralizzato. Grazie agli intensi scambi commerciali, in particolare marittimi, il regno ebbe la possibilità di acquisire nuove tecnologie, come i sistemi di controllo delle acque irrigue. Intensi gli scambi con le potenze dell’epoca, in particolare con la Cina, di merci imbarcate negli oltre 300 porti che si aprivano sul Mar Arabico ad Ovest e sul Golfo del Bengala ad Est.
La principale attività era l’agricoltura. Erano coltivati grano e cotone nelle regioni più aride, in quelle più piovose canna da zucchero e riso. Le spezie, trasportate in città, ne alimentavano i commerci.
Come in ogni società indù il sistema castale si sovrapponeva e intersecava le
divisioni di classe.
30 - I portoghesi
L’inizio del sedicesimo secolo vide un nuovo attore partecipare agli affari della penisola del Deccan: il Portogallo. Nel maggio del 1498 una consistente flotta guidata dall’esploratore Vasco da Gama, primo europeo, navigò fino in India doppiando il Capo di Buona Speranza. La nuova rotta permetteva ai portoghesi di evitare il Mediterraneo, altamente conteso, e le pericolose carovaniere nella penisola araba.
Attraccò nel porto di Calicut, capitale del piccolo Stato del Malabar, lungo la costa sud‑occidentale della penisola, che oggi costituisce la parte settentrionale dello Stato del Kerala. I principi indiani ricevettero gli inattesi ospiti come nuovi mercanti con cui instaurare proficui rapporti commerciali.
Già nel 1501, quelle che erano state iniziative di alcuni comandanti portoghesi nell’oceano Indiano, divennero parte integrante della politica della monarchia lusitana. Re Manuel del Portogallo assunse nel 1499 il titolo di “Signore della conquista, della navigazione e del commercio dell’Etiopia, dell’Arabia, della Persia e dell’India”.
La ricchezza che nel corso degli anni rifluì a Lisbona non derivava solo dal commercio, ma dal saccheggio delle navi arabe dirette ai porti indiani. La superiorità delle navi portoghesi e dei loro armamenti permetteva di catturare quelle navi che per parecchi secoli avevano avuto il monopolio del commercio con l’India e di escluderli da quelle importanti rotte.
Per alcuni decenni, pur trovando diverse resistenze, i portoghesi furono superiori ad ogni avversario navale, controllando di fatto molte delle rotte oceaniche. Nel 1510 conquistarono la città di Goa, che divenne la base militare per la flotta portoghese in India. In seguito furono espugnate la città portuale di Diu e, nel 1550, quella di Daman, che rappresentarono le prime e più durature conquiste europee in India. Sarebbero diventate parte dell’India indipendente solo nel 1961.
Tra i possedimenti che facevano parte dell’Estado da India, il più prezioso era l’arcipelago delle Molucche, all’epoca la principale fonte mondiale di spezie pregiate.
I potenti Stati indiani avevano le loro capitali nell’interno. I portoghesi
mantennero le loro teste di ponte sulla costa come scali commerciali e basi di
rifornimento, ma non fecero mai alcun serio tentativo per sfidare e sottomettere
i regni indigeni dell’interno, si interessavano quasi esclusivamente al
commercio delle spezie e dei cavalli da guerra.
31 - Le battaglie di Panipat e di Talikota
Nel Nord, il rinato sultanato di Delhi, sotto i Lodi, ebbe la classe dirigente dominata da una aristocrazia afgana. Era esclusa dal potere la componente indù, probabilmente a causa delle numerose ribellioni di quel periodo guidate proprio dagli indiani.
Il conflitto fra l’ultimo sultano Lodi e quella parte dell’aristocrazia che non intendeva sottomettersi subì una svolta quando Alam Khan, governatore di Lahore, chiamò in aiuto il principe di Kabul, Ẓahir al‑Din Muḥammad, noto come Babur (Tigre), discendente di Tamerlano e fondatore della dinastia Moghul. Costui accolse la richiesta, ma presto dimostrò che non sarebbe stato uno strumento nelle loro mani. La battaglia risolutiva fra il suo esercito e quello del sultano Ibrahim ebbe luogo nel 1526 nei pressi della cittadina di Panipat. Nonostante la superiorità numerica l’esercito sultaniale fu annientato. Da allora si considera iniziare l’impero Moghul. Quella battaglia fu una delle prime in cui si fece uso delle armi da fuoco e delle artiglierie nel subcontinente. I cannoni di Babur risultarono decisivi sui Lodi, ai quali ancora mancavano e al cui rombo gli elefanti terrorizzati scompigliarono lo schieramento.
L’anno successivo Babur sconfisse un altro poderoso esercito messo in campo dall’alleanza di tutti i principali clan dei Rajput.
Nel frattempo, nel 1564, nel Sud, tra i sultani della penisola del Deccan, si riuscì a stabilire una breve tregua con l’obiettivo di procedere uniti contro il regno di Vijayanagara, che dall’inizio del cinquecento andava trasformandosi in una minaccia sempre più concreta. Nel gennaio del 1565 si arrivò alla battaglia decisiva di Talikota (oggi distretto di Bijapur, nello Stato federato del Karnataka) che vide la netta vittoria dei sultanati. La cavalleria dei sultani mise in fuga l’esercito Vijayanagara saccheggiando e distruggendone la grande omonima capitale, che non venne più ricostruita.
Il Regno, benché fortemente indebolito, sopravvisse per qualche tempo, ma i suoi sovrani perdettero il controllo delle regioni periferiche, le quali crearono nuovi autonomi centri di potere. Pochi anni dopo la stessa sorte toccò al regno dell’Orissa, conquistato dal sultanato del Bengala.
Nonostante queste sconfitte, non tutto il meridione passò sotto il controllo delle dinastie musulmane.
(continua dal numero 90)
Parte 2
Dal Soviet Internazionale Provvisorio al Profintern
Nei sindacati crescono robuste minoranze comuniste
Nel luglio 1921, l’anno successivo alla nascita del Soviet Internazionale Provvisorio, si tenne il Congresso di fondazione dell’Internazionale Sindacale Rossa (Profintern).
Il Soviet Internazionale Provvisorio era stato concepito con lo scopo di opporre l’idea e la pratica della lotta di classe e della rivoluzione sociale a quelle di collaborazione fra le classi sostenute dalla Internazionale gialla di Amsterdam.
Gli undici mesi che intercorsero prima del Congresso di fondazione dell’Internazionale dei Sindacati Rossi erano stati dedicati a una intensa e capillare diffusione della propaganda e alla raccolta e coordinamento delle forze rivoluzionarie. Durante questo periodo all’interno dei sindacati di tutti i paesi si erano costituite importanti minoranze proletarie in tenace opposizione alla politica delle vecchie organizzazioni economiche collaborazioniste.
Un aspetto molto importante, ma delicato e di cui si dovette necessariamente tener conto, fu che il movimento rivoluzionario sindacale presentava delle caratteristiche notevolmente variegate, e che non avevano unità né di programma né di azione.
A questo riguardo Lozovski affermava: «C’era una estrema diversità di tendenze e di idee, che l’odio contro gli oppressori riuniva, ma che venivano divise dalla diversa maniera di intendere la strada che conduce alla rivoluzione sociale, e i compiti che si impongono alla classe operaia nell’ora presente [...] Questa molteplicità era inevitabile, ma poiché essa ostacolava l’unità di azione, bisognava farla scomparire, adottando una tattica unica, generale, obbligatoria».
Come abbiamo visto, in un primo tempo era stata avanzata la proposta di
convocare il Congresso di fondazione entro il 1920. Era stato poi rimandato al
1° gennaio 1921, in seguito al 1° maggio, per giungere infine al luglio, in
concomitanza con il terzo congresso dell’IC.
Le Internazionali Due e Due e mezzo
Prima di procedere all’analisi dei congressi di Mosca delle due Internazionali rivoluzionarie, la politica e la sindacale, occorre fare un accenno alla riorganizzazione politica, proprio in quello stesso periodo, dell’opportunismo collaborazionista attraverso la rinascita e nascita delle altre due Internazionali dei traditori del proletariato: la Seconda Internazionale e la Internazionale due e mezzo.
I primi giorni dell’agosto 1920 si tenne a Ginevra quel congresso che, nelle intenzioni dei suoi partecipanti, avrebbe dovuto far resuscitare la Seconda Internazionale. Non staremo a dire che si trattò della riunione di uno sparuto gruppo di politicanti sciovinisti, altrettanto odiosi al proletariato quanto cari alla borghesia. Praticamente si trattò di un incontro tra i soli due gruppi di una certa importanza, gli inglesi e i tedeschi. A presiedere il congresso era l’inglese Tom Shaw, mentre erano assenti giustificati, in quanto trattenuti dai loro impegni ministeriali, il belga Vandervelde e lo svedese Branting.
La prova del ritrovato spirito internazionalista fu data dai delegati francesi che sollevarono immediatamente la questione delle responsabilità della guerra a cui i tedeschi risposero che ancora non era possibile formulare un giudizio definitivo poiché i governi interessati, ad eccezione di quello tedesco, non avevano reso noti i documenti relativi alle origini del conflitto mondiale. Vediamo bene come ognuno dei due gruppi fosse schierato a difesa della propria “patria”. La soluzione del problema venne demandata a una apposita commissione che avrebbe avuto il compito di studiare il problema. Risolto infine con l’approvazione di una generica mozione in cui si proponeva di lottare contro i governi “militaristi e conservatori”. Quindi ancora una volta adesione alle “guerre di difesa” contro gli Stati “militaristi”, cioè, gli altri.
L’unica cosa degna di nota di questo congresso, per noi comunisti, fu che il giorno 3 agosto sui muri della città venne affisso il seguente manifesto:
«Compagni operai! Sotto il titolo di Congresso della Seconda Internazionale, ha luogo nella nostra città una riunione dei principali sabotatori del movimento operaio. State in guardia contro gli uomini che compongono quel congresso, essi sono responsabili del sangue versato nell’ultima guerra, perché tutti hanno votato nei loro Parlamenti i crediti di guerra e hanno incoraggiato i Governi borghesi nell’opera criminale. Compagni, non dimenticate coloro che vi hanno traditi!».
Il giorno successivo i locali in cui si svolgeva il congresso erano occupati dagli operai che dalle tribune interrompevano: «Viva Lenin! Viva la Terza Internazionale! Viva Liebknecht! Abbasso Scheidemann assassino..!».
Sull’“Avanti!”, edizione milanese dell’8 agosto 1920, leggiamo: «Il comp. Brunner, segretario dei metallurgici ginevrini, redattore della “Nouvelle Internationale” organo dei comunisti della Svizzera francese, prese la parola e dalla tribuna fece il processo alla Seconda Internazionale che non fece nulla né per impedire la guerra, né per stroncarla. Denunciò Scheidemann come l’assassino di Liebknecht, di Rosa Luxemburg e degli operai della Ruhr; terminò dicendo che la Seconda Internazionale è morta e che il proletariato mondiale è per la Terza. Il Congresso, sorpreso, lo lasciò parlare, e le tribune gli fecero coro gridando: “Viva Mosca! Viva Lenin”. [...] In seguito alla irritazione popolare verso i traditori del proletariato, oggi la sala del Congresso è custodita dalla polizia. I “rivoluzionari” dell’Internazionale gialla si radunano e discutono sotto la protezione dei gendarmi, chiamati a salvarli dalla giusta collera del popolo da essi venduto al capitalismo sfruttatore ed al militarismo assassino».
Ancora più ignobile fu la formazione della Internazionale di Vienna. Dopo una conferenza preparatoria tenutasi a Berna, su iniziativa principalmente dell´austriaco Federico Adler, che ne diventerà il capo, venne fondata a Vienna nel febbraio 1921 l´Unione dei Partiti Socialisti per l’Azione Internazionale (IASP), chiamata anche, in modo spregiativo “Internazionale senza numero” o “Internazionale due e mezzo”, in quanto pretendeva di collocarsi politicamente tra la Seconda e la Terza.
I delegati presenti erano pochi e ancor peggio assortiti: del Partito Socialista Svizzero, che si era dato una veste di sinistra, dei controrivoluzionari menscevichi russi, della socialdemocrazia austriaca, di quella francese espulsa a Tours, degli indipendenti di destra tedeschi, dell’Independent Labour Party inglese e di altri partiti o gruppi sconosciuti fino al Poale Zion, il partito socialista sionista. Tra i personaggi individuati a questo congresso spiccavano Renaudel, Longuet, Kautsky, Hilferding, Grimm, Grumbach, Martoff, etc., etc. ...
Questo eterogeneo gruppo di politicanti «su un punto, certo, si sono trovati tutti d’accordo, nell’inveire contro la tirannia e la violenza del regime soviettista russo e sulla difesa della libera “forma democratica” che contava, pour cause, tra i delegati molti ferventi apologisti» (“Il Comunista”, 10 marzo 1921). Non ci fu intervento che non lanciasse accuse contro lo Stato sovietico, la III Internazionale, il comunismo. «Per i convenuti a Vienna dunque il nemico immediato non è la società borghese, ma... la Russia dei Soviet. Questo è il grande ammaestramento per il proletariato che emerge da tutta la discussione» (“L’Ordine Nuovo”, 1 marzo 1921).
Gli svizzeri azzardarono una timida protesta contro la presenza di Renaudel e di altri troppo sfacciatamente social-sciovinisti, ma immediatamente Adler e Longuet ne presero le difese. Non mancarono calorosi applausi del congresso quando Adler espresse pubblica lode al coraggioso atteggiamento dei deputati serbi durante la guerra, ma si dimenticò di dire una parola sulla condotta della socialdemocrazia austriaca. Anzi, la disse: «Non vogliamo parlare dell’intermezzo corso dal 1914 ad oggi». Come si dice, era acqua passata! Infatti la Conferenza di Vienna, malgrado vi partecipassero con tutti gli onori taluni dei maggiori responsabili del tradimento socialpatriottico del 1914, decise per il 13 marzo una manifestazione internazionale “contro i pericoli di nuove guerre”.
Avrebbe potuto mai il Partito Socialista Italiano astenersi dall’esaltare una simile impresa “rivoluzionaria”? Infatti l’“Avanti!” di quello stesso giorno, sotto il titolo “Contro la guerra”, scriveva: «I partiti socialisti di Francia, d’Austria, di Svizzera, che si trovano sul terreno della lotta di classe, hanno deciso che la giornata di oggi, 13 marzo, sia dedicata a dimostrazioni popolari contro i nuovi pericoli di guerre [...] Contro la mentalità di conquiste e di rapine che è propria dei Governi insorgono oggi a Parigi, a Vienna, a Berna le turbe assetate di pace e di lavoro [...] Noi che teniamo ad onore nostro l’essere stati fra i primi assertori della volontà proletaria di pace, fra i primi avversari della guerra imperialistica, associamo oggi la nostra voce a quella dei compagni d’ogni paese imprecanti al militarismo e denuncianti gli intrighi dei Governi che preparano altri conflitti».
Più aperta confessione il Partito Socialista Italiano non avrebbe potuto fare: i suoi pari erano quei partiti riuniti a Vienna con la dichiarata intenzione di sabotare la III Internazionale. I partiti ai cui vertici sedevano gli ex collaborazionisti e ministri di guerra, per il PSI, si trovavano sul “terreno della lotta di classe”.
Il PSI non cessava di ostentare la sua passata opposizione alla guerra. Però,
puntualizzava il nostro giornale, «la opposizione alla guerra, quando non è
portata alle logiche conseguenze cui la porta la dottrina e la tattica
comunista, diviene un argomento specifico dell’opportunismo centrista che vuol
ingenerare la confusione tra i termini inconciliabili dell’indirizzo comunista e
di quello socialdemocratico» (“Il Comunista”, 17 marzo 1921). Quale “opposizione
alla guerra” poteva vantare il PSI se non la traditrice affermazione lazzariana
del “Non aderire né sabotare”, forse peggiore della turatiana “la nostra Patria
è sul Grappa”?
Le Tesi al Terzo Congresso
Riprendiamo però il filo dei due veri Congressi rivoluzionari svoltisi in contemporanea a Mosca.
Molti dei delegati parteciparono ad entrambi. Per esempio, il 3 luglio il congresso dell’IC iniziava i suoi lavori sulla questione sindacale alle 2 del pomeriggio e lo stesso giorno, alle 8 di sera, il congresso dell’ISR apriva i suoi lavori.
Le questioni sindacali più importanti trattate dal III Congresso dell’IC furono: 1) la lotta contro l’Internazionale gialla di Amsterdam; 2) i rapporti tra l’Internazionale Comunista e l’Internazionale Sindacale Rossa.
Prima di iniziare a parlare della costituzione dell’Internazionale Sindacale è necessario soffermarci sul documento concernente “L’Internazionale Comunista e l’Internazionale Sindacale Rossa” approvato il 12 luglio 1921 (24° seduta).
Il documento era costituito da “Tesi”, suddivise in 5 punti, e da un “Programma d’azione” proposto dal Komintern per l’Internazionale Sindacale Rossa.
La tesi n. 1 parte dall’affermazione che la borghesia tiene la classe operaia nella schiavitù non solo con la forza bruta, ma anche per mezzo di tutti gli altri inganni che ogni regime capitalistico adotta in sua difesa. Uno di questi consiste nella rivendicazione della neutralità dei sindacati, del loro apoliticismo, della loro non adesione a partiti. Ma «allorché cominciò la carneficina imperialista, i vecchi dirigenti dei sindacati si videro costretti a lasciar cadere la maschera della neutralità e a mettersi apertamente dalla parte della “propria” borghesia [...] Finita la guerra imperialista, gli stessi dirigenti socialdemocratici e dei sindacati tentano di riprendere la maschera dell’apoliticismo e della neutralità sindacale». Al contrario, nella lotta tra lavoro e capitale nessuna organizzazione di massa del proletariato può rimanere neutrale. «La borghesia non può invitare apertamente i sindacati operai ad appoggiare i partiti borghesi; e quindi li invita a non appoggiare alcun partito, intendendo in realtà con ciò, che i sindacati non debbono appoggiare il partito del comunismo [...] Quei sindacati che si mantengono apolitici e neutrali [...] appoggiano in realtà i partiti della borghesia e della piccola borghesia.»
La tesi n. 2 afferma: «L’Unione sindacale internazionale di Amsterdam è l’organizzazione in cui le Internazionali due e due e mezzo si sono incontrate e si sono date la mano. Tutta la borghesia internazionale guarda fiduciosa e rassicurata a questa organizzazione. L’idea centrale dell’Internazionale sindacale di Amsterdam è quella della neutralità dei sindacati [...] Sotto la bandiera della neutralità l’Internazionale sindacale di Amsterdam accetta dalla borghesia gli incarichi più gravi e più sporchi [...] L’elaborazione di congrui metodi di lotta contro l’Internazionale sindacale di Amsterdam dev’essere perciò preceduta da una precisa e chiara definizione dei reciproci rapporti fra partito e sindacati in ogni singolo paese».
La tesi n. 3 precisa la differenza tra partito e sindacato. «Il Partito comunista rappresenta la parte più avanzata del proletariato, quella avanguardia, che ha riconosciuto pienamente le vie e i mezzi atti a liberare il proletariato dal giogo capitalistico, e quindi ha accettato coscientemente il programma comunista. I sindacati invece sono piuttosto un’organizzazione di massa del proletariato, che tende ad abbracciare tutti gli operai di un dato ramo d’industria, e alla quale non appartengono soltanto i comunisti coscienti, ma anche gli strati medi e perfino gli strati più arretrati del proletariato, i quali si avvicinano al comunismo gradualmente, indotti dall’esperienza della vita [...]
Tanto prima della conquista del potere quanto durante e dopo di essa, i sindacati costituiscono una organizzazione più ampia che non il Partito, estesa a più grandi masse, più generale, e debbono stare di fronte al Partito, in certo qual modo nel rapporto della periferia col centro [...] Nel corso di tutte queste tre fasi della lotta i sindacati devono sostenere l’avanguardia proletaria, il Partito comunista, che dirige la lotta del proletariato in tutte le sue tappe. A tal fine i comunisti e gli elementi simpatizzanti con essi devono organizzare in seno ai sindacati i loro gruppi comunisti, che sono completamente subordinati al Partito comunista.
«Il fatto che [...] considerevoli schiere di operai poco provati e politicamente non abbastanza esperti, che non si attendono più alcun vantaggio immediato dall’adesione ai sindacati liberi, vadano negli ultimi tempi abbandonando i sindacati liberi socialdemocratici, non deve in nessun caso mutare la posizione di principio dell’Internazionale Comunista nei riguardi della partecipazione dei comunisti al movimento sindacale. Ai comunisti spetta il compito di chiarire ai proletari che la salvezza non consiste nell’abbandonare i vecchi sindacati e nel rimanere fuori di ogni organizzazione, ma invece nel rivoluzionare i sindacati, scacciandone da essi lo spirito del riformismo e i traditori dirigenti riformisti, e trasformando così i sindacati in un reale sostegno del proletariato rivoluzionario».
La tesi n. 4 stabilisce che il compito principale dei comunisti è di lavorare con il massimo impegno nei sindacati al fine di conquistare la maggioranza degli operai alla causa del comunismo.
«L’influenza reale che un Partito comunista esercita sulle masse della classe operaia, nei sindacati, è il miglior indice della sua forza. Il Partito deve saper esercitare la sua influenza decisiva sui sindacati, senza volerli perciò mettere meschinamente sotto tutela. Al Partito è subordinato soltanto il gruppo comunista nel sindacato, e non il sindacato come tale. Solo mediante il lavoro costante, disinteressato e intelligente dei gruppi comunisti nei sindacati, il Partito può e deve raggiungere uno stato di cose tale che i sindacati nella loro totalità seguano con entusiasmo e prontezza i consigli del Partito».
La tesi prende poi in esame i sindacati dei vari paesi mostrandone, succintamente, pregi e difetti e termina con questa chiara affermazione: «Ai fautori della parola d’ordine “fuori dai sindacati” non si deve fare alcuna concessione, perché ciò significherebbe soltanto portar l’acqua al mulino dei socialpatrioti. Ai tentativi di espellere i comunisti bisogna contrapporre una lotta tenace e indefessa, e la tensione di tutte le forze per conquistare la maggioranza dei sindacati».
La tesi n. 5 afferma: «Queste considerazioni valgono anche a fissare i rapporti che devono intercorrere fra l’Internazionale Comunista da una parte e l’Internazionale Sindacale Rossa dall’altra [...] L’Internazionale Comunista deve ispirare e coordinare l’opera di tutte le organizzazioni proletarie, sia di quelle prettamente politiche, sia di quelle sindacali, cooperative, soviettiste e culturali.
«Il Consiglio Internazionale dei Sindacati, a differenza dell’Internazionale gialla, non può assolutamente mettersi sulla piattaforma dell’apoliticismo e della neutralità.
«Un’organizzazione che volesse rimanere neutrale di fronte alla II Internazionale, a quella due e mezzo, e alla III, diverrebbe inevitabilmente un fantoccio nelle mani della borghesia [...] I pregiudizi sulla neutralità, sulla “indipendenza”, sull’apoliticismo e sulla non adesione ad alcun Partito, di cui sono affetti anche taluni onesti sindacalisti rivoluzionari [...] sono obbiettivamente null’altro che un tributo pagato all’ideologia borghese. I sindacati rossi non possono vincere l’Internazionale gialla di Amsterdam, e per conseguenza neppure il capitalismo, se essi non si sbarazzano una volta per sempre dell’idea borghese dell’indipendenza e della neutralità».
La tesi terminava affermando che la «situazione ideale» sarebbe stata «la formazione di una Internazionale unica, che riunisse nelle sue file tanto i partiti politici, quanto le altre forme dell’organizzazione operaia [...] Ma nell’attuale periodo di transizione, data la varietà multiforme e variopinta dei sindacati nei diversi paesi, è assolutamente necessario creare un’Unione internazionale indipendente dei sindacati rossi, che in linea di massima si trovano sulla piattaforma dell’Internazionale Comunista, ma che accettano i loro membri con maggiore libertà di quanto non sia regola nell’Internazionale comunista».
Ed infine: «Il III Congresso dell’Internazionale Comunista promette il suo
appoggio all’Internazionale Sindacale Rossa, da organizzarsi su questa base, e
per raggiungere un più stretto collegamento fra l’Internazionale Comunista e
l’Internazionale dei Sindacati Rossi, il III Congresso dell’Internazionale
Comunista propone che essa sia rappresentata da tre membri nell’Esecutivo
dell’Internazionale Sindacale Rossa e viceversa».
Il Programma di Azione
Di seguito riportiamo quelle che ci sembrano le parti più importanti del “Programma d’azione” proposto dall’Internazionale Comunista per quella sindacale. Naturalmente la cosa migliore sarebbe riproporre il documento per intero, anche perché nelle riduzioni non è assolutamente garantito che vengano sempre riportate le parti più significative, comunque noi faremo del nostro meglio. Il documento si articola su 18 punti.
1. « [...] La politica aggressiva della borghesia contro la classe operaia, gli ostinati tentativi di ridurre i salari e i conati di far retrocedere di decenni gli operai nel loro sviluppo, la crescente esasperazione delle masse che ne consegue da una parte, e l’impotenza dei sindacati coi loro vecchi metodi dall’altra, pongono i sindacati rivoluzionari di tutto il mondo dinanzi a nuovi compiti [...] Occorre una politica economica aggressiva da parte dei sindacati per respingere l’offensiva del capitale, e quindi, una volta consolidate le vecchie posizioni, passare all’attacco».
2. «La base della tattica sindacale è costituita dall’azione diretta delle masse rivoluzionarie e delle loro organizzazioni contro il capitale [...] Il compito dei sindacati rivoluzionari è dunque quello di fare dell’azione diretta uno strumento di educazione e di preparazione delle masse operaie alla lotta per la rivoluzione sociale e per la dittatura del proletariato».
3. «[...] Il punto di partenza di una lotta non attenuata deve essere il passaggio dall’organizzazione prettamente per mestiere all’organizzazione dei sindacati per rami di industria. “In ogni azienda un solo sindacato” tale deve essere la parola d’ordine nel campo del lavoro di organizzazione. La fusione dei sindacati affini in una sola federazione deve avvenire in via rivoluzionaria, presentando tale questione direttamente ai membri dei sindacati nelle fabbriche e nelle aziende, e in seguito nelle conferenze distrettuali e provinciali e nei congressi nazionali».
4. «Ogni fabbrica ed ogni azienda deve diventare un baluardo, una fortezza della rivoluzione.
«La vecchia forma dei rapporti fra i semplici membri del sindacato e i funzionari [...] deve venir sostituita dai Consigli di fabbrica. I Consigli di fabbrica devono venire eletti da tutti gli operai di una data azienda, indipendentemente dalla loro fede politica. Il compito degli aderenti all’Internazionale Sindacala Rossa è di chiamare tutti gli operai di una data azienda a prender parte alle elezioni del loro organo rappresentativo. Va categoricamente condannato ogni tentativo di limitare il diritto di voto nelle elezioni dei Consigli di fabbrica ai soli comunisti, di fondare questi organi esclusivamente su base di partito, e di escludere la grande massa dei senza-partito dalle elezioni. In questo modo si formerebbero dei gruppi, ma non dei Consigli di fabbrica e di azienda».
5. «Il primo compito che incombe ai Consigli di fabbrica e di azienda, è quello di esigere che [...] l’imprenditore [sia] obbligato a corrispondere al disoccupato l’intero salario. Su questa piattaforma devono venire organizzati non i disoccupati, ma soprattutto gli operai delle varie aziende, spiegando loro che il problema della disoccupazione non può venir risolto nei quadri dell’ordinamento capitalista, e che il miglior mezzo contro la disoccupazione è la rivoluzione sociale, la dittatura del proletariato».
6. «La chiusura degli stabilimenti e la riduzione delle giornate di lavoro sono attualmente i mezzi principali nelle mani della borghesia coi quali essa costringe gli operai a subire la riduzione dei salari, il prolungamento degli orari e l’abolizione del contratto collettivo [...] Bisogna perciò combattere contro la chiusura degli stabilimenti [...] Devono venir costituite speciali Commissioni di controllo, alle quali spetta il controllo sulle materie prime, i combustibili, le ordinazioni; esse compiono inoltre la revisione delle scorte di materie prime esistenti e necessarie per la produzione, ed esercitano il controllo sulle riserve finanziarie depositate nelle banche».
7. «Uno dei mezzi di lotta contro la serrata generale degli stabilimenti [...] è l’occupazione delle fabbriche e delle aziende da parte degli operai, è la continuazione della produzione contro la volontà degli imprenditori».
8. « [...] Tutti i tentativi di ridurre le condizioni di lavoro al livello dell’anteguerra devono essere combattuti in modo risoluto e rivoluzionario [...] I sindacati rivoluzionari devono considerare i problemi dei salari e del miglioramento delle condizioni di lavoro non già dal punto di vista della concorrenza fra gli elementi rapaci delle diverse nazioni, ma dal punto di vista del sostentamento e della tutela della forza-lavoro».
9. «Nel caso in cui i capitalisti usino la tattica della riduzione dei salari [...] impedire che la riduzione dei salari avvenga in un’industria dopo l’altra, cioè non lasciarsi dividere in diversi gruppi [...] Sarà necessario e congruo l’impiego di tutte le forme di resistenza, cominciando dagli scioperi parziali e isolati fino allo sciopero generale di qualche importante ramo di produzione, impostato su scala nazionale».
10. «I sindacati devono affrontare praticamente il problema della preparazione ed organizzazione di scioperi internazionali comprendenti una data industria. La sospensione della produzione carbonifera o l’interruzione dei trasporti su scala internazionale sono mezzi di lotta importanti contro i complotti reazionari della borghesia di tutti i paesi [...] Senza dimenticare un solo momento che l’offensiva su scala internazionale di qualunque forma essa sia potrà aver luogo solo quando si saranno formati sindacati realmente rivoluzionari e internazionali, che non abbiano nulla di comune con l’Internazionale di Amsterdam».
11. «La credenza nel valore assoluto dei contratti collettivi, diffusa dagli opportunisti di tutti i paesi, deve essere decisamente respinta dal movimento sindacale rivoluzionario. Il contratto collettivo è null’altro che una tregua d’armi [...] I sindacati rivoluzionari non devono ripudiare il contratto collettivo, ma devono riconoscere la relatività del suo valore, e tener sempre presenti i problemi intorno al metodo di infrangere questi contratti, qualora l’interesse della classe operaia dovesse richiederlo».
12. «La lotta delle organizzazioni operaie contro gli imprenditori individuali e collettivi deve avvalersi, tenendo conto delle condizioni nazionali e locali, di tutta l’esperienza della lotta di emancipazione della classe lavoratrice. Quindi ogni grande sciopero deve essere non solo ben preparato dagli operai, ma è pure necessario organizzare fin dal suo inizio quadri speciali per la lotta contro il crumiraggio e per la resistenza contro le varie provocazioni delle guardie bianche, appoggiate dai Governi borghesi [...] In tali condizioni diventa questione vitale l’organizzazione di speciali reparti armati a difesa dello sciopero e delle persone».
13. «Queste nuove organizzazioni di combattimento non devono limitarsi a respingere gli attacchi degli imprenditori e delle organizzazioni crumiresche, ma devono anche prendere l’iniziativa di trattenere tutte le materie e merci destinate alla rispettiva fabbrica, e di impedire l’esportazione dei prodotti in altre fabbriche ed aziende [...] ».
14. «L’intera lotta economica della classe operaia nel prossimo avvenire deve concentrarsi sulla parola d’ordine del Partito: “controllo operaio sulla produzione” [...] I sindacati rivoluzionari devono combattere con grande risolutezza le illusioni e le furfanterie dei dirigenti dei vecchi sindacati [...]. Tutte le chiacchiere di questi signori su una socializzazione pacifica, non tendono ad altro che a trattenere gli operai dall’azione rivoluzionaria e ad allontanarli dalla rivoluzione sociale».
15. «Per distogliere l’attenzione degli operai dai loro compiti immediati e alimentare tra di loro tendenze piccolo-borghesi si fa propaganda dell’idea della partecipazione dei lavoratori agli utili, cioè della restituzione di una parte insignificante del plusvalore da loro prodotto. Questa parola d’ordine demoralizzante deve essere sottoposta ad una aspra e spietata critica. (Non partecipazione ai profitti, ma “soppressione del profitto capitalistico”, tale deve essere la parola d’ordine dei sindacati rivoluzionari)».
16. «Per paralizzare o spezzare la forza combattiva della classe operaia, col pretesto della difesa delle industrie vitali, gli Stati borghesi sono ricorsi alla militarizzazione temporanea di singole aziende e di interi rami d’industria [...] Istituirono a difesa del capitale tribunali arbitrali obbligatori o commissioni arbitrali [...] Si introdusse [...] il sistema della esazione delle imposte mediante trattenute sui salari, esercitando così l’imprenditore la funzione di esattore fiscale. Contro questi provvedimenti statali, attuati nell’esclusivo interesse della classe capitalistica, i sindacati devono impegnare la più aspra lotta».
17. « [...] I sindacati rivoluzionari devono strappare passo per passo concessioni alle classi dominanti, costringendole ad attuare una legislazione socialista, ma nello stesso tempo rendere chiaro alle masse operaie che la questione sociale non può venir risolta che con la soppressione del capitalismo e l’istituzione della dittatura del proletariato [...] I sindacati rivoluzionari devono generalizzare questi conflitti e portare le masse operaie alla comprensione della necessità ed ineluttabilità della rivoluzione sociale e della dittatura del proletariato».
18. «La lotta economica è nello stesso tempo una lotta politica, vale a dire una
generale lotta di classe. Questa lotta, anche quando coinvolga i più larghi
strati proletari di un paese, non potrà essere condotta in modo realmente
rivoluzionario e col maggiore beneficio possibile per la classe operaia nella
sua totalità, se non a condizione che i sindacati rivoluzionari procedano nella
più stretta unione e comunanza di lavoro col Partito comunista del proprio paese
[...] Azioni parziali del Partito comunista o dei sindacati rivoluzionari rossi
sono a priori destinate al fallimento e alla sconfitta. Pertanto l’unità
d’azione e l’unione organica del Partito comunista coi sindacati sono condizione
indispensabile per il successo nella lotta contro il capitalismo».
Il convergere del movimento politico e di quello immediato della classe operaia
Per l’Internazionale Comunista le due organizzazioni, politica e sindacale, seppure distinte, avrebbero dovuto essere strettamente legate. Ma questa posizione sarebbe stata accettata dai non comunisti? «Esistono in merito parecchie opinioni e parecchie tendenze che si combatteranno al prossimo Congresso», aveva preannunciato Lozovski. «Per me è chiaro che queste due Internazionali diversamente organizzate, diverse per i loro regolamenti e per le loro condizioni di reclutamento, si completano reciprocamente e ogni tentativo di separarle condurrebbe ai più deprecabili risultati».
Ma nelle Tesi non può sfuggire la contraddizione di fondo: prospettare una unica internazionale “comunista” che accolga, contemporaneamente, partiti e sindacati. Infatti, mentre giustamente si pretende che i partiti aderenti all’Internazionale siano comunisti, lo stesso non può essere richiesto ai sindacati, a meno che non si vogliano creare sindacati comunisti, scissionisti. È la stessa Tesi 4 ad affermare che «soltanto i gruppi comunisti dei sindacati sono subordinati al partito, non già i sindacati in quanto tali».
Invece la dizione “sindacati rivoluzionari” va inquadrata nella situazione concreta. Noi parliamo in genere di “sindacati di classe”, organi difensivi immediati emananti dalla classe operaia e sua espressione. Solo in epoca rivoluzionaria, come quella in Russia di allora 1921, e si sperava in occidente, i sindacati divengono, possono e debbono divenire, di fatto rivoluzionari. Questo pur non perdendo il loro carattere specifico di sindacati, aperti a tutti i lavoratori, per la loro difesa immediata, indipendentemente dalla loro fede politica, religiosa, ecc.
Nell’erompere del corso rivoluzionario tutti gli organi della classe, soviet, sindacati, cooperative, organizzazioni proletarie femminili, giovanili, sportive, culturali, professionali, ecc. mettono a disposizione della rivoluzione lo slancio dei loro uomini e delle loro capacità, nelle funzioni di Stato, economiche, tecniche, educative, organizzative, e financo commerciali in un primo periodo. Ma in una situazione rivoluzionaria, in quanto cioè accettano “con entusiasmo e prontezza” (Tesi 4) la direzione esclusiva del partito comunista.
Anche il rigetto della “idea borghese dell’indipendenza e della neutralità” (Tesi 5) è proprio del partito marxista, non del sindacato, per quanto di classe, “rosso”, sia. Impossibile farlo accettare a dei sindacalrivoluzionari, di matrice anarchica. La fondazione della Internazionale Sindacale veniva quindi a coincidere in occidente con la lotta dei comunisti per scalzare e cacciare le dirigenze opportuniste dei vari sindacati.
Difficile quindi allora fra le due Internazionali, separate e “autonome”, stabilire uno stretto legame costituito da una rappresentanza permanente di tre membri dell’Internazionale comunista nel C.E. del Profintern e viceversa.
E di fatto la costituzione di una Internazionale Sindacale Rossa presentò
problemi e difficoltà molto superiori a quelli affrontati dall’Internazionale
politica. Problemi che si sarebbero potuti chiarire e risolvere solo nel fuoco e
nella pratica della lotta rivoluzionaria, se questa avesse dato i frutti
sperati. Ma la situazione in occidente non era rivoluzionaria. Sconfitta la
rivoluzione ogni suo organo ne seguì il destino.
Conferenze preparatorie degli anti‑comunisti
Grosso modo i partecipanti potevano essere considerati come appartenenti principalmente a due gruppi: da una parte i comunisti che, ad eccezione dei russi, rappresentavano delle minoranze rivoluzionarie all’interno dei sindacati riformisti; dall’altra i sindacalisti rivoluzionari e gli anarchici di varie tendenze. Questi negavano la funzione del partito e la necessità della dittatura del proletariato prospettando, dopo la rivoluzione, l’assunzione immediata del controllo della produzione da parte dei sindacati. E una parte di questi erano perfino giunti a boicottare il Congresso sindacale di Mosca. Poi vi erano i comunisti tedeschi, delegati delle “Unioni”, e i rappresentanti italiani della CGL che dichiararono di partecipare come semplici “osservatori”. Dell’indegno comportamento dei bonzi italiani tratteremo a parte.
Gli anarco-sindacalisti avevano già tenuto una conferenza internazionale a Berlino (dal 16 al 21 dicembre 1920) dove avevano stabilito di partecipare al congresso costitutivo del Profintern, ma alla sola condizione che la nuova Internazionale sindacale godesse di piena autonomia rispetto ai partiti politici e all’I.C.
Questo il preciso mandato ricevuto dalla delegazione sindacalista-rivoluzionaria francese: «1) Appoggiare la rivendicazione che il congresso dell’Internazionale dei sindacati sia e rimanga indipendente dall’Internazionale Comunista. 2) Far riconoscere l’indipendenza e l’autonomia del movimento sindacale in ogni paese, e soprattutto mantenere l’inviolabilità dell’autonomia del sindacalismo francese, le cui forme e i cui principi servono da punto di partenza alla futura rivoluzione sociale. 3) Radiare dallo Statuto l’articolo relativo alla rappresentanza reciproca delle due internazionali, comunista e sindacale, tramite i rispettivi comitati esecutivi [spiegazione del “giallo” sulla differenza tra il testo in francese e quello nelle altre lingue, ndr]. 4) Qualunque siano le decisioni del Congresso, la delegazione francese non deve associarvisi; essa deve prenderne conoscenza e riferirne al Comitato centrale, che metterà la questione in discussione in tutte le organizzazioni. Un congresso speciale delibererà successivamente sull’adesione».
Gli anarco-sindacalisti francesi dichiararono di attenersi ai principi della carta di Amiens, del 1906: «La Cgt raggruppa, al di là di ogni scuola politica, tutti i lavoratori coscienti della necessità di lottare per la scomparsa dei salariati e del padronato [...] L’accrescimento del benessere dei lavoratori mediante la realizzazione di miglioramenti immediati, quali la riduzione delle ore di lavoro, l’aumento dei salari, ecc.[...] è solo un aspetto della pratica del sindacalismo, il quale prepara l’emancipazione integrale che si può realizzare solo mediante l’espropriazione dei capitalisti, preconizza lo sciopero generale come mezzo d’azione, e ritiene che il sindacato, oggi organismo di resistenza, sarà, in futuro, il raggruppamento responsabile della produzione e della distribuzione, base della riorganizzazione sociale [...] La condizione [...] che pesa sulla classe operaia [...] rende doverosa per tutti i lavoratori, quali che siano le loro opinioni o le loro tendenze politiche o filosofiche, l’appartenenza al raggruppamento essenziale costituito dal sindacato. Di conseguenza, per quanto riguarda gli individui, il Congresso afferma che, fuori dal raggruppamento corporativo, gli iscritti al sindacato sono totalmente liberi di partecipare alle forme di lotta corrispondenti alle loro concezioni filosofiche o politiche e si limita a esigere, in cambio, che non vengano introdotte nel sindacato le opinioni professate all’esterno».
Vi si stabilisce la completa indipendenza del sindacato dai partiti. Gli iscritti erano liberi, a livello individuale, di aderire a dei partiti politici, ma a condizione di non introdurre nel sindacato le opinioni politiche professate all’esterno. Come abbiamo più volte affermato, negando la funzione del partito, il sindacalismo rivoluzionario si comportava come un vero e proprio partito.
Oltre agli anarco-sindacalisti anche i comunisti di sinistra tedeschi, delegati
delle “Unioni”, reclamarono la completa indipendenza dell’Internazionale
sindacale da quella politica.
Il congresso
Come abbiamo detto i lavori del congresso sindacale internazionale cominciarono il 3 luglio con la partecipazione di 380 delegati (di cui 336 con diritto di voto) provenienti da 41 paesi in rappresentanza di 11 milioni di iscritti.
Lozovski, in una intervista al “Moscou” riportata dall’”Ordine Nuovo” del 4 luglio 1921 aveva affermato che il primo congresso dell’Internazionale Sindacale Rossa avrebbe avuto lo stesso carattere di orientamento generale di quello avuto dal II Congresso dell’Internazionale Comunista per il movimento politico, dovendo elaborare una comune linea di condotta per tutti i sindacati “rivoluzionari”. Precisava però che tale compito non sarebbe stato semplice, ma senz’altro più gravoso di quello avuto dal II Congresso dell’I.C. poiché «quest’ultima raggruppa solamente l’avanguardia del proletariato. I Sindacati raggruppano [anche] le masse senza partito. Ciò che è già chiaro e non ha più bisogno di essere provato per l’avanguardia deve essere ancora chiarito per i vasti ranghi del grande esercito sindacale».
L’Internazionale sindacale non avrebbe potuto limitarsi a raggruppare quanti si opponevano ad Amsterdam, ma avrebbe dovuto elaborare una tattica comune. Il difficile stava proprio in questo. È vero che vi aderivano soltanto quelle organizzazioni che riconoscevano la necessità “della lotta rivoluzionaria”, però ognuna la intendeva in modo ben diverso, con metodi di lotta e tattiche differenti.
Su questo problema sembrava però che, nel corso dell’anno, le cose avrebbero
potuto chiarirsi. Infatti Lozovski affermava: «Il controllo della produzione non
può essere realizzato che dopo il trionfo della rivoluzione. Tutti i progetti
presentati oggi dai riformisti di ogni specie non valgono un solo momento di
attenzione, poiché il controllo operaio non è una questione di diritto, ma di
forza» (ivi).
Il deliberato
Riportiamo qui il testo della “Deliberazione sui rapporti tra l’Internazionale dei Sindacati Rossi e l’Internazionale Comunista”, relatori i compagni Rosmer e Tom Mann, così come su “L’Ordine Nuovo”:
«Considerato
«che la lotta fra capitale e lavoro, in conseguenza della guerra mondiale e della crisi mondiale, ha assunto in tutte le nazioni capitalistiche carattere particolarmente acuto, aspro e deciso; che nello svolgimento di questa lotta le vaste masse lavoratrici si rendono conto in modo sempre più chiaro della necessità di escludere la borghesia dalla gestione della produzione, e di conseguenza dal potere politico;
«che un tale risultato può esser raggiunto solamente con l’instaurazione della dittatura proletaria e della società comunista;
«che nella lotta per la conservazione della dittatura borghese tutti gli elementi capitalistici hanno già raggiunto una considerevole concentrazione o fusione delle loro organizzazioni nazionali e internazionali, sia politiche, sia economiche, e oppongono all’assalto del proletariato la forza compatta della borghesia, così nella difensiva come nell’offensiva;
«che la logica della odierna lotta di classe richiede una saldissima unione delle forze proletarie, determinando con ciò la necessità di uno stretto contatto e di un legame organico tra i vari aspetti del movimento operaio rivoluzionario, e in prima linea fra l’Internazionale Comunista e il Consiglio Internazionale dei Sindacati Rossi, per cui appare oltremodo desiderabile che si faccia tutto il possibile per creare nei singoli paesi rapporti analoghi fra i Partiti Comunisti locali e i Sindacati rossi,
«tenendo conto di quanto qui esposto, il Congresso delibera di:
«1° - prendere tutte le misure per la più intensa fusione dei Sindacati rivoluzionari in un’unica organizzazione di lotta con un unico centro direttivo: l’Internazionale dei Sindacati Rossi;
«2° - stabilire le più strette relazioni con la III Internazionale comunista, avanguardia del movimento operaio in tutto il mondo, in base a una reciproca rappresentanza negli organi esecutivi di ambedue le Internazionali, mediante conferenze in comune, ecc.;
«3° - dare a questo legame un carattere organico e fattivo, esplicandolo con la preparazione e l’attuazione in comune delle azioni rivoluzionarie, tanto sul terreno nazionale quanto su quello internazionale;
«4° - Il Congresso insiste pure sulle necessità di tendere allo stabilimento di una vera e stretta unità delle organizzazioni sindacali rivoluzionarie, e di stretti e reali legami fra i Sindacati rossi e il Partito comunista, per l’applicazione delle direttive di ambedue i Congressi.
«Fra un anno resterà della Internazionale di Amsterdam presso a poco quanto
resta oggi della II Internazionale».
La relazione finale
Da quanto sommariamente detto si deduce che le questioni che il congresso dovette affrontare furono molteplici, e soprattutto molto complicate: le condizioni di ammissione dei sindacati, i diritti e i doveri, la cassa dell’organizzazione e il fondo internazionale per gli scioperi, centralismo o federalismo, il collegamento con i movimenti operai delle colonie, etc.
All’indomani del I Congresso Lozovski relazionava:
«Il primo Congresso internazionale dei Sindacati rivoluzionari ha completamente assolto questo compito di fondere le disunite forze rivoluzionarie, di creare un’unica direttiva e una base unica per la salda organizzazione dei sindacati rivoluzionari di classe.
«[...Il Congresso] dopo lunghe e febbrili discussioni, dopo lotte e concessioni reciproche, ha trovato la sua forma definitiva [...]
«La deliberazione decisiva per tutto il programma del movimento sindacale internazionale è senza dubbio quella riguardante i rapporti tra l’Internazionale Comunista e l’Internazionale dei Sindacati Rossi [...] Su questa questione la decisione approvata, mentre stabilisce l’indipendenza dell’Internazionale dei Sindacati rossi nei rapporti organizzativi, insiste però nella necessità assoluta, nella lotta, di unità d’azione e di stretta collaborazione con l’Internazionale Comunista. Il Congresso motiva tale concezione con il fatto che la borghesia a sua volta ha proceduto a un concentramento di forze, avendo essa già da un pezzo coordinato le sue organizzazioni politiche ed economiche per la lotta comune [...] Non solo la maggioranza del Congresso, ma anche la minoranza sindacalista rivoluzionaria, sostenitrice dell’indipendenza del movimento sindacale, [ha riconosciuto] la necessità di stabilire i più stretti rapporti con la III Internazionale Comunista, quale avanguardia in tutto il mondo del movimento operaio rivoluzionario. [Il Congresso] ha ritenuto che in ogni paese sia cosa desiderabile soprattutto l’attuazione di una connessione reale e pratica fra i Sindacati rossi ed il Partito Comunista.
«[Il Congresso ha precisato che il fine del movimento sindacale] è l’abbattimento del capitalismo, e l’instaurazione della dittatura del proletariato. Su questo punto si ebbe unanimità quasi completa, giacché nove decimi dei sindacalisti [...] si pronunciarono per la dittatura del proletariato, pure interpretandola a modo loro, cioè sindacalisticamente.
«[Al contrario] le discussioni si inasprirono quando fu sollevata la questione se fosse necessaria la distruzione, oppure la conquista dei vecchi sindacati. [I fautori della scissione dichiaravano] incompatibile la permanenza in essi dei veri rivoluzionari, [ritenendo che] si dovesse porre, come base della tattica rivoluzionaria la totale distruzione dei vecchi sindacati. [Il Congresso, invece, sentenziò] non distruzione, ma conquista dei sindacati.
«[... In] un apposito paragrafo sui “metodi di lotta” il Congresso richiama l’attenzione sulla necessità di una tattica flessibile [...] Si dice che non bisogna credere che l’offensiva sia sempre e in qualsiasi condizione il migliore modo d’agire [...]
«Il Congresso prestò particolare attenzione all’elaborazione di un programma d’azione perfettamente identico col programma d’azione deliberato dal III Congresso dell’Internazionale comunista. Questa piattaforma pratica deve diventare il grido di battaglia di ogni sindacato.
«[A questo primo Congresso dell’Internazionale sindacale rossa] erano rappresentate non solo organizzazioni intere, ma anche frazioni di esse. Ciò ha reso più difficile la soluzione del problema sulle modalità della organizzazione e circa l’elaborazione di un piano unico di organizzazione [...]
«Il Congresso ha fornito delle indicazioni intorno alle questioni fondamentali di struttura organizzativa, ha dato le parole d’ordine della costituzione dei sindacati di industria, della creazione dei consigli di fabbrica come base dei sindacati di industria; [della] questione della conquista dei vecchi sindacati; [della] creazione di federazioni dei sindacati espulsi [...]
«Oltre a queste questioni fondamentali, il Congresso ha pure attribuito grande importanza alla questione del controllo operaio [...]
«Tutte le altre deliberazioni prese dal Congresso come quelle intorno alla questione dei danneggiati di guerra, e dalla disoccupazione, alla questione della donna nell’industria e nei sindacati, ecc., si ispirano tutte a questo pensiero: il compito dei sindacati rivoluzionari sta nell’organizzare le masse sul terreno della lotta politica quotidiana, per prepararle così all’assalto finale contro il capitalismo [...]
«Occorre inoltre segnalare la risoluzione dedicata al movimento sindacale nell’Oriente e nell’estremo Oriente, nonché nelle colonie [...] In questi paesi il processo si presenta sotto un doppio aspetto: di un movimento rivoluzionario nazionalista, svolgendosi spesso sotto lo stimolo dell’odio di razza, e di un parallelo movimento proletario, diretto contro gli sfruttatori indigeni o forestieri che siano [...] Il Congresso ha insistito sull’urgente necessità di trasformare l’odio di razza mirando ad elevare la coscienza delle masse sfruttate fino alla concezione della lotta rivoluzionaria di classe ed alla rivoluzione sociale.
«[...] Il fatto che [...] si sia riusciti a radunare i rappresentanti di undici milioni di operai e a metterne d’accordo le vedute intorno ai compiti loro incombenti, a disporre organizzativamente le falangi combattive contro il capitalismo; questo fatto ha importanza eccezionale [...]
«All’Internazionale dei compromessi è ormai contrapposta l’Internazionale della lotta: all’Internazionale dell’inazione, l’Internazionale dell’assalto; all’Internazionale gialla di Amsterdam, l’Internazionale rossa.
«[...] I partecipanti al Congresso si son fatti delle reciproche concessioni, soltanto dopo laboriose e appassionate discussioni [...] tutti si sono accordati sulla piattaforma seguente: rivoluzione sociale, dittatura del proletariato, collaborazione stretta ed organica con l’Internazionale comunista» (da: “Deliberazioni, statuti, appelli del I congresso internazionale dei sindacati rossi”).
Il primo documento che pubblichiamo nell’Archivio sono le Tesi dell’Internazionale sulla Conferenza di Washington, elaborate nell’agosto del 1921 in vista dell’annunciata Conferenza che si sarebbe riunita a partire dal successivo novembre e avrebbe terminato i lavori il 6 febbraio del 1922.
Nel 1921, le potenze imperialiste, che avevano da poco terminato il massacro della guerra in Europa, furono spinte a riunirsi in conferenza a Washington per tentare di dirimere i loro contrasti, alimentati da un rapido e notevole riarmo navale e dalle loro brame per la spartizione e lo sfruttamento dell’Oriente. Appena conclusa una guerra un’altra era già all’orizzonte.
Ma, a differenza del periodo antecedente la prima guerra mondiale, il movimento proletario internazionale aveva minacciato di liberarsi dalle catene dell’opportunismo, il quale aveva svolto il proprio ruolo controrivoluzionario sostenendo gli sforzi bellici delle rispettive borghesie. Inoltre la rivoluzione in Russia aveva fondato il primo Stato di dittatura del proletariato che avrebbe potuto aprire la strada alla rivoluzione mondiale. Il tutto sotto la guida dell’Internazionale Comunista, che difendeva un programma integralmente marxista e rivoluzionario. Di fronte alle manovre degli imperialismi l’Internazionale Comunista intervenne con delle Tesi, qui riprodotte, che smascheravano gli interessi predatori di tutti i briganti e che mettevano in evidenza come nessuna pace borghese potesse eliminare le loro rivalità, che inevitabilmente avrebbero condotto ad un nuovo conflitto.
Dato che l’oggetto della spartizione era l’Asia, l’Internazionale convocava un Congresso dei Comunisti e delle Organizzazioni Rivoluzionarie dell’Estremo Oriente. Questo, riunitosi a Mosca tra il gennaio e il febbraio del 1922, rappresentava una chiamata alle armi per le sterminate masse asiatiche contro gli oppressori imperialisti, in alleanza con il proletariato dei paesi capitalisticamente più avanzati, secondo quanto stabilito sulla questione nazionale e coloniale dall’Internazionale al suo secondo congresso.
Iniziamo in questo numero la pubblicazione di una parte dei lavori di quel Congresso, l’intervento di Zinoviev di apertura dei lavori e il suo rapporto tenuto nella seconda sessione “Sulla situazione attuale e i risultati della Conferenza di Washington”.
Come esattamente cento anni fa, anche oggi ci troviamo di fronte alle manovre degli imperialismi in Oriente, che condurranno inevitabilmente a un conflitto devastante. Ma, a differenza degli anni Venti, quando l’Asia era immersa nell’arretratezza e vi dominavano sterminate masse contadine, oggi vi si erge un possente proletariato che ha dato già numerose prove della sua combattività e non ha più l’incombenza storica di porsi alla testa di un movimento nazional-rivoluzionario, ma, come nel resto del mondo, tutto borghese, lotta per una rivoluzione monoclassista e per la propria dittatura.
I rapporti di Zinoviev sono qui in nostre traduzioni dall’edizione originale “The First congress of the toilers of the Far East” pubblicato a Pietrogrado nel 1922 e ripubblicato nel 1970 da The Hammersmith Bookshop Limited per la serie “Documenti rari”. Nota dell’editore: «l’edizione originale fu stampata male su carta economica. La nostra ripubblicazione ovviamente mantiene gli errori di stampa dell’originale».
Tesi del C.E. della Internazionale Comunista in previsione della conferenza di Washington
15 agosto 1921
Inprecor, I, p. 203, novembre 1921
I. La conferenza di Washington
La Conferenza che si deve tenere a Washington, indetta dal governo americano per risolvere i problemi dell’Asia Orientale e per la riduzione degli armamenti, è l’ultimo di una serie di tentativi falliti messi in atto dalla società capitalistica per trovare una via d’uscita dalle insolubili contraddizioni su cui la guerra imperialistica ha gettato una luce così viva, e che così si è dimostrata incapace di risolvere.
L’idea della “Mittel-Europa” e l’idea della Società delle Nazioni sono fallite l’una dopo l’altra. Il capitalismo inglese e quello tedesco, l’uno dopo l’altro, si sono dimostrati incapaci di organizzare il mondo su di una base che, pur permanendo ancora lo sfruttamento di una nazione sull’altra, ciononostante eliminasse gli armamenti e il pericolo di guerra. Oggi, a due anni dalla fine della guerra e a due anni dalla conclusione della pace, l’Europa può essere paragonata a una gabbia in cui le belve litigano intorno a un osso rosicchiato, sorvegliate da domatori che ora gettano loro un osso fresco, e ora le frustano.
Dopo che il capitalismo vittorioso ha così brillantemente mostrato i propri titoli per il ruolo di organizzatore del mondo, gli Stati Uniti d’America, che avevano preso parte al tentativo fatto a Versailles per formare la Società delle Nazioni, e che poi si erano rifiutati di aderire a questa Società, opera loro, per la seconda volta prendono l’iniziativa per risolvere i problemi dell’Oceano Pacifico, o, in altre parole, i conflitti dell’Asia Orientale, che sono per essi della massima importanza. Poi, abbandonando le spiagge del Pacifico, vogliono sollevare la questione del disarmo, come problema di importanza mondiale.
Tutto questo si dovrà fare alla Conferenza di Washington. Ma questo tentativo,
al pari di tutti i tentativi precedenti, fallirà. Nella migliore delle ipotesi,
non può che finire con un nuovo raggruppamento delle varie potenze e con un
acuirsi delle divergenze esistenti. Ciò risulta evidente da un’analisi delle
forze che premono dietro a Stati Uniti, Inghilterra e Giappone, e dall’esame
delle contraddizioni tra di loro.
II. Il ritorno degli Stati Uniti all’Europa
Gli Stati Uniti si sono ritirati dalla Società delle Nazioni, primo, perché l’Inghilterra, con sei voti a disposizione, ha impresso alla Società il marchio inglese; secondo, perché i capitalisti americani non si sentivano propensi a garantire i confini territoriali mondiali raffazzonati a Versailles; e, terzo, perché la cricca capitalistica rappresentata dal partito repubblicano voleva sfruttare il fatto che le masse piccolo borghesi si erano stancate dell’Europa per subentrare alla cricca capitalistica rappresentata dal partito democratico nelle funzioni clientelari governative.
Gli Stati Uniti, però, non hanno potuto ritirarsi dalla politica mondiale, perché i capitalisti europei e gli alleati dovevano loro 20 miliardi di dollari. L’esito dei conflitti europei non deciderà soltanto se i debitori saranno in grado di pagare i propri debiti, ma anche se gli Stati Uniti saranno o non saranno in grado di mantenere in attività l’industria sviluppatasi durante le guerra. Nel 1919 non tutti i capitalisti americani credevano che la loro prosperità dipendesse dallo sviluppo economico dell’Europa, ma la crisi che infierì nel 1920‑21 dimostrò anche agli agricoltori americani che l’America non può esportare i propri prodotti in Europa se l’economia europea continua a decadere.
Per questo motivo gli Stati Uniti hanno già partecipato alla sistemazione della
questione delle riparazioni tedesche; ora partecipano alla sistemazione della
questione dell’Alta Slesia tramite il Consiglio Supremo; hanno preso posizione
sul problema della carestia in Russia. In breve, gli Stati Uniti hanno
nuovamente aderito al vero rappresentante del capitalismo mondiale vittorioso,
il Consiglio Supremo, che ha reso il Consiglio della Società delle Nazioni un
fantoccio. Adesso gli Stati Uniti si stanno sforzando di ottenere il controllo
del Consiglio Supremo e a questo scopo sfruttano la difficile situazione in cui
si trova attualmente il rivale inglese.
III. La situazione dell’Inghilterra
Per vincere, l’imperialismo inglese fu costretto a trascinare le proprie colonie nella guerra, nel corso della quale esse diventarono economicamente più forti. Nel 1917 fu dato loro il diritto di voto sulle decisioni di politica estera britannica. Ora questo diritto nominale dev’essere trasformato in realtà, perché l’imperialismo inglese è incapace di sostenere da solo il costo degli armamenti navali che deve mantenere sia contro gli Stati Uniti sia contro i propri alleati, Francia e Giappone, e perché deve tenere conto delle colonie come fattori interni alla situazione dei rapporti di forze. La Gran Bretagna ora è stata sostituita da una confederazione fra la Gran Bretagna e le colonie capitalistiche inglesi che si autogovernano, i cui interessi in politica estera non si identificano con quelli della madrepatria.
L’imperialismo inglese vuole mantenere l’alleanza con il Giappone per avere un alleato in caso di conflitto con gli Stati Uniti, per assumere il ruolo di arbitro tra l’imperialismo americano e quello giapponese, dopo aver attizzato la discordia tra americani e giapponesi.
Ma il giovane capitalismo canadese che, per ragioni di vicinanza, sta diventando sempre più dipendente dagli Stati Uniti, non può permettersi il lusso di un turbamento dei rapporti con il suo potente vicino. Alla recente Conferenza Imperiale il Canada si è opposto al rinnovo dell’alleanza con il Giappone e cortesemente rifiutato di farsi vincolare da un eventuale rinnovo. L’Australia, il cui solo nemico possibile è il Giappone, in caso di conflitto con quel paese avrebbe trovato un alleato negli Stati Uniti. Gli agricoltori del Sud Africa non vogliono avere niente a che fare con i conflitti politici mondiali. Questo atteggiamento assunto dalle principali colonie ha privato l’imperialismo inglese della libertà di movimento nei confronti degli Stati Uniti.
In quest’atmosfera di divergenze politiche mondiali non risolte la crescente concorrenza economica tra Gran Bretagna e Stati Uniti pone a entrambi i paesi l’interrogativo se essa non porterà alla fine a una crescita della corsa agli armamenti che potrebbe condurre ad una nuova guerra mondiale. In tale guerra la Gran Bretagna si troverebbe in una posizione più pericolosa che nella guerra 1914‑18 perché, mentre da una parte non potrebbe contare completamente sulle proprie colonie, dall’altra si troverebbe ad avere come avversaria la Francia, il cui sforzo per dominare l’Europa continentale attraverso una rete di stati vassalli, Polonia, Cecoslovacchia e Romania, e la cui politica in Medio Oriente, la pongono sempre più in contrasto con la Gran Bretagna.
L’imperialismo inglese ha contribuito a distruggere la potenza non soltanto
navale, ma anche militare del capitalismo tedesco. Il disarmo del capitalismo
tedesco ha reso il militarismo francese l’elemento decisivo sul continente
europeo. L’avvento di armi a lunga gittata e di aerei e sommergibili in caso di
guerra permetterebbe alla Francia, alleata con gli Stati Uniti, non soltanto di
assediare l’Inghilterra, ma anche di invaderla. Questa situazione costringe il
governo inglese a cercare di arrivare a un’intesa con gli Stati Uniti. Lo scopo
di quest’intesa è la formazione di un trust capitalistico anglo-sassone. Gli
Stati Uniti sarebbero il centro di gravità di questo trust mentre il Giappone
dovrebbe farne le spese.
IV. L’isolamento del Giappone
Durante la guerra l’imperialismo giapponese ha accumulato ricchezze con poca spesa rifornendo gli Alleati e sfruttando l’incapacità dell’Inghilterra di rifornire le proprie colonie di una quantità sufficiente di prodotti industriali.
All’inizio della guerra, avendo accortamente impedito alla Cina di parteciparvi,
il Giappone sottrasse a forza Kiaochow e la provincia dello Shantung
all’imperialismo tedesco e vi si sostituì. Acuì le difficoltà della Cina e sotto
la maschera dell’organizzatore le sfruttò per impadronirsi del vasto impero che,
sotto la guida del Sud borghese, stava cercando a tentoni la via che lo
conducesse dalla disunione feudale all’unità. I risultati della guerra
minacciano di privare i giapponesi dei frutti della vittoria. La sconfitta della
Germania e la scomparsa della Russia come elemento imperialistico, che avrebbe
potuto unirsi al Giappone in imprese di saccheggio, lo riducono per un aiuto
contro gli Stati Uniti a fare assegnamento sulla sola Inghilterra.
V. I progetti degli Stati Uniti in Asia Orientale
Gli Stati Uniti vedono nella Cina e nella Russia (soprattutto nella Siberia) dei mercati per soddisfare la loro enorme necessità di espansione economica, e dei territori da conquistare all’investimento di capitale americano.
La posizione di monopolio di cui godono gli Stati Uniti nella loro condizione di creditori mondiali e, inoltre, la competitività dell’industria americana nei confronti non soltanto dell’industria giapponese ma anche di quella inglese, spingono gli Stati Uniti a contrastare tutti i privilegi imperialistici che gli Stati imperialisti più vecchi, Francia, Inghilterra e Giappone, hanno acquisito in passato in Cina, o quelli che potrebbero acquisire in Siberia. Gli Stati Uniti, sotto lo slogan della “porta aperta in Cina” coniato dal Segretario di Stato americano John Hay nel lontano 1900, stanno cercando di far indietreggiare il Giappone; il loro modo di trattare la questione delle stazioni radio cinesi sull’isola di Yap vale a dimostrare che essi sono decisi a dare battaglia su tutto il fronte.
Questa politica minaccia gli interessi inglesi, anche se in misura molto minore
di quelli giapponesi. Non soltanto perché l’Inghilterra è un osso più duro del
Giappone per la concorrenza americana, ma anche perché la questione del
Pacifico, vitale per il Giappone, non è che una delle preoccupazioni
dell’Inghilterra. Perciò il Giappone può contare sull’Inghilterra solo fino ad
un certo punto. Costretta a scegliere tra Giappone e Stati Uniti, l’Inghilterra
parteggerà per questi ultimi. Perciò la Conferenza di Washington rappresenta un
tentativo degli Stati Uniti per strappare al Giappone con mezzi diplomatici i
frutti della sua vittoria.
VI. Prospettive per la conferenza di Washington
Qualsiasi accordo sulla limitazione degli armamenti nel Pacifico, o sulla sua suddivisione in zone in cui ogni potenza abbia la supremazia, dipende dall’esito dei negoziati diplomatici sui dibattuti problemi del Pacifico. L’Inghilterra appoggerà il Giappone e cercherà di determinare un compromesso tra Stati Uniti e Giappone, che le permetta di continuare l’alleanza con il Giappone includendovi formalmente gli Stati Uniti. Il valore militare dell’alleanza con il Giappone in caso di guerra con gli Stati Uniti non va sottovalutato. Il compromesso potrà aver luogo sia che il Giappone riceva delle contropartite in Siberia, sia che si facciano agli Stati Uniti delle concessioni in Cina, o si dia loro il diritto di compartecipazione nello sfruttamento del petrolio della Mesopotamia ecc. ecc.
Se l’Inghilterra riuscirà a concludere questo compromesso, farà di tutto per mantenere, all’interno dell’alleanza anglo-nippo-statunitense, rapporti particolarmente stretti con il Giappone.
In seguito da parte delle tre potenze contraenti si arriverà ad un accordo per fissare gli armamenti navali ad un livello che non possa essere considerato pericolosamente competitivo.
Se invece le potenze non riuscissero a raggiungere un accordo sui punti in questione il conflitto economico e la corsa agli armamenti procederebbero senza limitazioni.
Nel primo caso, Stati Uniti e Inghilterra agirebbero di concerto per privare il Giappone di una parte dei frutti della sua vittoria a beneficio degli Stati Uniti e a spese della Cina e, forse, della Russia sovietica. Un accordo di questo tipo si rivelerebbe punto di partenza di nuovi raggruppamenti diplomatici e di nuovi conflitti politici mondiali, allo stesso modo della pace di Shimonoseki quando Russia, Germania e Francia fecero di tutto per strappare al Giappone i frutti della sua vittoria sulla Cina nel 1894.
Nel secondo caso, il processo di inasprimento dei conflitti esistenti si evolverebbe con maggior rapidità.
Essi tuttavia non scomparirebbero del tutto in nessuna delle due circostanze. Quindi il conflitto economico tra Inghilterra e America continuerà ad essere il principale problema mondiale. Il conflitto anglo-nipponico rimane, come rimane quello anglo-francese.
Nello sfondo di questi conflitti che dividono il mondo dei vincitori
capitalistici si profila il conflitto con i paesi capitalistici sconfitti, e, in
seguito, con i popoli coloniali, e, infine, con la Russia sovietica, che
rappresenta una breccia nel sistema degli Stati capitalisti.
VII. La conferenza di Washington e l’Internazionale Comunista
Anche il tentativo di risolvere la questione della limitazione degli armamenti sul continente europeo è condannato al fallimento. Dopo il completo disarmo della Germania, anche se la Francia abbandonasse i propri preparativi militari, la sua sicurezza non sarebbe compromessa; essa tuttavia non rinuncerebbe alla propria posizione di prima potenza militare in Europa, perché la politica dell’imperialismo francese mira al dominio del continente europeo.
A parte la Francia, ci sono i suoi Stati vassalli, che con la pace di Versailles e i successivi trattati hanno tutti ricevuto in assegnazione dei territori abitati da popolazioni straniere e ostili. La Polonia ha una gran quantità di abitanti ucraini, piccolo-russi e tedeschi, mentre le Cecoslovacchia può essere paragonata all’antico Impero austriaco, perché, oltre che dai Cecoslovacchi, è popolata da tedeschi e ungheresi. Un gran numero di ungheresi e bessarabici sono stati assoggettati dalla Romania. Moltissimi bulgari sono stati sottoposti al dominio romeno e jugoslavo. Lo status quo in Europa Centrale, Meridionale e Orientale oggi si regge sulle baionette.
Nel Medio Oriente, la Francia, partendo dai suoi possedimenti africani e dalla Siria, fa di tutto per aggirare l’Inghilterra nel suo punto più sensibile, il Canale di Suez. Si propone con questo di ostacolare la politica inglese volta a stabilire – attraverso il territorio di un grande Stato arabo dipendente dall’imperialismo inglese – le linee di comunicazione tra Egitto e India. Per costringere la Francia a rinunziare ai propri armamenti in una simile situazione, l’Inghilterra deve arrivare a un accordo con la Francia su tutti i problemi mondiali.
Quanto poco le stesse potenze capitaliste credano alla possibilità di un disarmo è dimostrato dal fatto che, avendo accolto cordialmente la proposta fatta da Harding di discutere il disarmo a Washington, immediatamente dopo il governo inglese ha deciso di spendere 30 milioni di sterline nella costruzione di nuove navi da guerra. Lo ha giustificato facendo rilevare che il Giappone sta costruendo otto corazzate che saranno terminate per il 1925, e che gli Stati Uniti sarebbero in possesso di 12 supercorazzate.
L’Esecutivo dell’Internazionale Comunista afferma che la Conferenza di Washington non ci porterà né al disarmo né a una stabile pace tra le nazioni, e che essa rappresenta semplicemente un tentativo di conciliare gli interessi dei grandi predoni imperialisti anglo-sassoni a spese del predone più debole, il Giappone, della Cina e della Russia sovietica. Questa analisi del carattere della Conferenza di Washington è confortata dal fatto che la Russia non vi è stata invitata, per renderle impossibile denunziare il modo vergognoso in cui a Washington si gioca con le sorti dei popoli.
A qualsiasi arrangiamento diplomatico si sia giunti a Washington, l’Esecutivo dell’Internazionale Comunista mette in guardia le masse operaie e i popoli coloniali asserviti dal nutrire la speranza che esso possa liberarli dalla minaccia del mondo capitalistico armato fino ai denti e dello sfruttamento da parte degli Stati capitalistici.
L’Esecutivo dell’Internazionale Comunista fa appello a tutti i partiti comunisti e a tutti i sindacati affiliati all’Internazionale Sindacale Rossa perché intensifichino l’agitazione e la lotta contro i governi imperialistici i cui interessi contrastanti avranno come risultato inevitabile un nuovo conflitto di dimensioni mondiali, se la rivoluzione proletaria non disarma la classe capitalista e non crea così le condizioni per una nuova federazione di dimensioni mondiali di tutti i popoli lavoratori.
L’Esecutivo attira l’attenzione della classe operaia di tutto il mondo sugli intrighi che si stanno tramando a Washington contro la Russia sovietica. Fa appello alle masse della Cina, della Corea e della Siberia Orientale perché si stringano ancora di più attorno alla Russia sovietica, l’unico Stato al mondo pronto a offrire assistenza su di una base di eguaglianza e di aiuto fraterno ai popoli d’Oriente che vengono minacciati dall’imperialismo mondiale.
Il Congresso dei lavoratori dell’Estremo Oriente
Sessione di apertura
21 gennaio 1922
Introduzione di Zinoviev
Compagni, a nome del Comitato Esecutivo dell’Internazionale Comunista, dichiaro aperto il Congresso dei Lavoratori dell’Estremo Oriente.
(Brindisi, canto dell’“Internazionale”)
Compagni, il Comitato Esecutivo dell’Internazionale Comunista dà una grande importanza a questo Congresso. Sono stato incaricato di accogliere tutti i compagni qui riuniti in nome di tutti i lavoratori comunisti organizzati nella Fratellanza Internazionale dei Lavoratori, conosciuta come Internazionale Comunista. La nostra fratellanza internazionale, dal primo giorno della sua esistenza, si è resa conto del fatto che la vittoria completa del proletariato sulla borghesia in questa situazione è possibile solo a scala mondiale.
C’è qualcosa di più che ci distingue dalla Internazionale precedente, una delle più importanti caratteristiche che distingue la Terza Internazionale dalle organizzazioni precedenti consiste nel fatto che noi, non solo a parole ma nei fatti, stiamo cercando di diventare l’organizzazione non solo dei proletari d’Europa ma anche dei lavoratori del mondo intero. L’Internazionale Comunista tiene sempre chiaramente presente il fatto che la rivoluzione dei lavoratori potrà essere vittoriosa nelle attuali condizioni solo come rivoluzione mondiale. Troppo spesso l’idea della rivoluzione mondiale è stata sostituita dall’idea di una rivoluzione europea.
Naturalmente, sappiamo molto bene lo straordinario significato che hanno in se stessi il movimento dei lavoratori e il generale movimento rivoluzionario in Europa. Non abbiamo alcun motivo di sottovalutarlo, ma allo stesso tempo, sappiamo che la vittoria decisiva sarà garantita solo nel caso che la lotta non sia limitata al solo continente europeo, quando le centinaia di migliaia e le centinaia di milioni di lavoratori e masse oppresse si risveglieranno all’Est.
Tutti sanno che l’Internazionale Comunista è diventata una potenza in relazione alla vittoria della rivoluzione operaia in Russia. La rivoluzione che ebbe luogo nel 1905 nel nostro paese ha causato considerevoli conseguenze internazionali. Quella rivoluzione ha innescato un movimento rivoluzionario in Turchia e Persia. Già la nostra rivoluzione del 1905 ha indubbiamente esercitato una notevole influenza sul movimento rivoluzionario in Cina degli anni 1911 e 1912, che ha assunto forme più turbolente. Ma la nostra rivoluzione del 1905 ha incontrato l’ostacolo delle forze coalizzate internazionali. Ha trovato eco presso le nazioni oppresse di altri paesi comprese quelle dell’Est, che risuonava però in lontananza.
La grande rivoluzione operaia in Russia, di cui siamo testimoni, ha già trovato una incomparabile maggiore eco tra i lavoratori del mondo intero compresi quelli dell’Estremo Oriente. Il più grande compito della Terza Internazionale è fare tutto il possibile per affrettare il risveglio dei popoli lavoratori dell’Estremo Oriente.
All’inizio della nostra attività, nel tentativo di attrarre i più avanzati lavoratori d’Europa come quelli dell’Est ci siamo scontrati con l’aspra critica e con i falsi eroi della Seconda e della Internazionale Due e Mezzo. Hanno inteso schernirci perché volevamo realizzare l’unione fra l’avanguardia proletaria dell’Ovest e i popoli dell’Est, che nelle opinioni di alcuni capi delle Internazionali Seconda e Due e Mezzo, sono ancora in un sonno da cui non è possibile svegliarli, perché non sarebbero in grado di diventare fattore attivo nella realizzazione della storia del mondo. Sappiamo perfettamente bene che questi nostri avversari sono solo dei social-opportunisti, solo socialisti piccolo-borghesi. Sappiamo che sono il vecchio, l’arrugginito, la ristretta mentalità dell’Europa piccolo-borghese, che non conoscono niente al di fuori dell’Europa se non cose lontane e misteriose.
La Internazionale Comunista sa con perfetta chiarezza che l’unione del proletariato avanzato di Europa e di America con il risveglio delle masse lavoratrici dell’Est è un fatto assolutamente necessario per la nostra vittoria. Di qui il nostro tentativo di poco più di un anno fa di organizzare il famoso Congresso di Bakù, da qui il tentativo attuale da parte della I.C. di raggiungere un’intesa con le masse lavoratrici e i loro dirigenti rappresentativi che dal lontano Oriente sono giunti nel paese dove ha sede il Comitato Esecutivo della I.C. e tutta la I.C.
Come si può giudicare dalle risoluzioni prese in tutti e tre i nostri Congressi, si comprende bene che siete costretti a lavorare in condizioni diverse da quelle in cui operano i partiti proletari dell’occidente. Il Comitato Esecutivo della I.C. ascolterà con grande attenzione i rapporti, le informazioni che ci darete.
Non vogliamo nascondere che i collegamenti che manteniamo con i delegati dei paesi qui rappresentati sono molto carenti. Sappiamo molto poco di cosa avviene in paesi come il Giappone e ogni resoconto sull’organizzazione, per esempio, di sindacati in Giappone merita la massima attenzione da parte dell’avanguardia proletaria organizzata nell’Internazionale Comunista. Sappiamo anche molto poco del movimento rivoluzionario in Cina, eccetto per le informazioni dei compagni qui presenti.
Siamo assolutamente certi che la presente rappresentanza del proletariato giapponese, che siamo felici di vedere qui, sia sufficientemente internazionalista, nel vero senso della parola, nel rapportarsi con i cinesi, i coreani e tutte le altre nazioni che sono oppresse dalla borghesia giapponese. Siamo convinti che i nostri compagni giapponesi terranno viva l’eredità di Karl Liebknecht, che il nemico è in casa propria, che il principale nemico dei lavoratori è la loro propria borghesia. Siamo convinti che a questo Congresso l’idea elementare che non ci può essere antagonismo nazionale fra i lavoratori di Giappone, Cina, Corea, Mongolia, etc. che sono qui rappresentate, emergerà alla luce di una verità evidente. Siamo profondamente convinti che questo Congresso rinsalderà la fratellanza dei lavoratori di tutti i paesi anche nella loro forma organizzata.
Compagni, ripeto, noi attribuiamo a questo Congresso grande importanza. La I.C. conseguirà completamente il proprio scopo solo se sapremo tradurre in azione e con successo il programma delineato ed elaborato nei dettagli al Secondo Congresso.
La Seconda Internazionale, ormai definitivamente diventata, e sempre di più, una organizzazione al servizio della borghesia, ha fatto bancarotta sulla guerra e sull’atteggiamento nella questione delle nazioni coloniali e semi‑coloniali, non ha avuto una chiara linea di condotta ed alla fine ha preso una chiara posizione borghese.
La questione del suo atteggiamento verso le nazioni coloniali è ben lontana dall’essersi risolta dopo il Congresso della Pace di Versailles e della Conferenza di Washington e continuerà ad esistere anche dopo l’approssimarsi della Conferenza di Genova, questa questione rimarrà all’ordine del giorno fin tanto che il proletariato, guidato dall’I.C., non avrà realizzato la vittoria finale sul sistema borghese. È su questa questione più che su tutte le altre che il Comintern ha rotto bruscamente con la maledetta tradizione della Seconda Internazionale, che ha portato alla vittoria della borghesia sul proletariato durante i non dimenticabili giorni della guerra imperialista. Questa è la questione delle questioni, il nodo principale della politica mondiale e della lotta dei lavoratori in tutto il mondo.
Alla Conferenza di Bakù il C.E. del Comintern esortò “i Partiti Comunisti di tutti i paesi e i lavoratori di tutte le nazioni oppresse ad unirsi!”. Questo è l’appello che adesso noi indirizziamo ai rappresentanti dell’Estremo Oriente che con grande gioia salutiamo oggi nel nostro paese. I Partiti Comunisti di tutti i paesi e i lavoratori del mondo intero, e in particolare dell’Estremo Oriente, si uniranno sotto la bandiera dell’Internazionale Comunista segnando la vittoria finale sul mondo imperialista.
Viva il Congresso dei Lavoratori dell’Estremo Oriente!
(applausi).
Rapporto di Zinoviev
23 gennaio 1922
La situazione internazionale e i risultati della Conferenza di Washington
Compagni, il mio compito sarà, naturalmente, di presentarvi nei suoi lineamenti fondamentali la situazione internazionale così come è durante il nostro Congresso, e per abbozzare le caratteristiche dei nostri compiti, concepite già dal C.E. del Comintern.
Sono passati già tre anni dalla fine della guerra imperialista. Ma è certo ovvio che ancora molti anni dovranno trascorrere prima che l’umanità inizi a dimenticare i suoi effetti. Tutto il mondo è in lotta, come un uccello in gabbia, cercando di limitare le terribili conseguenze della guerra, che si sono provate ad ogni svolto.
Le caratteristiche fondamentali dell’attuale periodo post‑bellico, così come lo vedo, consistono nel fatto che sempre più urgenti si sollevano questioni non dal fronte europeo ma da quello dell’Asia e dell’Estremo Oriente.
Con questo non intendo dire che prima di adesso queste problematiche non svolgessero un ruolo importante. Tutti sanno che per decenni il problema asiatico ha giocato un ruolo importante nelle questioni della politica mondiale. Tutti sono ben consci che la prima Rivoluzione in Russia, nel 1905, aveva una vicina attinenza con la guerra Russo-Giapponese, che nel suo svolgersi era intimamente connessa con i problemi dell’Estremo Oriente.
Ma nell’immediato futuro il problema dell’Asia e dell’Estremo Oriente sta prendendo effettivamente la precedenza rispetto ad ogni altra questione della politica mondiale. Ce ne rendiamo conto con particolare evidenza se analizziamo la lotta che sta prendendo piede intorno alla pace firmata dopo la chiusura della guerra imperialista. Se diamo un’occhiata anche agli ultimi fatti, se volgiamo lo sguardo alle recenti dimissioni del Ministro Francese Briand, il quale fa anche la proposta della controversa Conferenza di Genova, si vedrà come le questioni europee stanno iniziando ad essere sempre più svuotate e superficiali.
I paesi vincitori, e la borghesia francese in primo luogo, con i loro pii desideri, hanno solo brigato per ottenere una insignificante porzione di ciò che si aspettavano di ricavare e quello che la Francia pensava di essere autorizzata a portar via alla Germania sconfitta. Abbiamo letto ieri la dichiarazione del borghese ministro francese Poincaré: «Hanno cercato di rappresentarci, noi Francesi, come pazzi imperialisti (ha detto proprio così) e per di più che solo noi siamo colpevoli di chiedere che la Germania debba pagare per ciò di cui si è impegnata, per ciò che ha firmato». Suona proprio come una sacrosanta richiesta. Ma noi sappiamo che la Germania non è in condizione di pagare e qualsiasi cambiamento venga apportato nel Gabinetto francese, nessun serio cambiamento potrà aversi in questa situazione.
Questo piccolo insignificante fatto fornisce un esempio di come le questioni europee divengono del tutto superficiali e svuotate. La guerra tragica, che è costata i più tremendi sacrifici, è riuscita ad essere solo una cesura nel tempo. La borghesia vittoriosa non può ottenere alcunché dai paesi sconfitti, dentro i confini di Europa. Sono confini abbastanza estesi, ma in confronto all’intero globo sono assai piccoli e questi confini non possono contenere problemi di serie dimensioni.
È evidente quanto le questioni dell’Asia abbiano avuto la loro parte nella guerra imperialista del 1914‑17 e svoltovi un ruolo molto importante. Tuttavia per molti aspetti questa guerra ha portato in prima linea i problemi europei: la questione balcanica, quella degli Stretti, ecc. Ma ancora, dopo la più sanguinosa e terribile guerra che l’umanità abbia mai visto, vediamo con maggiore chiarezza che le questioni in contesa fra gli imperialismi si stanno spostando in Asia. Il problema dell’Estremo Oriente sta così diventando un milione di volte più concreto che non sia mai stato finora, sta diventando la questione delle questioni, il perno della politica mondiale, e anche il perno dell’intero movimento di liberazione del proletariato e delle nazioni oppresse.
La storia degli ultimi anni può essere riferita ad alcune città dove i più importanti accordi tra gli imperialisti e le loro vittime hanno avuto luogo. Quando noi citiamo il nome di Brest-Litovsk, Bucarest, Saint-Germain, Versailles, citiamo i più importanti eventi della politica imperialista degli ultimi anni. Ma recentemente un’altra città si aggiunge, Washington, diventata il centro dei problemi dell’Estremo Oriente e che ci interessa molto. Possiamo ricordarci bene il baccano che è stato fatto a Washington. Ricordate come a quella Conferenza promisero di risolvere la questione del disarmo, di sanare le ferite dei paesi come la Corea, come là promisero di risolvere la questione cinese, di rendere felici le nazioni dell’Estremo Oriente.
È comprensibile che i rappresentanti più avanzati delle nazioni dell’Estremo Oriente possano difficilmente avere una qualche fiducia in Washington, che difficilmente possano fondarvi qualche seria speranza. Dal passato corso degli anni recenti nessuno se ne può convincere, ovunque l’imperialismo assume forme particolarmente ipocrite, con gli autori di questa ipocrisia, i rappresentanti della borghesia americana, che si sforzano di combinare la più grande rapina imperialistica con la più farisaica ipocrisia doppiogiochista. Basta ricordare le memorabili attività di Mr. Wilson, che, come tutti sanno, sarebbe stato in procinto di risolvere tutte le aspettative dell’Estremo Oriente, dopo aver promesso di rendere felici tutte le nazioni oppresse.
Le stesse cose si ripetono oggi, quando i massimi predatori del potere capitalistico diffondono l’illusione che i più forti di questo mondo desiderino risolvere le grandi sofferenze che affliggono le nazioni oppresse dell’Estremo Oriente. La borghesia americana ha di nuovo messo in atto il suo imbroglio. Un gran miracolo si sarebbe dovuto vedere a Washington, le nazioni martirizzate dell’Estremo Oriente e le nazioni oppresse in generale, malgrado l’esperienza dei molti inganni del passato, avrebbero dovuto riporre qualche speranza nella Conferenza di Washington, le promesse di Wilson avrebbero dovuto risollevare le speranze di qualche nazione oppressa.
Siamo adesso ormai nella condizione di riassumere i risultati di Washington. Mi sembra che il 10 dicembre 1921 rimarrà una delle date più nere della storia dell’umanità. Il 10 dicembre 1921 a Washington abbiamo visto la conclusione dell’accordo fra quattro degli attuali più potenti governi, quattro dei maggiori governi imperialisti oppressori e reazionari: Inghilterra, Francia, Giappone e America. Penso che questa alleanza, nella sua vera essenza, sarà riportata nella storia come l’“Alleanza delle Quattro Sanguisughe”, l’alleanza dei quattro poteri imperialisti più sanguinari che, prima di entrate in lotta – e inevitabilmente dovranno rompere fra di loro – concludono un armistizio per meglio opprimere le nazioni, a spese del loro sangue, grazie al quale questi ladri imperialisti hanno vissuto per molti anni.
Conoscete le principali promesse fatte a Washington. Era per risolvere il problema del disarmo. In realtà, e questo è adesso del tutto evidente, hanno risolto il problema degli armamenti. Quelli di voi che hanno seguito le discussioni dei signori illuminati riuniti a Washington, possono ricordare bene la velenosa litigata che ebbe luogo fra Briand, neo‑dimesso, e i suoi oppositori alla Conferenza, con trattative all’ingrosso riguardo alle forze navali sottomarine da collocare in questo o quel paese. Questi signori, incuranti del fatto che tutta Europa stava ascoltando, che erano davanti agli occhi delle nazioni oppresse dell’Asia, come se fossero soli si sono scambiati delle innocenti battute sulla questione delle flottiglie sottomarine, dichiarando che avevano bisogno di questa flotta per esaminare il fondo del mare, raccogliere ciottoli, ecc. Ovvio che nessun disarmo è uscito da quella Conferenza. La conferenza ha confermato una volta di più l’affermazione comunista che nessun disarmo è possibile durante l’esistenza del capitalismo, e che sarà possibile parlare seriamente di disarmo solo quando le nazioni oppresse avranno riportato la vittoria sui governi imperialisti. Così solo si risolve la questione del disarmo.
Vediamo adesso come si affronta il problema dei diversi paesi dell’Estremo Oriente. Come si risolve il problema della Corea? Ci hanno detto che anche alcuni membri attivi del movimento di liberazione coreano nutrono delle speranze in Washington, pensano che potrebbe accadere qualche miracolo, che qualche chiarimento del problema coreano potrebbe venire in seguito. Ora, cosa è successo? La parola “Corea” non è stata neppure citata alla Conferenza di Washington, come se la Corea non esistesse sulla terra, come se a Washington dove c’erano tutti i poteri riuniti non avessero mai sentito dell’esistenza della Corea; nessuno ha detto una parola sul problema coreano, almeno nei discorsi ufficiali. Questo probabilmente non ha impedito a questi signori di scambiarsi opinioni dietro le quinte su chi deve continuare a opprimere la Corea. Se il popolo Coreano ha bisogno di lezioni penso che non ne possa trarre di migliori e convincenti che dal silenzio a Washington.
Il problema cinese, come sapete, è stato risolto completamente ed interamente nello spirito americano. Più o meno l’accordo è stato trovato per riconoscere alla Cina la cosiddetta politica della “porta aperta”, promossa dal capitalismo americano per egoistici motivi, perché pensano di essere capaci di battere tutti gli altri capitalismi concorrenti sul mercato cinese attraverso la libera concorrenza della “porta aperta”. Il commercio americano con la Cina ammontava nel 1916 a 189 milioni di dollari, arrivava nel 1920 a di 385 milioni, quasi il doppio. Questo dà al capitalismo americano la fiducia di essere capace di praticare la “porta aperta”, di poter trarre di gran profitti dalla Cina.
E sarebbe il più spiacevole errore immaginabile se si trovasse fra i rappresentanti della Cina del Sud, per esempio, qualche sempliciotto ad accettare come oro colato lo slogan della “porta aperta” della vera democrazia e di chi cadesse così nella più comune delle trappole capitaliste. Purtroppo dobbiamo osservare con rimpianto che, secondo le nostre informazioni (e devo ammettere che abbiamo veramente poche e sporadiche informazioni), alcuni lavoratori attivi nel movimento rivoluzionario della Cina del Sud, fra gli aderenti di Sun Yat Sen, fra i numerosi lavoratori del suo partito, talvolta guardano non senza speranza all’America e al capitalismo americano, aspettandosi appunto che da quello si rovescino sulla Cina rivoluzionaria i benefici della democrazia e del progresso. Spero che la Conferenza di Washington convincerà le avanguardie più lungimiranti della Cina del Sud, i rivoluzionari cinesi, tutti coloro che stanno combattendo per l’autodeterminazione delle loro nazioni, anche se non sono socialisti, che i capitalisti americani non sono affatto loro amici, ma i loro più implacabili nemici, che sempre avvicinano le loro vittime (e questo è il metodo preferito dal capitalismo americano, come ho già dimostrato) con parole d’ordine democratiche e con la più evidente ipocrisia.
Il problema mongolo è stato anch’esso dimenticato dalla Conferenza di Washington. Da quando la Mongolia fu liberata, grazie a qualche piccolo aiuto dal Governo dei Soviet (il Governo dei Soviet sarà, ovviamente, sempre fiero di prestare in ogni circostanza anche una minima assistenza alla Mongolia), il problema della Mongolia è stato rilanciato come una palla avanti e indietro fra tutti i capitalisti. Il capitalismo Giapponese sta adesso provando di avvalersi di questo problema, comprando una parte di politicanti mercenari cinesi, sta seminando discordia fra la Mongolia e i rivoluzionari cinesi sotto il pretesto del patriottismo democratico. Propongono la questione della restituzione della Mongolia alla Cina. Alla Conferenza di Washington, niente è stato detto apertamente sulla Mongolia, come è successo per il caso della Corea.
Sapete che gli incontri diplomatici a Washington, che sono ancora in corso, non hanno ancora ottenuto risultati definitivi. C’è adesso in prima linea il problema di andare alla nuova Conferenza di Genova, che, in parte, sposta l’attenzione dai negoziati di Washington. Nessuno di noi può prevedere quando la Conferenza di Genova avrà luogo, come finirà, con quale ampiezza saranno discussi i problemi dell’Estremo Oriente così come quelli europei.
In ogni caso una cosa è certa, Washington conferma che tutto ciò che è avvenuto era inevitabile, cioè che, fintanto alla testa dei più ricchi paesi – Giappone, America, Inghilterra, Francia – sta la borghesia imperialista, il problema dell’Estremo Oriente sarà gravemente destinato a crescere e in nessun caso potrà trovare soluzione. In parole povere, Washington conferma ancora una volta la politica di spartizione che i poteri imperialisti hanno condotto per molti anni. Infatti i nove decimi degli obbiettivi della guerra del 14/17 sono incentrati sul come dividersi il mondo. Il mondo era stato diviso dagli imperialisti già prima del 1914. In questa prima guerra imperialista la questione fu solo quella della re‑distribuzione del mondo. Anche prima dello scoppio della guerra imperialista del 1914, la spartizione era compiuta, per cui un commerciante inglese, in media, sfrutta non meno di 800 nativi in quelle colonie da cui l’Inghilterra succhia il sangue e i profitti. Ulteriori conflitti e contese nascono per la stesso motivo.
Adesso Washington ha, nel complesso, confermato la spartizione del bottino saccheggiato nel 1918, l’anno della chiusura della guerra imperialista. Al Giappone rimane il dominio su Corea, Yap, Liao‑Dun e Shantung; l’America mantiene le Filippine, l’Inghilterra l’Egitto ed India, la Francia l’Indo‑Cina. Come possono affrontare alcuna di questioni? È perfettamente chiaro che hanno deliberato in linea con la formula: io ti aiuto a rubare questa e quest’altra colonia, e tu mi aiuterai a rubare quella e quell’altra.
Seguendo le discussioni della Conferenza di Washington torna frequente il ricordo di un magnifico discorso dell’ultimo Jaurès, pronunciato poche ore prima dello scoppio della guerra imperialista, quando era ormai evidente che la guerra era inevitabile, e quando, esaminando le cause dell’imminente catastrofe, dichiarò a uno dei convegni tenutisi a Parigi: «Domani la guerra scoppierà, domani ti diranno che è una guerra per liberare le nazioni oppresse, ma io vi dico che questa sarà una guerra per spartirsi i profitti. Vi dico che sarà una guerra per la spartizione delle nazioni oppresse». Dicendo poi: «I rappresentanti dei governi di oggi si muovono secondo la formula: io ruberò su questo lato della strada e fingerò di non vedere tu che stai rubando sull’altro lato». I deliberati di Washington hanno seguito la stessa linea. Il Giappone disse all’America: stiamo chiudendo un occhio mentre voi saccheggiate questo o quel posto, ma vogliamo che voi li chiudiate entrambi mentre noi rapiniamo la Corea.
Deve essere perfettamente chiaro ai dirigenti delle nazioni oppresse dell’Estremo Oriente, anche per coloro che non condividono la visione comunista, che dalla Conferenza di Washington non un solo uomo cosciente possa aspettarsi niente, ma solo nuova oppressione, nuovo sfruttamento dagli imperialismi più potenti. Più acutamente che mai dopo la Conferenza di Washington la questione che sta davanti a tutti i membri del movimento di liberazione dei popoli dell’Estremo Oriente è: quale sarà la prossima tappa? Dove è la questione e dove la soluzione di tutte le questioni della liberazione nazionale di questi popoli, obbiettivi attuali dell’oppressione del potere imperialista?
Cerchiamo di affrontare le domande che sorgono dai principali paesi rappresentati a questo Congresso.
La questione cinese
Nell’ultimo decennio la Cina ha offerto il classico miglior esempio di ciò che gli imperialisti assetati di sangue sono in grado di fare quando si trovano di fronte un paese indifeso, oppure che non è abbastanza forte per difendersi. Cerchiamo di considerare i fatti che si svolsero all’inizio di questo secolo, per non parlare di quello che era accaduto prima di allora.
Le atrocità senza precedenti che hanno svergognato gli imperialisti di tutti i paesi, incluso Impero Russo sono il miglior esempio del cinismo e della rapina imperialista. In nessun posto come in Cina è così evidente la crudeltà, la ferocia e la barbarie della così chiamata civilizzazione dei poteri europei. Un grande popolo con una popolazione di centinaia di milioni è stata ed è preda di una banda imperialista. Questa banda è di per sé piuttosto piccola. Le ultime cifre che ho visto mostrano che ci sono 20.000 stranieri contro un milione e mezzo di cinesi a Shanghai. E tutti noi sappiamo che questi 20.000 tengono l’intera popolazione delle zona in schiavitù economica e schiacciano sotto il loro tallone la vita culturale e nazionale della popolazione locale. Gli imperialisti non si limitano nell’infliggere inaudite sevizie ai cinesi. Ovviamente, compagni, non sta a me dirvi come gli ufficiali, i bottegai americani e inglesi vi torturano, di come sputano in faccia ai cinesi, dei loro giardini chiusi a tutti gli indigeni, di come maltrattano le donne nel vostro paese. Potreste, ovviamente, dirci a noi europei, molto a proposito di tutto ciò. È una grande vergogna che queste cose possano accadere ai giorni nostri.
Se la Cina non è stata ancora fatta a pezzi, se è stata sacrificata così tanto sull’altare della guerra civile, se individui come Tchan-Tso-Lin, un Hoong‑Hoos [sic], che ancora oggi non sa scrivere il suo nome ma potrebbe arrivare a governare immensi territori, se il famoso Doodzuns può depredare questo ricchissimo paese e farlo tornare indietro nell’oscurità, se vogliono mantenere il giovane imperatore cinese con uno stipendio di quattro milioni di dollari all’anno, veramente enorme per un così giovane monarca, se, al momento, in connessione con l’offensiva capitalistica in Cina, vediamo un enorme sfruttamento dei lavoratori, ciò è dovuto principalmente all’insolente interferenza dell’imperialismo straniero.
È compito del presente Congresso indicare la guida luminosa per gli attivisti del movimento rivoluzionario cinese. Il problema della Cina, e in particolare il problema di questo Congresso, è quello di portare l’unità nelle file sparse dei rivoluzionari cinesi. Il compito di organizzare i lavoratori dell’Internazionale Comunista è aiutare il diviso e oppresso popolo cinese a svolgere il più elementare e semplice problema: buttar fuori tutti i suoi predoni, buttar fuori tutti gli oppressori del popolo cinese, che sono la causa delle vostre grandi sofferenze.
Sappiamo bene in quale difficile situazione sia adesso la Cina. I predoni imperialisti accumulano i debiti della Cina a tal punto che nel 1920 ammontavano a tre miliardi di dollari, per l’esattezza due miliardi ottocento milioni e novantacinquemila. Sappiamo che, grazie all’intervento degli imperialisti, grazie alle guerre intestine, la Cina mantiene un esercito di circa due milioni di uomini. Tuttavia appare un paese completamente disarmato perché, a causa dell’intervento imperialistico, questo esercito è diviso, separato, ed è utilizzato dagli imperialisti per i loro interessi.
Sappiamo che gli imperialisti europei hanno cercato di diffondere su di voi i loro missionari, e si vantano della grande quantità di denaro speso per loro. Non molto tempo fa ho letto un libro scritto da uno di questi imperialisti che con grande soddisfazione riportava le seguenti cifre: la Chiesa Cattolica ha 50 vescovi, 1.500 sacerdoti stranieri, 1.000 sacerdoti cinesi, ecc. Ci sono un milione e mezzo di cinesi convertiti al cristianesimo come risultato del loro lavoro. La missione protestante, secondo la sua dichiarazione, ha 500 istruttori, 383 missionari, circa 100 dottori cinesi, 1.092 ministri, ecc., ne risultato il fatto che ci sono circa mezzo milione di convertiti al protestantesimo. Tutti questi missionari, senza dubbio, hanno diffuso molte menzogne sulla Conferenza di Washington ma, comunque sia, non abbiamo mai sentito alzare una loro voce di protesta, non abbiamo sentito da loro descrizioni delle sofferenze e delle umiliazioni patite dal popolo cinese, risultato del rapace intervento imperialista nella loro vita.
Questo il quadro ideale che dipingiamo della vostra lotta, della vostra sofferenza, sebbene sfortunatamente le nostre informazioni attuali sulla situazione in Cina siano molto parziali. Probabilmente sappiamo poco dei fatti attuali, vediamo solo un piccolo angolo delle sofferenze, umiliazioni, e privazioni a cui il popolo cinese è sottoposto per il brutale intervento dell’imperialismo.
Sappiamo perfettamente bene che la protesta che si sta levando in Cina contro l’imperialismo non è una protesta comunista, è l’elementare naturale desiderio del popolo di essere padrone del proprio destino. Ma noi dichiariamo che il Comintern è completamente dedicato al sostegno dei desideri del vostro cuore, considerandoli indiscutibilmente giusti, e ritiene suo dovere mettere tutto il suo potere e autorità morale dalla parte del popolo cinese aiutandolo a raggiungere le elementari libertà e indipendenza che gli appartengono naturalmente. Il Comintern contribuirà a raggiungere il giorno in cui la borghesia giapponese, americana e inglese con i loro gendarmi non saranno più in grado di ingannare le masse della Cina, a comportarsi come fossero in una stalla, non sarà in grado di commettere le atrocità commesse impunemente durante la repressione della rivolta dei Boxer, rivolta per la quale avete pagato non solo col vostro sangue e le vostre lacrime, ma anche con il vostro oro.
Corea
Il destino della Corea all’inizio fu strettamente in relazione con la competizione fra gli imperialismi di Russia e Giappone, e durante gli ultimi anni il suo destino è stato principalmente legato al Giappone. Noi sappiamo bene che attualmente migliaia di rivoluzionari di Corea stanno riempiendo le galere, abbiamo sentito che centinaia e migliaia sono caduti nella lotta contro l’imperialismo giapponese, abbiamo sentito dell’insurrezione del 1919, e stiamo seguendo con non diminuita attenzione la lotta che si sta sviluppando del popolo coreano contro i suoi oppressori.
La Corea, è governata da un numero abbastanza insignificante di imperialisti giapponesi. Secondo i dati che ho letto (forse non sono abbastanza esatti) nel 1917 in Corea c’erano solo 332.000 giapponesi contro circa venti milioni di coreani. Di questi 332.000, 144.000 vivono in otto città coreane, cioè non sono andati nei villaggi dove vive la maggior parte della popolazione coreana. Il Giappone può vantarsi del fatto che un così insignificante numero di giapponesi (uno e mezzo per cento del totale della popolazione), maggiormente capitalisti e i loro agenti e mercenari, governa e opprime il 98,5% della popolazione coreana. Ovviamente, il Giappone è attratto dalla Corea soprattutto per le sue ricchezze naturali, carbone, grafite, ferro ed oro. Nel 1917 c’erano 38 milioni di yen di capitale giapponese investiti in Corea. Il capitale giapponese sta diventando ogni anno più potente in Corea.
Fino a quando, ovviamente, il popolo coreano non prenderà nelle sue mani il proprio destino la Corea svolgerà in relazione al Giappone la parte, per esempio (ci sono naturalmente delle differenze), dell’Irlanda rispetto all’Inghilterra, con l’unica differenza, che, come sappiamo, i più vicini dell’est, sono i più vili, più assetati di sangue, più cinici, diventando l’imperialismo più spudorato. Se i capitalisti inglesi stanno strangolando l’Irlanda con metodi in confronto civili, tanto per dire, se i boia dell’imperialismo inglese trattano gli irlandesi con i guanti, gli imperialisti giapponesi trattano la Corea con i più inauditi metodi barbari, che dovrebbero suscitare l’indignazione non solo di ogni rivoluzionario coreano, ma di ogni uomo onesto ovunque.
L’Internazionale Comunista sta guardando la lotta di emancipazione del popolo coreano con la massima attenzione. L’Internazionale Comunista ha seguito con sorpresa e dolore la svolta, nel corso della lotta per la libertà del popolo coreano, di alcuni capi coreani che hanno riposto delle speranze su Versailles, immaginando che sarebbero riusciti a ingraziarsi gli imperialisti europei e asiatici. Questo Congresso deve dire sinceramente e in modo fraterno a tutti i rivoluzionari coreani, riguardo alle loro particolari convinzioni, che devono una volta per tutte liberarsi, loro e la loro gente, di ogni residuo di speranza che la questione nazionale coreana possa essere risolta in altro modo che non la stretta unione con l’avanguardia dei lavoratori rivoluzionari di Europa e d’America. Devono una volta per tutte scacciare il pensiero che sia possibile ogni compromesso per la soluzione della questione nazionale tramite un accordo con gli imperialisti.
La questione della Mongolia
Ho detto di sfuggita che sulla questione della Mongolia qualcuno si aspetta che venga risolta dal ritorno sotto la sovranità cinese, e che gli imperialisti giocano con questa questione come con un giocattolo. Gli stessi imperialisti fingono aneliti di autonomia per quei popoli che hanno nelle loro grinfie, come ad esempio nel caso del governo giapponese in Corea. Mi sembra che sarebbe molto triste se tra i capi, per esempio, del sud della Cina rivoluzionaria si trovasse chi fosse così dottrinario sul problema della Mongolia da proporne il ritorno sotto il dominio cinese.
Mi sembra che la soluzione finale della questione mongola arriverà nello stesso tempo in cui la Cina si libererà dal giogo sotto il quale sta languendo adesso, quando la Cina di per sé scaccerà i soldati imperialisti delle nazioni straniere, quando la rivoluzione sarà completamente vittoriosa in Cina, e quando ci sarà sufficiente libertà per essere in grado di dire che il destino della Cina è nelle mani degli stessi cinesi, quando la Cina si sarà liberata dal giogo dell’oppressione sotto il quale essa oggi soffre; quando espellerà dal proprio territorio i soldati delle nazioni imperialiste straniere; quando i rivoluzionari trionferanno finalmente in Cina e il paese avrà raggiunto la prima fase dell’emancipazione; quando la Cina sarà in grado di dire che il suo destino è alla fine nelle mani del proprio popolo – poi, e solo dopo si potrà vedere la questione mongola in una nuova luce.
Per il momento diremo ai rivoluzionari cinesi che sono circondati da ogni parte da nemici e molto compromessi con gli imperialisti; che possono in ogni momento cadere vittime di questi imperialisti, fintanto la guerra civile non sarà finita e la Cina rimanga lacerata e divisa non solo in Nord e Sud ma in una serie di unità territoriali, fintanto il paese sarà governato dagli imperialisti stranieri.
Diremo a questi rivoluzionari del Sud che se qualche dottrinario dovesse pretendere che la Mongolia torni immediatamente sotto la Cina (indipendentemente dalla situazione del popolo cinese) sarebbe un grande errore, anzi più che un errore. Questo errore sarebbe non solo grave per la Mongolia ma anche per la Cina. Un popolo che tende a opprimerne un altro, anche in piccola misura, non sarà mai libero. Nessun popolo dell’Estremo Oriente può dimenticare questa verità. Effettivamente, spesso vediamo che un popolo oppresso si rende perfettamente conto di questo finché ne è coinvolto, ma cambia le sue idee quando si stabilisce su altri popoli un rapporto di dipendenza. Abbiamo spesso notato questo errore in merito ai popoli che hanno costituito formalmente l’Impero Russo, e riteniamo nostro dovere dare una parola di avvertimento ai rivoluzionari cinesi, in modo che non si possa ripetere nei confronti della Mongolia “come si dà, così si riceve”... Se si desidera l’emancipazione del popolo cinese, se si desidera la sua liberazione dal Giappone e dagli altri oppressori, fate attenzione a non dimenticare che la vostra politica deve essere lungimirante quando si tratta di un popolo come il mongolo il cui destino è strettamente collegato con il vostro.
Questo è lo stato delle cose riguardo ai principali popoli che sono i più oppressi nell’Estremo Oriente e i cui rappresentanti sono qui. Ma noi abbiamo invitato ugualmente a questo Congresso i rappresentanti delle nazioni che opprimono. Possiamo vedere qui un certo numero di rappresentanti giapponesi, la qual cosa, credo, sia una corretta indicazione e la prova che la Internazionale Comunista è sulla giusta strada per risolvere il problema dell’Estremo Oriente. Non esiste soluzione senza il Giappone: il proletariato giapponese tiene nelle sue mani la chiave della soluzione del problema dell’Estremo Oriente, e la presenza a questo Congresso dei rappresentanti dei lavoratori giapponesi è la nostra sola e seria garanzia che stiamo almeno partendo dal nostro metodo per trovare la soluzione a questo problema.
I giapponesi sono conosciuti come i prussiani dell’est. Una parte della borghesia giapponese è orgogliosa di questo nome. Essa prova a condizionare i lavoratori giapponesi con il veleno del patriottismo, proprio allo stesso modo degli imperialisti britannici, che in parte sono riusciti ad avvelenare i lavoratori britannici. Non ci può essere nulla di più triste che vedere, per esempio, l’atteggiamento dei lavoratori britannici riguardo alla questione irlandese, un atteggiamento che non sempre è quello che dovrebbe essere da parte dei lavoratori; in qualche maniera si sente che hanno assimilato insieme al latte materno i pregiudizi nazionali con i quali la borghesia britannica li ha coscienziosamente impregnati. Bene, diciamolo apertamente, qualche volta troviamo che anche i comunisti britannici hanno un modo sbagliato di trattare la questione irlandese. Fu Marx che 50 anni fa aveva già detto che la classe operaia britannica non sarebbe stata in grado di emanciparsi a meno che non si emancipasse l’Irlanda. Sebbene riconoscano il principio, il loro atteggiamento verso l’Irlanda, verso gli operai e i contadini irlandesi è rozzo e sprezzante. Non ci sono dubbi, la borghesia giapponese vuole fare esattamente la stessa cosa con i suoi operai rispetto alla Cina e alla Corea, e così provano ad iniettare nella giovane classe operaia giapponese la nota malattia dello sciovinismo.
Ma noi speriamo che il senso di autoconservazione del giovane proletariato giapponese prevarrà contro il pericolo di essere ammorbati da questa seria malattia. A questo Congresso, quando per la prima volta vediamo un gruppo considerevole di operai giapponesi, consideriamo nostro dovere dire tutto quello che si pensa su questo argomento, fraternamente, francamente e onestamente. Alla luce di tutte le esperienze fatte dall’Internazionale Comunista in tutti gli altri paesi, riteniamo necessario metterli in guardia contro l’abile e insidioso gioco che stanno praticando su di loro i capitalisti inglesi, e anche i capitalisti giapponesi ci stanno provando.
La chiave di volta della questione dell’Estremo Oriente è nelle mani del Giappone. Marx ha detto che senza una rivoluzione in Inghilterra ogni rivoluzione in Europa sarebbe come una tempesta in un bicchiere d’acqua. Bene, mutatis mutandis lo stesso si può dire della rivoluzione in Giappone, che senza di essa ogni altra rivoluzione nell’Estremo Oriente sarebbe un fatto locale e in confronto poco importante. La borghesia giapponese domina e opprime molti milioni di uomini nell’Estremo Oriente, tenendo nelle sue mani il destino di tutta quella parte di mondo. La sola cosa che può veramente risolvere la questione dell’Estremo Oriente è la sconfitta della borghesia giapponese e la vittoria finale della rivoluzione in Giappone. Solo dopo la vittoria in quel paese la rivoluzione nell’Estremo Oriente cesserà di essere “una tempesta in un bicchiere d’acqua”. La responsabilità maggiore è del giovane proletariato giapponese.
Le nostre informazioni sono lontane dall’essere complete (questa è la prima occasione che abbiamo per un incontro amichevole con gli operai giapponesi), ma anche quel poco che sappiamo dimostra che il movimento dei lavoratori giapponesi sta iniziando a risvegliarsi e ad organizzarsi. Per molti aspetti sta ancora passando lo stadio della malattia infantile.
Il Giappone ha quasi tre milioni di operai (stime attuali dicono molti di più). È vicino ad avere 5 milioni di contadini nullatenenti. Il Giappone sta vivendo uno sviluppo irruente del capitalismo, ciò nonostante vediamo il movimento dei lavoratori in Giappone ancora molto debole. Comunisti con coscienza di classe nel paese sono poche centinaia. Il numero dei rivoluzionari, sindacalisti, anarchici, ammonta solo a qualche centinaio. Dalle rivolte del riso del 1918, (il grande movimento elementare di massa) la borghesia giapponese, a quanto pare, non ha avuto occasioni per lottare contro ampi movimenti rivoluzionari. Se esaminiamo la situazione giapponese nel momento attuale, da una certa distanza, come è, arriviamo alla conclusione che la borghesia giapponese si avvantaggia del fatto che il Giappone è nella fortunata posizione di poter raccogliere i frutti dell’impetuosa crescita a larga scala del capitalismo e diventare favolosamente ricca. Fino ad oggi non ha avuto bisogno di guardare l’altra faccia della medaglia, e non ha ancora visto il saluto col pugno alzato del movimento operaio giapponese. Il destino del movimento operaio giapponese sta acquisendo una importanza internazionale enorme.
Ho già parlato a proposito della alleanza delle quattro sanguisughe sancita a Washington (in stretta collaborazione, per il momento), con lo scopo di spezzare, torturare, e dividere i popoli oppressi dell’Estremo Oriente, con maggiore ferocia di quanto non è stato fino ad ora. Questa quadruplice alleanza di sanguisughe, in ogni modo, non può rimandare l’ora della inevitabile gigantesca guerra nell’Oceano Pacifico. Questa guerra è inevitabile. Sicuro, come al giorno segue la notte, così la fine della prima guerra imperialista sarà seguita da una seconda guerra, il cui centro ruoterà intorno all’Estremo Oriente e al problema del Pacifico. Questa guerra potrà essere evitata solo dalla rivoluzione proletaria. Non è possibile dire quando questa guerra scoppierà, se nel 1925 o nel 1928, anno più anno meno, ma è inevitabile. E non può essere evitata dal destino. Sarà possibile evitare questa guerra se la giovane classe operaia giapponese rapidamente diventa sufficientemente forte da agguantare la borghesia giapponese per la gola, e se parallelamente con questo ci sarà un movimento rivoluzionario vittorioso in America.
Se la guerra civile scoppia in America, sarà qualcosa di molto superiore a ciò che abbiamo visto finora. Sarà portata avanti con spietata caparbietà. È giusto quello che affermano i compagni americani, che quando la lotta fra la borghesia e gli operai raggiungerà lo stesso livello raggiunto in Russia, intere città salteranno in aria, la borghesia americana lotterà con tale disperazione da produrre una terribile catastrofe, che in confronto, la lotta in Russia apparirà come un gioco da ragazzi. La resistenza della borghesia americana sarà molto determinata. Non meno determinata sarà la resistenza dell’avida e abile borghesia giapponese, giusto adesso al suo apice. Solo una parallela e rapida crescita di una forte organizzazione del giovane movimento operaio del Giappone e di America sarà capace di salvare l’umanità da un’altra guerra e prevenire una tremenda distruzione dell’industria, che risulterebbe da una guerra senza precedenti distruttiva fra America e Giappone.
Abbiamo il diritto quindi di affermare che il destino di diverse centinaia di milioni di persone che vivono in Cina, in Corea, e in Mongolia sono nelle mani della classe operaia giapponese. E l’obbiettivo di questo Congresso è quello di coordinare l’attività degli oppressi, le masse non proletarie dell’intero Estremo Oriente, con il proletariato industriale e delle campagne del Giappone. Voi, piccolo gruppo di avanguardia operaia del vostro paese, voce del pensiero e delle aspirazioni di centinaia di milioni di oppressi dell’Estremo Oriente, dovete trovare la felice soluzione che potrà realmente coordinare il movimento della giovane classe operaia del Giappone, con quello non proletario delle grandi masse di quei paesi che sono oppressi dal Giappone.
L’Internazionale Comunista assicurerà ogni coordinamento, il coordinamento con la classe operaia d’America, Inghilterra, Francia e delle altre nazioni che partecipano allo sfruttamento e alla spartizione dei profitti nell’Estremo Oriente, che partecipano alla alleanza delle quattro sanguisughe; il compito del coordinamento a scala mondiale del movimento deve essere preso dal Comintern tutto intero, perché lo considera la ragione più importante per la sua esistenza. Il Comintern ha scritto sulla sua bandiera “Rivoluzione Mondiale”, non la rivoluzione solo europea. La rivoluzione europea è una parte, un piccolo angolo sulla mappa della rivoluzione mondiale. Comprendiamo perfettamente bene che è nostro interesse non perdere mai di vista queste prospettive, fare tutto questo per realizzare la giusta cooperazione e coordinamento delle forze dell’Estremo Oriente con quelle della classe operaia d’America ed Europa. Ma l’iniziativa è nelle vostre mani, e dipenderà in larga misura da voi il corretto coordinamento degli interessi del proletariato con quelli delle masse non proletarie dell’Estremo Oriente, per i quali la libertà nazionale e l’indipendenza sono obbiettivi di principale importanza.
I sentimenti espressi qui non sono ancora quelli comunisti, sta semplicemente crescendo una eccitazione rivoluzionaria nazionale. Sarete capaci di attuare l’unione del movimento nazionale rivoluzionario con il più robusto movimento proletario i cui obbiettivi sono di carattere puramente comunista? Questa unione è necessaria e inevitabile. L’Internazionale Comunista ha capito l’inevitabilità di questa unione dall’inizio della sua esistenza. L’Internazionale Comunista nel suo secondo Congresso ha considerato la questione delle nazionalità oppresse come una questione particolarmente importante.
Vi dilungherete sulle politiche dei vari partiti nell’Estremo Oriente con maggiori dettagli. Non ho bisogno di parlare molto a lungo su questa questione. Voglio solo sottolineare il nostro atteggiamento in generale sui problemi del vostro Congresso in connessione con la situazione internazionale. Devo ricordarvi delle decisioni del secondo Congresso dell’Internazionale Comunista del 1920, che in nome degli operai comunisti del mondo dichiarò che non potevamo limitarci allo slogan sull’eguaglianza di tutte le nazioni. Che l’eguaglianza di tutte le nazioni sia necessaria è una semplice verità conosciuta da tutti noi. Dobbiamo affrontare una situazione nella quale se una nazione domina un’altra questa dovrebbe sembrare selvaggia e barbara.
Ma non possiamo fermarci qui. Molto spesso la borghesia contrabbanda le falsità borghese sotto la parola dell’uguaglianza di tutte le nazioni. L’Internazionale Comunista sa pienamente e chiaramente che i popoli oppressi dovrebbero unirsi intorno ad un paese, la Russia Sovietica. Questo non è stato pronunciato da un solo partito, 43 partiti rappresentati al secondo Congresso, provenienti da tutto il mondo, lo hanno dichiarato. Si sono presi in proprio la responsabilità per la Russia Sovietica, e hanno invitato tutti i popoli oppressi a raccolta intorno al primo paese dove per la prima volta nella storia la questione nazionale ha trovato una felice soluzione. Certo, molte altre questioni non sono ancora state risolte dalla Russia Sovietica, molte questioni, in particolare nel campo economico, non sono ancora state risolte, ci sono ancora molte piaghe aperte che sono causa di grandi sofferenze per la Repubblica Sovietica, ma c’è una questione che non esiste più in Russia, la questione nazionale. La questione nazionale è stata risolta nella Repubblica Sovietica con inusuale facilità, in modo abbastanza indolore, con la completa soddisfazione di tutte quelle nazionalità che facevano parte dell’Impero russo e adesso vivono nella Repubblica dei Soviet.
Solo l’altro giorno il Comitato Centrale Esecutivo di tutta la Russia ha deciso su alcune questioni nazionali nelle repubbliche autonome e alcuni distretti dell’Estremo Oriente e in Siberia, e sono state risolte facilmente e in modo indolore. Sapete che la Russia è abitata da decine di nazionalità che languivano sotto un giogo pesante. Sapete che durante il dominio zarista, e il dominio della borghesia, subivano molti torti tanto che odiavano e rifiutavano qualsiasi cosa fosse russo. Ciò che la borghesia e la nobiltà, nel corso di decenni e secoli, hanno rovinato, la classe operaia russa, onestamente e senza molta fatica ha restaurato in pochi mesi: risolvere la questione nazionale con metodi fraterni fino alla completa soddisfazione di tutte le nazionalità che hanno vissuto e vivono nella Russia dei Soviet. È per questo che abbiamo il coraggio di ritenere, a questo proposito, che diamo un esempio concreto di vita in carne e ossa. Non abbiamo più bisogno di discussioni astratte. Abbiamo un esempio di come una nazione, sconfitta la sua borghesia, possa risolvere i suoi problemi nazionali.
Questo è il motivo per cui il Secondo Congresso del Comintern ha, come deve avere, il coraggio di fare appello a tutti i popoli oppressi, inclusi quelli dell’Estremo Oriente, di stringersi intorno a quel paese che ha avuto varie esperienze in questo campo, la Russia dei Soviet, in modo che insieme alla Russia Sovietica possano risolvere i penosi problemi nazionali che rimangono ancora aperti per milioni di uomini. Il Secondo Congresso ha sciolto gli stessi fondamentali problemi che voi avete da risolvere, il coordinamento delle forze dei risvegliati popoli oppressi, che stanno conducendo una lotta che non è ancora la lotta per il socialismo, ma per la loro emancipazione insieme alla lotta del proletariato, in quei paesi dove un proletariato esiste.
Cina, Corea e Mongolia non sono da incolpare perché non hanno un proletariato industriale. Non possono saltare immediatamente diversi passaggi dello sviluppo. Non vi è nulla di male in questo. Ma sarà un disastro se falliremo l’unione con il movimento operaio in Giappone ed America.
Noi non siamo dottrinari né settari. Non abbandoniamo né abbandoneremo le basi del Comunismo. Noi esalteremo il Comunismo dovunque, anche in piccolo gruppo. Ma nello stesso tempo vivremo e combatteremo spalla a spalla con i milioni che vivono e combattono contro questo mondo crudele, e li prendiamo come sono. Consiglieremo i nostri compagni, cinesi, coreani e comunisti giapponesi, che per il momento sono un piccolo gruppo, a non farsi da parte e guardare dall’alto in basso con disprezzo ai derelitti come anime peccatrici che non sono ancora diventati comunisti, ma di andare correttamente fra le decine di milioni di uomini che stanno lottando in Cina, gente che contemporaneamente sta combattendo per la sua indipendenza ed emancipazione nazionale. Devono andare correttamente fra loro e diventare i loro dirigenti. Questo è essenziale, perché la storia ha messo in rilievo questa questione in modo definitivo. La soluzione della questione nazionale non sta a Washington ma solo nelle loro mani.
Ai capi del movimento nazionale diciamo: revocate la fiducia in Versailles e in Washington. Non credete agli intrighi di queste borghesie. Ricordate che il processo storico così pone la questione: o conquisterete la vostra indipendenza, fianco a fianco con il proletariato, o non vincerete niente; o riceverete la vostra emancipazione dalle mani del proletariato, in coordinamento con esso, sotto la sua guida, o siete destinati a rimanere schiavi delle fazioni inglesi, americane e giapponesi; o le centinaia di milioni di lavoratori di Cina, Corea, Mongolia e altri paesi capiscono che il loro alleato e dirigente è il proletariato mondiale e, una volta per tutte, rinunciano a tutte le speranze in ogni tipo di manovra della borghesia e dell’imperialismo, o i loro movimenti nazionali saranno condannati al fallimento, e avranno sempre sulle spalle gli imperialisti a seminare guerra civile, oppressione, per spartirsi il loro paese.
La questione si presenta in questo modo, non teoricamente, con degli scritti, non è la fantasia di qualche capo, ma si è dimostra nel processo di sviluppo della storia mondiale, nello sviluppo dell’imperialismo mondiale che spinge in avanti il problema dell’Estremo Oriente a un posto di primaria importanza. Questo è ciò per cui l’Internazionale Comunista si rivolge a entrambe le sezioni del Congresso: a quella composta da comunisti coscienti, con la funzione di organizzare la classe operaia per la vittoria sulla borghesia, e a quella sezione composta da elementi non proletari, a quei dirigenti delle masse lavoratrici che stanno lottando contro l’oppressione straniera. Una alleanza fra questi due gruppi è essenziale, e faremo il gioco della borghesia se con ogni mezzo indeboliremo questa alleanza. Il nostro congresso acquisirà una importanza storica universale, se riusciamo a far avanzare verso la soluzione di questo problema, del coordinamento e della cooperazione fra queste due gigantesche forze della storia mondiale.
Il compagno Lenin ha detto spesso, le centinaia di milioni di uomini nell’Estremo Oriente, parole sue, sono le ultime riserve dell’umanità. Infatti lo sono. Oggi, dopo molti anni di lotta, il proletariato russo sanguina ancora a morte come avanguardia della rivoluzione proletaria mondiale, e non intende abbandonare il suo posto. Ma anche se conseguiamo la vittoria in Europa, la nostra non sarà una vittoria finale fino a quando la questione dell’Estremo Oriente non sarà risolta, fino a quando le ultime riserve dell’umanità non si saranno risvegliate e le masse di molti milioni di uomini dei paesi che qui rappresentate non si saranno risvegliati.
Questo Congresso, che avviene nelle condizioni più difficili, mentre gli ipocriti predoni riuniti a Washington, ben lungi da esser morti, cantano in coro, non è molto forte numericamente, ma è importante per la sua qualità, per il suo compito storico e mondiale. Questi predoni imperialisti andranno all’incontro di Genova molto presto, e là proveranno a soffocare la Russia Sovietica. Non dimenticate che voi, i molti milioni di uomini dell’Estremo Oriente, siete oggi l’unico ricco boccone che non si sono ancora spartiti.
Oggi le borghesie nel mondo non sono loro stesse al corrente di quello che sta accadendo, e che cosa il futuro riservi loro; non sanno cosa le aspetta quando si risveglieranno, se sono alla vigilia di un nuovo periodo di prosperità o sull’orlo della rovina; e in questo momento siete quelli il cui peso sarà decisivo. Se questo risveglio dei popoli dell’Estremo Oriente procederà rapidamente, in modo organizzato ed energicamente, se dichiarerete la guerra al vostro sonnacchioso Oriente, se voi, che rappresentate gli elementi più avanzati dei vostri popoli, condurrete la loro battaglia senza alcuna considerazione per gli inevitabili sacrifici, e se capirete che il vostro vero dirigente è il Comintern, allora molti di voi vivranno per vedere la vera e finale vittoria della rivoluzione mondiale.
(Alti applausi)