|
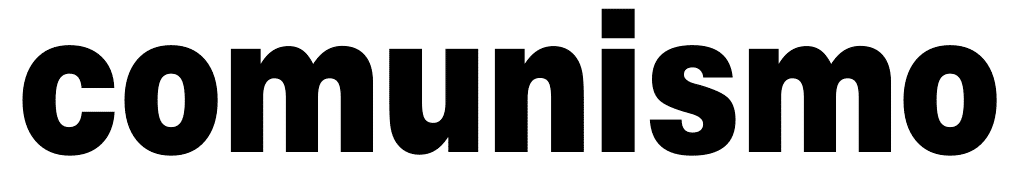 |
n. 93 - giugno 2022 - Anno XLIV aggiornato al 17 luglio 2022 |
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Dovrebbe essere evidente a tutti che le parole dei vari capi di Stato, emanazione delle rispettive borghesie, non valgono nulla. Altrettanto vale per i trattati internazionali, che permangono finché permangono i rapporti di forza che li hanno generati: l’unico diritto esistente, internazionale e non, è quello del più forte.
Oggi i vari Biden, Putin, Xi, Draghi, ecc., fanno a gara nel dichiararsi fautori della pace. Solo costretti dai cattivi di turno, devono, talvolta, e anche spesso, fare guerre. Ma non sono tali, sono “operazioni militari speciali”, “missioni internazionali di pace”.
Al lungo elenco di fautori della pace ne aggiungiamo altri due, si chiamavano Adolfo e Benito.
Leggiamo dal discorso di Mussolini pronunciato il 28 settembre 1937 a Berlino:
«Nazismo e fascismo hanno in comune molte concezioni della vita e della storia. Entrambi credono nella volontà come forza determinante la vita dei popoli, come motore della loro storia, e quindi respingono le dottrine del cosiddetto materialismo storico e dei suoi sottoprodotti politici e filosofici. Entrambi noi esaltiamo il lavoro – nelle sue innumerevoli manifestazioni – come il segno della nobiltà dell’uomo (...) Quello che è ormai conosciuto nel mondo come l’Asse Berlino‑Roma, nacque nell’autunno del 1935 e ha in questi due anni magnificamente funzionato per un sempre maggiore riavvicinamento fra i nostri due popoli e per una più effettiva politica di pace europea».
«La riaffermazione solenne dell’esistenza e della solidità dell’Asse Roma‑Berlino non è diretta contro altri Stati, poiché noi, nazisti e fascisti, vogliamo la pace e siamo sempre pronti a lavorare per la pace, per la pace vera e feconda, che non ignora ma risolve i problemi della convivenza fra i popoli. Alla gente che, ansiosa, in tutto il mondo si domanda che cosa può uscire dall’incontro di Berlino – guerra o pace – il Fűhrer e io possiamo rispondere insieme a voce alta: la pace».
Sembra di ascoltare gli odierni notiziari.
La pace dei capitalisti, democratici o no, è la pace dei cimiteri. Alla loro pace del 1937 è seguita due anni dopo la guerra mondiale. Ai discorsi di pace dei vari capi di Stato odierni seguirà, domani o fra pochi anni, inevitabilmente una guerra generale.
Guerra che una propaganda idiota, ma non per questo inefficace, presenta dovuta alla malvagità o alla pazzia di qualche “grande della terra”. C’è sempre un Caligola che viene fuori, ma, quando anche fosse, nessuno si domanda da quale società è prodotto.
In realtà i presunti grandi non decidono nulla: sono delle marionette nelle mani delle rispettive borghesie nazionali, o delle borghesie dei centri imperialisti attorno a cui gravitano. Questo anche quando hanno l’illusione di non esserlo, e di dare ordini alla propria borghesia, come è stato, tra gli altri, per Napoleone, per Hitler, per Stalin.
La guerra su scala mondiale non verrà a causa di qualche Caligola, ma per la necessità del modo di produzione capitalistico di sopravvivere alle proprie crisi, distruggendo merci e produttori di merci, per poi ricominciare un nuovo ciclo espansivo.
Solo il risveglio del proletariato mondiale può evitare la guerra, inquadrato nei suoi sindacati di classe e guidato dal suo partito comunista internazionale.
Che una guerra generale non tarderà a scoppiare, entro pochi anni, lo abbiamo previsto e lo confermiamo. Troppi i segnali e troppo pesanti le cause che spingono questo fradicio sistema produttivo verso l’immane catastrofe.
Tutti gli Stati negli ultimi decenni hanno condotto una costante politica di riarmo, nonostante la crisi economica, e più recentemente nonostante la pandemia. Essi puntano proprio sulla produzione di armamenti sempre più costosi e sofisticati, sul loro commercio, sul loro uso sempre più massiccio, per allontanare e superare la crisi di sovrapproduzione che in tutto il mondo attanaglia il capitalismo.
Riportiamo qui i dati raccolti dall’Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace, di Stoccolma (Sipri), pubblicati alla fine dello scorso mese di aprile.
Se ne deduce che l’anno scorso, secondo anno di pandemia, la spesa militare mondiale è tuttavia cresciuta dello 0,7% in termini reali rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2.113 miliardi di dollari. Questo il commento dei ricercatori del Sipri: «Nel pieno delle ricadute economiche della pandemia da Covid 19, le spese militari mondiali hanno raggiunto livelli record».
Gli Stati Uniti campeggiano al primo posto con una spesa di 768 miliardi di dollari, fatto costante sin dalla fine della seconda guerra mondiale. Ma da notare la diminuzione dell’1,4% rispetto al 2020. La spesa militare è diminuita anche in percentuale del PIL passando dal 3,7 al 3,5%.
Nell’ultimo decennio l’impegno militare degli USA è andato relativamente riducendosi rispetto a quello degli altri Stati: se nel 2009 rappresentava il 48% del totale mondiale, nel 2021 si era ridotto al 38%. C’è una diminuzione del peso dell’imperialismo statunitense riguardo alle altre potenze.
Al secondo posto la Cina che, aumentando la spesa militare, come da decenni, l’ha portata nel 2021 a circa 270 miliardi di dollari, con un aumento annuo del 4,7%: mentre nel 2009 rappresentava il 12% della spesa complessiva mondiale ora ne rappresenta il 14%.
Al terzo posto l’India con 74 miliardi di dollari e un aumento dello 0,9% rispetto al 2020. Allo scopo di rafforzare l’industria nazionale degli armamenti il 64% del suo bilancio militare del 2021 è destinato all’acquisizione di armi prodotte nel paese.
La Federazione Russa, che ancora nel 2009 si trovava all’ottavo posto per spesa militare, negli ultimi anni è salita al quarto. L’impegno nel 2021 è aumentato del 3% circa rispetto all’anno precedente e rappresenta il 4% del PIL. Osserva il Sipri: «Gli elevati profitti derivanti dalla vendita del gas e del petrolio hanno aiutato la Russia ad accrescere la sua spesa militare nel 2021. Questa era diminuita tra il 2016 e il 2019 a causa del basso prezzo dei prodotti energetici e delle sanzioni inflitte al Paese in risposta all’annessione della Crimea».
Tra gli Stati d’Occidente che negli ultimi anni hanno notevolmente aumentato il bilancio militare troviamo anche la Gran Bretagna, nonostante i problemi derivanti dall’uscita dall’Europa Unita e quelli causati dalla pandemia. Raggiunto il massimo nel 2009 con 65 miliardi di dollari, nel 2017 era scesa a un minimo con 54 ma è risalita ai 62,5 nel 2021.
Un altro membro della Nato che sta aumentando l’esborso militare è la Germania, già aumentato circa dell’8% nell’ultimo quinquennio ma il cui governo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ha annunciato un piano da 100 miliardi di euro per la modernizzazione dell’esercito. Pochi giorni dopo, le azioni delle aziende che producono armamenti sono salite alle stelle: +90% per Hensoldt e +50% per Rheinmetall.
Anche l’Italia ha annunciato un piano di riarmo seppure di consistenza minore rispetto a quello tedesco. E anche le azioni di Leonardo e Finmeccanica sono in salita.
Impegnata in un vasto piano di riarmo è la Polonia, lunga mano degli Stati Uniti all’interno della UE che, insieme ai tre piccoli Stati baltici, è schierata apertamente contro la Russia.
I principali Stati occidentali riarmano, presentando la mossa come la necessaria, ma non sofferta, risposta alla politica guerrafondaia della Russia, una minaccia per tutti gli Stati d’Europa. Se è vero che la borghesia russa si sta dando a una politica imperialista e terrorista, la stessa politica è praticata dai capitalisti d’occidente, dalla Nato, dagli USA, dalla Gran Bretagna, tant’è che negli ultimi anni la corsa al riarmo è ripresa in tutti gli Stati più industrializzati d’Europa e del mondo.
Non diversa situazione nel Pacifico, nuovo epicentro del prossimo scontro tra i massimi imperialismi, dei quali tre Paesi, il Giappone, la Corea del Sud e l’Australia, erano presenti al vertice NATO di Remstein dello scorso aprile. Il Giappone è impegnato in uno sforzo crescente di riarmo. Dalla fine della seconda guerra la sua spesa militare non ha superato l’1% del PIL, ma l’anno scorso al bilancio militare per il 2021 il governo ha aggiunto 7 miliardi di dollari con aumento del 9% rispetto all’anno precedente, corrispondente all’1,24% del PIL. Il Partito Liberaldemocratico di Kishida ha dichiarato che intende arrivare al 2%. Anche la Corea del Sud continua a riarmarsi e a sviluppare l’industria nazionale di armamenti, come anche l’Australia. Questa, aderendo all’accordo trilaterale con USA e Gran Bretagna, si è impegnata ad acquistare da Washington otto sottomarini a propulsione nucleare per l’astronomica cifra di 128 miliardi di dollari. «La presenza sempre più assertiva della Cina verso i mari della Cina orientale e meridionale è divenuta la causa principale delle spese militari dell’Australia e del Giappone», spiega il Sipri, sposando la tesi del militarismo filo americano. Ma anche la Cina giustifica il proprio riarmo con la necessità di difendere un suo “spazio vitale”, soprattutto le linee di comunicazione dai suoi porti al mondo.
Il regime capitalistico ha bisogno di guerra, di una grande guerra dispiegata. A questa gli Stati si stanno preparando attivamente. Ogni capitalismo nazionale giustifica il suo riarmo creandosi un nemico. L’Ucraina ha accusato la Russia di averla proditoriamente attaccata, Mosca risponde che erano anni che denunciava la minaccia dalla estensione verso Est della Nato e dalle sue manovre in Ucraina. La Corea del Sud lo motiva con la minaccia proveniente dalla Corea del Nord, ma anche dal Giappone; l’India perché teme la Cina e il Pakistan, ecc. ecc. Il morente capitalismo ha solo da temere, da amici e da nemici. Oltre che dal vero unico suo nemico storico, la internazionale classe operaia.
Rileviamo i bilanci in forte crescita anche del Pakistan, sottoposto a forti tensioni col crescere dell’antagonismo tra Cina e Stati Uniti, e della Turchia, impegnata su più fronti: dalla Libia, alla Siria, al Mediterraneo orientale, ove la Grecia si prepara apertamente allo scontro militare con Ankara.
Quali gli altri attori di primo piano del militarismo, lo mostra la tabella che segue. Riporta l’entità della spesa militare dei primi 20 Paesi, dalla grande crisi economica del 2009 fino al 2021. Questi 20 Stati rappresentano l’80% della spesa militare mondiale.
| Rango | 2009 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| 1 | USA | 852 | 690 | 753 | 778 | 768 | |
| 2 | Cina | 126 | 209 | 246 | 258 | 270 | |
| 3 | 4 | India | 55 | 63 | 75 | 73 | 74 |
| 4 | 8 | Russia | 45 | 74 | 60 | 62 | 63 |
| 5 | 3 | Gran Bretag. | 65 | 55 | 58 | 61 | 62 |
| 6 | 7 | Giappone | 47 | 48 | 50 | 52 | 58 |
| 7 | 5 | Arabia Saud. | 53 | 66 | 68 | 65 | 54 |
| 8 | 6 | Francia | 52 | 51 | 51 | 53 | 54 |
| 9 | Germania | 42 | 43 | 50 | 53 | 52 | |
| 10 | Corea d.Sud | 32 | 38 | 44 | 46 | 48 | |
| 11 | Italia | 31 | 27 | 27 | 29 | 30 | |
| 12 | 13 | Australia | 21 | 26 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 14 | Canada | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| 14 | 17 | Israele | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 |
| 15 | 16 | Brasile | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 |
| 16 | 15 | Spagna | 19 | 15 | 17 | 17 | 18 |
| 17 | 12 | Iran | 23 | 20 | 16 | 16 | 18 |
| 18 | Turchia | 10 | 13 | 19 | 17 | 17 | |
| 19 | Polonia | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | |
| 20 | Pakistan | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | |
| Mondo | 1768 | 1786 | 1932 | 1993 | 2113 | ||
Nella prima colonna è riportata la classifica degli Stati per spesa militare nel 2021; nella seconda colonna quella al 2009.
Si comprende come l’importo della spesa militare sia solo uno dei parametri che permettono di valutare l’effettiva potenza militare di uno Stato; molti altri vi concorrono, dall’estensione territoriale alla posizione geografica, al numero di abitanti, alla capacità industriale e agricola, al numero di militari in servizio attivo, ecc. È evidente che mantenere delle Forze Armate numerose con la coscrizione obbligatoria o ad altri sistemi di reclutamento permanente, come nel caso degli USA, della Cina, della Russia, o della Turchia e della Grecia in ambito UE, assorbe grandi risorse economiche, ma la guerra in Ucraina sta dimostrando che la disponibilità di carne da macello da schierare al fronte, come stanno facendo Ucraina e Russia, è indispensabile in una vera guerra tra Stati industrialmente sviluppati.
I dati sulla spesa militare inoltre, dichiara il Sipri, spesso sono falsati dai governi. Bisogna anche considerare che lo stesso sistema d’arma, come qualsiasi altra merce, può costare cifre diverse nei diversi Paesi.
La tabella non contrsta con la previsione di qualche esperto militare che prevede che gli Stati Uniti siano indotti ad affrontare militarmente la Cina entro una decina di anni: dopo Pechino potrebbe competere da pari con Washington. Questa valutazione coincide con alcune nostre considerazioni sui tempi della crisi generale, e confidiamo finale, dell’economia capitalistica. Ogni anno la Cina rafforza il suo apparato militare mentre gli Stati Uniti fanno fatica a mantenere il loro livello di supremazia. Questo non solo nei confronti della Cina ma anche del Giappone, della Corea del Sud, di Paesi europei come la Germania. In questa prospettiva anche la guerra russo ucraina può essere interpretata come il tentativo statunitense di indebolire la Russia, possibile alleato di Pechino, prima di affrontare quel nemico principale.
Difficoltà dell’imperialismo statunitense
A proposito delle difficoltà che incontra la classe dominante statunitense nel mantenere la posizione di dominio strategico di cui gode bisogna considerare, fra l’altro, quanto costa in termini di risorse finanziarie e umane il mastodontico apparato militare messo su nei decenni seguiti alla Seconda guerra mondiale. Le basi degli Stati Uniti, in un primo tempo presenti nei paesi usciti sconfitti, in particolare in Germania occidentale e Giappone, si sono in seguito estese a decine di altri. Attualmente sono le più numerose e grandi al mondo, si stimano nel 95% di quelle di tutti gli Stati. Il rimanente 5% se lo dividono Gran Bretagna, Francia, Russia, Cina e pochi altri. Si calcola che nel 2017 fossero dispiegati all’estero quasi 200.000 uomini, il 10% del personale militare statunitense, in 800 basi militari in ben 177 paesi. Il costo del loro mantenimento in attività è stimato a più di 150 miliardi di dollari all’anno, il doppio dell’intero bilancio militare dell’India, per un confronto. Dunque una superpotenza che si è assicurata una ramificata presenza sul pianeta ma che assorbe da sola il 20% del suo bilancio militare.
A queste basi terrestri si aggiungono le flotte che controllano oceani e mari. Scrive la rivista Limes: «Avviluppando il territorio continentale in due impenetrabili cuscinetti oceanici, la supremazia della Marina americana ha garantito agli Stati Uniti la sicurezza e la vitalità economica necessarie a giocare un ruolo attivo a livello globale. A sua volta, questo ha permesso alla superpotenza di condurre rapide operazioni militari nel Sud‑Est asiatico, in Medio Oriente e in America Latina, e prevenire dunque l’emergere di potenze egemoni in queste regioni» (luglio 2019).
Questa supremazia ha consentito agli USA di prolungare il loro ordine globale. Imponendo il dollaro quale moneta di riferimento internazionale hanno potuto riversare sugli altri Paesi una parte di questo enorme fardello. Da quando, nell’agosto del 1971, fu decretato lo sganciamento del dollaro dall’oro, annullando gli accordi di Bretton Woods, il mondo capitalista ha dovuto finanziare ogni anno lo strutturale deficit della bilancia commerciale statunitense e l’enorme debito pubblico nordamericano provocato dal mantenimento di uno spropositato apparato bellico, sulle spalle del proletariato americano e degli altri Paesi.
Il non più sostenibile attuale ordine mondiale a guida statunitense, spesso messo in evidenza dalle alte gerarchie cinesi, russe e di altri Paesi, non verrà modificato pacificamente dalla stipula di trattati internazionali o di una ”sana competizione” nel campo dell’industria e del commercio, non sarà così, in questa fase di decadenza estrema del capitalismo. Ogni contrasti non potrà che deflagrare in un generale conflitto armato verso cui spinge la pressante crisi economica generale. Starà al proletariato internazionale, che già sta soffrendo i costi della crisi, dell’inflazione, delle guerre locali, ribellarsi a questa devastante prospettiva, opponendovi la sua prospettiva comunista e la sua internazionale sollevazione rivoluzionaria.
In Toscana
Più volte, nel corso di questa serie di rapporti sulla guerra civile in Italia ci siamo presi la libertà di forzare la cronologia degli avvenimenti. E lo faremo anche ora iniziando la esposizione delle battaglie sostenute dal proletariato toscano.
A fine luglio 1922 la Centrale del PCd’I inviava al settimanale fiorentino “L’Azione Comunista” il seguente messaggio:
«[...] Voi siete nella mischia con onore, voi foste fra i primi a ricevere l’urto delle guardie bianche, e tutti i proletari italiani ricordano la magnifica difesa che voi manteneste. Il nome di Spartaco Lavagnini vi appartiene, tanto più in quanto voi e il proletariato fiorentino avete saputo meritare la eredità di fede che egli ha lasciata.
«Nelle campagne della Toscana, nella vostra provincia, il terrore s’accanisce e morde e uccide e incendia. Giorni più duri si preparano per le classi lavoratrici della Toscana proletaria.
«È tempo di suonare la campana per cacciare i nuovi nobili invasori e i mercenari che loro ubbidiscono. Voi compagni di Firenze e della Toscana avete ancora delle responsabilità da assumere. Noi sappiamo che il cuore non vi trema, e che i vostri morti saranno presto vendicati.
«Noi salutiamo il vostro giornale, a nome di tutto il partito, a nome dei proletari comunisti della Valle Padana e dell’Emilia. Fate che esso viva contro la ruggente rabbia del nemico. Tenetelo alto come una bandiera e difendetelo. Nel nome del suo primo direttore caduto nella guerra di classe, voi, compagni fiorentini, condurrete il vostro forte schernitore proletariato alla inevitabile riscossa.
«Con saluti fraterni – Il Comitato Esecutivo».
Ma il battagliero settimanale fiorentino non ebbe il tempo di pubblicare il messaggio del C.E. del partito, infatti le pubblicazioni erano cessate per mancanza di fondi il 1° luglio 1922. Fu invece riprodotto con una breve presentazione da “L’Avvenire”, edizione pistoiese dell’“Azione Comunista”, il 22 luglio 1922: «Questa nobilissima lettera – che ci riempie di soddisfazione e d’orgoglio – sia d’incitamento ai compagni tutti nell’aspra battaglia ingaggiata contro i banditi del fascismo italiano. Le camicie nere – simbolo di ogni peggiore delinquenza – dilagano da un capo all’altro d’Italia e minacciano la vita, la casa e la famiglia di tutti coloro che lottano per la redenzione del popolo. In piedi, o lavoratori, per la tutela dei vostri diritti e della vostra libertà!»
Guerra con le armi a Firenze
«La prima di quelle che i fascisti chiamano “spedizioni punitive” si è avuta nell’ottobre scorso in un simpatico paese di collina, a Montespertoli. Una notte, verso le 11 e mezzo, alcuni individui al comando di Abatemaggio, quello famoso del processo Cuocolo, entrano in un caffè, sparano dei colpi di rivoltella, senza che i reali carabinieri intervengano e poi se ne vanno tranquillamente a letto, dopo aver commesso ogni sorta di violenze contro la pacifica popolazione di Montespertoli. Il giorno dopo però il proletariato di questo paese è in armi e i signori fascisti sono costretti a rifugiarsi nella caserma dei reali carabinieri, ma non vengono arrestati. Un camion di carabinieri, giunto da Firenze, trasporta gli eroi nella nostra città» (Fernando Garosi, intervento parlamentare dell’1 febbraio 1921).
Ma la vera offensiva contro il proletariato di Firenze e provincia si ha dai primi di novembre 1920; a partire da quella data si registrano sempre più spesso atti di violenza e terrore compiuti dai fascisti con la diretta partecipazione, appoggio, incitamento di carabinieri e guardia regia e la totale immunità garantita dalla magistratura.
Si arriva al 26 gennaio 1921: a Firenze circa 150 fascisti inquadrati e diretti da ufficiali e sottufficiali e seguiti da un plotone di guardie regie, si dirigono verso via Laura, dove si trova la tipografia del settimanale “La Difesa”, diretto da Spartaco Lavagnini. “La Difesa” era presidiata da un maggiore dei carabinieri, da un brigadiere e da molte guardie regie che, all’arrivo dei fascisti lasciarono libero il passaggio di modo che potessero effettuare indisturbati la distruzione del giornale. “La Nazione” del 30 gennaio, quotidiano filo‑fascista, non nascondeva la soddisfazione nel fare la cronaca dell’accaduto: «Entrati in tipografia i fascisti rovesciavano le cassette dei caratteri che si trovavano nella prima stanza, cospargevano al suolo due latte di petrolio trovate nello stesso locale, e quindi vi appiccavano il fuoco, tagliavano poi i fili della luce elettrica e del telefono e completavano la devastazione nelle altre stanze [...] Intanto, nel giro di pochi attimi, l’incendio divampava furioso estendendosi al deposito della carta. Compiuta la devastazione, i fascisti si allontanavano. In via dei Servi fermavano i due autocarri dei pompieri che sopraggiungevano a grande velocità tentando di farli tornare indietro».
Alla notizia della devastazione il proletariato fiorentino, senza aspettarne la proclamazione da parte della Camera del lavoro, scese immediatamente in sciopero: gli operai di ogni categoria abbandonarono il lavoro. Per due giorni la città rimase paralizzata: negli scontri che si susseguirono i fascisti più di una volta dovettero assaggiare l’ira proletaria. Lo sciopero generale interessò e si svolse compatto anche a Prato, Pistoia, Empoli, Arezzo. Ad Arezzo, alla notizia dell’incendio de “La Difesa”, gli operai della Sacfem abbandonarono immediatamente il lavoro e si diressero verso il centro della città dove, per prima cosa devastarono il negozio di un fascista e ne bastonarono il proprietario, poi dopo aver disperso, a suon di sonori cazzotti, gruppi di studenti in cerca di gloria, invasero e diedero alle fiamme la sede del Fascio Giovanile di Azione Liberale.
Firenze il 28 gennaio, due giorni dopo la devastazione de “La Difesa”, i fascisti davano l’assalto alla Casa del popolo del rione delle Cure, ma la popolazione del sobborgo non si lasciò sorprendere ed i fascisti, accolti a sassate e fucilate, furono costretti a darsi alla fuga abbandonando sul posto i camerati feriti, che furono raccolti e sottratti alla furia popolare dalla guardia regia prontamente accorsa in loro soccorso.
Non a caso il fiorentino Fernando Garosi, deputato comunista, il 1° febbraio aveva affermato alla Camera: «Il proletariato ha assistito a queste scene, dapprima un po’ disorientato; ha visto incendiare le sue Case del Popolo, stroncare le proprie organizzazioni, malmenare i propri capi, arrestare in massa gli organizzatori, uccidere tanta povera gente, ma oggi è pronto a vendicarsi [...] La borghesia e il Governo facciano il loro comodo! Il proletariato ha trovato la sua strada maestra, ha imparato da voi il modo di combattere. Esso vi dichiara già che di ogni attentato alla vita degli operai e di ogni attacco ai loro organismi si devono ritenere responsabili gli industriali e gli agrari, che provocano questi attacchi e che ne traggono profitto [...] Noi vinceremo. Viva il comunismo!».
Questa guerriglia strisciante, dove i fascisti attaccano, il proletariato reagisce e sul terreno restano altrettanti fascisti di quanti siano stati i proletari uccisi o feriti, questa guerriglia si protrasse ancora un mese, fino alla fatidica giornata del 27 febbraio.
Quel giorno, presso la Camera di Commercio di Firenze, veniva inaugurato il gagliardetto del “Gruppo studentesco liberale”. Dopo la cerimonia, un piccolo corteo di poco superiore al centinaio di persone, scortato dai carabinieri, iniziò a sfilare per le strade cittadine. Ma tra via Tornabuoni e via degli Antinori sui manifestanti fu lanciata una bomba che provocò la morte di un carabiniere ed una quindicina di feriti.
La pista rossa fu immediatamente data per scontata: il “Corriere della Sera” titolava “L’agguato dei comunisti“.
Fu invece subito chiaro che si trattasse di una “bomba addomesticata” (così venne definita). Chi poteva avere interesse a lanciare una bomba contro uno sgangherato corteo di studenti vocianti se non l’“ordine costituito” che doveva trovare un pretesto per stroncare la resistenza dell’indomito proletariato fiorentino? Nessun arresto fu fatto e nessuna inchiesta fu aperta per individuarne i colpevoli.
L’“Ordine Nuovo” dell’8 marzo scriveva: «La bomba fiorentina dà alla borghesia italiana l’occasione di inveire contro i “rossi” e di chiedere tutto il rigore della legge e, magari, l’adozione di leggi speciali contro di loro. Si direbbe che una mano sapiente ha diretto un complotto di una abilità diabolica [...] I “rossi”, quali che essi fossero, non avevano alcun interesse a lanciare una bomba sopra un corteo, per quanto questo fosse composto da elementi a carico dei quali gravavano parecchi reati contro i lavoratori. I risultati dimostrano quale parte la bomba abbia politicamente favorito. Ma il passato viene innanzi con le sue lezioni. È Chicago che ci rammenta la famosa bomba di Haymarket, che uccise anche alcuni “policemen”, e per la quale generosi condottieri del proletariato d’America penzolarono dalle forche ed il movimento per le otto ore fu ruinato. È Firenze stessa che ci rammenta le famose bombe di via S. Antonino, per le quali parecchi innocenti furono condannati all’ergastolo, ed il movimento della Prima Internazionale in Italia fu distrutto».
Lo stesso veniva sostenuto alla Camera l’8 marzo dal nostro compagno Caroti: «Consideriamo l’episodio della bomba, che si vuole sia l’origine dei fatti [...] Non sono stati dei proletari, non dei rossi, non dei socialisti che hanno lanciato la bomba [...] Vi siete domandati a chi poteva giovare la bomba? Vi pare che abbia giovato a noi sovversivi? [...] Sì! A qualcuno, che ha bisogno di intimidire il proletariato, di spezzare la resistenza delle organizzazioni proletarie. A quei pescecani che hanno bisogno di riportare il proletariato al regime di salario e di orario quale prevaleva 20 anni fa; e che capiscono che non è possibile opprimere il proletariato finch’esso sia difeso dalle sue organizzazioni e dalla fiducia nella sua forza! [...] Questo metodo, del resto, non è nuovo e non esclusivo dell’Italia. Crispi ha insegnato in materia. Rammentate le famose bombe del 1878, proprio a Firenze? Furono messi in galera 5 innocenti. Poi si seppe che non erano stati loro a lanciare le bombe. Rammentate la famosa bomba di Haymarket a Chicago che ammazzò sei poliziotti, mandò alla forca i leaders del movimento per le otto ore di lavoro e spezzò il movimento stesso? [...] Fu dimostrato che il lancio avvenne per opera di agenti segreti di chi aveva interesse a produrre lo scoramento e lo scompaginamento delle masse» (dal resoconto stenografico).
Nel corso della stessa seduta parlamentare il socialista Ciccotti dichiarava: «È stato un agente investigativo che a Bologna sparò contro le guardie regie, durante il corteo per la protesta in pro’ delle vittime politiche».
Anche l’“Avanti!” del 5 marzo evidenziava come la bomba di Firenze fosse come minimo sospetta; ma allo stesso tempo il giornale socialista non mancava di dichiararsi contrario ad ogni tipo di violenza e ricordava come i deputati socialisti fiorentini avessero «sottoscritto un manifesto che, lanciato alla cittadinanza, fece ottima impressione in ogni classe di cittadini». Certo, quello che premeva al partito socialista era di fare ottima impressione ad ogni classe di cittadini! Ma di questo manifesto parlaremo in seguito.
Nell’“Azione Comunista” dello stesso giorno si legge: «I nostri avversari, prendendo pretesto dal doloroso eccidio di piazza degli Antinori [...] si dettero alla caccia dei comunisti. Squadre di cosiddetti uomini dell’ordine, protetti ed aiutati dalla polizia, commisero nel centro della città ogni sorta di sopraffazioni e di violenze a danno di pacifici cittadini, rei di appartenere alle organizzazioni ed a partiti diversi da quello che per il bene dei parassiti e de’ pescecani governa l’Italia. Il ferroviere Mugnai, in Piazza del Duomo, per non essersi a tempo tolto il cappello fu barbaramente trucidato da un carabiniere».
Immediatamente «la città prese un aspetto da stato d’assedio: autoblindate, drappelli di carabinieri, pattuglie di guardie regie, pattuglioni di bersaglieri e di soldati di fanteria percorrevano le vie» (“Corriere della Sera”, 1 marzo).
Appena due ore dopo l’attentato lo squadrismo fiorentino dava inizio alle già programmate azioni distruttive, al grido di “Occhio per occhio, dente per dente”, cinque “squadre punitive” venivano sguinzagliate a seminare il terrore nella città. Una di queste in via delle Belle Donne invase e distrusse la sede della Federazione dei lavoratori della mensa; un’altra si diresse verso il quartiere proletario del Mercato Centrale, e precisamente al numero 2 di Via Taddea. Questo stabile – che si trovava a pochi passi dalla Manifattura tabacchi, teatro di recenti battaglie delle sigaraie – al suo interno accoglieva: la sede della “Lega proletaria tra mutilati, invalidi e reduci di guerra”, con la redazione del proprio quindicinale “Spartacus”; la sede del “Sindacato Ferrovieri”; la sede della “Federazione provinciale del PCd’I” e la redazione dell’“Azione Comunista”.
Erano da poco passate le 17 quando arrivò la squadra, composta, sembra, da una trentina di fascisti. Le quattro guardie regie messe a piantonare lo stabile si erano “momentaneamente assentate” e i locali delle varie associazioni erano completamente deserti; unica eccezione Spartaco Lavagnini, «intento al consueto lavoro, a vantaggio della classe lavoratrice». Qui, trovato solo e disarmato, veniva trucidato con almeno 4 colpi di pistola. Compiuto l’assassinio, premeditato e preannunciato dai loro giornali, prima di abbandonare i locali i fascisti si davano alla devastazione e all’incendio.
Appena il proletariato venne a conoscenza del delitto «ebbe una sola volontà: vendicare Spartaco Lavagnini. Gli elettricisti, i tranvieri e i ferrovieri interruppero spontaneamente il lavoro. Nella stessa sera si riunirono i dirigenti del Partito Comunista ed assunsero la direzione dello sciopero estendendolo a tutte le categorie di lavoratori. Due comitati comunisti, nominati per l’estensione dello sciopero in Città e provincia, entrarono subito in azione» (“L’Azione Comunista”, 5 marzo).
Intanto «a Sesto Fiorentino i socialisti, che ivi imperano, diedero l’assalto alla sede della locale sezione dei combattenti, distruggendo ed incendiando i mobili» (“Corriere della Sera”, 1 marzo).
Lo Stato si dispose in assetto di guerra: autoblinde presidiavano i viali di circonvallazione, mitragliatrici piazzate sui tetti tenevano sotto tiro i ponti sull’Arno, quattro cannoni da 75 erano sistemati in Piazza del Duomo e in Piazza Vittorio. «Per tutta la notte la città veniva percorsa in lungo e in largo da autoblindate e tank, mentre le vie del centro venivano pattugliate da drappelli di guardie regie e carabinieri, dal canto loro i fascisti continuavano indisturbati la caccia all’uomo [...] Al termine della giornata si contavano già quattro morti, una trentina di feriti una cinquantina di arrestati, tutti di parte rossa, per misure di pubblica sicurezza» (F. Borghini, La Rivolta di Firenze).
I fascisti però si guardarono bene di avventurarsi “di là d’Arno”, dove nei quartieri di San Frediano, Santo Spirito, Camaldoli, i proletari si erano disposti alla difesa armata innalzando barricate «utilizzando il materiale dei cantieri allestiti per la pavimentazione delle strade. Vi venivano aggiunti carri messi di fianco con le ruote all’aria, cassettoni, materasse, portoni divelti dai cardini e perfino alcune vetture tramviarie. Sui tetti gli uomini con la fascia rossa al braccio prendevano ad accatastare tegole, lapidini, acquai, pietre ed ogni altro tipo di proiettile primitivo [...] Nella tarda mattinata Firenze assumeva l’aspetto di una città in stato d’assedio: la percorrevano in lungo ed in largo drappelli di cavalleria, plotoni di soldati del 69°, 84°, 127°, 213° e 268° reggimento di stanza a Firenze, pattuglie di carabinieri e guardie regie mentre numerose autoblindate si spostavano celermente da un capo all’altro del centro cittadino»
Nella mattinata del secondo giorno, il 28 febbraio, vari scontri a fuoco si ebbero praticamente per tutta quanta la città. Verso le 11 del mattino una spedizione proletaria proveniente dai quartieri di San Frediano e Santo Spirito attraversò l’Arno per dare l’assalto alla sede dei Combattenti. Poco dopo furono i fascisti a tentare l’attacco alla roccaforte proletaria di San Frediano dove, a detta del prefetto, «si annidavano gli elementi più pericolosi per l’ordine pubblico».
Nel tentativo di prendere San Frediano alle spalle «ai fascisti non rimaneva che attraversare l’Arno dal Ponte di ferro per poi inerpicarsi per le Rampe e attraverso il viale dei Colli discendere verso porta Romana [...] Attraversato il viale Petrarca giungevano in Piazza Torquato Tasso e da qui tentavano di penetrare nel dedalo di viuzze che costituivano il cuore di San Frediano. Ma già in via Camaldoli dalle finestre cominciavano a precipitare addosso agli aggressori persiane, tavolini, marmi da comodino, soglie delle porte il tutto unito a frequenti getti d’acqua bollente e colpi di rivoltella» (Borghini).
«Nel quartiere ma anche al Santo Spirito, a S. Maria Novella, ai Camaldoli, a San Giovanni, al Boschetto si sviluppò una incessante guerriglia, una vera e propria insurrezione popolare: fu il momento culminante di una guerra civile su scala cittadina. La folla stava quasi per lanciarsi “all’ultimo assalto che avrebbe segnato la nostra fine – narrò il fascista B. Frullini partecipe all’impresa di S. Frediano – quando il provvido intervento di un’autoblinda guidata dal tenente Pezza ci tolse da così tragica posizione”. Le forze della guarnigione locale, prontamente intervenute in armamento da guerra a sostegno della aggressione fascista, attaccarono le barriere innalzate dai popolani, mentre dai tetti e dalle case circostanti si infittiva un’intensa [...] sparatoria contro la truppa. La resistenza sulle barricate durò tutta la giornata e solo all’imbrunire si fece meno intensa» (F. Fabbri, Le origini della guerra civile).
Il comando delle operazioni dalla polizia, impossibilitata a ristabilire l’ordine, era passato all’esercito. «Verso le 16 venivano dirottati in San Frediano il 69° e l’84° battaglione del reggimento di fanteria rafforzati da reparti di bersaglieri, guardie regie, carabinieri e cavalleria preceduti da tre autoblindate e seguiti da un nucleo di agenti di polizia che raggiungevano San Frediano attraverso il Ponte Santa Trinita» (F. Borghini).
Ma andiamo al resoconto della giornata di lotta, intitolato “Barricate Comuniste”, descritto dal “Corriere della Sera” dell’1 marzo: «Un’altra giornata di disordini sanguinosi quella d’oggi [...] I primi tafferugli, tra ferrovieri e fascisti, si sono avuti in piazza della Stazione, in piazza Santa Maria Novella, in piazza Goldoni e in via della Chiesa. Si ebbero quattro feriti da arma da fuoco [...] Verso le 11, un gruppo composto di 150 individui provenienti dal quartiere popolare di San Frediano [...] si dirigeva, per compiere un atto di reazione comunista, verso la sede dell’Associazione combattenti, in via dei Fossi [...] I fascisti [...] discendendo dal Poggio Imperiale per il viale Petrarca, si avvicinarono al quartiere di San Frediano; ma ebbero ad imbattersi subito in una specie di barricata, alta mezzo metro, e formata da grosse pietre tolte dal lastricato e poste per il ritto [...] Quando i fascisti giunsero all’altezza delle barricate, s’ingaggiò una vera battaglia. Si tirava da una parte e dall’altra con rivoltelle, fucili e bombe a mano. Si sparava principalmente dalle finestre [...] Altre barricate erano state poste attraverso le vie che formano il cuore del quartiere. Una ve n’era all’altezza di piazza dei Merli, una in piazza del Carmine, una in via del Leone, e due o tre in Borgo San Frediano e in via San Giovanni. Nella prima barricata i fascisti furono accolti da un fuoco nutritissimo non solo dalle finestre ma anche dalle soglie delle porte di casa, mentre dai tetti si gittavano tegole e ogni specie di proiettili [...] Il combattimento durò non meno di un quarto d’ora, finché giunse la forza pubblica per ristabilire l’ordine. La forza era costituita da un grosso pattuglione di guardie regie, da un battaglione del 69° reggimento fanteria e da carabinieri. Vi erano poi due autoblindate. Questo forte nerbo di soldati e militi passava il ponte Santa Trinita e si spingeva in Borgo San Frediano. [...] Anche la truppa fu fatta segno ad un fuoco furioso da tutte le finestre di Borgo San Frediano [...] Allora furono messe in azione le autoblindate, le quali diressero le raffiche delle mitragliatrici contro le case, dalla sommità al suolo [...] Dove il conflitto fu più tragico fu in pazza del Carmine, alla imboccatura di via del Leone. Qui un pattuglione del 69° reggimento di fanteria, dovette porsi a terra e fare fuoco di plotone poiché era stato accolto da una grandine di proiettili. Stasera la calma è quasi completamente ristabilita sulla riva sinistra dell’Arno [...] I ponti sono sbarrati da cordoni di truppe [...] In sostegno della forza pubblica furono portati in piazza del Duomo una sezione di artiglieria da montagna someggiata e una artiglieria da campagna. I pezzi sono stati piazzati sui ponti e nelle tre piazze principali».
Passate le 17 si verificò l’episodio di Giovanni Berta: figlio del proprietario della Fonderia delle Cure, fascista della prima ora, al suo attivo, tra l’altro, aveva la partecipazione all’attacco di Palazzo D’Accursio a Bologna e a quello che, a Firenze, portò alla distruzione del periodico “La Difesa”, in via Laura.
Mentre infuriava la battaglia gli abitanti del Pignone avevano occupato il ponte sospeso per impedire a fascisti ed esercito di usarlo per accerchiare San Frediano. Il Berta, mentre dal quartiere del Pignone tentava di attraversare il ponte sospeso «precedendo una pattuglia armata dei suoi [per] rinnovare l’attacco al rione popolare» (“L’Ordine Nuovo”, 11 marzo), dopo una colluttazione venne gettato in Arno dove morì affogato. Il regime fascista poi ne fece un martire della ferocia rossa. Secondo la ricostruzione fascista il Berta, scaraventato giù dal ponte, nel tentativo di salvarsi si sarebbe aggrappato con le mani al piano del ponte, ma i rossi gliele avrebbero pestate fino a farlo precipitare. L’autopsia non rilevò nessuna ferita alle mani. Comunque, vera o falsa, questa ricostruzione non dispiacque ai proletari.
Il 1° marzo lo sciopero generale, esteso ormai a tutta la provincia, proseguiva compatto; attraverso le staffette dei ciclisti rossi e la fitta rete di circoli rionali, case del popolo, società di mutuo soccorso e sedi di cooperative, i due Comitati di agitazione comunisti che dirigevano il movimento di sciopero e di rivolta, erano tempestivamente aggiornati sull’evolversi degli scontri.
«Al di fuori del PCd’I le altre forze politiche latitavano: erano assenti del tutto il Partito Popolare e il Partito Socialista mentre gli anarchici partecipavano isolatamente alle azioni di rivolta senza alcun collegamento con i loro dirigenti» (F. Borghini).
Al mattino del 1° marzo, mentre la città era paralizzata dallo sciopero generale, nei quartieri si continuava ad innalzare barricate e scavare trincee per impedire nuove incursioni di esercito e fascisti, in modo particolare al Pignone e a Ponte a Ema.
Violenti scontri armati si ebbero nelle periferie: nei pressi di piazza del Bandino, all’attacco frontale dei carabinieri fu risposto con il lancio di bombe a mano e una violenta battaglia si sviluppò nelle vie del quartiere nel corso della quale rimase ucciso un maresciallo dei carabinieri; a Scandicci un camion dei carabinieri fu incendiato sviluppando una violenta battaglia. Di come Scandicci sia stata espugnata a colpi di cannone abbiamo già parlato in precedenti capitoli.
La battaglia di Ponte a Ema così viene descritta dal Borghini: «Imponente era [la barricata] eretta attraverso la via Chiantigiana [...] solidamente costruita con vecchie masserizie, sacchi pieni di terra, grosse pietre e lunghi paloni da impalcature ben inchiavardati [...] Duecento metri circa davanti a questa barriera ne era stata edificata un’altra, meno robusta, composta di longarine e alta quasi un metro da terra». Dietro queste barricate i proletari armati attendevano le «due autoblinde al comando dei tenenti Ruzzi e Pezza seguite dall’artiglieria, dai carabinieri e dalle guardie regie. [Appena le autoblinde giunsero] di fronte allo sbarramento sulla colonna militare cominciava a piovere una scarica di fucileria proveniente dai tetti, dalle finestre e dalle alture che circondavano l’agglomerato. Le scariche, da una parte e dall’altra, si susseguivano senza interruzione e senza che gli insorti dessero segno di desistere. [Allora venne fatto] entrare in funzione il pezzo da 75 [...] Seguivano altre due cannonate, [mentre un’autoblinda] puntava le due mitragliatrici verso la piazzetta del paese mitragliando senza tregua. Protetti dalle bocche di fuoco della blinda, i carabinieri potevano demolire a colpi di piccone la barriera, mentre alle loro spalle le guardie regie, ginocchio a terra, infittivano il fuoco della mitragliatrice».
Solo così l’esercito poté avere ragione del proletariato, e consegnare il paese alla successiva devastazione da parte dei fascisti.
Intanto fin dal mattino il prefetto aveva convocato le autorità cittadine e i deputati dei singoli partiti allo scopo di redigere un manifesto comune che invitasse la popolazione alla pacificazione. Naturalmente i rappresentanti comunisti disertarono l’incontro, mentre i socialisti parteciparono di buon grado, dichiarandosi però impotenti a far cessare lo sciopero generale essendo il movimento completamente in mano ai comunisti. Tutti quanti i partecipanti, fascisti compresi, si dichiararono disponibili ad accettare l’invito. Anche se non venne redatto un unico manifesto sottoscritto da tutte le componenti, se ne ebbero diversi, per ogni gruppo politico, che in definitiva dicevano la stessa cosa. Come a Bari, come a Trieste, anche a Firenze la borghesia chiedeva la pace!
Il manifesto socialista, che è l’unico ad avere per noi un qualche interesse, dopo avere ricordato che «tristi fatti di violenza avevano offesa, nella nostra Firenze, l’antica civiltà della lotta politica», rivolgeva a «tutti i sereni spiriti un appassionato appello per la cessazione della barbara guerriglia», e invitava alla «ripresa della feconda attività rivolgendo un mesto pensiero a quanti, in ogni campo, sono caduti vittime di una cieca violenza». Per i socialisti le forze armate, regolari e irregolari, della reazione borghese nella guerra civile erano messe sullo stesso piano di quelle, purtroppo insufficienti, della classe operaia e tutti “i morti” avevano lo stesso valore.
Anche i fascisti si erano dichiarati pronti ad aderire alla “pacificazione”. Ma cosa la borghesia intendesse per pacificazione non tardò a palesarsi: scriverà il fascista Mario Piazzesi: «Dal Corpo d’Armata con un camion 15 ter. ci vengono mandati 120 moschetti, caricatori (e sotto banco, il buon capitano della Fortezza da Basso ci ha aggiunto 3 cassette di sipe» (Diario di uno squadrista toscano).
Era il primo pomeriggio quando i fascisti ritentarono l’attacco alla sede comunista di via dell’Agnolo, invano assalita due giorni prima. La difesa comunista fu talmente energica che i fascisti ebbero la peggio. La notizia dell’assalto si propagò così rapidamente che tutto il quartiere di Santa Croce immediatamente insorse. Altrettanto celere fu l’azione dell’esercito che fece intervenire reparti di fanteria, bersaglieri e carabinieri. La battaglia fu accanita, furono innalzate barricate, sia fisse che mobili: queste ultime formate da carretti e barrocci, erano celermente spostate da una strada all’altra creando disorientamento agli attaccanti. Dalle finestre si sparava sulla truppa al cui rinforzo vennero inviati drappelli di cavalleria e le autoblinde. Le detonazioni provenienti dall’esterno provocarono tentativi di rivolta all’interno del carcere delle Murate. La truppa che dagli scontri del Bandino e Ponte a Ema rientrava in città era accolta a fucilate dai proletari insorti.
Contemporaneamente i fascisti davano l’assalto alla Camera del lavoro senza che le guardie regie poste “a sua difesa” intervenissero. Dopo averla devastata i fascisti passavano alle sedi sindacali della Fiom, degli elettricisti e a quella del Libro dove, dopo averle devastate, ne asportavano mobili e documenti dandoli alle fiamme in piazza.
Questo era il risultato dell’accordo di pacificazione al quale tanto prontamente avevano aderito i dirigenti del partito socialista.
La resistenza di Santa Croce, che durò oltre 5 ore, fu così tenace che lo stesso prefetto riferì che «il conflitto fu asprissimo pari a quello avvenuto a San Frediano».
Mentre lo sciopero generale si era diffuso a gran parte della Toscana, in molti altri luoghi, che qui non è possibile enumerare, si verificarono scontri a fuoco tra carabinieri e fascisti da una parte e proletari dall’altra.
Alla sera i due comitati di sciopero comunisti annunciarono la cessazione dello sciopero. «Tanta era l’irritazione del proletariato contro gli assassini di Spartaco Lavagnini che non tutte le categorie di operai obbedirono all’ordine di ripresa del lavoro. Il 2 marzo lo sciopero proseguì e vi furono nuovi episodi di violenza e sangue» (“Azione Comunista”, 5 marzo). A San Frediano si ebbe un ultimo bagliore di rivolta, i carabinieri inviati a rimuovere una barricata furono accolti da un ininterrotto fuoco di fucileria.
Se la calma era ritornata in città, altrettanto non si poteva dire per il circondario: lo sciopero continuava a Prato, Borgo San Lorenzo, Signa, Calenzano, Marradi, San Piero a Sieve. Ma anche città maggiori come Pisa, Lucca, Grosseto, La Spezia, Pontedera e l’Isola d’Elba avevano proclamato lo sciopero in solidarietà con la rivolta di Firenze.
Il bilancio delle giornate fiorentine fu pesante per il proletariato: una ventina di morti, circa 300 feriti (contando solo quelli ricoverati negli ospedali), 1.500 arresti, e gran numero di proletari che dovettero abbandonare la città o espatriare.
Come scrisse l’“Ordine Nuovo”, «è giunto il momento per i proletari di impugnare con freddezza le armi [...] Rendiamo al proletariato di Toscana questo primo merito: il merito di avere avuto questa freddezza, il merito di essersi gettati nel combattimento senza fare nessuna riserva» (9 marzo). «La rivolta del proletariato fiorentino è stata completa, superba di generosità e di slancio. Chi ne farà la storia dovrà dire come per due giorni il popolo fu padrone dei suoi borghi e delle sue case e le difese con le armi in pugno. Dovrà esaltare la freddezza di sangue degli operai che affrontarono, con una arma meschina, le mitraglie ed il cannone: di quelli che strisciando carponi si portarono fin sotto un’autoblindata e se ne impadronirono lottando corpo a corpo; donne che un’altra autoblindata riuscirono ad immobilizzare, rovinandola col lancio da una finestra di un lavandino di marmo; del monello che raccolse una bomba inesplosa per lanciarla di nuovo contro gli assalitori. La rivolta fu completa, si estese a tutti i borghi, strinse in una cerchia di ferro e di fuoco la città» (11 marzo).
Un manifesto dell’Esecutivo locale del PCd’I affermava: «Il Partito Comunista d’Italia, sezione della III Internazionale, prende atto con soddisfazione della vostra reazione alla brutale violenza nemica. E mentre s’impegna a non abbandonare la lotta selvaggia imposta al proletariato tutto dalle bande dei saccheggiatori, sente il dovere di ricordare tutti gli umili eroi che a San Frediano, a Ricorboli, al Ponte a Ema, a Scandicci, alle Panche e in centinaia di altri episodi, sono caduti vittime in lotta impari contro le artiglierie e i formidabili mezzi di offesa, di cui ancora il nemico dispone per aggredire e difendersi. A tutti coloro che nelle scorse giornate tennero a sacrificare la vita per il comune ideale di un più vasto rivolgimento sociale [...] a tutti i nostri compagni lavoratori la nostra parola di ringraziamento e di gratitudine. Pensino i lavoratori che la lotta decisiva s’inizia oggi: ciascuno stia al suo posto di lotta e di dovere, con le armi al piede, in attesa delle prossime asprissime battaglie, per la vittoria degli oppressi contro gli oppressori».
Mentre il partito comunista esaltava lo slancio del proletariato fiorentino il partito socialista non mancava ancora una volta di condannare “ogni tipo” di violenza e, per bocca del deputato Targetti, esprimeva il suo «spontaneo, sincero compianto di tutti». Questo servo della borghesia continuava la sua professione di fede reazionaria con queste parole: «Nessuno di noi può ricordare senza un tremore di pianto l’episodio [...] di quel giovane creduto, non so se a torto o a ragione, fascista [Si riferiva allo squadrista Giovanni Berta, ndr] che trova la morte nei gorghi dell’Arno [...] invocando il sacro nome della mamma» (Atti parlamentari, 8 marzo 1921).
Provocazione borghese a Empoli
Liberi di compiere ogni tipo di azione terroristica, garantiti dell’immunità e dell’aperto sostegno di tutti gli organi statali, i fascisti, dopo le giornate fiorentine irrompono, portando morte e terrore in ampie zone della Toscana. Il proletariato si difende e, quando può, offende anche: agli incendi delle Case del popolo, delle redazioni dei giornali, delle Camere del lavoro si risponde con l’incendio di cantieri, ville, fattorie. Anche se la lotta è impari, nei paesi il proletariato resta in attesa dell’attacco organizzando al meglio la difesa armata.
Si sapeva per certo che uno dei prossimi obiettivi delle incursioni fasciste sarebbe stata la cittadina di Empoli, una vera roccaforte rivoluzionaria della rossa Toscana: quando il partito si spaccò al Congresso di Livorno, ad Empoli la maggioranza degli iscritti e la quasi totalità della sezione giovanile aderirono al PCd’I.
«Era inconcepibile che il fascismo non dovesse cercare il pretesto per la penetrazione in una plaga tanto importante. L’attacco diretto era pericoloso. Più volte era stato minacciato. Più volte i fascisti fiorentini avevano minacciato che si sarebbero recati ad Empoli, che vi avrebbero compiuto una delle loro spedizioni [...] ma la parola d’ordine tacita e decisa era che non dovessero uscirne» (Jaurès Busoni, “L’’Eccidio’ di Empoli del 1° marzo 1921”).
Proletari e contadini stavano in vigile attesa pronti allo scontro armato. E lo scontro ci fu, quello scontro che poi passerà alla storia come dimostrazione della selvaggia ferocia comunista che avrebbe fatto strage di poveri militari innocenti. La sentenza della Sezione d’accusa della Corte d’appello di Firenze attribuì l’eccidio ad «impulso di brutale malvagità di una folla assetata di sangue».
Lo scontro a fuoco che il 1° marzo si verificò ad Empoli provocò 9 morti tra soldati di leva della marina militare della Spezia e i carabinieri di scorta che, a bordo di due camion, avevano fatto ingresso in paese.
Se la bomba di Firenze aveva colpito gli stessi figli della borghesia pur di avere il pretesto per scatenare una operazione militare contro il proletariato, i suoi dirigenti e le sue istituzioni, quello che venne orchestrato e messo in opera per Empoli mandò a morte certa degli ignari giovani marinai.
La loro funzione sarebbe stata quella di sostituire i ferrovieri di Firenze in sciopero. Ma l’operazione prevedeva invece di immolarli, notati e scambiati per fascisti.
Invece di metterli in un treno, magari da loro stessi condotto, con partenza da La Spezia e arrivo a Firenze, furono imbarcati alla volta di Livorno. Qui, spogliate le uniformi, furono vestiti in borghese, muniti di porto d’armi individuale (non necessario ai militari in divisa) e armati di pistola. I camion con i quali avrebbero dovuto raggiungere Firenze non andarono a prelevarli all’Accademia navale, ma, visibilmente armati, dovettero recarsi all’autoparco, da raggiungere prendendo per due volte il tram. Scesi dal primo si imbatterono, ed ebbero un primo scontro fisico, con un gruppo di proletari in sciopero. Il capitano N. Ambrogi che comandava il gruppo racconta: «giunto [il secondo] tramway a noi occorrente [...] d’un tratto echeggiò il grido: sono crumiri, sono crumiri. E in un attimo il tramway fu inutilizzato togliendo il trolley e la manovella di manovra [...] E i marinai scesi rapidamente tennero in rispetto la folla minacciosa che ci lasciò via libera per proseguire a piedi» (P. Pezzino, Empoli antifascista).
Quindi, con scorta armata di carabinieri, i marinai partono. «A quale scopo mandarli a Firenze su camion e non farli iniziare il servizio dalla stazione di Livorno per farli giungere a Firenze in ferrovia? [...] Sugli stessi camion, inoltre, vengono posti, ad accompagnarli, carabinieri armati in divisa. Ora c’è da tener presente che da Livorno i camion devono attraversare paesi e cittadine dove vige in pieno lo sciopero [...] Si sa che non è insolito vedere i carabinieri sui camion coi fascisti. È possibile che nessun incidente si verifichi? Il diabolico spirito che ha voluto si svestissero i marinai della divisa certo ha anche voluto che un incidente si verificasse» (“L’’Eccidio’ di Empoli”).
Senza incidenti i due camion attraversano i paesi che si trovano lungo il percorso, e ad ogni passaggio si pensa che si tratti di una spedizione fascista. Precedendo i camion si cerca di avvertire gli abitanti dei paesi successivi dell’arrivo dei fascisti. A Fucecchio ai conducenti dei camion che chiedono quale sia la direzione per Empoli per due volte è indicata una via sbagliata per dare tempo a un motociclista di precederli portando ad Empoli la notizia che due camion di fascisti stanno arrivando.
Agli abitanti, già preparati all’evento, non occorre molto per predisporsi a difesa e quando arriva il primo camion i proletari sono già dislocati in posizione, dietro gli angoli delle vie, i portoni, nei balconi, sui tetti, dietro le siepi. Appena i camion entrano in paese viene bloccata ogni via d’uscita. Poco dopo dal primo camion si comincia a sparare. Il capitano Ambrogi dichiarò: «Ho visto le strade deserte e ho avuto la sensazione di un agguato. Allora ho dato ordine ai miei uomini, per intimorire, di sparare in aria».
Jaurès Busoni, che ebbe parte attiva nella vicenda, narra: «Gli spari, come era naturale, dettero esca alla miccia. Vennero posti e gettati alcuni ostacoli per impedire o ritardare la marcia dei camion [...] Il primo camion accelerò la marcia, corse, riuscì ad attraversare Empoli in tutta la sua lunghezza mentre da ogni angolo, porta, finestra, tetto, gli veniva sparato contro e dal camion stesso si replicava sparando. All’altro capo della cittadina il camion era colpito al serbatoio della benzina, e ne discendevano gli occupanti che avevano avuto due morti ed alcuni feriti, rifugiandosi in un magazzino [...] Il secondo camion, invece, udendo l’accoglienza ricevuta dal primo, si fermava all’inizio dell’abitato cittadino; ne scendevano i borghesi e i carabinieri rifugiandosi in un orto mentre la folla si avvicinava insultando i “fascisti”, malmenandoli e minacciandoli».
Mentre i fuggitivi scappano terrorizzati in ogni dove, senza nessun riferimento, in un ambiente del tutto sconosciuto, sono rincorsi dalla folla e, raggiunti, malmenati ed anche uccisi. Finalmente i marinai imploranti pietà, quando riescono finalmente a dimostrare chi veramente erano, vennero addirittura soccorsi dalla popolazione.
Intanto mentre accade tutto questo i carabinieri se ne stanno in caserma «barricati dietro sacchetti di terra».
«La caratteristica dei fatti di quel giorno in Empoli fu che ad essi partecipò interamente tutta la popolazione, tanta era la volontà di combattere i fascisti ed agire contro di essi. Chi non partecipò direttamente sparando o facendo parte dei gruppi armati, mise a disposizione mezzi ed ambienti [...] Poche volte nella storia un’azione fu compiuta da una folla in modo tanto spontaneo quanto compatto, cosicché, se si fosse voluto veramente andare in fondo ad una capillare ricerca di responsabilità, anche oltre quella genericamente collettiva, volendo colpire tutti coloro che, in modo diretto o indiretto, parteciparono ai fatti di quel giorno, si sarebbe dovuto recingere Empoli da un muro alzato a vastissimo raggio di distanza dal centro e fare di tutta la città e adiacenze un’immensa prigione [...] Quelli che furono denominati mostri e jene, belve e sciacalli, assai compressero la loro furia, furono anche troppo miti e generosi. E se i sessantaquattro dei camion fossero stati veramente fascisti, non esagero affermando che il bilancio della giornata si sarebbe chiuso con la somma di sessantaquattro morti. Vittima di un equivoco e fatale tranello era stata Empoli, pronta in linea nella lotta rivoluzionaria e nella lotta contro il fascismo».
Il piano predisposto dalla reazione statale è perfettamente riuscito, e già alle prime luci dell’alba del 2 marzo la cittadina di Empoli si trova occupata militarmente. Con un treno speciale è stato inviato un intero reggimento. Le autoblinde percorrono le strade mitragliando porte e finestre mentre i militari procedono agli arresti. Oltre 500 sono gli arrestati ed ancor più i ricercati latitanti. Ad occupazione militare effettuata, arrivano gli eroi in camicia nera che, eroicamente, incendiano, devastano, bastonano, uccidono.
Il proletariato empolese è stato sconfitto, ma non fiaccato. Lo dimostra il fatto che «in pieno terrore reazionario, le squadre degli operai e dei contadini pronte nelle campagne, mandavano emissari a domandare ai dirigenti empolesi se dovevano marciare sulla cittadina per sbarazzarla di militi e fascisti».
Il processo contro 138 imputati, tra cui 3 donne, iniziò l’8 maggio 1924 presso la Corte d’Assise di Firenze; 92 furono le condanne. Contro 5 imputati latitanti, ritenuti i massimi responsabili dei fatti, fu comminato l’ergastolo. Di questi, 2 avevano trovato “riparo” in Russia.
Il 12 febbraio 1945 il CLN propose la revisione del processo e il 12 maggio 1946, all’unanimità, il consiglio comunale empolese deliberò in tal senso. Ma queste richieste, anche se formulate in chiave democratica, non ebbero seguito. Vennero dimenticate, archiviate, insabbiate (ognuno scelga l’aggettivo che preferisce). Per il ministro di Grazia e Giustizia, Palmiro Togliatti, sarebbe stato di qualche imbarazzo dover giustificare il fatto che Giovanni Morelli e Adolfo Sandonnini, scampati all’ergastolo fascista e rifugiati in Russia, erano entrambi passati per i gulag staliniani.
L’assalto alla Camera del Lavoro di Siena
Il 5 marzo 1921 un trafiletto su “L’Ordine Nuovo” riportava: [A Siena] «i fascisti inscenarono una dimostrazione andando poi all’assalto a mano armata della Casa del Popolo. I lavoratori che vi si trovavano ne tentarono la difesa, ma allora intervenne subito la forza pubblica [...] ed iniziava un vivo fuoco di fucileria contro la Casa del Popolo dove ha sede la Camera del Lavoro. [...] I soldati circondarono il fabbricato continuando a sparare contro il fabbricato e le finestre. Infine è stata fatta intervenire l’artiglieria con due pezzi da 75 da montagna i quali hanno aperto una prima breccia nel fabbricato. Allora i difensori si arresero [...] Tutti furono arrestati e trasportati alle carceri. Dopo i fascisti sono entrati nella Camera del Lavoro devastandola e incendiandola».
Mettiamo a confronto questa breve cronaca del giornale comunista con quanto apparso, lo stesso giorno, sul quotidiano socialista, che si limita a riportare il comunicato dell’Agenzia Stefani: «Un gruppo di fascisti aveva organizzato una pubblica questua per le vittime del dovere cadute nei fatti di Firenze e di Empoli [...] Giunti presso la Casa del Popolo sono stati fatti segno a colpi di rivoltella da parte di comunisti che vi si erano asserragliati. Ne nacque un conflitto, durante il quale furono sparati molti colpi d’arme da fuoco. Alle intimazioni delle autorità, non avendo i comunisti aperto la Casa del Popolo, si dovette ricorrere alla forza [...] I fascisti, superando la resistenza opposta dalla forza, sono riusciti a penetrare nei locali e vi hanno appiccato il fuoco».
L’“Avanti!” dopo aver riprodotto pari pari il comunicato stampa dell’Agenzia filo‑fascista, lo faceva seguire da questo ipocrita commento: «[...] I nostri lettori sanno di quali falsificazioni sia capace l’Agenzia ufficiosa». Ma come veramente erano andate le cose i lettori dell’“Avanti!” non lo avrebbero saputo mai.
Sempre il 5 marzo, alla Camera, il deputato socialista Treves «chiede d’interrogare il Governo, per sapere perché fu distrutta la Casa del Popolo di Siena». Il presidente del consiglio, Giolitti, con il massimo candore risponde che «il Governo non ha ancora i dati sufficienti per rispondere», «il sottosegretario per l’Interno è indisposto [...] Il ministro che sta a Roma non può aver notizia dei fatti che succedono a Siena». A questi sberleffi di Giolitti, Treves vanta l’opera del partito socialista per riportare la pace sociale in Italia: «Da parte nostra non abbiamo bisogno di dire quali sono in quest’ora i nostri intendimenti; ci sono atti pubblici della direzione del partito; c’è un manifesto del partito socialista, non solo, ma il recente congresso della Confederazione del Lavoro ha stabilito in che modo noi entriamo nella vita politica», quindi, da buon collaborazionista, si indigna della violenza statale che aveva preso a «cannonate un monumento artistico di notevole pregio» (Atti parlamentari).
Ecco cosa interessava ai deputati del PSI, il patrimonio artistico!
Il “delitto di Bonelle”
I giornali quotidiani di tutt’Italia, a partire dal giorno 4 giugno 1921 riportavano la notizia di un atroce delitto consumatosi a Bonelle, piccola frazione del comune di Pistoia. E chi se non dei comunisti avrebbero potuto compiere un simile orrendo delitto?
Il fiorentino “Nuovo Giornale” usciva con il titolo su sei colonne: “Una nuova sanguinosa raffica d’odio e di strage si abbatte sulla tormentata terra della nostra Toscana – Orrenda morte d’un giovane fascista – Immerso nell’acqua bollente e poi tagliato a pezzi – La scomparsa misteriosa – Febbrili indagini della polizia - Un arresto importante – La confessione – Il disgraziato fascista messo alla tortura – La casa del delitto – La scoperta”. Pur lasciando da parte quel giornale fascista, così “La Stampa” e “Il Corriere della Sera”, seri ed equilibrati quotidiani dell’alta borghesia, presentarono il caso: “La Stampa” del 4 giugno titolava: “L’orribile scempio d’un fascista ad opera di comunisti nel pistoiese. La testa nell’acqua bollente. Il cadavere squartato”; il “Corriere della Sera”: “Fascista trucidato e tagliato a pezzi in un circolo comunista”.
Nei loro articoli si legge: «Si ha da Pistoia notizia di un orrendo omicidio avvenuto qualche tempo fa». «Da circa un mese era scomparso un giovane operaio fascista, e legionario fiumano [...] Una sera dell’aprile egli aveva lasciato la sua abitazione per fare una passeggiata e non fu più visto». «Si fecero supposizioni e nacquero molte dicerie su questa scomparsa e se ne occupò anche l’autorità [che] esperirono subito indagini stringendo sorveglianza attorno ad individui sospetti abitanti in un gruppo di case covo di sovversivi». «Ora la polizia ha potuto porre in luce completamente la scomparsa del giovanotto, il quale è stato assassinato in modo orrendo». «Un giovane, certo Giovanni Mazzoni [arrestato] negò dapprima, ma dopo uno stringente interrogatorio narrò come [il fascista, ndr] era stato avvelenato [...] Per assicurarsi che egli fosse realmente morto, tutti insieme i comunisti lo ficcarono con la testa in un paiuolo di acqua bollente [...] e non contenti ancora di questo, i comunisti [...] con un coltellaccio squartarono il cadavere in 5 pezzi, che furono poi gettati in un pozzo vicino». «Questa è la confessione del Mazzoni, il quale in un emozionante confronto ha rievocato tutta la macabra scena». «La Polizia stanotte ha inviato a Bonelle, su camions, un centinaio di carabinieri e soldati, i quali hanno circondato il paese. Sono state perquisite tutte le abitazioni e gli individui più indiziati sono stati tratti in arresto. Gli arrestati ammontano a circa una trentina, e tra essi vi sono anche gli autori materiali del delitto». «I fascisti, fra i quali è vivo il fermento, vorrebbero penetrare nel paese per compiere vendette».
L’”Avanti!” non poteva esimersi dal partecipare al coro della stampa reazionaria, ma in maniera più subdola. Il giorno dopo, sotto il titolo: “Un fascista scomparso - Ucciso e squartato?”, riportava pari pari un trafiletto ripreso dai giornali borghesi, aggiungendo il suo commento: «Se l’orribile delitto è stato in realtà commesso così freddamente come viene raccontato, noi non esitiamo a stigmatizzarlo come ogni altra infamia di questa feroce epoca di imbarbarimento, seguita alla più tremenda delle carneficine mondiali».
Vediamo come realmente si erano svolti i fatti.
Un fascista, tale Urbani, risultava scomparso da un paio di mesi. La famiglia non si era data pena per la sua assenza e altrettanto aveva fatto la forza pubblica. Arrestò un ragazzo minorenne, minorato psichico, tale Mazzoni, e sotto tortura gli fece confessare l’atroce delitto. Il settimanale comunista locale, “L’Avvenire”, scriveva: «Sappiamo, come tutti sanno a Pistoia, che oltre dieci gravi lesioni (di cui due ancora pericolose ai polmoni) sono state riscontrate su di lui e il suo martirio dovette essere lungo e atroce, da sconvolger la sua mente».
Il giorno successivo quasi trenta proletari comunisti erano stati immediatamente arrestati e sottoposti a violenti interrogatori per estorcere confessioni.
«Gli operai arrestati a Bonelle, oltre venti cittadini rei soltanto di appartenere a partiti sovversivi furono trasportati a Pistoia [...] Per oltre due mesi furono tenuti in carcere ed alcuni di essi subirono sevizie [...] perché si voleva ottenere da loro ad ogni costo la confessione d’aver partecipato al misfatto» (Intervento parlamentare del compagno Garosi del 17 dicembre). Il Procuratore del re «minacciò, insisté a lungo perché la truppa da Bonelle venisse ritirata». Infatti, una volta liberato il paese dall’assedio militare, i fascisti avrebbero avuto modo di intervenire portando la distruzione, la morte, il terrore. A questo mirava il magistrato che «si espresse con ferocia, desiderando la distruzione dell’abitato, la strage delle famiglie» (“L’Avvenire”, 8 giugno).
Le famiglie, sotto l’incubo della morte, dell’incendio, della distruzione cercavano in qualche modo di mettersi al riparo. «Continua l’esodo straziante degli abitanti da Bonelle, vecchi e malati, donne e ragazzi hanno raccolto le poche cose necessarie e sono andati altrove, nei fienili, nelle stalle, nelle altre case coloniche di parenti, dovunque possa esser meno possibile la tempesta che ha già fatto le sue vittime. E in città si fà la caccia all’uomo, si percuotono ferocemente i nostri migliori per vendicare... la vittima che non c’è. Ah! Giolitti! Boia labbrone ridi pure».
Passarono due mesi, l’istruttoria aveva preso il corso di una qualunque pratica indiziaria. C’era l’assoluta assenza di qualunque prova a carico degli oltre venti comunisti arrestati che, malgrado le ripetute violenze rifiutavano di confessare, c’era la ritrattazione del giovane minorato che ancora portava sul corpo i segni delle torture subite.
Del corpo del fascista avvelenato e squartato non era stato trovato neanche un pezzetto. Riapparve il 1° agosto, non era stato né avvelenato, né lessato, né squartato. Era intero, vivo e vegeto. Tutto questo tempo lo aveva passato a Bologna: lo sapevano i familiari, lo sapevano i fascisti, lo sapeva la polizia.
«Il vice‑segretario della Camera del lavoro [di Pistoia, ndr] saputo che l’Urbani trovavasi nel bolognese si affrettò a darne notizia ad un giornale fiorentino; ma il suo intervento onesto e coraggioso non gli fruttò che un carico di bastonate. Finalmente al fascista Urbani venne a noia di fare il morto e un bel giorno tornò tutto allegro a Pistoia [...] Allora si ebbe uno scoppio generale d’indignazione contro gli autori dell’indegno trucco. Fu proclamato lo sciopero generale per ottenere l’immediata scarcerazione degli operai di Bonelle, e quando il giorno dopo questi poveri disgraziati furono rilasciati coi segni in volto delle sevizie e delle sofferenze di due mesi di detenzione, una folla immensa li acclamò alla loro uscita dal carcere» (Garosi)
“Il Comunista” del 28 aprile 1922 e “L’Avvenire” del 5 maggio relazionano di un attacco fascista contro Bonelle. «Martedì 18 corr. mese, a notte inoltrata i fascisti occuparono il paese e si scaglionarono lungo la strada armati di moschetti e rivoltelle». «Sono stati devastati i locali del Circolo e della cooperativa, con l’aiuto dei regi carabinieri che nello svolgere dell’azione hanno piantonato le vie d’accesso al paese». «I bravi dopo aver compiuto il loro eroico gesto sparando in aria una nutrita scarica [...] si allontanarono al canto dei loro inni [...] Fu solo potuto salvare il fabbricato perché il popolo [...] in pochi minuti riusciva a smorzare le fiamme che gli eroi della nuova Italia avevano creato con latte di benzina».
Il successivo 11 agosto gli armati tornarono a portare terrore nella piccola frazione pistoiese. «Venerdì notte arrivò la spedizione fascista; arrestati i camions presso il ponte che trovasi all’inizio del paese, i fascisti armati di moschetto e bombe e mascherati, irruppero nel paese silenzioso e deserto. La Cooperativa, la casa del barbiere ed altre abitazioni furono incendiate, mentre centinaia di colpi venivano sparati» (“Il Comunista” 15 agosto 1922).
* * *
Riportiamo i dettagli di tutte queste vicende non certo per denunciare la violenza e il suo uso illegale da parte della classe dominante. Nemmeno per vantare il martirio dei nostri compagni come fosse un merito in sé di fronte alla storia. Sono episodi di una guerra combattuta fra le classi, che fa uso di tutti gli strumenti della guerra, compresa la menzogna e l’inganno. Li descriviamo perché non se ne perda il ricordo, non per provocare una generica indignazione ma solo a lezione del partito comunista di domani, insegnamenti sulla lotta armata, su di cosa sono capaci le possidenti classi reazionarie. La prima condizione di una vittoria è, freddamente, conoscere il proprio nemico.
La Rivoluzione d’Ottobre
Capitolo esposto alla riunione generale del settembre 2020
Dopo il tentativo di Kornilov e la dissoluzione dell’esercito di Krimov, nel resto del paese e nelle campagne continuano numerose e aspre rivolte, le requisizioni delle terre, anche se represse dalle truppe governative, la formazione di comitati e Soviet per la gestione delle fabbriche. Operai e contadini russi si riconoscevano sempre più nel programma bolscevico, come dimostrano le elezioni per la gestione dei Soviet, che finora avevano visto il predominio dei Socialrivoluzionari di Kerensky.
Quelle di Mosca in luglio avevano registrato il netto vantaggio degli S‑R, col 51% dei voti, i cadetti col 17%, i menscevichi col 12% e ultimi i bolscevichi con l’11%. In quelle d’inizio ottobre la situazione si capovolse: i bolscevichi arrivarono al 51% dei votanti; i cadetti stabili al 16%; gli S‑R crollarono al 14%, infine i menscevichi ultimi col 4%. In seguito a ciò il Soviet di Mosca ebbe un esecutivo bolscevico.
A Pietrogrado la situazione era più complessa per le caratteristiche della città, della sua guarnigione e della flotta. Il Soviet della città disconobbe il potere del Governo Provvisorio. La sezione operaia del Soviet nominò una dirigenza bolscevica e approvò una mozione a favore del potere sovietico con 510 voti contro 414 e 67 astenuti. In seguito a ciò i rappresentanti menscevichi e degli S‑R si dimisero dall’esecutivo che passò sotto il controllo dei bolscevichi. Trotski ne fu nominato presidente.
I bolscevichi giorno dopo giorno assunsero il controllo della maggior parte dei Soviet di tutta la Russia rivendicando la parola d’ordine: Tutto il potere ai Soviet.
Il 15 settembre il Governo provvisorio, preoccupato per il rinvio dell’Assemblea costituente, indisse a Pietrogrado una “Conferenza Democratica” di 1.200 delegati alla quale non vennero invitati i rappresentanti delle associazioni padronali e dei partiti borghesi, ma delle cooperative, degli organi consultivi dei governatorati locali (zemstvo) e delle associazioni locali, allo scopo di riportare il C.E. sotto il suo controllo. Risultarono 532 S‑R, cui 71 dell’ala sinistra, 530 menscevichi, compresi 56 dell’ala internazionalista, 55 social popolari; 17 si dichiararono non iscritti ad alcun partito; i bolscevichi erano soltanto 134. Scopo dichiarato era che il prossimo governo doveva essere a base “socialista” e non comprendere i partiti borghesi e i cadetti, che avevano sostenuto Kornilov e ne erano la rappresentanza politica. In realtà la Conferenza esprimeva il tentativo del Governo di respingere l’indicazione di Tutto il potere ai soviet.
Il 20 settembre si concluse la Conferenza in modo confuso, spaccandosi sulla ammissione nel nuovo governo di coalizione dei partiti borghesi, dei cadetti e dei sostenitori di Kornilov, e sulla formazione di un Preparlamento con funzioni solo consultive, cioè un organo assolutamente inutile.
I bolscevichi, anziché abbandonare la Conferenza e rivolgersi alle masse per spingerle all’insurrezione, come aveva indicato Lenin in particolare su due delle molte lettere inviate in quei giorni (“Sui compromessi” e successive note su “Marxismo e insurrezione”), puntavano solamente alla formazione di un governo più radicale.
In particolare in “Marxismo e insurrezione” Lenin spiegava la differenza tra il periodo di luglio, in cui l’insurrezione sarebbe stata un errore perché i bolscevichi non avevano sufficiente forza e non sarebbero stati in grado di conservare il potere, e prima dell’avventura di Kornilov, quando l’esercito e la provincia avrebbero marciato contro Pietrogrado. Ora, dopo Kornilov, la situazione era capovolta e bisognava agire scegliendo con cura il momento per l’insurrezione: la soluzione della crisi non era nella Conferenza ma nei quartieri proletari e nelle caserme di Pietrogrado e di Mosca.
Concludeva la successiva lettera: “La crisi è matura”, indirizzata al CC del partito, perentorio e minaccioso: «Non prendere il potere oggi, “attendere”, chiacchierare al Comitato esecutivo centrale, limitarsi a “lottare per l’organo” (dei Soviet), a “lottare per il congresso” significa perdere la rivoluzione. Visto che il CC ha perfino lasciato senza risposta le mie richieste insistenti in questo senso dopo l’inizio della Conferenza Democratica, che l’organo centrale del partito sopprime nei miei articoli i brani che rilevano questi stridenti errori dei bolscevichi, come la decisione disonorevole di partecipare al Preparlamento, la concessione di un posto ai menscevichi nel presidium del Soviet ecc. ecc. io devo considerare questi fatti come una manifestazione “sottile” del desiderio del CC di non discutere neppure la questione, un discreto accenno a chiudermi la bocca e un invito a ritirarmi. Sono perciò costretto a chiedere di uscire dal CC, cosa che faccio riservandomi libertà di agitazione nella base del partito e nel congresso del partito. Perché è mia convinzione profonda che se noi “attendiamo” il congresso dei Soviet e lasciamo passare il momento attuale, noi perdiamo la rivoluzione».
In particolare nelle “Lettera al comitato centrale” e nei “Consigli d’un assente” dei giorni immediatamente successivi dava chiarissime indicazioni strategiche su come impostare l’insurrezione. Concludeva: «Il successo della rivoluzione russa e della rivoluzione mondiale dipende da due o tre giorni di lotta». Nonostante il divieto del Comitato Centrale del partito, per motivi di sicurezza, Lenin, senza informarlo, lasciò la Finlandia e si trasferì a Vyborg, quartiere operaio di Pietrogrado.
Il 7 ottobre i bolscevichi uscirono dal Preparlamento impedendo la pacifica soluzione parlamentare della crisi: si avvicinava l’insurrezione.
Si formò allora un nuovo governo Kerensky con la partecipazione del partito dei cadetti. Per assicurare il suo incerto potere cercò di allontanare da Pietrogrado le truppe rivoluzionare inviandole verso la frontiera col pretesto di una imminente invasione tedesca dopo la caduta di Riga.
Per coordinare l’uso della forza armata si costituì a Pietrogrado il Comitato militare rivoluzionario (CMR) formato dal comando militare della circoscrizione e dall’organizzazione militare bolscevica. Funzionerà come Stato maggiore della rivoluzione, la cui direzione politica fu assunta dall’Esecutivo di Pietrogrado. Vennero censite le unità più fidate, le armi, le munizioni e i viveri e stimate le necessità per coordinare l’azione.
Il 20 ottobre il governo emise un nuovo ordine di cattura per Lenin, dopo voci che ne segnalavano la presenza a Pietrogrado.
Il 22 ottobre il CMR, in risposta al tentativo di Kerensky di allontanare le truppe rivoluzionarie da Pietrogrado, nominò propri commissari in tutte le unità della guarnigione, di fatto assumendo il controllo di quasi tutte le forze armate della capitale baltica, disarmando il Governo provvisorio senza alcun scontro diretto. Trotski descriverà la manovra come necessaria per concretizzare il passaggio di tutti i poteri al Soviet e difenderlo dall’attacco del Governo che, in combutta con le forze reazionarie, intendeva sabotare il prossimo Congresso pan russo dei Soviet.
Il 23 ottobre il CC bolscevico stabilì la data dell’insurrezione, che secondo Lenin avrebbe dovuto precedere l’inizio del Congresso dei Soviet: essendo questo numericamente consistente e composto da diverse tendenze politiche non sarebbe giunto a una rapida e univoca decisione. Il partito lo doveva porre di fronte alla già compiuta conquista del potere da parte dei lavoratori. Occorreva poi rovesciare Kerensky per impedire che il governo utilizzasse contro la rivoluzione le truppe lealiste distolte dal fronte.
Le organizzazioni militari della Guardia Rossa in tutta la Russia potevano disporre di un massimo di 150.000 armati in 62 città, 20‑25.000 a Pietrogrado, 12.000 a Mosca, 5.000 a Kiev, 3.500 a Charkov, 2.600 a Saratov e 1.000 a Nižnij Novgorod più i raggruppamenti nei centri minori, nei villaggi e nelle campagne.
Il 28 ottobre i bolscevichi di Pietrogrado dettero l’ordine dell’insurrezione. Il CC, che l’aveva decisa il 23 ottobre, ne affidò la direzione a un triumvirato composto da Antonov-Ovseenko capo del CMR, ex ufficiale di fanteria con un avventuroso passato di organizzatore di sommosse militari dalla Polonia alla Siberia e clamorose evasioni da diversi carceri, a Podvojskij, compagno di vecchia data che aveva già partecipato ai moti del 1905, e a Čudnovskij. Facevano altresì parte del gruppo organizzatore: Eremeev, Blagonravov e Sadovskij. Nessuno di loro aveva una consolidata esperienza di comando di unità militari.
Queste per lo più erano formate da elementi eterogenei e differentemente armati. I volontari della Guardia Rossa erano armati di fucili, pistole e qualche mitragliatrice. Erano organizzati in squadre di 10 uomini, in plotoni di 4 squadre, in compagnie di 3 plotoni e in battaglioni di 3 compagnie. I battaglioni di un distretto cittadino formavano una divisione. Le fabbriche più importanti avevano già le loro divisioni. L’istruzione all’uso delle armi, che prima avveniva di nascosto, ora si teneva nei cortili delle fabbriche, nei giardini e nei viali, segno che il vecchio Stato era ormai distrutto e ne era sorto uno nuovo, che necessitava solo dell’atto dell’insurrezione per sostituirsi al vecchio.
Il CMR dovette tenere conto dei rapporti di forza nella capitale, così sintetizzati da Trotski: «Dalla parte degli operai era la stragrande maggioranza della guarnigione: ma la minoranza era contro gli operai, contro l’insurrezione, contro i bolscevichi, una piccola minoranza composta dagli elementi più qualificati dell’esercito: il corpo degli ufficiali, gli junkers, i battaglioni d’assalto e forse anche i cosacchi. Questi elementi non si poteva conquistarli politicamente: bisognava batterli».
Il 31 ottobre nel palazzo dello Smolny, sede dei Soviet, si tenne la riunione dei delegati di reggimento e di compagnia della regione di Pietrogrado, che si pronunciò per l’insurrezione armata. Un manifesto diffuso dal CMR accusava il Governo Provvisorio e il comando generale della guarnigione di aver rotto i buoni rapporti con la guarnigione rivoluzionaria e il Soviet di Pietrogrado e di essere diventati strumenti della controrivoluzione. Esortava i soldati della capitale a difendere l’ordine rivoluzionario, all’obbedienza agli ordini del solo Comitato Militare Rivoluzionario.
Zinoviev e Kamenev, i quali nelle precedenti riunioni del CC avevano sempre votato contro l’insurrezione, resero nota, tramite un’intervista a un giornale esterno al Partito, la Novaya Žhizn, la loro opposizione; altri addirittura pubblicarono dettagliati piani e date. Lenin rispose con la “Lettera ai membri del partito bolscevico” accusandoli di tradimento e ne chiese l’espulsione.
Sono giorni di continui congressi e assemblee in tutta la Russia delle varie organizzazioni militari e dei comitati di fabbrica.
Il 4 novembre la “Giornata del Soviet di Pietrogrado” è una grande manifestazione di operai e soldati che conferma l’adesione delle avanguardie della città alle parole d’ordine bolsceviche. Ovunque si parla dell’insurrezione che appare imminente.
L’insurrezione armata a Pietrogrado e a Mosca
Il 5 novembre i soldati della fortezza-prigione Pietro e Paolo, in seguito al vigoroso intervento di Trotski alla loro assemblea, aderiscono al CMR mettendo a sua disposizione il loro fornito arsenale e i cannoni a controllo della città. Questo fatto militare contribuisce alla rottura delle trattative tra CMR e Comando generale della guarnigione di Pietrogrado. Nella notte il Governo accenna ad una tardiva reazione.
All’alba del 6 novembre il Governo ordina all’incrociatore Aurora di salpare per una crociera di addestramento, per allontanare dalla capitale il suo equipaggio fortemente influenzato dai comunisti, mobilita tutte le unità disponibili, compresi gli allievi e i cadetti, che vengono poste a difesa dei principali edifici pubblici, di alzare e presidiare i ponti sulla Neva in modo di separare i quartieri operai dal centro della città, di isolare i telefoni dello Smolny, di sequestrare i giornali bolscevichi Soldat e Rabochij Put’, di arrestare tutti i comunisti ritornati in libertà dopo le giornate di luglio e di processare per sedizione i membri del CMR.
Nella stessa mattina il CMR ordina al reggimento Litovskij e al VI battaglione del genio di riaprire le tipografie dei due giornali soppressi, che riprendono subito le pubblicazioni, ed ordina all’Aurora di rimanere a difendere la città e la rivoluzione. Il CC. bolscevico mette a punto gli ultimi particolari dell’insurrezione ed affida al triumvirato il comando delle operazioni militari. Le forze fedeli a Kerensky, vista l’inefficacia delle loro direttive, precipitano nella confusione e nell’impotenza.
Lenin chiude la sua breve “Lettera ai membri del CC” con: «Il governo esita. Bisogna conquistare il governo a qualsiasi costo! Indugiare nell’azione equivale alla morte». lascia il rifugio segreto di Vyborg e si trasferisce in incognito allo Smolny.
Il 7 novembre alle ore 2 la Guardia Rossa occupa le stazioni ferroviarie Nikolaevskij e del Baltico; alle 3,30 l’Aurora attracca presso il ponte Nikolaevskij e caccia gli junker che lo presidiano; alcune torpediniere partite da Helsingfors risalgono la Neva in appoggio all’Aurora. Alle 6 un plotone di soldati e della Guardia Rossa occupa la Banca di Stato; alle 7 un distaccamento del reggimento Keksgel’mskij occupa la centrale telefonica e isola il Palazzo d’Inverno e il comando del presidio militare; una pattuglia della Guardia Rossa assume il controllo del ponte del Palazzo d’Inverno vicino al quartier generale governativo.
Alle 10 Kerensky, vistosi isolato, fugge a bordo di un’auto con le insegne dell’ambasciata americana, diretto al fronte settentrionale dove cerca rinforzi militari.
Alle 12 la milizia del CMR, dopo aver respinto un attacco dei governativi alla centrale telefonica, occupa il palazzo Mariinskij e disperde il Consiglio della repubblica.
Alle 14,30 Lenin interviene nella seduta straordinaria del Soviet di Pietrogrado dove si sta analizzando la situazione determinatasi con il rovesciamento del Governo provvisorio e la presa del potere del Soviet e sui compiti da assumere.
Nel pomeriggio tutta la città è occupata dagli insorti ad eccezione di una ristretta area attorno al Palazzo d’Inverno, che viene circondato. Alle 18,30 il CMR intima la resa al comando che difende il Palazzo, mentre gli assediati iniziano a sbandarsi. I cannoni della fortezza di Pietro e Paolo sono puntati sul Palazzo d’Inverno e alle 23 aprono il fuoco. Le forze del CMR passano all’assalto, annientano ogni resistenza e arrestano i membri del Governo Provvisorio ancora presenti.
Alle 22,40 si apre il secondo Congresso panrusso dei Soviet, ora a maggioranza bolscevica. I delegati menscevichi, bundisti e parte degli S‑R abbandonano i lavori e in corteo si dirigono verso il Palazzo d’Inverno, non ancora espugnato, ma sono dispersi da un gruppo di marinai bolscevichi. Il Congresso, ora composto da bolscevichi e dalla sinistra degli S‑R, approva l’appello scritto da Lenin: “Agli operai, ai soldati e ai contadini” in cui si annuncia che il nuovo potere sovietico proporrà un armistizio su tutti i fronti e una pace immediata, il passaggio gratuito delle terre delle grandi proprietà e della Chiesa, la democratizzazione dell’esercito, il controllo operaio sulla produzione, e provvederà a fornire il pane alle città e i beni di prima necessità alle campagne. Tutto il potere, in tutte le località passa ai soviet, che dovranno assicurare l’ordine rivoluzionario.

Man mano giungono notizie sulla diffusione dell’insurrezione e la formazione dei vari CMR nelle diverse città, compreso quello a Pskov, sede del quartier generale del fronte settentrionale, e la formazione di un Soviet composto da soldati, operai e varie organizzazioni. I Soviet di numerose importanti città assumono il potere. A Mosca il Soviet organizza il suo CMR, la Guardia Rossa prende il controllo dei vari punti strategici della città e ne assume il controllo mentre i menscevichi, gli S‑R, i cadetti e altre formazioni moderate formano un Comitato di Sicurezza per combattere l’insurrezione.
L’8 novembre, dopo l’insurrezione quasi incruenta, il CMR assume il controllo della polizia, ordina e regola l’apertura dei depositi alimentari e il funzionamento dei servizi pubblici e dei trasporti, libera i detenuti politici e abolisce la pena di morte al fronte. Gran parte delle banche restano chiuse.
La controrivoluzione a Pietrogrado si organizza rapidamente costituendo un Comitato per la Salvezza del Paese e della Rivoluzione, cui aderisce parte del Consiglio cittadino, parte dell’Esecutivo dei soviet contadini, socialisti moderati, parte del Consiglio della repubblica e comitati di varie formazioni. Il Comitato esecutivo centrale decaduto collabora e disconosce il secondo Congresso dei Soviet. Questo Comitato si presenta alla popolazione come l’erede del Governo Provvisorio e chiama al boicottaggio e alla resistenza contro il nuovo potere. Ottiene adesioni tra i funzionari e nei servizi.
Kerensky a Pskov si accorda con Krasnov, comandante della cavalleria cosacca, per sferrare un attacco su Pietrogrado.
In tarda serata Lenin presenta al Congresso pan russo il decreto sulla pace, annuncia l’abolizione della diplomazia segreta, l’armistizio generale, la proprietà privata della terra viene abolita immediatamente senza indennizzo e l’amministrazione dei beni ecclesiastici e privati è affidata ai comitati agrari e ai soviet dei contadini. Viene eletto un nuovo CEC composto di 101 membri, 29 dei quali sono S‑R di sinistra; Kamenev ne è il primo presidente.
A Mosca i bolscevichi interrompono ogni trattativa con le opposizioni, proseguono nell’azione armata e il CMR ordina alla guarnigione di allertare tutte le unità.
Continuano a giungere notizie sul controllo sovietico di altre città, ma anche dell’opposizione organizzata nei territori cosacchi del Don e del Kuban.
Il 9 novembre il governo sovietico telegrafa la proposta di pace a tutte le potenze belligeranti. I cosacchi di Krasnov si posizionano a 45 chilometri da Pietrogrado.
Il CMR di Mosca respinge l’ultimatum del comando della regione militare e chiama alla lotta armata i 600 rivoluzionari che erano detenuti a Dvinsk per le giornate di luglio, che affrontano nei primi scontri armati nella Piazza Rossa i controrivoluzionari e gli allievi ufficiali. Altre città sono controllate dai soviet. Gli junker occupano il Cremlino, la posta centrale, la centrale telefonica, il telegrafo e alcune stazioni ferroviarie. La controffensiva del CMR scaccia gli junker dalla sede del quartier generale sovietico.
A Pietrogrado il 10 novembre i cosacchi di Krasnov si impossessano della residenza imperiale di Tsarskoe Selo, presidiata da 16.000 uomini, che si dichiarano neutrali: altro segno della disgregazione dell’esercito. Il CMR dispone la difesa della città affidata alla Guardia Rossa mentre gli operai stendono barriere di filo spinato.
L’11 novembre, durante la notte gli allievi ufficiali guidati dal colonnello Polkovnikov con un’audace manovra si impadroniscono di alcune autoblindo, occupano la centrale telefonica e prendono in ostaggio Antonov-Ovseenko. Il CMR invia reparti della Guardia Rossa e di marinai che in successivi assalti reprimono i centri di resistenza degli junker. Krasnov, in assenza di rinforzi, rimane a Tsarskoe Selo.
L’esecutivo dei ferrovieri propone la formazione di un governo formato dai rappresentanti di tutti i partiti socialisti. Le trattative falliscono per la richiesta dei socialisti moderati di sciogliere il CMR e di escludere dal governo Lenin e Trotski.
Il 12 novembre fallisce l’attacco dei cosacchi sulle alture alla periferia. Krasnov, temendo l’accerchiamento, ripiega di una decina di chilometri sulla reggia di Gatčina.
Armistizio a Mosca tra i combattenti
Il 13 novembre truppe sovietiche occupano Tsarskoe Selo. A Mosca il CMR denuncia l’armistizio e riprende il controllo della posta, dei telefoni e delle stazioni ferroviarie. I rappresentanti di 6 Armate si schierano con i soviet.
A Kiev è rovesciato il governo provvisorio e la Rada assume il controllo della città.
Il 14 trattative di armistizio tra Krasnov e Dybenko, un energico attivista bolscevico proveniente dalla flotta del Baltico, che chiede la consegna di Kerensky, il quale riesce a sparire in tempo. Marinai bolscevichi si infiltrano tra i cosacchi fiaccandone il morale e la disciplina. Nel pomeriggio, truppe sovietiche conquistano Gatčina. Krasnov e lo stato maggiore di Kerensky sono arrestati. A Mosca i bolscevichi espugnano le roccaforti degli junker e iniziano il bombardamento del Cremlino, ultimo loro rifugio.
Il 15 novembre si estende ulteriormente il controllo sovietico in altre città. Il generale Alekseev, già comandante in capo dell’esercito zarista, inizia ad organizzare forze antibolsceviche a Novočerkassk, capoluogo cosacco del Don.
Il 16 novembre alle 3 del mattino la Guardia Rossa inizia a Mosca l’assalto finale al Cremlino e ne travolge le difese.
Il 17 alcuni dirigenti bolscevichi escono dal governo rivoluzionario e dal CC del partito come protesta al rifiuto di Lenin di allargare il governo a esponenti di altri partiti socialisti che da tempo trattavano in tal senso.
Il 18 novembre Lenin, in qualità di presidente del Consiglio dei commissari del popolo, redige l’appello “Alla popolazione” annunciando la definitiva vittoria della rivoluzione a Pietrogrado e Mosca e sui compiti immediati dei soviet.
Il 19 trattative tra i bolscevichi e la sinistra S‑R per un loro ingresso nel governo.
Il 20 è inviato un radiomessaggio a tutte le potenze belligeranti con la proposta di armistizio; il governo bolscevico ordina al generale Duchonin di avviare trattative in tal senso con i comandi tedeschi e di sospendere le operazioni militari.
Il 22 novembre il bolscevico Krylenko sostituisce il generale Duchonin, che si
rifiuta di trattare con i tedeschi per le forti pressioni dei rappresentanti
militari di tutte le potenze alleate. Prima di essere portato a Pietrogrado
davanti a un tribunale rivoluzionario Duchonin ordina di liberare diversi
generali posti agli arresti dopo il fallito tentativo di colpo di Stato, tra cui
Kornilov e Denikin. Appena diffusa la notizia una folla di soldati trascina
fuori dal treno Duchonin e lo finisce a colpi di fucile e baionetta. Il suo
corpo è usato come bersaglio nelle esercitazioni di tiro.
La guerra civile
(Capitolo esposto alla riunione generale del gennaio 2021)
Cruciali sono i primi giorni del potere bolscevico. Tre i compiti più urgenti.
Primo: estendere il dominio nella sconfinata Russia. Occorre velocemente proteggere militarmente Pietrogrado e Mosca assicurando una contiguità territoriale, possibile perché fin dai primi moti i soviet di molte città hanno preso il potere, come man mano avviene in molte altre.
Secondo: difendere il potere dagli attacchi interni della controrivoluzione. Già il 20 novembre, giorno del radiomessaggio alle potenze belligeranti per un armistizio, l’atamano cosacco Kaledin aveva dichiarato l’indipendenza dei territori del Don, attirando un eterogeneo e instabile mosaico di ogni sorta di disparate forze antibolsceviche, da frange della nobiltà militare, dal clero e anche menscevichi che si organizzano militarmente contro il potere dei soviet.
Terzo: difendere la base sociale del potere dando concrete risposte alle più urgenti richieste che avevano spinto le masse alla rivoluzione contro i residui dello zarismo e il governo borghese di Kerensky. Tra le misure più significative l’introduzione per legge della giornata lavorativa di otto ore e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; la pubblicazione dei trattati segreti tra le capitali imperialiste europee alla vigilia della guerra; il decreto sul controllo operaio delle imprese industriali; prime misure sulla spartizione delle terre tra i contadini; decreto sulla soppressione delle caste e dei gradi civili, misure concrete contro la piaga ereditata dallo zarismo dell’analfabetismo.
Occorre inoltre gestire il tempestivo rifornimento e la distribuzione alimentare e combattere le bande dei sabotatori e accaparratori di grano: le razioni distribuite a Pietrogrado sono scese a 395 calorie, di gran lunga inferiori al fabbisogno di 1800, mentre si avvicina l’inverno con scarsità di combustibile.
Dal 23 novembre all’8 dicembre si riunisce a Pietrogrado il Congresso straordinario panrusso dei soviet dei deputati contadini. Sono adottate risoluzioni sull’organizzazione dei soviet dei deputati operai nel Turkestan musulmano.
Il 27 novembre gli Imperi Centrali per primi aderirono alla proposta sovietica di armistizio, allo scopo di chiudere velocemente il fronte orientale per concentrare le loro forze sul fronte occidentale, ancora aperto e vitale. Questo presenta esiti incerti per gli opposti fronti, nonostante l’offensiva austro tedesca si sia arrestata sul Piave e sul Grappa.
Il 30 novembre Trotski invita a Pietrogrado le missioni diplomatiche dell’Intesa per partecipare a negoziati di pace con gli Imperi centrali: nessuna risposta.
Del 1° dicembre un accordo di massima tra i bolscevichi e gli S‑R di sinistra per una loro partecipazione al governo. Inviati i primi distaccamenti militari bolscevichi contro i cosacchi bianchi di Kaledin. A Vladivostok e a Mogilev i soviet locali prendono il potere.
Il 2 dicembre iniziano a Brest Litovsk i colloqui con gli Imperi centrali.
Gran parte degli ufficiali e generali, tra cui Denikin, posti agli arresti nel monastero di Bykov sotto la sorveglianza di parte della Divisione Selvaggia del reggimento Tekniskij, che aveva fatto la guardia al Quartier generale di Kornilov, riesce agevolmente a fuggire e a raggiungere in treno il Don. Kornilov con 400 cosacchi del reggimento Tekniskij, pur con varie difficoltà tra cui scontri a fuoco con i bolscevichi, il 19 dicembre raggiunge il distaccamento del Don. Da questo insieme di forze fuggiasche si forma il nucleo di quella che diventerà l’Armata dei Volontari (A.V.).
A Mogilev il 3 dicembre Krylenko con un reparto di marinai sbaraglia definitivamente lo Stato maggiore generale che si era ribellato ai soviet.
Il 5 dicembre a Brest Litovsk è firmato con gli Imperi centrali un preliminare di armistizio in vigore dal 7 al 17 dicembre.
L’8 dicembre è emesso un appello ai lavoratori cosacchi perché combattano le formazioni controrivoluzionarie degli atamani Kaledin e Dutov. Nei giorni successivi si hanno sul Don i primi combattimenti contro Kornilov e Kaledin. Dutov arriva ad Orenburg.
L’11 dicembre, su proposta di Lenin, è emanato il “Decreto sull’arresto dei capi della guerra civile”. Il partito cadetto è posto fuori legge.
Il 15 dicembre è concluso l’armistizio con gli Imperi centrali a Brest Litovsk. Le truppe cosacche di Kaledin occupano Rostov sul Don.
Il 20 dicembre è costituita la Čeka (Commissione Straordinaria), voluta con convinzione da Lenin e dal polacco Dzeržinskij, incaricato alla sua guida. Il suo scopo principale è eliminare ogni nemico della rivoluzione: il potere sovietico non è consolidato, con la guerra civile solo agli inizi, con la penuria di alimenti che procurava un gran numero di vittime per fame, con le varie organizzazioni armate controrivoluzionarie già esistenti e quelle appena sorte e con bande di delinquenti e banditi di ogni genere che imperversano approfittando della situazione. Alla Čeka passano le funzioni del Comitato rivoluzionario militare di Pietrogrado, che è sciolto. Lenin in una nota in merito ribadisce: «Per la lotta ai controrivoluzionari e ai sabotatori, sono necessarie misure straordinarie». La Čeka «non è una commissione istruttoria, né la sede di un dibattito giudiziario, né un tribunale (...) ma è un organo combattente che opera sul fronte interno della guerra civile. Non sottopone a giudizio il nemico, ma lo colpisce. Non risparmia chi è dall’altra parte della barricata ma lo distrugge».
Inizialmente è costituita da un ristretto numero di fidati rivoluzionari, dotata di poteri eccezionali; in un suo primo appello invita tutti «i soldati, operai e contadini a mandare alla Commissione tutte le informazioni e le comunicazioni di fatti riguardanti le organizzazioni e le singole persone che svolgano un’attività ai danni della rivoluzione e del potere del popolo».
Poiché la Čeka non era tenuta a fornire alcun rendiconto del suo operato non si conosce il numero degli arresti e delle esecuzioni. La sua funzione sarà capovolta durante lo stalinismo, dopo diverse modifiche funzionali, per essere impiegata contro i comunisti rivoluzionari.
La crisi con la Rada ucraina
La complessa questione ucraina fu uno dei numerosi e gravi problemi che il potere bolscevico dovette affrontare fin dalla sua affermazione. Il punto più critico fu a cavallo del 1917/18. Ne ripercorriamo brevemente lo sviluppo.
Il 17 marzo 1917, subito dopo la Rivoluzione di Febbraio, a Kiev fu istituito il Consiglio Centrale, o Rada, per il governo della regione: un organo rappresentativo a maggioranza socialista, in cui erano presenti formazioni nazionaliste anticomuniste, e i bolscevichi erano in minoranza. Durante degli scontri a Kiev contro le forze del Governo Provvisorio i bolscevichi e la Rada si erano comunque forniti reciproco sostegno.
Il 22 novembre la Rada annunciò la creazione della Repubblica Ucraina come entità politica autonoma su un vasto territorio esteso fino al Caucaso e agli Urali, mantenendo però stretti legami con la Russia sovietica, instaurando una sorta di tregua con i bolscevichi ucraini. Assunse l’esercizio del potere in attesa delle risoluzioni in merito all’autodeterminazione dei popoli dell’Assemblea Costituente di tutta la Russia.
Ma questa, a maggioranza antibolscevica, nella seduta inaugurale del 18 dicembre aveva respinto la "Dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore e sfruttato" proposta dai bolscevichi e dagli S‑R di sinistra, i quali abbandonarono subito i lavori. Il giorno successivo l’Assemblea Costituente fu chiusa, e definitivamente soppressa il 20 gennaio, ancor prima di iniziare i lavori.
I bolscevichi ucraini avevano organizzato a Kiev per il 16/18 dicembre il loro primo Congresso, con l’intento di controllare il Congresso pan ucraino dei soviet. Il tentativo fallì subito per la generale ostilità loro riservata. Lasciata Kiev si rifugiarono a Charkov, dove proclamarono la Repubblica sovietica ucraina.
Il 18 dicembre il Consiglio dei Commissari del popolo (CCdP) inviava un “Manifesto al popolo ucraino con richieste ultimative alla Rada” in cui si riconosceva il diritto all’autodecisione di tutte le nazioni oppresse dallo zarismo, compreso quello di separarsi dalla Russia, ed eventualmente stabilire relazioni federative o similari. Al tempo stesso però accusava la Rada di perseguire un’ambigua politica borghese, che si traduceva nel mancato riconoscimento dei Soviet e del loro potere in Ucraina.
Ancora più gravi erano le accuse di aver richiamato dal fronte con ordini unilaterali i reparti ucraini, creando una pericolosa disorganizzazione militare, di aver disarmato le truppe sovietiche in Ucraina e, fatto ancor più grave, di appoggiare il complotto di Kaledin e dei vari suoi sostenitori lasciando transitare attraverso il suo territorio le truppe controrivoluzionarie che a lui si ricongiungevano, rifiutando invece il passaggio delle truppe dirette contro Kaledin. Si trattava di un vero tradimento della rivoluzione dei soviet che avrebbe implicato una dichiarazione di guerra, se fosse continuata.
Il Manifesto quindi poneva alla Rada 4 richieste: rinunciare ai tentativi di disorganizzare il fronte comune; non lasciar più passare reparti armati diretti al Don; collaborare con le truppe rivoluzionarie contro i cadetti e Kaledin; cessare di disarmare i reggimenti sovietici e della guardia rossa e restituire loro immediatamente le armi sequestrate. Dava tempo 48 ore per una risposta, e nel caso contrario il CCdP avrebbe considerato la Rada in stato di guerra contro il potere dei soviet in Russia e in Ucraina.
La risposta della Rada fu così evasiva e contraddittoria che il CCdP la considerò un rifiuto e affidò ad Antonov-Ovseenko il comando delle forze bolsceviche in Ucraina, contro quelle della Rada, delle Armate bianche di Kaledin, di Kornilov, di Denikin, nel frattempo giunte a Novočerkassk, divenuta una specie di capitale cosacca.
Antonov-Ovseenko fu coadiuvato in questo incarico come Capo di stato maggiore dall’ex alto ufficiale istruttore zarista M. Artemyevich Muravyov, da poco passato negli S‑R di sinistra e inserito nel CMR. Lenin gli aveva in precedenza affidato il compito di combattere i sabotatori e gli accaparratori a Pietrogrado. Mentre affluivano truppe bolsceviche a Charkov a sostegno della neo costituita repubblica sovietica ucraina, iniziarono gli scontri contro le truppe controrivoluzionarie e della Rada.
La situazione non era per niente netta perché vi erano reparti ucraini fedeli ai bolscevichi, viceversa nazionalisti ucraini combattenti sui più disparati fronti in Russia. Per cui, mentre Krylenko, al momento comandante supremo sovietico, ordinava di disarmare 6.000 ucraini in Bielorussia, Petljura il suo omologo ucraino, intimava ai suoi connazionali sotto le armi in Russia di disobbedire agli ordini dei soviet bolscevichi.
Ovseenko aveva ben chiaro che il nemico principale era Kaledin, e occorreva concentrare tutti gli sforzi contro le sue formazioni. Allo scopo le iniziali truppe bolsceviche, circa 15.000 unità eterogenee dotate complessivamente di circa 30 cannoni, alcune decine di mitragliatrici e due treni blindati, furono divise in 3 gruppi separati d’attacco, contando di trovare rinforzi in loco tra gli attivisti civili e militari bolscevichi ucraini.
Il primo gruppo di 3.500 uomini, al comando di N.P. Sablin, della sinistra S‑R, doveva dirigere a sud su Novočerkassk per liquidare i cosacchi di Kaledin; il secondo, di 4.500 unità, guidato dal veterano bolscevico colonnello R. Sivers, doveva avanzare nella vicina Rostov per annientare l’Armata dei Volontari; infine il terzo, composto da 7.000 uomini, 23 cannoni, 3 autoblindo e treni corazzati, affidato a Muravyov, risalendo la ferrovia passante per Poltava, doveva prendere Kiev e rovesciare il governo della Rada.
In questo modo si ebbero tre modesti eserciti che operavano in modo indipendente tra loro, sufficienti comunque contro le forze controrivoluzionarie che, se pur superiori come numero, erano però frammentate e prive di coordinamento.
L’impostazione di Muravyov, che risentiva della strategia napoleonica di mantenere separati, nei vasti territori ucraini, i due principali cobelligeranti, la Rada e Kaledin, si basava sul rapido spostamento di colonne indipendenti, principalmente su linee ferroviarie che, oltre ad assicurare il pronto rifornimento alle truppe, permetteva spostamenti veloci, anche notturni, per cogliere di sorpresa le guarnigioni locali e prendere il controllo delle stazioni principali.
In questa prima fase non esisteva un fronte ma una successione di piccoli scontri lungo le principali arterie del paese in una guerra ad elevata mobilità.
I primi combattimenti partirono nel gennaio 1918 da Charkov verso sud a una temperatura sotto zero. Segnarono l’inizio della guerra civile, dopo la rottura dei rapporti diplomatici con la Romania il 14 gennaio. Due giorni dopo è istituita l’Armata Rossa degli Operai e dei Contadini, il cui comando è affidato a Krylenko.
Le colonne indipendenti di Sablin e Sivers, sostenute dalle sommosse dei bolscevichi locali, occuparono importanti centri industriali bloccando ogni possibile collegamento lungo il Don tra le diverse formazioni cosacche, specialmente quelle di Kaledin.

Rimanevano ancora attive ma separate le formazioni di Kaledin nella regione del Don e quelle di Kornilov più a sud nelle steppe del Kuban.
Il 22 gennaio la Rada proclamò l’indipendenza dell’Ucraina come Stato sovrano, indipendente dalla Russia sovietica, dandosi così la possibilità di una pace separata con la Germania, considerata l’unica vicina forza militare in grado di arginare l’avanzata bolscevica. Mantenne aperto allo stesso tempo i contatti coi Soviet, in un doppio gioco.
A una delegazione di militari ucraini inviati da Kiev a Pietrogrado per chiedere le condizioni per fermare la sanguinosa guerra civile, Krylenko fece pervenire questa risposta: «Noi combattiamo la Rada per stabilire un governo sovietico dei lavoratori, dei soldati e dei contadini, rappresentativi dell’intero territorio di una repubblica federale russa. Appena il governo in Ucraina sarà trasferito alla Repubblica sovietica ucraina (quella di Charkov, ndr) tutte le operazioni contro l’Ucraina cesseranno».
La Rada, nella confusione dilagante, rilanciò il nazionalismo. Ma non ottenne nuovi arruolamenti di volontari a sua difesa. Inoltre commise l’errore di inviare i reparti a frenare l’avanzata bolscevica in modo scaglionato, disperdendo le già scarse forze. Né aveva tenuto conto del gran numero di diserzioni per cui probabilmente poteva disporre solo di circa 15.000 soldati, più o meno affidabili, sparsi nel suo immenso territorio. Di questi solo 1.200 riuscirono a raggiungere Kiev per unirsi a gruppi di studenti, di volontari civili e a quelli della guarnigione.
Anche Muravyov aveva sovrastimato in modo esagerato le forze di Kiev per cui rallentò l’avanzata in attesa di rinforzi. Quando fu rassicurato da Antonov-Ovseenko sulla reale consistenza avversaria riprese l’avanzata superando con piccoli combattimenti tutti gli ostacoli incontrati sulla linea ferrata per Kiev, mentre da nord sopraggiungeva una formazione bolscevica di 3.500 uomini con 12 cannoni, comandati dal lettone bolscevico Y.K. Berzin. Contro questo secondo fronte furono inviate forze di volontari assolutamente insufficienti a fermarli: ebbero forti perdite e dovettero arretrare. Per contrastare l’avanzata di Muravyov fu fatto saltare un viadotto costringendo i bolscevichi a fermarsi 3 giorni per ripararlo prima di poter riprendere la marcia.
Il 27 gennaio la situazione precipitò quando i migliori reparti ucraini furono richiamati a Kiev per sedare la rivolta dei soldati del Reggimento Brovary, che avevano arrestato i loro ufficiali e alzato la bandiera rossa. L’insurrezione, cogliendo di sorpresa la città, si estese ai civili comunisti, portando ad un totale di circa 2.200 rivoluzionari, a cui la Rada riuscì a contrapporre un numero simile di difensori. In città avvennero scontri, i rivoluzionari riuscirono ad avvicinarsi al palazzo del governo bombardandolo ripetutamente, ma furono poi respinti dai reparti scelti ancora fedeli alla Rada.
L’impeto dei rivoluzionari si esaurì nei 5 giorni di combattimenti per le perdite sul campo di 250 di loro, la mancanza di rifornimenti e il mancato arrivo delle truppe di Muravyov, impegnate nella riparazione del viadotto. Molti rivoluzionari gettarono le armi e si dispersero in città. Solo 250 resistettero per altri due giorni asserragliati nell’arsenale, fino all’arrivo dal fronte di altri reparti scelti della Rada guidati da Petljura. La battaglia finale strada per strada si concluse con la cattura degli ultimi rivoluzionari. Discordanti sono le versioni sulla repressione seguita, non poche furono le esecuzioni sommarie da aggiungere ai 1.100 bolscevichi caduti e i 900 della Rada, che la indebolivano ulteriormente.
Ripresa l’avanzata Muravyov arrivò a Kiev il 6 febbraio. Il piano per la presa della città prevedeva 7.000 uomini divisi in tre linee d’attacco: quella da nord, guidata da Berzin, su un treno blindato, avrebbe dovuto penetrare per il Ponte delle Catene; da est la colonna di Egorov doveva irrompere nella città attraverso il ponte ferroviario; la terza, di Muravyov, con l’artiglieria e la fanteria avrebbe dovuto prendere il centro della città.
Nella fase iniziale si ebbero solo modesti avanzamenti. Il giorno seguente l’unico reparto di cavalleria cosacca bolscevica, sul fiume ghiacciato aggirò i ponti e penetrò nella parte settentrionale della città incontrando una debole resistenza. Seguì un consistente bombardamento dell’artiglieria che permise l’avanzare delle poche autoblindo seguite dai reparti della fanteria, che incontrarono forte resistenza dei reparti scelti della Rada, che li bloccò al limitare del centro.
Il giorno seguente le colonne avanzarono in massa bloccando gli ucraini nell’area governativa. Il governo della Rada decise la sua immediata evacuazione, dei principali funzionari e delle truppe scelte alla retroguardia. Secondo un rapporto del console americano presente nella città, i cosacchi e i volontari prima di evacuare la città giustiziarono molti soldati che avevano disertato a favore dei bolscevichi.
Il 9 febbraio sul palazzo della Rada sventolò la bandiera rossa, costata la perdita di 500 uomini. La borghese Repubblica ucraina era durata solo 86 giorni. Muravyov si distinse per le sue capacità militari.
Prima dell’assalto finale, il 4 febbraio diramò l’ordine alle truppe «di eliminare senza pietà gli ufficiali, i cadetti, i gruppi paramilitari di cittadini, i monarchici e i nemici della rivoluzione a Kiev». Discordanti sono le versioni della repressione che seguì; secondo un rapporto della Croce Rossa ucraina gli uccisi furono 5.000.
Muravyov, più interessato alla caccia dei nemici interni e dell’annientamento delle ultime sacche di resistenza sociale, commise il gravissimo errore strategico di non inseguire e annientare quanto rimaneva del governo e dell’esercito della repubblica in fuga. La Rada infatti tentò di riorganizzarsi e si stabilì a Žytomyr, 150 chilometri ad ovest di Kiev, contando sull’aiuto degli austro-ungarici, per preparare la controffensiva.
Rimanevano anche attive e pericolose sacche di resistenza cosacca, principalmente del generale Alekseev, nel sud‑est dell’Ucraina, di Kaledin nella regione del Don e di Kornilov più a sud, nel Kuban, il tutto grosso modo l’attuale Donbass.
Ad Antonov-Ovseenko furono dati 7.000 uomini e carta bianca circa i mezzi per sconfiggere i controrivoluzionari di Kaledin, con i quali, alla prima chiamata di novembre, si arruolarono in 2.493. In più Kaledin aveva dato ospitalità nei territori da lui controllati all’Armata dei Volontari di Kornilov, costituita prevalentemente da ufficiali e cadetti. Questa armata, inizialmente composta di 1.440 elementi, era una formazione particolarmente esperta militarmente, giustamente temuta, vista come una continuazione del vecchio esercito zarista. I tre comandanti bianchi contavano di arruolare i veterani di rientro dai fronti, i quali invece o non volevano più combattere o si univano all’Armata Rossa di Ovseenko; solo una sparuta minoranza passò ai bianchi.
Kaledin aveva ottenuto un primo successo espugnando il 25 novembre l’importante città di Rostov, principalmente per l’azione dell’Armata dei Volontari. Ma le forze della controrivoluzione, composte di piccoli gruppi di volontari scollegati tra di loro, erano troppo esigue per sostenere l’urto dell’Armata Rossa, per cui il 9 gennaio i tre comandanti decisero di formare un Triunvirato per un minimo di organizzazione tra di loro, spartendosi le aree di azione. Adottarono una strategia di difesa in attesa del momento propizio per un’offensiva.
Ovseenko, incoraggiato dai successi della propaganda comunista per attirare forze locali alla causa, conquistata Kiev, cercò di incitare la popolazione non cosacca della zona alla rivolta contro il regime di Kaledin.
Sul piano militare Ovseenko aveva previsto un movimento avvolgente di due colonne principali su Novočerkassk, una scendendo dall’Ucraina e l’altra lungo il Don utilizzando le linee ferroviarie. Ma la manovra fu più lenta del previsto per la difficoltà degli approvvigionamenti e delle comunicazioni, per il timore di un intervento militare tedesco e specialmente per le continue incursioni della cavalleria cosacca, che agiva indisturbata alle spalle delle colonne sovietiche.
Diversi furono i successi dei gruppi cosacchi, in particolare quello comandato dal capitano Chernetsov, che però cadde il 21 gennaio in un duro scontro durato due giorni con la colonna del veterano della guerra russo-turca, il bolscevico Golubov. Nei giorni successivi la resistenza cosacca, priva del comandante, cessò in quel settore e le colonne di Sablin si ricongiunsero per riprendere l’avanzata su Novočerkassk.
Quelle del sovietico Sivers ebbero duri scontri con la disciplinata formazione dell’Armata dei Volontari presso la città di Taganrog. Questa fu conquistata il 9 febbraio, non senza fatica e consistenti perdite, per l’azione congiunta delle truppe rosse e della sollevazione di circa 5.000 operai della città che aprirono un fronte interno alle spalle dei controrivoluzionari.
I gruppi cosacchi, per la difficoltà degli approvvigionamenti, dipendenti dai capitali dei controrivoluzionari russi, per la stanchezza, per la propaganda comunista e per l’assenza di importanti vittorie strategiche ma soltanto di continue ritirate, iniziarono a disperdersi. La loro capitale restò difesa da un centinaio di uomini cui si aggiunse un solo battaglione di ufficiali inviato da Kornilov. I cosacchi di rientro dal fronte con la ferrovia erano fermati e disarmati dalle guardie rosse.
Al 10 febbraio 1918 si considera conclusa la resistenza dei bianchi nella loro capitale, nonostante che le forze bolsceviche avanzassero lentamente per i danni alle linee ferroviarie e per le incursioni delle formazioni cosacche ancora attive.
L’Armata dei Volontari di Kornilov si era attestata alla difesa di Rostov, dove anche qui la sollevazione della popolazione e l’avvicinarsi dell’Armata Rossa suggerì ai cosacchi di abbandonare la città e di condurre le residue forze nel Kuban, dove era ancora attiva la resistenza controrivoluzionaria.
Il 12 febbraio Kaledin si suicidò, mentre la colonna di Sivers giungeva nei pressi di Rostov e quella di Sablin si preparava all’attacco finale di Novočerkassk, dove si concentravano nuovi volontari cosacchi. Questi però il 20 febbraio, al momento di andare sulla linea del fuoco, si rifiutarono di combattere avviando il definitivo collasso delle truppe cosacche. La situazione peggiorò quando una divisione di 3.000 uomini di rientro dal fronte del Caucaso passò interamente ai bolscevichi e attaccò alle spalle l’Armata dei Volontari, che di notte riuscì a rompere l’accerchiamento e a fuggire nella steppa.
Il 23 febbraio le truppe di Sivers occuparono Rostov e due giorni dopo quelle di Sablin entrarono in Novočerkassk.
La marcia sul ghiaccio
Il 25 febbraio 1918 l’Armata dei Volontari decise di marciare verso sud su Ekaterinodar, al limite delle steppe del Kuban, sperando in un qualche sostegno. Infatti in quei giorni la locale Rada cosacca aveva proclamato una repubblica indipendente, che Kornilov intendeva trasformare nella capitale della controrivoluzione da cui partire per riconquistare la Russia.
Inoltre, per la scarsa presenza di industrie era scarsa la componente operaia, favorevole ai comunisti e le loro unità militari erano ancora in fase di organizzazione, mancavano di collegamenti con la loro lontana sede di Armavir.
Le due principali componenti dell’Armata Rossa inviate nella regione ebbero compiti diversi. La prima di circa 18.000 effettivi, al comando del cosacco rosso del Kuban A.I. Avtonomov, aveva l’obiettivo di conquistare Ekaterinodar e schiacciare la Rada; la seconda, affidata al medico militare cosacco I.L. Sorokin, di circa 12.000 cosacchi rossi, doveva intercettare l’Armata dei Volontari, che al momento contava circa 4.000 effettivi divisi in 3 reggimenti più diverse centinaia di profughi civili. L’Armata dei Volontari, a piedi, percorrendo circa 15 chilometri al giorno, superò alcuni scontri con le forze locali bolsceviche. La loro tattica fu di aggirare con i migliori reparti a cavallo le batterie dei rossi, impegnate a colpire l’avanguardia della colonna, e a travolgerle.
Il 15 marzo Avtonomov conquistava Ekaterinodar.
Il 17 marzo, presso Korenovskaja, 60 chilometri a nord di Ekaterinodar, avvenne la prima importante battaglia contro le più consistenti forze di Sorokin, che disponevano di forte artiglieria e munizioni, che invece iniziavano a mancare a Kornilov. Nonostante l’inferiorità il suo piano, basato su un fronte d’attacco centrale e due colonne laterali per l’accerchiamento, funzionò ancora. La vittoria costò la perdita di 400 uomini che, sommati a quelli degli scontri precedenti, giunsero ad un totale di 1.011, il 25% delle forze dell’inizio della campagna; i successivi arruolamenti di cosacchi volontari non erano sufficienti sia per numero sia per esperienza.
La caduta di Ekaterinodar impose un rapido cambiamento di strategia per cui l’Armata dei Volontari decise di scendere a sud oltre il fiume Kuban, sempre inseguita dalle truppe di Sorokin, che in questa fase non riuscirono ad organizzare una controffensiva coordinata tra i vari gruppi, lasciando l’iniziativa ai singoli comandanti. Il 30 marzo le truppe residue della Rada del Kuban, dopo una serrata trattativa si sottomisero a Kornilov, portando così il suo organico a 6.000 combattenti, più 3.000 profughi.
Il 10 aprile inizia l’attacco di Kornilov. Questo, viste le precedenti facili vittorie e sottovalutando la capacità combattiva dei rossi, decise di attaccare la città quando solo la metà del suo esercito era arrivato e disposto secondo i piani di battaglia. Si prevedeva di occupare le alture attorno alla città da cui lanciare l’attacco. Kornilov stabilì il suo quartier generale su una fattoria posta sulla cima di una di queste.
L’Armata dei Volontari riuscì ad occupare alcuni quartieri, pur accusando forti perdite. In città la popolazione, comprese le donne, sostenne i soldati rossi nelle trincee.
Il 13 aprile iniziò il contrattacco sovietico. Un proiettile di artiglieria colpì il quartier generale di Kornilov uccidendolo. Denikin assunse il comando. Visto che le sue unità, demoralizzate e sfinite, venivano ricacciate dalla città dalla controffensiva sovietica, decise per una rapida ritirata verso nord attraverso territori poco controllati dai bolscevichi e lontani dalle ferrovie.
Anche Sorokin commise l’errore di non inseguire in forze i resti dell’Armata dei Volontari, per cui la ritirata dei bianchi fu debolmente ostacolata.
Il 22 aprile Denikin, dopo una marcia di 245 chilometri in 9 giorni, nel fango ghiacciato, con una colonna lunga 10 chilometri, raggiunse il 30 aprile una linea ferroviaria, per arrivare a sud‑est di Rostov, da dove erano partiti 80 giorni prima nei quali avevano percorso 1.266 chilometri. Qui si dispersero. Il tentativo controrivoluzionario dell’Armata dei Volontari si concluse con una pesante sconfitta.
La situazione per l’Ucraina si complicò alla firma del trattato di Brest-Litovsk, con l’offensiva militare tedesca che occupò Kiev e gran parte della Crimea e vi instaurò un governo fantoccio allo scopo di impadronirsi delle materie prime e del grano ucraino necessari al sostegno del suo impegno militare sul fronte occidentale.
1.1. - Introduzione
Il Quarto Libro del Capitale di Marx si apre con la seguente tesi generale, che caratterizza tutta la storia delle dottrine economiche: «Tutti gli economisti commettono l’errore di considerare il plusvalore non semplicemente in quanto tale, ma nelle forme particolari di profitto e di rendita». Da ciò nascono i loro errori, a causa di questa mancanza di astrazione tutti gli economisti si precluderanno la possibilità di trovare la genesi del plusvalore.
Prima di sintetizzare la teoria fisiocratica è bene dare una breve ricostruzione del quadro storico del periodo.
Alla fine del XVII secolo la teoria mercantilista, che guidava la politica economica delle principali monarchie assolute, cominciò ad essere messa in discussione. Le misure protezionistiche adottate a favore delle manifatture avevano depresso le campagne. Le continue guerre espansionistiche avevano provocato gravi danni economici nei paesi che adottavano la dottrina mercantilista.
Cominciarono a manifestarsi dubbi sulla sua efficacia a guidare l’economia politica e si iniziò a cercare nuove soluzioni. Più in generale la società iniziava ad emanciparsi da tutto quell’apparato ideologico che aveva incardinato l’età medievale: sulla falsariga delle altre scienze, si affacciava la pretesa che anche l’economia avesse le sue leggi e che, per mezzo della loro conoscenza, fosse possibile regolarla.
1.2 - I maggiori esponenti della scuola
– Pierre le Pesant de Boisguilbert nacque a Rouen nel 1646 da una famiglia nobile. Nella città natale ottenne una carica nella magistratura che conservò fino alla morte. Occupandosi delle proprie terre vide la miseria dei contadini, oppressi in special modo dal pesante carico tributario. Avversò la politica di Jean‑Baptiste Colbert, controllore generale delle finanze di Francia, accusandolo d’aver trascurato l’agricoltura. In seguito ad alcune proposte di riforma fu esiliato per breve tempo in Alvernia. Morì nel 1714.
Le sue opere principali sono “Le détail de la France” a cui seguì “Le factum de la France”; altri scritti verranno da lui stesso raccolti nel “Testament politique du maréchal de Vauban”.
Secondo Boisguilbert, l’incremento della ricchezza deriverebbe da aumenti del consumo. L’organismo economico sarebbe infatti costituito dalla somma degli individui, nello stesso tempo produttori e consumatori, generanti il reddito, successivamente distribuito fra le diverse classi sociali. Conseguentemente il governo dello Stato avrebbe dovuto adottare provvedimenti di stampo liberista, come l’abolizione delle dogane.
Arriverà a percepire la possibilità di crisi economiche in quanto l’equilibrio del sistema produttivo si può mantenere solo a due condizioni: 1) che operi la libera concorrenza; 2) che i redditi siano completamente spesi invece che tesoreggiati.
– Richard Cantillon nacque da un proprietario terriero attorno al 1680 nella contea irlandese di Kerry. Nel primo decennio del ‘700 si trasferì in Francia. Acquistata una banca, ne trasse discreti guadagni grazie ad ingenti investimenti nella Mississippi Company, società fondata dall’economista John Law, che possedeva, su concessione del governo francese, il monopolio nello sviluppo dei territori francesi in Nord America. Ricavò grandi vantaggi dalla “bolla del Mississippi”, del quale crack molti dei creditori incolperanno Cantillon. Morì nel 1734 nell’incendio della sua dimora londinese, probabilmente doloso.
La sua opera principale è l’”Essai su la nature du commerce en général”. Punto di partenza della sua analisi è il concetto di ricchezza. «La terra è la fonte o la materia donde si trae la ricchezza; il lavoro dell’uomo è la forma che la produce». «Il prezzo o valore intrinseco di una cosa è la misura della quantità di terra e della quantità di lavoro che vi entra. Accade sovente, tuttavia, che parecchie cose, che hanno effettivamente questo valore intrinseco, non sono vendute al mercato secondo il loro valore: ciò dipenderà dalle fantasie e dai capricci degli uomini e dal consumo che ne faranno». Nota che terra e lavoro possono incidere in differente misura: il lavoro può avervi un peso preminente nella sua formazione o viceversa.
– François Quesnay nacque a Méré nel 1694. In gioventù intraprese lo studio della chirurgia trasferendosi quindi a Parigi dove si laureò. A metà del XVIII secolo venne introdotto alla corte di Luigi XV e divenne ben presto medico personale di Madame de Pompadour, la favorita del re. La vita di corte permise a Quesnay di frequentare gli enciclopedisti, i quali ottennero la sua collaborazione nella stesura di alcune voci dell’Enciclopedia; collaborazione che dovette bruscamente interrompersi in seguito all’attentato di Robert François Damiens ai danni del re.
La nascita della scuola fisiocratica può considerarsi l’incontro di Quesnay con il marchese di Mirabeau dopo che il primo ebbe letto e apprezzato l’”Ami des hommes ou Traité sur la population” scritto dal secondo. Successivamente i due entreranno in contatto anche con Anne Robert Jacques Turgot e Pierre‑Paul Lemercier de La Rivière. È in questo periodo che Quesnay comincerà a stendere varie versioni del fondamentale Tableau économique. Negli ultimi anni di vita abbandonerà gli studi prettamente economici dedicandosi alla matematica, prima di morire a Versailles nel 1774.
1.3. - La dottrina fisiocratica
La corrente fisiocratica è parte del pensiero illuminista secondo cui la struttura sociale è retta da leggi eterne che garantiscono la felicità all’individuo che vi si uniforma. L’ordine naturale però s’impone come necessità solo se gli uomini non ostacolano il dispiegarsi delle leggi che regolerebbero la società stessa. Qual è, allora, la norma economica fondamentale che regola il funzionamento di una società lasciata libera di agire? «La perfezione della condotta economica sta nell’ottenere la massima soddisfazione con la minima spesa» (Quesnay, “Sur le travaux des artisan”). È il principio che caratterizza il capitalismo.
Ma come può una norma prettamente individuale garantire l’ordine sociale? Per il fatto che l’interesse particolare è servitore degli interessi della collettività. Ogni individuo, pur operando egoisticamente per il raggiungimento dei propri fini, entra nella «concorrenza universale», e là trova altri individui, che, perché si propongono i suoi stessi scopi, ne limitano le pretese. “Laissez faire”, “laissez passer”, diventa il motto della scuola fisiocratica.
Tra i vari settori produttivi è l’agricoltura il più importante. Se si considera che la Francia del tempo era un paese capitalisticamente immaturo, dove l’artigianato rappresentava la base del settore manifatturiero, allora la tesi di Quesnay appare niente altro che il frutto di una visione limitata della realtà. I fisiocratici tuttavia non svolgono una ricerca parziale, settoriale e, tra i primi, cercano di percepire i legami che uniscono i fenomeni economici.
Come per i mercantilisti il valore si realizza nello scambio, ma trova origine nella produzione agricola, la sola attività in grado di generare un plusvalore; a questa scuola perciò spetta il merito d’aver superato l’assunto mercantilista che vedeva nello scambio la fonte della ricchezza. Quale fra le attività umane è la più idonea a creare una eccedenza? Per dare la risposta i fisiocratici propongono la distinzione fra lavoro produttivo e improduttivo. Il lavoro è produttivo se il prodotto ottenuto è superiore al costo del lavoro erogato.
Non potendo ancora individuare solo nel lavoro l’origine del valore, che scoprirà soltanto Marx, identificano nella terra il fattore produttivo in grado di creare il plusvalore. Quella agricola è l’attività umana che consente più facilmente di percepire concretamente la differenza tra il lavoro eseguito e il risultato ottenuto: il raccolto è in quantità maggiore del seminato. Ogni altra attività non fa che modificare le materie prime, scambiare manufatti, ecc. senza incrementare la ricchezza: in tutte le attività extra agricole ogni aumento di valore è annullato da un corrispondente consumo di ricchezza; sono “sterili”, benché non considerate inutili.
I fisiocratici non ignorano che nell’industria esistono capitali accumulati e che generano dei redditi individuali, ma arrivano a concludere che il loro apporto al prodotto nazionale è comunque nullo. I capitali lì ammassati sono solo prelevamenti operati sull’unico plusprodotto: quello agricolo.
Lo stesso vale per le attività commerciali. Nello scambio, prestazione e controprestazione si equivalgono ed eventuali differenze fra costo di acquisto e prezzo di vendita rappresentano solamente il corrispettivo trattenuto dagli operatori commerciali per coprirsi delle spese incontrate. L’incrociarsi degli scambi permetterà migliore soddisfazione dei bisogni umani ma non produrrà nuova ricchezza dato che le cose scambiate hanno valore equivalente.
Quesnay nota che laddove nell’attività agricola vengono investiti abbondanti capitali, i rendimenti risultano superiori; da qui non giunge ad affermare la produttività del fattore capitale, ma ammette che l’agricoltura sarebbe destinata a inaridirsi qualora non fosse alimentata con investimenti. Riconosce cioè che la conduzione capitalistica della terra consente la formazione di un surplus superiore agli altri tipi di conduzione.
I fisiocratici distinguono gli investimenti nelle aziende agricole in: 1) “Avances foncierés”, capitali investiti in bonifiche, ecc.; 2) “Avances primitives”, costi sostenuti dai fittavoli per l’acquisto dell’attrezzatura; 3) “Avances annuelles”, necessarie per far fronte ai costi d’esercizio dell’impresa; 4) “Avances souveraines”, costituite dalle spese statali nell’esercizio delle funzioni demandategli.
In coerenza con la loro visione del ciclo economico, elaborano una teoria delle classi che postula l’armonia fra gli interessi dei vari soggetti economici. Considerano la nazione formata da tre classi e tentano di dimostrare come ciascuna sia legata alle altre e come solo la loro collaborazione realizzi la prosperità.
Nell’elaborare le teorie sul salario i fisiocratici sono indifferenti riguardo eventuali problemi “morali” ed accettano la tesi che il lavoro sia una merce come le altre, soggetta pertanto alle leggi del mercato. A causa dell’aumento demografico la legge della domanda e dell’offerta costringerà i lavoratori a farsi concorrenza e il salario non potrà elevarsi al di sopra del prezzo dei mezzi di sussistenza. I fisiocratici introducono già la teoria per cui i capitalisti anticipano ai lavoratori quanto è loro necessario per vivere: gli imprenditori pagherebbero i salari prima che sia ottenuto il frutto del lavoro, con il che sono date le premesse per la futura teoria del “fondo salari”.
Quesnay nel suo classico “Tableau économique” disegna tre classi. La classe “produttiva” è costituita dagli imprenditori e dai lavoratori agricoli, a cui spetta annualmente il compito di ricreare, tramite lo sfruttamento agricolo, la ricchezza nazionale.
La classe “oziosa” comprende tutti coloro che vivono di rendita fondiaria, ovvero la corte, i funzionari pubblici, il clero, ecc. Essi ricevono la totalità del prodotto netto e provvedono alla sua redistribuzione. La rendita fondiaria appare ai fisiocratici legittima in quanto: 1) costituisce la remunerazione dei capitali anticipati dal proprietario; 2) rappresenta la manifestazione del diritto di proprietà; 3) l’azione dei proprietari favorisce lo sviluppo economico della nazione. L’importanza dei proprietari terrieri quindi non deriva dal fatto che essa crea il plusvalore, ma che se ne appropria.
La classe “sterile” comprende tutti quei lavoratori impegnati in attività extra agricole come gli artigiani, i lavoratori delle manifatture, ecc.
A detta dello stesso Marx questo tentativo di rappresentare l’intero processo in un Tableau costituito esclusivamente da cinque linee che collegano tra loro sei punti di partenza e di ritorno; questo tentativo fu un’idea estremamente geniale, indiscutibilmente la più geniale dell’economia politica.
Vi si riassume 1) la produzione del capitale come processo di riproduzione, 2) la circolazione come la forma di questo processo di riproduzione, 3) la circolazione del denaro solo come un momento della circolazione del capitale, include in questo processo di riproduzione 4) l’origine del reddito, 5) lo scambio tra capitale e reddito, 6) il rapporto tra il consumo riproduttivo e il consumo definitivo, 7) include nella circolazione del capitale la circolazione tra consumatori e produttori (tra capitale e reddito), 8) rappresenta la circolazione tra le due grandi partizioni del lavoro produttivo – produzione di prodotti grezzi e manifattura – come momenti di questo processo di produzione.
1.4. - La ricerca sull’origine del plusvalore
L’analisi del capitale, entro l’orizzonte del pensiero borghese, appartiene essenzialmente ai fisiocratici. Questo merito fa di essi i veri iniziatori dell’economia politica moderna. In primo luogo hanno analizzato i diversi elementi oggettivi nei quali il capitale si scompone nel corso del processo lavorativo.
Non si può inoltre rivolgere loro il rimprovero di separare, come faranno i loro successori, questi elementi oggettivi di esistenza del capitale, strumenti di lavoro, materie prime, ecc., dalle condizioni sociali in cui appaiono. Per essi le forme borghesi appaiono naturali, fisiologiche della società, che scaturiscono dalla necessità naturale della produzione, indipendenti dalla volontà, dalla politica, ecc.
I fisiocratici determinano le forme che il capitale assume nella circolazione (capitale fisso, capitale circolante), e il nesso tra processo di circolazione e processo di riproduzione del capitale. Adam Smith ne raccoglierà l’eredità.
La base per lo sviluppo della produzione capitalistica è la capacità lavorativa, in quanto merce appartenente agli operai, separata dalle condizioni di lavoro, merci che polarizzano nel capitale.
In quanto la forza lavoro è merce, è essenziale determinarne il valore, che è uguale al tempo di lavoro necessario per produrre i mezzi di sussistenza indispensabili alla sua riproduzione. Solo su questa base sorge la differenza tra il valore e la capacità di valorizzazione della forza lavoro, differenza che non esiste per nessun’altra merce, in quanto il valore d’uso di nessun’altra merce può accrescerne il valore di scambio.
Fondamento dell’economia politica moderna, il cui compito è l’analisi della produzione capitalistica, è di conseguenza la concezione del valore della forza lavoro come una grandezza data. Perciò il minimo del salario costituisce il perno della dottrina dei fisiocratici. Essi ebbero la possibilità di stabilirlo, sebbene non avessero scoperto la natura del valore, perché questo valore della capacità lavorativa si rappresenta in determinati valori d’uso. Perciò, anche senza avere idee chiare sulla natura del valore in generale, furono in grado di concepire il valore della forza lavoro come una grandezza determinata. Poi però commisero l’errore di concepire questo minimo come una grandezza invariabile, secondo loro interamente determinata dalla natura, non dal grado di sviluppo storico.
I fisiocratici hanno trasferito l’origine del plusvalore dalla sfera della circolazione alla sfera della produzione, hanno stabilito il principio che è produttivo soltanto il lavoro che crea un plusvalore, il lavoro nel cui prodotto è contenuto un valore superiore alla somma dei valori consumati nella sua produzione. Giacché il valore della materia prima e del materiale è dato, mentre il valore della forza lavoro è uguale al minimo del salario, questo plusvalore non può consistere che nell’eccedenza del lavoro fornito dall’operaio al capitalista rispetto alla quantità di lavoro che l’operaio riceve nel proprio salario. Tuttavia nei fisiocratici il plusvalore non appare in questa forma, poiché essi non hanno ancora ridotto il valore in generale alla sua sostanza semplice, a quantità o tempo di lavoro.
La differenza tra il valore della forza lavoro e la sua valorizzazione appare nel modo più tangibile, fra tutte le branche della produzione, nell’agricoltura. La somma dei mezzi di sussistenza che l’operaio consuma, è minore della somma dei mezzi di sussistenza che egli produce. Nella manifattura non si vede in genere l’operaio produrre direttamente i propri mezzi di sussistenza e l’eccedenza sui propri mezzi di sussistenza. Il processo è mediato dalla compra e dalla vendita, dai diversi atti della circolazione, e la sua comprensione richiede l’analisi del valore in generale. Perciò il lavoro agricolo è per i fisiocratici l’unico lavoro produttivo, e la rendita fondiaria è l’unica forma del plusvalore. L’operaio della manifattura non accresce la materia; ne modifica soltanto la forma. Per il fatto che il lavoro agricolo viene concepito come l’unico lavoro produttivo, la forma di plusvalore che distingue il lavoro agricolo dal lavoro industriale, la rendita fondiaria, viene concepita come l’unica forma del plusvalore.
Il profitto del capitale, di cui la rendita fondiaria non è che una diramazione, non esiste dunque per i fisiocratici. Il profitto appare ad essi solo come una specie di salario pagato dai proprietari fondiari ai capitalisti, a compensare un costo a cui va incontro il capitalista nel trasformare la materia prima in un nuovo prodotto.
L’interesse percepito da chi ha anticipato il denaro – altra diramazione del profitto in Marx – viene quindi considerato da una parte dei fisiocratici come usura, contraria alla natura. Il Turgot, al contrario, ne adduce a giustificazione il fatto che il capitalista monetario avrebbe potuto altrimenti comprare terra, e quindi il suo capitale-denaro deve procurargli altrettanta rendita.
Essendo il lavoro agricolo l’unico lavoro produttivo, la forma del plusvalore che distingue il lavoro agricolo, la rendita fondiaria, è la forma generale del plusvalore. Il profitto e l’interesse non sono che rubriche in cui la rendita fondiaria si ripartisce e passa, in determinate proporzioni, dalle mani dei proprietari fondiari in quelle di altre classi.
Ciò è l’opposto di quanto sostiene Smith il quale – in quanto concepisce giustamente il profitto industriale come la forma in cui il capitale si appropria originariamente del plusvalore, quindi come la forma generale originaria del plusvalore – rappresenta l’interesse e la rendita fondiaria come semplici diramazioni del profitto industriale, distribuito dal capitalista industriale alle differenti classi comproprietarie del plusvalore.
Vi sono altri motivi che spiegano la concezione dei fisiocratici.
In primo luogo nell’agricoltura la rendita fondiaria appare come terzo elemento, forma del plusvalore che non si trova nell’industria, o che vi si trova in misura trascurabile. È un plusvalore oltre il profitto, una forma tangibile ed evidente del plusvalore, un plusvalore alla seconda potenza.
In secondo luogo, se si astrae dalla importazione di derrate dall’estero – come i fisiocratici giustamente dovevano fare in un’analisi astratta della società borghese – è chiaro che la massa degli operai occupati nella manifattura ecc., svincolati dall’agricoltura, è determinata dalla massa dei prodotti agricoli che i lavoratori agricoli producono in eccedenza al proprio consumo. Poiché il lavoro agricolo è dunque la base naturale, non soltanto del pluslavoro nella sua propria sfera, ma anche dell’esistenza indipendente di tutte le altre branche di lavoro, dunque anche del plusvalore creato in queste, il lavoro agricolo doveva essere concepito come il creatore del plusvalore, specialmente finché veniva considerato come sostanza del valore il lavoro determinato, concreto, non il lavoro astratto e la sua misura, il tempo di lavoro.
In terzo luogo ogni plusvalore, non solo il plusvalore relativo, ma anche quello assoluto, dipende da una data produttività del lavoro. Se il grado di sviluppo della produttività del lavoro fosse così limitato che il tempo di lavoro di un uomo bastasse unicamente a mantenere in vita lui stesso e i suoi figli, non vi sarebbe plusvalore, non ci sarebbe in generale nessuna differenza tra il valore della capacità lavorativa e la sua valorizzazione. La possibilità del plusvalore dipende perciò da una data forza produttiva del lavoro, da una forza produttiva che consenta alla capacità lavorativa di riprodurre più del suo valore; questo grado della produttività deve esistere anzitutto nel lavoro agricolo, appare quindi come dono di natura, come forza produttiva della natura. Nell’agricoltura, la cooperazione delle forze della natura – il potenziamento della forza lavoro mediante l’impiego e lo sfruttamento delle forze naturali – è un fattore implicito che esiste fin dalle origini.
In quarto luogo la fisiocrazia comincia necessariamente la sua ricerca, in contrasto col sistema monetario e mercantilistico, dalla branca di produzione che può essere pensata in generale come separata dalla circolazione, dallo scambio, e che non presuppone lo scambio fra uomo e uomo, ma solo quello tra uomo e natura.
1.5. - Duplice spiegazione del plusvalore
La dottrina fisiocratica è il primo sistema che analizza la produzione capitalistica, che rappresenta le condizioni entro le quali il capitale viene prodotto ed entro le quali il capitale si riproduce secondo date leggi.
D’altra parte sembra una riproduzione borghese del sistema feudale dove le sfere industriali nelle quali il capitale viene a svilupparsi appaiono piuttosto come branche di lavoro “improduttive”, appendici dell’agricoltura.
La prima condizione dello sviluppo del capitale è la separazione della proprietà fondiaria dal lavoro, al lavoratore libero si deve contrapporre in modo indipendente la terra in quanto potenza indipendente, che si trova in mano a una particolare classe. Il proprietario fondiario appare perciò come capitalista, colui che si appropria del pluslavoro. Il feudalesimo viene così riprodotto e spiegato sub specie della produzione borghese, mentre l’agricoltura viene rappresentata come la branca produttiva in cui esclusivamente si manifesta la produzione capitalistica, cioè la produzione del plusvalore. Il feudalesimo viene imborghesito, la società borghese assume un’apparenza feudale.
Per questo motivo il suo luogo d’origine è la Francia, un paese prevalentemente agricolo, non l’Inghilterra, prevalentemente industriale, commerciale e marittimo. In Inghilterra lo sguardo è rivolto alla circolazione, al fatto che il prodotto acquista valore solo in quanto trasformato in denaro, espressione del lavoro sociale generale. Poiché il problema non è la forma del valore, ma la grandezza del valore e la valorizzazione, abbiamo qui il profit upon expropriation, il profitto relativo descritto dal mercantilista james Steuart. Ma se si deve dimostrare la creazione del plusvalore nella sfera della produzione, bisogna anzitutto risalire a quella branca di lavoro in cui esso si presenta indipendente dalla circolazione, all’agricoltura.
L’operaio agricolo, che può fare assegnamento solo sul minimo del salario, riproduce più di questo stretto necessario: questo è la rendita fondiaria, il plusvalore, di cui si appropriano i proprietari della condizione di “lavoro” fondamentale, che è quello della natura. I fisiocrati non dicono: l’operaio lavora più del tempo di lavoro necessario per la riproduzione della sua capacità lavorativa, il valore che egli crea è perciò maggiore del valore della sua capacità lavorativa; ma dicono: la somma dei valori d’uso che egli consuma durante la produzione è minore della somma dei valori d’uso che egli crea, la produttività della terra consente all’operaio, nel suo lavoro giornaliero, che è supposto come dato, di produrre più di quanto egli abbia bisogno di consumare per mantenersi in vita. Questo plusvalore appare dunque come dono della natura.
Correttamente presuppongono che il proprietario fondiario si contrapponga all’operaio come capitalista. Egli paga all’operaio la sua capacità lavorativa, offerta al proprietario fondiario come merce, e in cambio si appropria della valorizzazione di questa capacità lavorativa. La separazione delle condizioni oggettive del lavoro, terra e strumenti, e della forza lavoro sono in questo scambio presupposte. Il proprietario fondiario “feudale” si presenta come capitalista, come possessore di merci, che nel loro scambio contro lavoro riceve in cambio non solo il loro equivalente, poiché paga la forza lavoro solo come merce, ma un’eccedenza sopra questo equivalente. Il sistema fisiocratico è nel vero nel rilevare che la separazione del lavoratore dalla terra e dalla proprietà della terra è la condizione fondamentale per la produzione capitalistica.
Una contraddizione del sistema fisiocratico è, da un lato, definire il valore come semplice valore d’uso, e il plusvalore come un semplice dono della natura – la quale restituisce al lavoro, al posto di una data quantità di materia organica, una quantità maggiore – dall’altro spiegare il plusvalore con l’appropriazione di lavoro altrui e questa appropriazione sulla base dello scambio di merci, mentre non concepisce il valore in generale come una forma del lavoro sociale, e il plusvalore come pluslavoro.
Da un lato la rendita fondiaria – la sostanza economica reale della proprietà fondiaria – viene spogliata del suo involucro feudale, viene ridotta a semplice plusvalore. Dall’altro lato questo plusvalore, accettando di nuovo il punto di vista feudale, viene fatto derivare dalla natura, non dalla società, dal rapporto con la terra, non dai rapporti sociali. Il valore stesso è ridotto a semplice valore d’uso, cioè a materia. Di questa materia interessa solo la quantità, l’eccedenza dei valori d’uso prodotti su quelli anticipati.
Al di là degli errori teorici dei vari esponenti della scuola fisiocratica, questa contraddizione deriva dalla produzione capitalistica stessa, che si sta ancora aprendo la via per trarsi fuori dalla società feudale e si limita a interpretare la stessa società feudale in modo più borghese, ma non ha ancora trovato la sua forma specifica. Pressappoco come la filosofia, la quale dapprima si elabora nella forma religiosa della coscienza, e da un lato annienta la religione come tale, dall’altro si muove soltanto in questa sfera religiosa idealizzata, risolta in pensiero.
Perciò anche nelle conseguenze tratte dagli stessi fisiocratici, l’apparente glorificazione della proprietà fondiaria si rovescia nella negazione economica di questa e nell’affermazione della produzione capitalistica.
Poiché l’industria non creerebbe niente, solo trasformando in altra forma i valori che l’agricoltura le ha fornito, non aggiunge a questi nuovo valore – ma si limita a restituire in altra forma, equivalente, i valori che le sono stati forniti – è naturalmente desiderabile che questo processo di trasformazione proceda senza disturbi e il più a buon mercato possibile. Ciò dovrebbe realizzarsi solo per mezzo della libera concorrenza, abbandonando la produzione capitalistica a se stessa. L’emancipazione della società borghese dalla monarchia assoluta, eretta sulle rovine della società feudale, si compie dunque solo nell’interesse del proprietario fondiario feudale trasformato in un capitalista.
1.6. - L’analisi più profonda dei rapporti capitalistici in Turgot
In Turgot, il primo motivo per cui il lavoro agricolo è il solo produttivo sta nel fatto che esso è la base naturale per l’esercizio di tutti gli altri lavori. «Il lavoro (degli agricoli), nell’ordine dei lavori ripartiti tra i diversi membri della società, conserva lo stesso primato che aveva il lavoro necessario al suo nutrimento rispetto ai differenti lavori che egli, quando viveva isolato, era obbligato a dedicare ai propri bisogni. Ciò che il suo lavoro fa produrre alla terra in eccedenza ai suoi bisogni personali è l’unico fondo dei salari che tutti gli altri membri della società ricevono in cambio del loro lavoro. Questi, servendosi del ricavato di questo scambio per acquistare a loro volta i prodotti dell’agricoltore, gli restituiscono quello che hanno ricevuto» (Turgot, “Reflexions sur la formation et la distribution des richesses”, 1766).
Come nasce il plusvalore? Non nasce dalla circolazione, ma si realizza in essa. Vendendo il prodotto al suo valore, il venditore realizza un plusvalore. Ciò è possibile soltanto perché egli non ha affatto pagato interamente il valore che vende, ossia perché il prodotto contiene una porzione di valore non pagata dal venditore. E questo è il caso del lavoro agricolo. Turgot rappresenta però in un primo tempo questa porzione non comprata come puro dono della natura, ma ciò gli si trasformerà sotto mano nel pluslavoro dei lavoratori impiegati nell’agricoltura, pluslavoro che non è stato comprato dal capitalista agricolo, ma che questi vende nei prodotti agricoli. «Non appena il lavoro dell’agricoltore produce in misura superiore ai suoi bisogni, con questo superfluo che la natura gli concede come puro dono, oltre il salario, può comprare il lavoro di altri membri della società. Questi, vendendo lavoro a lui, guadagnano soltanto il necessario per vivere; l’agricoltore invece, oltre alla sua sussistenza, riceve una ricchezza indipendente che egli non ha affatto comprato, ma che vende. Egli è dunque l’unica sorgente delle ricchezze che, con la loro circolazione, animano tutti i lavori della società, poiché egli è il solo il cui lavoro produca un’eccedenza sul salario del lavoro».
In questa prima concezione si esprime l’essenza del plusvalore, che esso è valore realizzato nella vendita senza che il venditore abbia dato un equivalente in cambio. Valore non pagato. Questa eccedenza sul salario viene però ancora concepita come dono della natura, dipende cioè dalla produttività della natura se il lavoratore è in grado, nella sua giornata lavorativa, di produrre di più di quanto è necessario alla riproduzione della sua capacità lavorativa. In questa prima concezione il lavoratore stesso si appropria ancora del prodotto totale. E questo prodotto totale si suddivide in due parti. La prima costituisce il suo salario; egli viene rappresentato come salariato di sé stesso: paga a sé stesso quella parte del prodotto necessario alla riproduzione della sua capacità lavorativa. La seconda parte, eccedenza sulla prima, è dono della natura e costituisce il plusvalore.
La natura di questo plusvalore si configurerà con maggiore chiarezza non appena cessa l’ipotesi del proprietario coltivatore e le due parti del prodotto, il salario e il plusvalore, vanno a classi differenti, l’una al lavoratore salariato, l’altra al proprietario.
Perché si formi una classe di lavoratori salariati è necessario che le condizioni di lavoro si separino dai lavoratori. La base di questa separazione è che la terra stessa appaia come proprietà privata di una parte della società, in modo che l’altra parte resti esclusa da questa condizione oggettiva per la valorizzazione del suo lavoro.
«Nelle epoche più antiche non si poteva distinguere il proprietario fondiario dal coltivatore poiché ogni uomo trovava tanta terra quanta ne desiderava, non poteva essere tentato di lavorare per altri. Ma alla fine ogni terra trovò il suo padrone, e quelli che rimasero senza proprietà non ebbero dapprima altra risorsa che quella di scambiare il lavoro delle proprie braccia contro l’eccedenza dei prodotti del proprietario coltivatore».
Il fondiario, con le notevoli eccedenze che la terra dava al suo lavoro poté «pagare alcuni uomini per coltivare la sua terra. La proprietà della terra dovette dunque essere separata dal lavoro di coltivazione».
Con ciò il rapporto tra capitale e lavoro salariato s’introduce quindi anche nell’agricoltura. Ora per il salariato, che non può più produrre alcuna merce ma è costretto a vendere la sua stessa forza lavoro, il minimo del salario, l’equivalente dei mezzi di sussistenza necessari, diviene necessariamente la legge del suo scambio col proprietario delle condizioni di lavoro. «Il semplice operaio, il quale dispone solo delle sue braccia, non ha nulla, se non in quanto riesce a vendere la sua fatica ad altri. In ogni genere di lavoro deve accadere, e in effetti accade, che il salario dell’operaio si limiti a ciò che gli è necessario per procurarsi la sua sussistenza».
Non appena è introdotto il lavoro salariato «il prodotto della terra si divide in due parti: l’una comprende la sussistenza e i profitti del coltivatore, che sono la retribuzione del suo lavoro e la condizione alla quale egli si incarica di coltivare il campo del proprietario; il rimanente è quella parte indipendente e disponibile che la terra concede come puro dono a chi la coltiva, oltre alle sue anticipazioni e alla retribuzione delle sue fatiche; e questa è la parte del proprietario, ossia il reddito col quale egli può vivere senza lavorare».
Questo dono della terra appare ora già definito come dono che essa concede «a colui che la coltiva», dono che essa concede al lavoro; in quanto forza produttiva del lavoro applicato alla terra, una forza produttiva che il lavoro possiede grazie all’utilizzazione della forza produttiva della natura, che quindi attinge dalla terra, però solo in quanto lavoro. In mano al proprietario, l’eccedenza non appare più come dono della natura, ma come appropriazione – senza equivalente – di lavoro altrui, lavoro che è in grado – grazie alla produttività della natura – di produrre una quantità di mezzi di sussistenza superiore al proprio bisogno, che però deve limitarsi, per il fatto che è lavoro salariato, ad appropriarsi di quella parte soltanto del prodotto del lavoro «che gli è necessaria per procurarsi la sua sussistenza».
«Il coltivatore produce il proprio salario, e in più il reddito che serve a retribuire tutta la classe degli artigiani e degli altri stipendiati. Il proprietario fondiario non riceve niente se non mediante il lavoro del coltivatore; riceve da lui i suoi mezzi di sussistenza e i mezzi per pagare i lavori degli altri stipendiati; il coltivatore ha bisogno del proprietario fondiario solo in virtù delle leggi».
Qui il plusvalore è direttamente rappresentato come la parte del lavoro dell’operaio agricolo di cui il proprietario si appropria senza equivalente.
Turgot non conosce e non ha in mente il valore di scambio come tale, misurato dal tempo di lavoro, ma l’eccedenza dei prodotti che il lavoro del salariato fornisce al proprietario oltre il proprio salario. Questa eccedenza di prodotti è frutto della quantità di tempo in cui egli ha lavorato gratuitamente per il proprietario, oltre al tempo in cui egli ha lavorato per la riproduzione del proprio salario.
È solo nell’ambito del lavoro agricolo che i fisiocratici intendono giustamente il plusvalore, lo concepiscono come prodotto del lavoro salariato, benché considerino questo lavoro stesso nella forma concreta in cui si presenta nei valori d’uso.
Turgot analizza le condizioni di lavoro: «In qualsiasi mestiere bisogna che il lavoratore disponga in anticipo degli utensili e abbia in quantità sufficiente i materiali che costituiscono l’oggetto del suo lavoro. Bisogna che egli possa sostentarsi fino alla vendita dei suoi prodotti».
Queste anticipazioni, in mancanza delle quali il lavoro non può procedere, che sono dunque presupposti del processo lavorativo, in origine venivano fornite gratuitamente dalla terra. Ora queste condizioni di lavoro divengono capitale non appena esse devono venire anticipate al lavoratore da una terza persona; e ciò avviene a partire dal momento in cui il lavoratore non possiede niente all’infuori della sua stessa capacità lavorativa. «Quando a una gran parte della società non rimase altro mezzo per vivere all’infuori delle braccia, fu necessario che coloro che vivevano di salari cominciassero a ricevere qualcosa in anticipo, sia per procurarsi le materie prime che lavoravano, sia per potersi mantenere fino al pagamento del salario».
Turgot definisce i capitali: “valori mobili accumulati”. In origine il proprietario ogni giorno paga direttamente il salario e fornisce la materia prima. Non appena l’industria si sviluppa, sono necessarie maggiori anticipazioni e la continuità di questo processo di produzione. Si assume allora questo compito il possessore di capitali. Nel prezzo del suo prodotto deve recuperare tutte le sue anticipazioni e un profitto pari a ciò «che gli avrebbe fruttato il suo denaro se l’avesse impiegato nell’acquisto di terra», come pure il loro salario, «poiché, a profitto uguale, avrebbe preferito vivere, senza alcuna fatica, del reddito di una terra che avrebbe potuto acquistare con lo stesso capitale».
La classe “industriale” è suddivisa a sua volta «in imprenditori capitalisti e semplici operai». La posizione degli imprenditori agricoli è uguale alla posizione di questi imprenditori. Anch’essi devono recuperare tutte le anticipazioni più il profitto. «Tutto ciò deve essere prelevato dal prezzo dei prodotti della terra; l’eccedenza serve al coltivatore per pagare al proprietario il permesso che questi gli ha concesso di servirsi del suo terreno per impiantarvi una azienda. È il canone d’affitto, il reddito del proprietario, il prodotto netto; perché tutto ciò che la terra produce fino alla quantità necessaria per recuperare le anticipazioni e il profitto non può essere considerato come un reddito, ma solo come recupero dei costi di coltivazione; se il coltivatore non le recuperasse si guarderebbe bene dall’impiegare le sue ricchezze nella coltivazione di un terreno altrui».
«Sebbene i capitali si formino in parte dal risparmio sui profitti delle classi attive, tuttavia, poiché questi profitti vengono sempre dalla terra, in quanto tutti vengono pagati o dal reddito o dalle spese che servono a produrre il reddito, i capitali vengono dalla terra proprio come il reddito, essi non sono altro che l’accumulazione della parte di valori prodotti dalla terra che i proprietari del reddito possono mettere da parte senza impiegarli per i propri bisogni».
È normale, dato che la rendita fondiaria costituisce l’unico plusvalore, che l’accumulazione derivi esclusivamente da essa. Ciò che i capitalisti accumulano in altro modo essi lo lesinano sul loro reddito.
Poiché tanto il profitto quanto i salari vengono calcolati tra i costi di
coltivazione, e solo l’eccedenza costituisce il reddito del proprietario, questi
rimane di fatto escluso dai costi di coltivazione e perciò non viene considerato
come agente della produzione.
5.4 La questione cinese al Congresso dei Toilers
Capitolo esposto alla riunione generale del gennaio 2021
Nel gennaio del 1922, su iniziativa dell’Internazionale, si tenne a Mosca il Primo Congresso dei Comunisti e delle Organizzazioni Rivoluzionarie dell’Estremo Oriente, che seguiva a distanza di poco più di un anno il Congresso di Baku, dove si era levato il grido di battaglia dei popoli coloniali e semicoloniali contro la dominazione imperialista.
Il Congresso vide la partecipazione di delegati provenienti dai principali paesi dell’Estremo Oriente, con una consistente presenza di 52 delegati coreani, 42 dalla Cina, 16 dal Giappone e altri dall’India, la Mongolia, l’Indonesia e altre regioni della Russia sovietica. Solo metà di loro erano comunisti, i restanti appartenevano ad organizzazioni rivoluzionarie nazionaliste, come il Kuomintang dalla Cina.
Il Congresso si poneva in contrapposizione alla Conferenza di Washington, dove le principali potenze imperialiste si erano riunite per tentare di risolvere i loro contrasti nel Pacifico e trovare un compromesso per continuare lo sfruttamento e l’oppressione dei popoli orientali. Di fronte ai rapaci interessi degli imperialismi, l’Internazionale Comunista tendeva una mano ai popoli oppressi in Oriente, affermando la solidarietà del comunismo mondiale e del proletariato dei paesi capitalisticamente più sviluppati con i movimenti nazional-rivoluzionari dell’Estremo Oriente.
Nella prospettiva dell’Internazionale, il Congresso dei Lavoratori dell’Estremo Oriente rivestiva una grande importanza: «l’Internazionale Comunista capisce con perfetta chiarezza che l’unione del proletariato avanzato di Europa e di America con il risveglio delle masse lavoratrici di Oriente è un fatto assolutamente necessario per la nostra vittoria», affermò Zinoviev all’apertura dei lavori.
Netto era anche il contrasto con la Seconda Internazionale, e con tutti gli opportunisti che, camuffati dietro un falso rigore marxista, rifiutavano il ruolo attivo delle masse sfruttate dei paesi colonizzati contro l’ordine borghese. Invocavano l’avvento della rivoluzione mondiale, ma concepita come una rivoluzione solo europea, che per altro stavano affossando e tradendo. La vittoria rivoluzionaria in Russia e la successiva nascita della Terza Internazionale avevano smascherato l’opportunismo dei partiti socialisti, affermando che la vittoria completa del proletariato sulla borghesia era possibile solo a scala mondiale, non con una lotta riformista e limitata al continente europeo ma in collegamento con il risveglio dei milioni di lavoratori e delle masse oppresse dell’Oriente.
Il rapporto principale del Congresso fu tenuto da Zinoviev, che delineò la situazione internazionale, i risultati della recente Conferenza di Washington e i compiti dell’Internazionale. Con la fine della prima guerra mondiale i contrasti inter-imperialistici si erano estesi dall’Europa all’Asia, per cui nell’immediato futuro il problema asiatico e dell’Estremo Oriente diveniva prioritario nella politica mondiale. La contesa tra gli imperialismi in Asia rendeva di fondamentale importanza la rivoluzione nei paesi oppressi dell’Estremo Oriente: l’Asia diveniva, quindi, non solo “il perno della politica mondiale”, ma anche “dell’intero movimento di liberazione del proletariato e delle nazioni oppresse”.
I popoli oppressi dell’Oriente non avevano da riporre nessuna speranza nei proclami degli imperialismi. I risultati della Conferenza di Washington facevano cadere qualunque illusione in tal senso. A Washington, sostanzialmente, si era giunti a un accordo fra i quattro maggiori imperialismi, Inghilterra, Francia, Stati Uniti e Giappone, che Zinoviev definiva come l’”Alleanza delle quattro sanguisughe”, le quali avevano concluso un armistizio per facilitarsi nell’oppressione delle nazioni.
Nessuna delle promesse fatte in precedenza fu mantenuta a Washington: il problema del disarmo, la cui soluzione resta impossibile sotto il dominio del capitale; il problema della Corea, di cui non si parlò proprio; il problema della Cina, risolto secondo la visione americana della politica della “porta aperta”, che avrebbe favorito la penetrazione del capitale americano in grado di imporsi sui rivali; il problema della Mongolia, dimenticato nelle discussioni a Washington, dando così la possibilità all’imperialismo giapponese di seminare discordia tra la Mongolia e i rivoluzionari cinesi con la proposta della restituzione della Mongolia alla Cina. A Washington fu sostanzialmente confermata la spartizione del bottino dell’ultima guerra, secondo la formula “io ruberò da questa parte della strada e chiuderò un occhio sul fatto che tu ruberai dall’altro lato”.
Zinoviev passò poi in rassegna la situazione nei principali paesi asiatici: Cina, Corea, Mongolia. Per la situazione cinese, Zinoviev criticò quei nazionalisti cinesi e alcuni membri del Kuomintang che «guardano non senza speranza all’America e al capitalismo americano, aspettandosi proprio da quello che i benefici della democrazia e del progresso siano fatti cadere sulla Cina rivoluzionaria», e mise in guardia i rivoluzionari del Sud della Cina dall’errore di porre all’ordine del giorno la questione del ritorno della Mongolia alla Cina.
La Cina costituiva il classico esempio della sorte che l’imperialismo riserva ai paesi deboli, il miglior esempio del cinismo e della rapina imperialista, il posto in cui è evidente la crudeltà, la ferocia e la barbarie della cosiddetta civiltà dei poteri europei.
Per l’Internazionale il compito principale in Cina era coordinare il moto delle classi rivoluzionarie cinesi al fine di risolvere «il più elementare e semplice problema: buttar fuori tutti i suoi predoni, buttar fuori tutti gli oppressori del popolo cinese». L’Internazionale, quindi, cosciente che la lotta contro l’imperialismo in Cina non aveva ancora un carattere puramente comunista, appoggiava le aspirazioni del popolo cinese all’indipendenza dalle potenze straniere.
In Asia, però, il ruolo decisivo per le sorti della rivoluzione era affidato al Giappone, l’unico paese dell’Estremo Oriente che aveva sviluppato una notevole industria, e di conseguenza anche una classe proletaria, alla quale si aggiungevano cinque milioni di contadini senza terra. Senza un movimento rivoluzionario del proletariato giapponese la rivoluzione in Asia sarebbe rimasta incompiuta. Nelle parole di Zinoviev: «Il proletariato giapponese tiene nelle mani la chiave della soluzione del problema dell’Estremo Oriente. La borghesia giapponese domina e opprime molti milioni di uomini nell’Estremo Oriente, tenendo nelle sue mani il destino di tutta quella parte di mondo. La sola cosa che può veramente risolvere la questione dell’Estremo Oriente è la sconfitta della borghesia giapponese e la vittoria finale della rivoluzione in Giappone».
La questione asiatica riguardava le sorti del mondo intero, in quanto, essendosi spostate in Asia le tensioni inter-imperialistiche, era lì che sarebbe scoppiato un secondo scontro mondiale, che nessun accordo tra le grandi potenze avrebbe potuto evitare. Solo la rivoluzione proletaria poteva farlo. «La quadruplice alleanza di sanguisughe non può rimandare in alcun modo l’ora della inevitabile gigantesca guerra nell’Oceano Pacifico. Questa guerra è inevitabile. Sicuro, come al giorno segue la notte, così la fine della prima guerra imperialista sarà seguita da una seconda guerra, il cui centro ruoterà intorno all’Estremo Oriente e al problema del Pacifico. Questa guerra potrà essere evitata solo dalla rivoluzione proletaria [...] Sarà possibile evitare questa guerra se la giovane classe operaia giapponese rapidamente diventa sufficientemente forte da agguantare la borghesia giapponese per la gola, e se parallelamente a questo ci sarà un movimento rivoluzionario vittorioso in America. Se la guerra civile scoppia in America, sarà qualcosa di molto superiore a ciò che abbiamo visto finora [...] Quando la lotta fra la borghesia e gli operai raggiungerà lo stesso livello raggiunto in Russia, intere città salteranno in aria, la borghesia americana lotterà con tale disperazione da produrre una terribile catastrofe, che in confronto la lotta in Russia apparirà come un gioco da ragazzi. La resistenza della borghesia americana sarà molto determinata. Non meno determinata sarà la resistenza dell’avida e abile borghesia giapponese [...] Solo una parallela e rapida crescita di una forte organizzazione del giovane movimento operaio del Giappone e di America sarà capace di salvare l’umanità da un’altra guerra e prevenire una tremenda distruzione dell’industria, che risulterebbe da una guerra senza precedenti distruttiva fra America e Giappone».
L’Internazionale aveva chiaro i suoi compiti. Dato il ritardo dello sviluppo capitalistico dei paesi dell’Estremo Oriente, ad eccezione del Giappone, non erano ancora mature le condizioni per una rivoluzione socialista, ma v’era la concreta possibilità di uno sviluppo di un movimento rivoluzionario nazionale diretto contro l’imperialismo. Si trattava di coordinare e unire la lotta delle masse oppresse non proletarie dell’Estremo Oriente con il proletariato industriale e agricolo del Giappone. Il movimento rivoluzionario in Estremo Oriente sarebbe andato poi a legarsi alla lotta del proletariato dei paesi occidentali, che partecipavano all’oppressione e allo sfruttamento dei popoli orientali.
Erano così ribadite le Tesi dell’Internazionale adottate al Secondo Congresso, per cui la vittoria della rivoluzione mondiale sarebbe passata attraverso la realizzazione dell’unione delle forze rivoluzionarie dell’Estremo Oriente, costituite da masse prevalentemente non proletarie che lottavano contro l’oppressione nazionale, per l’indipendenza in un movimento nazionale rivoluzionario, con quelle della classe operaia d’America e Europa, i cui obbiettivi erano di carattere puramente comunista.
Zinoviev esortava i capi del movimento nazionale a unirsi alla lotta mondiale del proletariato: «Il processo storico così pone la questione: o conquisterete la vostra indipendenza, fianco a fianco con il proletariato, o non vincerete niente; o riceverete la vostra emancipazione dalle mani del proletariato, in coordinamento con esso, sotto la sua guida, o sarete destinati a rimanere schiavi delle fazioni inglesi, americane e giapponesi; o le centinaia di milioni di lavoratori di Cina, Corea, Mongolia e altri paesi capiscono che il loro alleato e dirigente è il proletariato mondiale e, una volta per tutte, rinunciano a tutte le speranze in ogni tipo di manovra della borghesia e dell’imperialismo, o i loro movimenti nazionali saranno condannati al fallimento, e avranno sempre sulle spalle gli imperialisti a seminare guerra civile, oppressione, per spartirsi il loro paese».
Dopo la introduzione di Zinoviev i lavori congressuali proseguirono con sedute dedicate ai rapporti sulla situazione di ogni paese. I tre dedicati alla Cina illustrarono la condizione generale del paese, quella della classe operaia e la situazione economica. Fu esposta la storia dell’oppressione politica della Cina, iniziata con le guerre dell’oppio nel 1839, e la sua conseguente sottomissione politica alle potenze straniere e di prostrazione economica. Il paese era diviso in sfere di influenza controllate dalle varie potenze che strangolavano l’economia cinese, a cui si aggiungeva la penetrazione del capitalismo americano tramite la imposizione della politica della “porta aperta”.
Quasi tutta l’industria cinese era strettamente subordinata al capitale straniero, priva di esistenza indipendente. La situazione finanziaria era drammatica, con un pesante debito che gravava sul paese, e con gli stranieri che avevano preso il controllo della riscossione di diversi dazi. Le esportazioni erano basate principalmente sulle materie prime, e gigantesche erano le importazioni.
Tutto ciò si ripercuoteva sulle condizioni di esistenza del popolo. Sempre più difficile diveniva la condizione dei contadini: i conflitti con gli europei, l’alta tassazione, il mercato controllato dagli stranieri; poi le carestie e le continue guerre civili determinavano la rovina dei contadini, con la loro espulsione dalla terra, masse di diseredati costrette ad arruolarsi nelle truppe dei vari signori della guerra.
L’importazione dei manufatti dai paesi stranieri aveva, inoltre, determinato la rovina dell’artigianato locale, che costituiva un’attività economica molto importante per le famiglie contadine. Anche piccoli e medi padroni erano sopraffatti dalla concorrenza economica dei capitalisti stranieri.
Misera la condizione anche dei due milioni di operai cinesi: giornata lavorativa di 12 ore e più, bassi salari che spesso non riuscivano neanche a garantire la sopravvivenza delle famiglie, bestiale sfruttamento di donne e minori, assenza di qualunque legislazione sul lavoro, presenza di capisquadra, capireparto e appaltatori che opprimevano gli operai nelle fabbriche. Insomma il paradiso ideale per i capitalisti stranieri, e indigeni, che avevano a disposizione manodopera da sfruttare e sottomettere senza limite. Per non parlare della condizione dei coolies, gli operai non specializzati, con lavoro e salario incerto, rimanendo spesso senza alloggio e patendo la fame.
Ma a partire dal 1919 la classe operaia cinese aveva iniziato ad organizzarsi in sindacati. Dapprima alcune corporazioni, il cui scopo era limitare l’aumento del numero di operai in un determinato mestiere, si riorganizzarono come sindacati; poi, nacquero dei veri sindacati, organi di combattimento degli operai. Gli ultimi anni, inoltre, indicavano un risveglio della classe operaia, con larghi e numerosi scioperi nelle principali zone industriali del paese.
Fu dato spazio anche all’intervento di un delegato del Kuomintang, che si soffermò sulla situazione politica in Cina, e alla rappresentante di una organizzazione di donne.
Dopo i resoconti sulla situazione negli altri paesi dell’Estremo Oriente, Safarov presentò un rapporto sulla posizione dei comunisti nella questione nazionale e coloniale e sulla collaborazione dei comunisti con i partiti nazional-rivoluzionari.
Il rapporto descriveva come il capitalismo mondiale avesse la necessità di mantenere una politica coloniale predatoria, rendendo la questione coloniale il più importante fattore della politica mondiale. Come già affermato da Zinoviev, l’Estremo Oriente, restato ai margini della competizione imperialistica, era divenuto l’obiettivo delle grandi potenze, bramose di accaparrarsi le sue enormi riserve di materie prime e di sfruttarne il lavoro a basso costo. Ciò rendeva impossibile la liberazione dei paesi coloniali e semi‑coloniali attraverso la conciliazione con le grandi potenze.
Così Safarov riportava l’esortazione dell’Internazionale Comunista verso le nazioni oppresse: «La vostra liberazione sta nelle vostre mani. Ma potete vincere solo stando spalla a spalla con il proletariato internazionale che sta combattendo per la sua liberazione sociale. Il proletariato internazionale sa bene che non si può distruggere il giogo capitalista su tutta la Terra, che non si può instaurare la dittatura proletaria sul globo intero senza avere attratto a questa grande battaglia per la libertà gli strati più arretrati della società, gli strati più arretrati del proletariato, gli ultimissimi dell’umanità».
Poi Safarov passò ad analizzare le condizioni dei paesi, soffermandosi molto sulla situazione in Cina. Come in altri paesi arretrati anche in Cina prevaleva una forma di agricoltura basata sulla piccola proprietà contadina. L’arrivo degli invasori stranieri non aveva alterato le vecchie arretrate strutture formate nel corso dei secoli, ma, giunti in questi paesi per sfruttarli, ne impedivano ogni possibilità di sviluppo indipendente. Il capitale straniero aveva conquistato la campagna arretrata, costringendo i contadini cinesi a rimanere in uno stato di servile legame con la terra. Gli artigiani locali furono messi nella condizione di non poter competere con le manifatture europee e americane. Artigiani e contadini rovinati finivano per vivere in condizioni miserabili.
Il capitale straniero aveva assoggettato la Cina, controllando i più importanti porti, le maggiori vie di comunicazione, le principali industrie, le materie prime, determinando da una parte l’arretratezza dello sviluppo industriale nel paese, dall’altra un brutale sfruttamento del gran numero di lavoratrici cinesi.
Mentre in Europa il capitalismo aveva avuto un ruolo rivoluzionario, trasformando i contadini in proletari, nei paesi arretrati non sviluppava l’industria, anzi la ritardava con ogni mezzo, in modo da perpetuare i propri interessi predatori, mantenendo questi paesi nella loro arretratezza come fornitori di materie prime. A tal fine il capitalismo mondiale si serviva della guerra e delle sue conseguenze per lacerare il potere politico in Cina e spezzare l’integrità del territorio. La rovina della nazione cinese era perpetrata fomentando la guerra civile attraverso il sostegno ai vari signori della guerra: dietro ogni predone cinese c’era un capitalista straniero. Nessun paese imperialista, Stati Uniti, Inghilterra o Giappone, avrebbe sostenuto lo sviluppo industriale in Cina, perché era contrario ai loro interessi coloniali e capitalistici.
In questo contesto, il principale compito del movimento rivoluzionario in Cina consisteva nell’emancipazione dal dominio straniero. Non solo i comunisti ma tutti i sinceri democratici cinesi avrebbero dovuto implacabili denunciare i vari politicanti cinesi che andavano accordandosi con una delle bande imperialiste, in particolare i molti simpatizzanti dell’America.
Condizione indispensabile per l’emancipazione dal giogo straniero era l’intervento delle masse contadine: «Senza il risveglio di queste masse contadine non c’è alcuna speranza di emancipazione nazionale”, affermava Safarov. Per conquistare le masse contadine alla causa della rivoluzione bisognava alzare la bandiera della nazionalizzazione delle terre. Liberazione della Cina dal giogo straniero, nazionalizzazione della terra, rovesciamento dei signori della guerra, istituzione di una singola federazione, di una repubblica democratica, introduzione di una tassa uniforme sul reddito, questi erano gli obiettivi per i quali dovevano lottare le masse lavoratrici cinesi e i loro elementi avanzati, i comunisti.
In Cina, infatti, stava iniziando la sua avanzata anche il giovane movimento operaio. Aveva di fronte a sé il compito primario di organizzare dei veri sindacati. Non essendo all’ordine del giorno una rivoluzione puramente classista, bensì doppia, i comunisti dovevano appoggiare il movimento nazionalista rivoluzionario, con la precisazione che tale appoggio poteva esserci solo nella misura in cui esso non era diretto contro il movimento proletario, e nello stesso tempo rafforzare le proprie organizzazioni di classe e mantenere la propria autonomia dai partiti democratici e dagli elementi borghesi.
Chiare erano le consegne date alla giovane classe operaia cinese circa i rapporti da stabilire con i democratici borghesi: «Deve essere stabilito definitivamente che il movimento dei lavoratori, gli operai cinesi devono percorrere la loro strada, non devono collegarsi con alcun partito democratico o con qualsiasi elemento borghese. Non abbiamo intenzione di nascondere la verità. Sappiamo perfettamente bene che nel prossimo futuro non ci potranno essere forti conflitti fra noi e questi elementi borghesi democratici organizzati nella organizzazione nazionale rivoluzionaria. Ma allo stesso tempo dobbiamo dire a questi elementi democratici borghesi che – poiché si adopereranno a schiacciare il movimento operaio cinese, poiché proveranno ad usare i sindacati cinesi per i loro propri meschini interessi e terranno questi sindacati nel vecchio spirito di mestiere, predicando la concordia di classe fra lavoro e capitale – al quel punto noi faremo una lotta determinata contro di loro.
Noi sosteniamo ogni movimento nazionale rivoluzionario, ma lo sosteniamo solo nella misura in cui non è diretto contro il movimento proletario. Dobbiamo affermare: è un traditore della causa della rivoluzione proletaria comunista chi non sostiene il movimento nazionale rivoluzionario. Ma dall’altra parte dobbiamo esser consapevoli che è traditore della causa nazionale chi combatte contro il risveglio del movimento proletario, è traditore del suo popolo e della causa nazionale, chi ritarda la classe operaia cinese nei suoi sforzi per alzarsi sulle sue gambe e parlare il suo proprio linguaggio».
La classe operaia non doveva isolarsi dalle masse contadine, ma unirsi ad esse propagandando le idee comuniste. Anche se in Cina non era all’ordine del giorno una imminente rivoluzione comunista, i Soviet erano comunque la forma più adeguata di organizzazione per la lotta rivoluzionaria delle masse.
Concludeva Safarov: «Compagni, il principale risultato del nostro Congresso e del nostro dibattito potrebbe essere che tutti coloro che hanno partecipato al Congresso dovrebbero avere una effettiva comprensione della correlazione fra il movimento nazionale rivoluzionario e quello dei lavoratori [...] Il proletariato rivoluzionario non può prendere in considerazione l’idea sbagliata che noi sosteniamo solamente il movimento proletario delle colonie [...] Il risultato della nostra discussione deve essere la chiara visione che le possibilità di vittoria per il movimento rivoluzionario nazionale aumenteranno notevolmente se le masse proletarie svolgeranno un ruolo indipendente in questo movimento, se gli elementi proletari delle nazioni oppresse si affermeranno come capi e alfieri in questa lotta nazional-rivoluzionaria».
Come già sostenuto da Zinoviev, il rapporto di Safarov individuava il proletariato giapponese come principale forza in grado di risolvere la questione dell’Estremo Oriente.
Le Tesi che furono approvate, riprendendo quanto esposto nei lavori congressuali, si inserivano nel solco tracciato dalla tradizione marxista e confermavano quanto stabilito al secondo Congresso dell’Internazionale sulla questione nazionale e coloniale, da cui scaturivano chiare consegne per i giovani partiti comunisti dell’Estremo Oriente.
Data la situazione orientale, dove solo il Giappone aveva raggiunto uno stadio di capitalismo avanzato, il ruolo principale nel movimento rivoluzionario era riservato al proletariato giapponese, sul quale ricadeva il compito di combattere il proprio imperialismo. In Cina e in Corea invece era previsto che in un primo tempo il movimento rivoluzionario dovesse inevitabilmente avere il carattere di un moto nazional-rivoluzionario. Ma nell’appoggiare questo movimento rivoluzionario nazionalistico «i comunisti dovranno nel tempo stesso criticare e smascherare nella maniera più spietata le esitazioni e la doppiezza degli elementi liberal borghesi i quali, chi più chi meno, tendono a far affari coi gruppi imperialisti in concorrenza, a scapito delle masse lavoratrici».
Ai partiti comunisti d’Oriente si chiedeva di conquistare dalla loro parte le masse lavoratrici e di porsi all’avanguardia del movimento nazional-rivoluzionario attraverso una tenace lotta contro l’imperialismo condotta tramite le organizzazioni di classe e la politicizzazione in senso comunista dei lavoratori e delle masse rurali semiproletarie, unendo il movimento nazionalista rivoluzionario in Estremo Oriente con la lotta internazionale del proletariato.
Veniva affidato ai comunisti il compito di «svolgere un lavoro preparatorio e far propaganda sui Soviet come unici e soli strumenti capaci di riportare una definitiva vittoria sul giogo del capitale e dell’imperialismo nella loro qualità di organi della lotta rivoluzionaria di massa».
La prospettiva proletaria era realizzabile solo in unione con le sterminate masse contadine, con il proletariato alla loro guida. «L’egemonia del proletariato su tutto il movimento rivoluzionario e più ancora la dittatura del proletariato sono impossibili a meno che il proletariato riesca a far schierare dalla sua parte le masse contadine, che gemono sotto l’oppressione dei latifondisti, dei guerrafondai e dei burocrati, barbaramente sfruttate dal capitalismo. In paesi a economia rurale prevalentemente primitiva o a debole livello industriale – come è il caso della massima parte dell’Estremo Oriente – un vasto movimento rivoluzionario è pensabile soltanto con la premessa di una stretta alleanza fra operai e contadini, alleanza in cui la classe operaia sia chiamata a sostenere un ruolo di guida».
L’Internazionale ribadiva i punti fermi della lotta nei paesi arretrati: a) stretta unione tra la lotta proletaria in Occidente per scopi puramente comunisti con i movimenti nazionalisti rivoluzionari dell’Oriente; b) critica spietata alle esitazioni della borghesia nazionale troppo legata all’imperialismo; c) difesa dell’assoluta autonomia politica e sindacale di classe; d) alleanza del giovane proletariato con le masse contadine; e) ruolo guida del proletariato nella rivoluzione contadina.
Ancora agli inizi del 1922 il programma della rivoluzione mondiale così come delineato al secondo Congresso del 1920, guidava i vertici dell’Internazionale e raggiungeva gli sfruttati dell’Estremo Oriente, ai quali si chiedeva di unirsi al proletariato d’Occidente in una lotta comune per la vittoria finale sul capitalismo mondiale.
Capitolo esposto nella riunione generale a Genova nel maggio 2015
5. Ascesa e scomparsa dell’Impero Moghul
32 - I commerci su lunga distanza
All’inizio del Quattrocento le conseguenze della pandemia di peste e della crisi economica che avevano sconvolto alcune aree della terra cominciarono ad essere superate. Questo in particolare nell’Europa occidentale e in Cina dove insieme alla ripresa demografica si manifestò un sostanziale incremento delle coltivazioni e lo spingersi innanzi delle esplorazioni marittime.
È in questo quadro che, come abbiamo descritto, nell’estremo occidente europeo il piccolo regno del Portogallo, grazie al prezioso apporto finanziario di banchieri genovesi e tedeschi, intraprese la sistematica esplorazione delle coste dell’Africa alla ricerca di una via per le Molucche, un gruppo di isole del vasto arcipelago malese fonte delle spezie, preziose per l’alimentazione europea dell’epoca. Sempre in questo contesto la corte spagnola finanziò un avventuriero genovese, Cristoforo Colombo, che pretendeva di trovare, navigando a ponente, una via più rapida per l’Asia.
Una serie di grandi spedizioni marittime della Cina definirono la sua egemonia sui centri commerciali chiave dell’oceano Indiano: gli stretti di Malacca, Ceylon e Calicut (oggi Sri Lanka e Kozhikode), fino a raggiungere, e in parte controllare, Hormuz, all’ingresso del golfo persico. Tuttavia, nonostante i successi riportati, la corte di Pechino abbandonò l’espansione nell’Oceano Indiano, privilegiando i fruttuosi commerci nel Sud‑Est asiatico. In generale l’economia cinese ebbe una ripresa nel corso del Quattrocento, una fase di espansione che durò fino alla fine del Settecento e che fece della Cina uno dei motori trainanti dell’economia mondiale.
In concomitanza con la scoperta delle Americhe, in questo periodo storico si chiuse la tormentata crisi del quattordicesimo secolo. Prosperò un’economia in cui varie parti del pianeta erano collegate da commerci di lunga distanza, sempre più intensi e importanti e caratterizzati da un progressivo abbattimento dei loro costi.
Le precedenti frontiere economiche furono abbattute, sia quelle esterne, con la conquista delle Americhe e l’occupazione e la colonizzazione di larghe aree dell’Asia, abitate da popolazioni nomadi, sia quelle interne, con la destinazione a colture mercantili di terre tribali, anche geograficamente consistenti. Questo processo fu molto evidente in India, dove vennero disboscati enormi territori di foreste e giungle. Qui le popolazioni autoctone, contrariamente alle Americhe, vennero spesso convertite alla religione islamica e gli fu assegnato un ruolo nella produzione sociale, negato ai nativi americani e agli stessi indiani “fuori casta”.
33 - Un potere più centralizzato
Fu anche un periodo di nuove scoperte tecniche e della loro diffusione, in particolare nel campo militare con le armi da fuoco. Tali nuovi strumenti costrinsero gli Stati, per ampliare i propri apparati, a rendere più efficiente la tassazione, necessaria per far fronte al costo crescente di mantenimento degli eserciti equipaggiati con le nuove armi.
I successi dell’impero Moghul in India furono determinati soprattutto dall’uso di queste armi, che i turchi avevano portato in Asia dall’Occidente. L’imperatore moghul Babur seppe combinare l’impiego della polvere da sparo con l’arte della cavalleria, appresa dagli Uzbeki. L’artiglieria mobile di Babur fu per l’India una stupefacente innovazione. Da tempo si conoscevano i grandi cannoni, usati nell’assedio delle fortezze, che i mongoli avevano introdotto in India nelle loro incursioni, obbligando i sultani di Delhi ad adeguare le fortificazioni delle città. Ma l’artiglieria leggera da campo e i moschetti, sconosciuti agli indiani, diedero a Babur un decisivo vantaggio sugli avversari.
In generale ne risultò una centralizzazione del potere, che in Europa occidentale determinò l’emergere delle monarchie assolute, ma processi simili si verificarono anche nella Russia zarista, nell’impero ottomano, in quello persiano, nel Giappone dei Tokugawa, nella Cina della dinastia Tang e infine nell’India dell’impero Moghul.
Una delle tesi della storiografia ufficiale vede, in questo periodo, l’Europa occidentale nucleo portante del sistema economico mondiale, con il resto del mondo in una posizione subordinata già a partire dal Cinquecento. I punti cardine di questa superiorità consisterebbero nelle scoperte geografiche, nella progressiva conquista del continente americano e nell’egemonia sui preziosi commerci dell’oceano Indiano. Questa tesi, per noi marxisti, si fonda solo sulla maggiore resistenza del modo di produzione asiatico alla affermazione del capitalismo moderno e alla sua accumulazione originaria.
Ma dal punto di vista delle conoscenze tecniche la Cina e la stessa India potevano competere alla pari con le produzioni europee. A partire dal Quattrocento fino alla fine del Settecento l’Europa non fu in grado di produrre nulla che avesse un significativo mercato in Asia. Viceversa, sia dal Nuovo Mondo sia dall’Europa vi era una richiesta continua di beni lavorati e semilavorati prodotti in Asia: spezie, porcellane cinesi, tessuti di lino e seta mista a lino prodotti in India. Erano produzioni che comportavano anche l’utilizzo di capitali, un’organizzazione del lavoro di tipo industriale e talvolta, come nel caso delle porcellane, ingenti quantità di capitale fisso.
La fame degli occidentali per i prodotti asiatici, come per esempio le solidissime navi costruite in India, venne soddisfatta solo attingendo all’argento che come un torrente scorreva dalle miniere americane. In quei secoli la bilancia commerciale fra Cina e India e occidente pendeva decisamente a favore delle prime.
34 - L’impero Moghul
Nella seconda metà del Cinquecento la parte settentrionale del subcontinente fu definitivamente unificata nell’impero moghul. Il vero creatore della potenza moghul fu il terzo padishah, sultano ottomano, Akbar, che regnò dal 1556 al 1605. A seguito di brillanti campagne militari il territorio conquistato prima del 1562 venne esteso a gran parte dell’India del nord, all’Afghanistan e al Khandesh (regione geografica dell’India centrale, che forma la parte nord‑occidentale dell’attuale Stato del Maharashtra).
Akbar a soli 34 anni si trovò al comando di un vasto impero. Il sogno del terzo sovrano timuride era la riconquista di Samarcanda e la restaurazione del regno moghul nella madrepatria, da cui gli uzbeki avevano scacciato Babur. Ma gli uzbeki possedevano un possente esercito e Akbar non rischiò l’impero indiano per una incerta avventura nell’Asia centrale. La prudente politica estera consentì al sovrano moghul di dedicare la maggior parte delle sue energie al consolidamento del vasto impero che si estendeva da est a ovest dall’Orissa al fiume Helmand e da nord a sud dal Kashmir al Gujarat.
Nel peculiare contesto del sistema di produzione asiatico, descritto nei capitoli precedenti, il processo di centralizzazione attuato da Akbar fu davvero notevole. Il giovane imperatore intervenne personalmente nell’imporre la regola per cui i generali vittoriosi erano obbligati a versare tutto il bottino conquistato allo Stato.
Al 1564 tutta l’aristocrazia al servizio imperiale era stata classificata in un mansab, rango, espresso con un numero, lo zat, che definiva anche il numero di cavalieri in armi da tenere pronti per il servizio imperiale. Ogni mansabdar era ricompensato con l’assegnazione di uno jagir, diritto di riscuotere e trattenere per sé parte delle imposte di un determinato territorio, o in una minoranza dei casi con uno stipendio in denaro.
Fu ridefinito anche il ruolo dei molti intermediari tra la classe contadina e l’aristocrazia moghul, gli avi degli zamindari. Questi, dopo una serie di indagini sul potenziale produttivo delle terre dell’impero, vennero sistematicamente integrati nel sistema fiscale stabilendo la quota dell’eccedenza agricola che ogni intermediario doveva trasmettere ai moghul. In cambio dei loro servigi venne loro riconosciuto il diritto di trattenerne una parte prefissata dell’eccedenze.
Anche se gran parte dell’esercito moghul era formato dalle leve di cavalleria pesante provviste dagli stessi mansabdar, l’imperatore aveva alle proprie dirette dipendenze una guardia pretoriana formata da uomini scelti. Inoltre esercitava una sorta di monopolio su quelli che erano giudicati i due più temibili strumenti bellici dell’epoca: gli elefanti da guerra e, ancor più, l’artiglieria.
Una parte dell’aristocrazia si oppose alla politica di Akbar con una serie di rivolte, soprattutto a opera dei turanidi, ma il processo di centralizzazione subì un’ulteriore accelerazione negli anni Settanta e incluse la progressiva riappropriazione da parte del fisco imperiale delle terre date in jagir. Queste terre vennero trasformate in khalisa, ovvero sottoposte alla diretta amministrazione dell’imperatore, mentre diversi mansabdar vennero ricompensati in moneta. Solo con il passare del tempo, anche a seguito delle numerose rivolte, furono fatte alcune concessioni alle classi privilegiate adottando una considerevole flessibilità nell’applicazione delle regole, anche quelle sul mantenimento dei distaccamenti di cavalleria pesante. Alla fine del regno di Akbar l’estensione delle khalisa si era notevolmente ridotta rispetto a quella degli anni Settanta.
A differenza di quanto era avvenuto al tempo del sultanato, quando si erano succedute una serie di dinastie di breve durata e in genere destinate a una fine violenta, i discendenti di Timur regnarono ininterrottamente fino al 1858, cioè fino a dopo la scomparsa dell’impero come attore politico.
Durante il regno di Akbar, le frequenti e sempre più sistematiche stime delle caratteristiche e del potenziale produttivo delle terre dell’impero si tradussero, soprattutto ad opera di Todar Mal, nella creazione di un catasto; più o meno contemporaneamente si reintrodusse definitivamente la riscossione in denaro dell’imposta terriera. Tecnicamente questo presuppose la disponibilità di uno strumento monetario adeguato, cioè, dato il tipo di sviluppo economico dell’epoca, di una moneta dotata di un valore intrinseco, espresso dal contenuto in metallo prezioso. Venne quindi messa in circolazione in alcune aree dell’impero la rupia d’argento, il cui valore nominale era sostanzialmente identico al peso in argento della moneta stessa. Essendo in India la produzione d’argento al tempo inesistente, le enormi quantità del metallo necessarie a coniare monete per l’economia del Nord dell’India furono fornite dalle miniere del Nuovo Mondo. Da questo l’argento transitava in Europa e dopo diversi anni raggiungeva il subcontinente. La riscossione dell’imposta terriera in denaro rese possibile il trasferimento di circa la metà del valore dell’eccedenza agricola, cioè la quota di competenza della classe mansabdari, al settore urbano, dove risiedeva.
35 - L’arrivo delle compagnie europee e le nuove classi
È in questo periodo che emersero una serie di strati sociali intermedi tra la nobiltà urbana grande e piccola e la classe contadina: questi comprendevano le svariate categorie di artigiani specializzati, piccoli e grandi mercanti, finanzieri, mediatori d’affari, amministratori, intellettuali, artisti di vario genere. Le fortune dei grandi mercanti e dei grandi finanzieri erano legate al mercato indotto dalle esigenze sia della classe mansabdari e dei suoi dipendenti sia ai commerci di lunga distanza. Il grosso delle esportazioni era rappresentato da manufatti di cotone o di cotone misto a seta, di cui l’India era la principale produttrice al mondo. Questi manufatti erano direttamente venduti dagli operatori economici indiani in particolare in Medio Oriente, ma anche in Africa e in Cina. Nel Seicento, questi prodotti sostituirono le spezie come principale merce acquistata dalle compagnie mercantili di Europa.
Qui, in quel secolo, era stato spezzato il monopolio commerciale dei portoghesi nell’oceano Indiano. Le compagnie europee, in particolare olandesi e inglesi, soddisfacevano la domanda di merci indiane in Europa, in America e, in parte, in Africa. Ma le esportazioni indiane verso l’Africa orientale e il Medio Oriente erano gestite prevalentemente da mercanti indiani, o in generale asiatici, turchi e armeni, residenti nel subcontinente.
Oltre alla nascita di una potente classe mercantile, la diffusione dell’economia monetaria ebbe un’altra importante conseguenza che interessò il mondo rurale: il commercio, previo consenso imperiale, dei diritti zamindari portò gli uomini appartenenti alle nuove classi emergenti, mercanti e amministratori di jagir, a investire i loro congrui guadagni nell’acquisto di zamindari, diventando di fatto essi stessi parte dell’aristocrazia rurale. Le contese fra queste opposte aristocrazie furono automaticamente azzerate.
Iniziò una nuova politica espansiva in grande dello Stato moghul. Akbar ascese al potere dopo una sanguinosa guerra civile, autoproclamandosi imperatore a Delhi con il nome di Alamgir. Uno degli obiettivi era trasformare l’impero in uno Stato musulmano governato secondo le leggi della sharia. Oltre alle diverse ribellioni dei rajput indù e dei persiani – che erano sì musulmani ma sciiti – l’aristocrazia indiana in generale si opponeva all’eccessiva influenza acquisita da una nuova “generazione” proveniente dalle fila dei giureconsulti musulmani, con scarsa competenza amministrativa e militare.
36 - L’espansione a sud e la resistenza dei maratti
Con il termine maratha fra il X e il XIV secolo si designavano i residenti del Maharashtra, l’area linguistica dove si parlava il marathi. Oggi è una delle 22 lingue ufficialmente riconosciute dalla costituzione, parlata da circa 70 milioni di indiani.
A quel tempo l’economia agraria di questa regione si era espansa sulla scia dei commerci in direzione nord‑sud e oltremare. Le classi dominanti nelle campagne prosperavano in quanto il cotone, che vi cresceva in abbondanza, poteva pervenire nei centri tessili che rifornivano i mercati mondiali.
Nel XVII secolo con maratha si venne a intendere l’insieme delle famiglie agrarie di diversa provenienza castale dedite in particolar modo all’uso delle armi, una classe che si sosteneva ponendo la propria spada al servizio delle monarchie islamiche della penisola, le quali non solo erano perennemente in guerra fra di loro ma avevano a che fare con le ingerenze dei loro potenti vicini del nord, i moghul. L’espansione dei maratti offrì quindi molte possibilità di mobilità sociale ai contadini in armi.
Nel corso degli anni Cinquanta del Seicento un giovane capitano di ventura maratha, Shivaji, riprese il tentativo, già inseguito senza fortuna dal padre, di ritagliarsi un dominio indipendente. Alla fine del decennio si era impadronito di un insieme di territori, in gran parte strappati al sultanato di Bijapur, localizzati attorno alla città di Pune e con lo sbocco sul mare di fronte all’isola di Bombay (oggi Mumbai), allora ancora nelle mani dei portoghesi. All’inizio degli anni Sessanta la potenza di Shivaji era tanto aumentata da destare la preoccupazione dei moghul. Nel 1664 Shivaji attaccò e saccheggiò Surat, nel Gujarat, una delle più grandi città moghul e principale porto dell’impero.
Aurangzeb reagì con l’invio di un grosso esercito che inflisse una serie di sconfitte al monarca maratha e lo convinse ad arrendersi in cambio della promessa di essere ammesso al servizio imperiale come Amir. Il sovrano moghul lo gratificò con un basso rango della gerarchia imperiale (mansab di 500 unità) e sperò con questo di averlo comprato. Ma Shivaji fuggì da Delhi nascosto in un cesto e tornato a Pune consolidò il potere maratti in quella regione. Vi introdusse un rigido sistema tributario sulla rendita terriera: i contadini dovevano consegnare ai magazzini governativi la metà del prodotto che, venduto, avrebbe reso cospicue entrate al governo. Ai contadini tuttavia era concesso un credito rurale al fine di incrementare la produzione, il che avrebbe aumentato la loro capacità di far fronte a un’imposta maggiore.
Sulla base di queste buone risorse Shivaji riprese le incursioni contro i territori imperiali e Surat fu più volte saccheggiata o costretta a pagare considerevoli riscatti.
Avendo i moghul respinto facilmente gli attacchi di Shivaji, questo fu costretto ad estendere la propria influenza soprattutto verso l’estremo sud. Nel 1681 Aurangzeb invase il Deccan: la decisione non fu presa tanto per la pericolosità maratha, quanto per i crescenti problemi del fisco imperiale che avrebbero potuto essere risolti solo attraverso un sostanziale allargamento dei confini dell’impero. Ma fin dall’inizio la conquista del meridione si rilevò più lunga e difficile di quanto l’imperatore si fosse aspettato. Tuttavia nella seconda metà del decennio il padishah riportò una serie di vittorie decisive portando l’impero al massimo della sua espansione. Va ricordato che le aree del Deccan conquistate producevano molto meno delle fertili pianure del nord.
Se diversi territori vennero integrati senza problemi, lo stesso non si verificò nel caso di quelli maratti. Quando Aurangzeb, oramai ottantanovenne, all’inizio del 1707 morì, la resistenza maratta continuava. Come spesso avviene nei casi di guerriglia, il semplice fatto che questi ribelli fossero riusciti a continuare la lotta era di per sé una vittoria. La strategia maratta si basò, oltre che sull’uso della guerriglia, su una serie di numerose fortezze costruite sulle alture o su isole vicine alle coste occidentali della penisola. Mentre i moghul logoravano le forze in un assedio dopo l’altro, gli scorridori maratti, truppe leggere e assai più mobili di quelle imperiali, facevano tutto ciò che si suppone i buoni guerriglieri debbano fare: evitare scontri in campo aperto, tagliare le linee di comunicazione nemiche, assaltare distaccamenti isolati e inferiori di numero e condurre scorrerie nelle retrovie devastando, incendiando, uccidendo e ritirandosi prima che il nemico potesse concentrare le proprie forze. L’offensiva del Deccan dimostrò quindi la pericolosità di una resistenza ad oltranza.
Allo stesso tempo, l’imperatore fu prodigo di mansab e jagir per quei capi maratha che passavano nelle file moghul. Durante la seconda fase del regno di Aurangzeb si ebbe quindi il paradosso, con la politica di reclutamento nella classe mansabdari del più islamico dei padishah, che portò a una crescita senza precedenti dell’elemento indù.
37 - Il declino dell’impero Moghul
La morte dell’anziano imperatore segnò la fine dell’offensiva moghul: si mantennero le posizioni conquistate nel Deccan, ma le principali risorse dell’impero rimasero a nord.
I tre figli superstiti diedero inizio a una guerra interna per decidere a chi sarebbe toccata la corona imperiale, guerre intestine che aggravarono una crisi che condusse ad inefficienze nell’intero sistema imperiale. Le casse dello Stato erano vuote, con la crisi finanziaria dell’aristocrazia, si era bloccato il meccanismo di frequente rotazione delle cariche e jagir, il processo di demilitarizzazione delle campagne si era arrestato, anzi era incoraggiato dal declino dell’autorità imperiale, rivolte zamindari e delle classi contadine erano in corso in varie parte dell’impero. Fra il 1713 e il 1727, oltre agli estesi possedimenti Moghul del Deccan, si resero autonomi il Punjab, il Bengala e gli Stati rajput.
Anche i maratti erano passati attraverso una fase di guerra civile, scoppiata subito dopo la morte di Aurangzeb e conclusasi solo nel 1714 con la vittoria du Shahu I. È comunque un’esagerazione parlare di un regno maratto in quegli anni. A quel tempo, infatti, rimaneva solo l’idea di uno Stato unitario. Il potere effettivo, dopo la guerra contro i Moghul e la successiva guerra interna, era nelle mani dei capi delle bande che nei trent’anni precedenti avevano condotto la resistenza anti moghul e di quei grandi mercanti e banchieri che le avevano finanziate.
Gli anni successivi alla vittoria di Shahu videro la ripresa in grande della guerra contro i moghul sotto la guida di Balaji. Entro il 1716 fu evidente che le truppe moghul in Maharashtra non stessero vincendo le bande maratte in corso di unificazione. Le ragioni di questa svolta vanno ricercate nella diminuzione e frammentazione delle forze moghul, causate delle convulsioni interne ancora in corso e dalla progressiva debolezza del potere di Delhi, contrapposta alla crescente unificazione di quelle maratte. I decenni fra il 1720 e il 1760 furono caratterizzati dalla vorticosa ascesa della potenza maratta: una larga parte del subcontinente passò sotto il controllo dell’uno o dell’altro signore della guerra maratti, mentre una gran parte degli Stati ancora indipendenti fu costretta a versare loro pesanti tributi.
38 - Il dominio degli eserciti europei
Possiamo considerare il diciottesimo l’ultimo secolo in cui nel sistema mondiale non fosse l’Occidente l’area economicamente più sviluppata e non si imponesse un ordine gerarchico in cui la parte più forte subordinasse politicamente e sfruttasse economicamente il resto del mondo. Già nel Settecento l’alterarsi dei rapporti di forze tra l’Occidente e il resto del mondo incominciò a diventare percepibile a livello militare. Il progressivo allargarsi del divario in tal senso tra gli Stati dell’Europa occidentale e quelli dell’Asia e dell’Africa mediterranea fu in parte causato dall’utilizzo di armi più efficienti, soprattutto i cannoni. Inoltre le fanterie europee avevano acquisito una flessibilità di manovra e una capacità di mantenere un volume di fuoco costante tali da renderle praticamente invincibili in uno scontro frontale con eserciti che, come quello indiano. Questa rottura di equilibrio militare tra gli eserciti europei e quelli dei potentati asiatici divenne percepibile proprio in India, intorno al 1740.
Tra la fine del secondo e l’inizio del terzo decennio del secolo, l’Impero moghul si era trasformato da una forte monarchia centralizzata in un insieme di province sostanzialmente autonome. Dal 1739 la funzione di comando della corte di Delhi venne a scemare, e con essa cessò il pagamento dei tributi.
Ma la fine dell’unificazione moghul non coincise con l’unificazione maratta. La rapida espansione del potere maratto, infatti, non portò mai alla costituzione di un vero impero. Accanto agli Stati moghul e a quelli maratti sopravvissero o nacquero altri Stati, in perenne guerra ma in un sostanziale equilibrio fra loro.
Dopo il 1739 il grande sistema di canali irrigui creato dai moghul nella zona a nord di Delhi venne lasciato in stato di abbandono e questo portò a 1.000 chilometri quadrati di terre coltivabili in meno. Le piantagioni di canna da zucchero e di indaco dell’area di Delhi e del Punjab declinarono per il venir meno del sostegno economico delle locali classi dominanti moghul, ormai rovinate. Una delle conseguenze di questo processo involutivo fu la scomparsa di una parte delle reti commerciali che legavano le varie parti dell’impero fra loro e il resto del mondo.
39 - La fine dell’impero
Tuttavia in alcune aree del subcontinente la situazione economica era diversa. La parte orientale della pianura gangetica, l’Awadh, appare segnata dall’espansione dell’agricoltura, resa possibile grazie alla costruzione di una fitta rete di laghetti artificiali e pozzi. Il Bengala e il Bihar godettero di un’economia fiorente fino alla conquista inglese e alla grande carestia del 1769‑70, determinata sia dalle piogge eccessive sia dalla rapacità dei funzionari della Compagnia inglese. Nelle aree orientali e meridionali del subcontinente si superò la crisi provocata dalla lunga guerra condotta da Aurangzeb e l’economia riprese vigore. In generale i territori sotto il controllo dei maratti si distinsero per l’eccellente gestione agricola e il basso livello d’imposizione fiscale, volta a promuovere la messa a coltivazione di terreni incolti. L’espansione dell’economia monetaria è testimoniata dal moltiplicarsi delle zecche per l’emissione di moneta.
Il sacco di Delhi del 1739 rappresentò la conclusione di un’epoca, la fine dell’egemonia moghul. La cessazione delle marche di frontiera del nord‑ovest segnò lo spalancarsi delle vie di invasione per qualsiasi potentato che dominasse l’Afghanistan. La perdita di potere e prestigio del padishah si tradusse nell’interruzione dell’invio di tributi da quelle province dell’impero che ancora lo facevano. Il potere effettivo dell’imperatore si ridusse così all’area di Panipat ed Agra, ma anche qui venne continuamente sfidato da bande armate e da intermediari ribelli. Nel 1740 l’espansione maratta riprese verso nord, puntando soprattutto sul Rajasthan, sull’area di Delhi e sul Punjab.
Nel 1748, alla partita in corso per il dominio dell’alta vallata gangetica si aggiunse un altro e cruciale giocatore. Amahd Shah Abdali, un generale afgano, dopo essersi impadronito dell’Afghanistan aveva lanciato una serie di scorrerie nel nord dell’India. Nello stesso anno era stato affrontato e fortunosamente sconfitto a Sirhind, nel Punjab, da quello che poi risultò essere l’ultimo grande esercito messo in campo dai moghul. Ma, mentre Abdali riuscì a salvare il grosso del suo esercito, quello moghul si dissolse nei mesi successivi a causa della mancanza di denaro con cui pagare le truppe.
40 - Terza battaglia a Panipat e arrivo delle compagnie europee
Negli anni seguenti, quindi, lo scià afgano fece la sua ricomparsa in India, sforzandosi di portare sotto la propria supremazia il Punjab e l’area di Delhi. Questo fu all’origine, a partire dal 1757, di una serie di scontri fra le avanguardie afghane e quelle maratte. Dopo numerosi combattimenti dall’esito incerto, nel 1760 l’esercito maratta e quello afgano si fronteggiavano sulle pianure di Panipat, dove i maratti avevano il loro campo trincerato. La battaglia di Panipat iniziò il 14 gennaio del 1761 fra l’artiglieria e la cavalleria dei maratti e la cavalleria pesante e l’artiglieria montata degli afghani. La disfatta maratta fu spaventosa. La battaglia durò diversi giorni, una delle più grandi combattute nel XVIII secolo per numero di soldati, circa 130.000, più della metà dei quali uccisi in combattimento o giustiziati a battaglia finita. Ne risultò l’arresto dell’avanzata maratha nel Nord e la destabilizzazione dei loro territori per circa un decennio.
Ma, nonostante le vittorie sul campo, lo scià afgano non riuscì mai a mettere radici nell’India del nord. Subito dopo Panipat, Abdali si ritirò in Afghanistan e, salvo un breve periodo nel Punjab qualche anno dopo, cessò di giocare un qualsiasi ruolo nella storia dell’India. La conseguenza principale della terza battaglia di Panipat fu dunque di determinare un vuoto di potere, di cui approfittarono i vincitori di un altro importante conflitto, svoltosi negli anni Quaranta e Cinquanta, che aveva visto come protagoniste le compagnie commerciali francesi e inglesi, e marginalmente quelle olandesi. Tale conflitto aveva coinvolto una serie di potentati indiani, che si erano rivelati molto deboli rispetto alle organizzazioni europee.
Dopo uno sfortunato tentativo di sfidare militarmente Aurangzeb, nel 1688‑90, la Compagnia inglese aveva gradualmente aumentato il volume dei propri affari fino a superare, all’inizio del Settecento, la Compagnia olandese diventando la principale esportatrice di merci asiatiche in Europa. Inoltre nel 1717 la Compagnia inglese ottenne dall’imperatore moghul notevoli privilegi commerciali in cambio di un contributo annuo. A quel punto, oltre a una serie di stabilimenti commerciali in varie parti dell’India, l’East India Company possedeva, acquisite in tempi diversi e a vario titolo, tre basi fortificate principali: l’isola di Bombay, Fort St. George, che sulla costa del Coromandel era destinato a diventare il nucleo intorno a cui sarebbe nata Madras (oggi Chennai), e l’insediamento di Calcutta in Bengala, originariamente un villaggio di pescatori.
Nel periodo immediatamente successivo, cioè tra il 1720 e 1740, la più pericolosa concorrente commerciale dell’East India Company divenne la Compagnie française des Indes orientales, che all’inizio degli anni Quaranta disponeva non solo di un certo numero di insediamenti commerciali in varie parti dell’India ma anche diverse basi fortificate tra cui Pondicherry nel Coromandel.
Lo scoppio della guerra di successione austriaca in Europa (1740‑48) e la comparsa delle navi da guerra di sua Maestà britannica nell’Oceano indiano, presto seguite da quelle della marina reale francese, finirono per coinvolgere le compagnie francesi e inglesi nel conflitto armato. La Compagnia francese, sotto la guida del governatore di Pondicherry, prese l’iniziativa assediando gli inglesi a Fort St George e conquistandolo.
Le attività belliche degli europei provocarono la reazione del governatore provinciale (nawab) del Carnatico, regione sulla costa sud‑orientale affacciata sul Golfo del Bengala. Alla fine del 1746 un esercito del nawab, la cui forza principale era un corpo di cavalleria pesante di 10.000 uomini, attaccò a San Thomé nei pressi di Madras un distaccamento di fanteria francese di 930 unità. Nonostante l’enorme disparità numerica, la fanteria indo‑francese inflisse una secca sconfitta alla cavalleria pesante del governatore moghul dimostrando così per la prima volta, e in modo clamoroso, la schiacciante superiorità qualitativa che le fanterie addestrate all’europea avevano ormai raggiunto nei confronti degli eserciti indiani.
Il VI volumetto della collana “Biblioteca dell’Internazionale Comunista” edita dal PCd’I nel 1921, porta il titolo: «I sindacati italiani al Primo Congresso della Internazionale dei Sindacati Rossi». Lo scritto inizia con queste parole di Losowski: «Una fra le più importanti questioni che agitarono il Congresso fu quella delle relazioni tra il movimento sindacale italiano e l’Internazionale rossa». Per metter bene a fuoco quelle relazioni è necessario tornare alle riunioni del 1920, dei lavori e dei risultati delle quali abbiamo già parlato.
Riassumiamo brevemente che le riunioni tenute a Mosca nel giugno 1920, alle quali avevano partecipato i rappresentanti della CGL, avevano avuto il preciso obiettivo di costituire l’organizzazione sindacale internazionale di quelle forze che intendevano staccarsi e opporsi alla Internazionale gialla. Quelle riunioni si erano concluse con l’impegno di tutti i partecipanti di abbandonare Amsterdam. A tale scopo venne costituito un primo “Soviet Internazionale provvisorio dei Sindacati Operai” con il proposito di organizzare a breve una Internazionale dei sindacati rossi per contrapporre la concezione della lotta rivoluzionaria di classe a quella della collaborazione, rappresentata dalla Internazionale di Amsterdam.
Il primo passo dei bonzi della CGL per svincolarsi dall’impegnio fu affermare che la promessa uscita da Amsterdam non comportava un distacco “immediato”. I caporioni confederali che l’avrebbero fatto, ma “al momento opportuno”, non prima di avere svolto all’interno della Internazionale gialla una tenace opposizione di classe.
A questo primo passo seguì il successivo, ancora più subdolo: si cercò di fare intendere a Mosca che la CGL fosse già uscita da Amsterdam per il solo fatto di essere legata, dal famoso patto di Firenze del 1907, al Partito Socialista, il quale aderiva alla III Internazionale. A quell’epoca la Direzione massimalista del PSI, e soprattutto Serrati, si dichiaravano apertamente per il boicottaggio dell’Internazionale gialla, affermando che fosse cosa scontata sia per il Partito sia per la Confederazione.
Naturalmente ai compagni russi non sfuggiva il gioco sporco che la CGL portava avanti. Losowski il 23 ottobre inviava una lettera molto chiara alla Confederazione Generale del Lavoro. Lo scritto, nel lamentare di non essere potuto arrivare in Italia a causa del divieto governativo, rilevava che «purtroppo la Confederazione Generale del Lavoro, alla quale la nostra delegazione si era rivolta [...] non esercitò una sufficiente pressione sul Governo italiano, ed io fui costretto a partire per la Russia senza aver discusso con voi tutti i problemi teorici e pratici del nostro movimento».
Non possiamo qui riportare per intero la lettera di Losowski (che può essere letta nell’ “Avanti!” edizione torinese del 19 novembre 1920) e citiamo soltanto alcuni passi.
«Se esaminiamo obiettivamente lo stato delle cose nei principali Stati d’Europa e d’America, noi vedremo che le organizzazioni professionali appaiono presentemente come le salvatrici del capitalismo, come l’intralcio principale nella lotta sociale, e come uno dei sostegni della borghesia morente, ma che si aggrappa ancora alla vita». A conforto di questa affermazione Losowski passava ad enumerare sinteticamente le posizioni prese dai sindacati ufficiali di Germania, Francia, Inghilterra, Italia.
«In che modo si spiega questa funzione conservatrice delle organizzazioni professionali? In primo luogo con ciò che esse sono sorte come organizzazioni di lotta sulla base dei rapporti capitalistici, si sono formate e sono cresciute nell’epoca del “pacifico” sviluppo del capitalismo, si sono adattate nella loro lotta alle condizioni generali dello sviluppo organico della società, hanno creato e sviluppato in questa loro evoluzione, la burocrazia professionale, che vive alla giornata delle quistioni di carattere professionale corporativistico. Queste organizzazioni professionali correggevano e miglioravano il capitalismo, lottavano, con abbastanza successo, contro i lati peggiori dello sfruttamento, e crearono in tal modo l’organizzazione operaia che si sviluppava insieme con lo sviluppo del capitalismo. Questa contraddizione appare risultato di una intera epoca; e a noi tocca ora fare i conti con le conseguenze di essa. Comunque sia, fatto sta ed è che la borghesia possiede oggi un sostegno nei capi delle organizzazioni professionali operaie e questa è la sua unica salvezza [...] I social-patrioti che tradirono durante tutta la guerra gli interessi degli operai del proprio Paese crearono una organizzazione che deve rappresentare la sintesi dei tradimenti nazionali. Se si considera l’attività dell’Internazionale di Amsterdam, [vedremo che] si riduce tutta a cercare di tacitare la lotta di classe, a cercare accordi con la borghesia».
Una volta stabilito ciò, era chiaro che «per contrapporre al capitale internazionale organizzato, il lavoro internazionale organizzato, era necessario creare una nuova organizzazione che non avesse nessun vincolo con la Lega delle Nazioni e le sue Sezioni, e per la quale fossero chiari i problemi della classe lavoratrice nell’epoca che attraversiamo. Di qui l’idea della creazione di un Soviet internazionale delle organizzazioni professionali. Questa idea nacque, naturalmente, in Russia, poiché il proletariato russo più di tutti attualmente soffre per le debolezze dell’organizzazione rivoluzionaria internazionale e per la mancanza di uno stato maggiore internazionale di combattimento delle organizzazioni professionali. Questo Soviet internazionale delle organizzazioni professionali fu creato con la partecipazione attiva dei rappresentanti della Confederazione Generale del Lavoro italiana, compagni D’Aragona e Bianchi. Ma giustizia vuole si noti che fin dai primi giorni delle nostre trattative era emersa la nostra divergenza di vedute rispetto alle quistioni più scottanti del movimento operaio internazionale [...] Ora l’Internazionale di Amsterdam delle Unioni professionali ed il Soviet internazionale delle unioni professionali sono appunto due campi nemici, due organizzazioni in lotta fra loro».
Riportiamo anche quanto Losowski scrive a proposito dell’occupazione delle fabbriche e che concorda in pieno con quanto affermato dai nostri compagni.
«Noi che siamo passati per queste forme di lotta alla fine del 1917, noi che abbiamo percorso a passo a passo tutte le tappe del controllo operaio, della direzione operaia, della conquista del potere da parte del proletariato e delle sue influenze sulle forme del controllo, noi volevamo dirvi: questo movimento nasconde in sé grandi vittorie e una grande sconfitta. Occupare una fabbrica, impadronirsi di uno stabilimento, è molto facile. Ma è difficilissimo conservare questa fabbrica, questo stabilimento, giacché il capitalismo è tutto un sistema che trova la sua espressione completa nello Stato contemporaneo; e finché il potere, con tutto il suo apparato di polizia, funzionari, imposte, ministero, esercito, flotta, ecc., rimane nelle mani delle classi dominanti, l’impossessarsi delle fabbriche e degli stabilimenti non è effettivo, non potendo esistere una contraddizione duratura fra condizioni economiche e politiche. Politica ed economia sono uno, e chi vuole impadronirsi delle fabbriche e degli stabilimenti, deve prima di tutto conquistare il potere, distruggere la borghesia come classe. In caso contrario, sarà solamente una ginnastica rivoluzionaria» (“Avanti!”, ed. torinese, 19 novembre 1920).
Come avrebbero potuto rispondere i caporioni della CGL se non utilizzando l’argomento tipico di tutti gli opportunisti? «La lettera aperta del compagno Losowski [...] ci ha dato la dimostrazione palmare che nel [...] Grande Stato della Repubblica dei Soviety vi è una conoscenza assai scarsa del nostro movimento politico-sindacale, e dello spirito socialista che anima i dirigenti la nostra massima organizzazione italiana dei lavoratori». Dopo questa premessa gli atteggiati a indispettiti bonzi italiani ricordavano che la CGL non aveva «atteso che il nostro compagno russo formulasse la sua critica [...] per decidere del suo atteggiamento nei riguardi dell’Internazionale di Amsterdam e della Conferenza Internazionale del Lavoro». Nella lettera si rivendicava tutta una opera di opposizione svolta e l’intenzione di continuare a svolgere. «Non si esce da un organismo di tanta importanza, senza tentare tutti gli sforzi per far prevalere i propri criteri, le proprie teorie, i propri metodi di lotta [...] Non vale la pena di tentare di formare nel suo seno una minoranza combattiva che possa propagandare le ragioni del perché noi propugniamo il metodo della lotta di classe e perché noi vogliamo sostituire al metodo di produzione capitalistico, quello socialista a beneficio della collettività?» In fondo, dicevano i bonzi, noi non facciamo altro che mettere in pratica le direttive di Mosca che stabiliscono il criterio secondo cui le «minoranze combattive devono cercare di penetrare negli organismi più restii ad accettare i principi e i metodi dei socialisti» (in “Avanti!”, ed. torinese, 23 novembre).
Eh, no! La cosa non stava affatto in quei termini. Rispondemmo noi ne “Il Comunista” del 28 novembre: «La lettera di Losowski chiarisce una importantissima questione, che del resto emerge da molti altri documenti del Congresso Internazionale di Mosca: i comunisti seguono la tattica di lavorare e penetrare in tutti i sindacati, anche se essi sono diretti dai peggiori riformisti, i comunisti non dovranno spingere i lavoratori ad uscirne per costituire nuovi sindacati, ma invitarli a rimanervi, organizzando in seno ad essi gruppi comunisti per guadagnare la direzione dei sindacati al Partito Comunista [...] La cosa cambierà però logicamente, quando si tratti della Internazionale Sindacale. Il senso stesso della costituzione a Mosca di una Internazionale dei Sindacati è quello di iniziare il boicottaggio della Internazionale gialla di Amsterdam da parte degli organismi sindacali nazionali guadagnati alla causa comunista, che devono invece aderire a Mosca».
Come già annunciato la CGL, a novembre, partecipava al congresso di Londra della Internazionale gialla per farvi la sua “opposizione”.
“Il Comunista” scriveva: «La Confederazione Generale del Lavoro italiana ha partecipato a mezzo dei suoi rappresentanti in Russia all’atto costitutivo della III Internazionale dei sindacati. Essa però, mentre qualche suo avvocato asseriva a Mosca che già la Confederazione stessa aveva tagliato i ponti con Amsterdam, non ha affatto ritirato la sua adesione a quel segretariato, anzi si prepara come abbiamo detto, a recarsi al Congresso di Londra ove tenterà di rifarsi una verginità a buon mercato atteggiandosi ad elemento di sinistra frammezzo a quell’accolta di social traditori, dei quali farà invece proprio per questo mirabilmente il gioco».
Infatti nell’organo della CGL, “Battaglie Sindacali” del 6 novembre si poteva leggere quella che sarebbe stata la relazione dei bonzi italiani sull’indirizzo politico dell’Internazionale sindacale. Dalle molto vaghe enunciazioni sarebbe stato difficile comprendere cosa in concreto proponessero, tanto più che vi veniva addirittura inserita la convenzione sottoscritta a Mosca da D’Aragona assieme ai dirigenti dei sindacati russi e di diversi altri organismi sindacali esteri. Concludendo, la CGL, al congresso di Londra, presentava un documento molto vago (l’opportunismo è sempre vago) ma dal quale risultava evidente che essa riconosceva Amsterdam come la legittima unione sindacale mondiale, però allo stesso tempo e con la massima disinvoltura, ai fini di gettar polvere negli occhi dei lavoratori, riportava la seguente recisa dichiarazione della convenzione di Mosca: «La Federazione Internazionale dei sindacati di Amsterdam è incapace, in ragione del suo programma e della sua azione di far trionfare i principii sopra enunciati ed assicurare la vittoria delle masse proletarie di tutti i paesi».
I principi a cui si riferiva il documento di Mosca erano semplici, ed estremamente chiari: quando una organizzazione nazionale di sindacati dichiara di voler aderire a Mosca deve immediatamente rompere con Amsterdam.
Naturalmente a Londra i bonzi italiani si atteggiarono a “sinistri”, in “opposizione” allo “spirito sciovinista” che regnava nel congresso. L’“Avanti!” del 28 novembre riportava la notizia che il francese Dumoulin aveva «proposto una mozione che stigmatizza[va] le critiche calunniose contenute nel manifesto internazionale di Mosca» e che «gli italiani, pur disapprovando i procedimenti adottati dai russi per imporre alle nazioni estere la loro forma di governo», si erano astenuti dal votare quella risoluzione contro l’Internazionale Sindacale rossa: si astennero, non votarono contro la risoluzione!
In effetti da Mosca al congresso di Londra era stato indirizzato questo non lusinghiero augurio: «Voi chiamate la vostra conferenza il Congresso mondiale dei sindacati. In verità non è che un Convegno di leaders gialli che tradiscono costantemente gli interessi del movimento operaio e dei Sindacati. La vostra associazione sindacale è morta, come è morta la II Internazionale, vostro organo politico. Gli operai d’Occidente si distaccano e si allontanano da voi, il cui vero posto è il letamaio borghese» (“Avanti!”, 27 novembre 1920).
I delegati italiani votarono invece a favore, unanimemente a tutti gli altri rappresentanti, della mozione sulla “socializzazione” da loro stessi presentata in cui si diceva che «i fini della classe operaia [...] dovrebbero essere riassunti nella enunciazione: socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio». Queste erano enunciazioni per accattivarsi la massa dei lavoratori, ma per sapere cosa realmente i gialli intendessero con “socializzazione” basta leggere cosa scriveva lo sciovinista francese Jouhaux in una lettera al degno compare americano Gompers: «Non bisogna confondere la socializzazione con il socialismo: il primo operaio venuto vi dirà, infatti, che la socializzazione è un’azione pacifica, non un’azione rivoluzionaria».
A questo proposito scrivevamo: «Su questa pagina equivoca e spregevole della attività dei confederalisti italiani si deve molto insistere nella propaganda contro di essi nel seno delle organizzazioni, mettendola in rapporto alle gesuitiche decisioni di Livorno [il Congresso confederale, ndr] circa il problema internazionale» (“Il Comunista” 13 marzo 1921).
Infatti nell’imminenza del congresso confederale di Livorno la Segreteria del PSI aveva pubblicato un comunicato il quale, tra l’altro, solennemente affermava: «Per ciò che riguarda i rapporti della Confederazione Generale del Lavoro con altri organismi internazionali dobbiamo volere il distacco delle nostre forze sindacali dall’Internazionale di Amsterdam e la loro adesione incondizionata all’iniziativa per la creazione dell’Internazionale dei sindacati rossi di Mosca. A questo proposito si sono manifestati concordi gli organizzatori socialisti, riuniti giorni or sono a Milano» (“Avanti!”, 17 febbraio 1921). Vedremo tra poco quanto questa affermazione fosse subdola.
Il congresso confederale di Livorno
Il congresso della CGL si tenne a Livorno nel febbraio 1921. Innanzi tutto dobbiamo brevemente ricordare come già nell’agosto dell’anno precedente un nutrito gruppo di organizzatori sindacali si era accordato a favore di una decisa opposizione alla direzione opportunista della confederazione allo scopo di imprimerle un indirizzo conforme alle direttive del partito socialista, a direzione massimalista “rivoluzionaria”. Dopo la scissione dei comunisti a Livorno detto gruppo si dissolse e quei “rivoluzionari” si squagliarono. Solo i comunisti mantennero la loro posizione, mentre i “comunisti unitari” non mancarono di distinguersi per la loro classica tattica opportunista.
Al Congresso confederale i capi sindacali tentarono di presentarsi al proletariato italiano come veri rivoluzionari proclamando l’uscita dalla internazionale gialla di Amsterdam. Allo stesso tempo, presentando come “impossibile” una immediata separazione, proponevano una via di mezzo, che altro non era che un tentativo di ricatto nei confronti della III Internazionale. «La Confederazione generale del Lavoro dichiarerebbe di uscire da Amsterdam e si farebbe iniziatrice di un convegno dei sindacati di sinistra e aderirebbe a Mosca a condizione però che Mosca accetti il “Patto di Alleanza” con il Partito Socialista Italiano, il quale dovrebbe rimanere immutato. Basta enunciare queste condizioni per sentirne la enormità. La III Internazionale, per far piacere a D’Aragona, che essa considera come un traditore della classe operaia, dovrebbe accettare i socialisti italiani, i quali hanno dimostrato di essere traditori dell’Internazionale» (“L’Ordine Nuovo”, 26 febbraio 1921).
Dove andasse a parare il congresso della CGL lo si capì fin dal primo giorno. Prima ancora che il congresso fosse dichiarato aperto, Fimmen, delegato dell’Internazionale gialla di Amsterdam, aveva preso posto al banco della presidenza.
Dopo il rituale saluto del comune di Livorno, prese la parola Bacci, per il partito socialista, e di seguito Repossi per i comunisti. «Noi non ci illudemmo mai – affermò Repossi – di essere maggioranza. Ma siamo venuti qui per affermare i nostri principi, affermare che sul campo economico la classe proletaria è una, e una deve rimanere. Di non poter vincere lo sapevamo da un pezzo per la fisionomia stessa del Congresso e per la struttura della Confederazione, ma a noi non importa perché parliamo oggi a nome del proletariato. Se anche voi ci voleste mandar via, noi ci aggrapperemmo alla porta dell’Organizzazione proletaria perché da lì sopra di tutto per noi, che pure ci siamo separati dal Partito che più non rispondeva ai nostri ideali, sta l’indirizzo supremo della unità proletaria» (“L’Ordine Nuovo”, 27 febbraio 1921).
Immediatamente a seguire, prima ancora della nomina della Presidenza, a sorpresa non solo dei comunisti ma anche dei socialisti massimalisti (che oramai sia nel sindacato sia nel partito erano succubi dei riformisti), il segretario della Confederazione, D’Aragona, dava la parola al delegato di Amsterdam. Malgrado tutte le dichiarazioni ufficiali della Direzione della CGL e le rassicurazioni date a Mosca, i congressisti dovettero subire la presenza e l’intervento del delegato dei nemici dell’Internazionale Comunista. Energiche le proteste dei comunisti con anche qualche scontro fisico.
Interessante la giustificazione data da D’Aragona: «La Confederazione è ancora aderente ad Amsterdam per un voto di Congresso e lo sarà fino a che non intervenga un altro voto di Congresso. Nella internazionale di Amsterdam, poi, non ci sono soltanto dei traditori [...] Fimmen inoltre appartiene alla sinistra del movimento sindacale. Si ha quindi il dovere di ascoltare le sue parole».
Da consumato opportunista Fimmen si presentò come «rappresentante dell’Internazionale di Amsterdam, ma anche di milioni di lavoratori di tutti i paesi. Questi trenta milioni che rappresento non sono tutti gialli e traditori; molti sono rivoluzionari [...] A nome dei trenta milioni di proletari che non sono tutti gialli [...] vi saluto fraternamente e vi esprimo la speranza che le conclusioni del Congresso siano per il rafforzamento del proletariato italiano e voi e noi marceremo insieme verso il fine comune per il bene del proletariato».
Come si vede, cambiano i luoghi, cambiano i tempi ma il copione dell’opportunismo resta sempre il medesimo.
Al congresso i comunisti avevano presentato la seguente mozione:
«Il Congresso della Confederazione Generale del Lavoro, dopo discussione in merito ai rapporti internazionali ed ai rapporti col partito proletario, considerato: [...]
- che i sindacati operai, volti dalla politica socialdemocratica dei dirigenti riformisti e piccolo borghesi ad una pratica antirivoluzionaria di collaborazione di classe, possono e devono esser fattori importantissimi dell’opera rivoluzionaria, quando ne sia radicalmente rinnovata la struttura, la funzione, la direttiva, strappandoli al dominio della burocrazia dei funzionari attuali;
- che la tattica che la Terza Internazionale adotta per conseguire tali obiettivi esclude e condanna l’uscita delle minoranze rivoluzionarie dalle file dei sindacati diretti da riformisti, ma prescrive ad esse di lavorare e lottare dall’interno, con la propaganda dei principii comunisti, con la critica incessante all’opera dei capi, con l’organizzazione d’una rete di gruppi comunisti nelle aziende e nei sindacati strettamente collegata al Partito comunista, allo scopo di conquistare a questo la direzione del movimento sindacale e dell’insieme dell’azione di classe del proletariato;
- riconosce indispensabile la creazione, al fianco dell’Internazionale Comunista di Mosca, di un’Internazionale di sindacati rivoluzionari; finalità raggiungibile solo con l’uscita delle confederazioni sindacali conquistate da comunisti dall’Internazionale sindacale gialla di Amsterdam, organismo nel quale si perpetuano i metodi disfattisti della Seconda Internazionale, e attraverso il quale gli agenti dissimulati della borghesia, e di quella sua organizzazione di brigantaggio che si chiama la Lega delle Nazioni, tendono a conservare un influsso sulle grandi masse proletarie;
- ritiene che queste confederazioni sindacali nazionali, ed anche le minoranze comuniste organizzate nel seno dei sindacati riformisti, debbano aderire all’Internazionale Sindacale Rossa di Mosca, che a lato dell’Internazionale politica raccoglie tutti gli organismi sindacali che sono per la lotta rivoluzionaria contro la borghesia.
Per conseguenza il Congresso delibera che la Confederazione Generale del Lavoro
italiana:
a) si distacchi dall’Internazionale sindacale di Amsterdam;
b) rompa il patto d’alleanza col Partito Socialista Italiano, sia perché tale
patto è inspirato a superati criterii tattici social-democratici, sia perché il
partito stesso è fuori dalla Terza Internazionale;
c) aderisca incondizionatamente all’Internazionale Sindacale di Mosca, e
partecipi al suo imminente Congresso mondiale per sostenervi le direttive
sindacali sopra richiamate, ossia quelle contenute nelle tesi sulla questione
sindacale approvate dal secondo Congresso mondiale dell’Internazionale Comunista;
d) inspiri a queste direttive i suoi rapporti col Partito Comunista d’Italia,
unica sezione italiana della Terza Internazionale, riconoscendo in esso
l’organismo cui spetta la direzione dell’azione di classe del proletariato
italiano» (“Il Comunista”, 24 febraio 1921).
Possiamo notare come nella mozione comunista ogni singola parola sia al suo posto e non possa, in alcun modo, generare confusione od equivoci. «I comunisti non nascondono le loro opinioni e le loro intenzioni, ma le diffondono apertamente» (Manifesto del Partito Comunista)
Naturalmente, visto anche il modo truffaldino di come erano stati attribuiti i
voti esprimibili suddivisi tra Camere del lavoro e Federazioni, fu approvato a
larga maggioranza l’ordine del giorno socialista, apparso sull’“Avanti!” del 4
marzo:
«Il Congresso della Confederazione delibera:
«1. L’adesione incondizionata alla iniziativa per la creazione
dell’Internazionale dei Sindacati rossi, con l’impegno comunque di conservare i
rapporti della Confederazione col Partito socialista e purché venga riconosciuto
per l’Italia il principio dell’unità sindacale confederale.
«2. Il distacco dall’Internazionale dei Sindacati di Amsterdam, in seguito ai
deliberati che saranno presi al Congresso sindacale di Mosca».
Questo ordine del giorno fu votato da tutti i socialisti, destri e “sinistri”. Ed immediatamente i delegati massimalisti («Alcuni per ingannare, altri per essere stati ingannati», scrisse “Il Comunista” del 17 marzo) riferirono, nelle rispettive province, la vittoria di Mosca e l’uscita da Amsterdam. I destri, pure nella loro malafede, si dimostrarono meno imbroglioni dei compari di sinistra dichiarando che «in seguito all’esito del Convegno dei sindacati di sinistra, convocati in virtù della convenzione di Mosca, si prenderanno decisioni definitive».
Quindi la CGL non aveva preso nessuna decisione, il distacco da Amsterdam era una fandonia.
La mozione comunista era stata redatta in parole semplici, ma chiare, in modo da
non creare nessun tipo di equivoco o interpretazione. Non altrettanto chiaro era
l’ordine del giorno votato a maggioranza.
«L’ordine del giorno prevalso a Livorno sulla situazione internazionale [...] è
redatto in modo volpino per ingannare le masse, ma rappresenta la diserzione
dall’impegno di Mosca. Che dice infatti questo ordine del giorno che molti hanno
ben considerato per scrutare il vero senso della sua insidiosa formulazione?
«“Il congresso delibera... l’adesione incondizionata alla INIZIATIVA PER LA
CREAZIONE dell’Internazionale dei sindacati rossi (dunque non adesione alla
Internazionale sindacale rossa né al suo consiglio provvisorio di cui i capi
confederali ACCETTARONO DI FAR PARTE!) coll’impegno di conservare comunque i
rapporti col P.S.I. (COMUNQUE, ossia anche a costo di rompere definitivamente
con Mosca se questa non rimangerà il suo atteggiamento verso i fuorusciti
italiani; e siccome questa ipotesi è assurda, cade senz’altro l’adesione
eventuale avvenire a Mosca) e purché venga riconosciuto per l’Italia il
principio della unità sindacale confederale (queste parole di colore oscuro
vogliono dire che Mosca dovrà sconfessare l’Unione Sindacale Italiana se questa
non accetterà di entrare nella Confederazione. I furbi capi di questa sanno che
creeranno tali difficoltà per questa entrata da renderla impossibile!)”.
«Dunque da questa prima parte dell’ordine del giorno (che reca la firma del
massimalista Ramella) si deduce che LA CONFEDERAZZIONE NON È ADERENTE A MOSCA e
si è posta in condizioni tali che non lo sarà giammai. Ossia la firma della
famosa convenzione è stata rimangiata definitivamente da quei falsari che vi
parteciparono [...]
«Chiariti così i rapporti con Mosca come escono dal congresso confederale,
passiamo a quelli con Amsterdam. Seconda parte dell’ordine del giorno trappola:
“il distacco dalla Internazionale sindacale di Amsterdam (ah, è dunque fatta!
Hanno gridato tutti i frettolosi lettori, e chi sa quanti frettolosi delegati
votanti all’ultimo momento del tumultuoso congresso! Un momento, amici; aprite
bene le orecchie) IN SEGUITO AI DELIBERATI CHE SARANNO PRESI AL CONGRESSO
SINDACALE DI MOSCA”.
«Avete ben capito? Dunque il distacco di Amsterdam NON È AVVENUTO esso è stato
deliberato... per l’avvenire, rinviato a dopo il congresso di Mosca a cui la
confederazione interverrà, perché non perderà nulla ad intervenirvi, ma per
porvi quelle tali condizioni che si sa già che non saranno accettate. E quindi
non solo cadrà l’adesione a Mosca, ma altresì il distacco da Amsterdam» (“Il
Comunista” 13 marzo).
Ingannata la classe operaia
Una parte del proletariato italiano volle ritenere infondate le accuse lanciate dai comunisti nei confronti delle intenzioni della CGL: l’ordine del giorno approvato sembrava dire il contrario di ciò che in realtà v’era scritto.
Del resto, se CGL e Partito Socialista non fossero stati dalla parte di Mosca avrebbero mai pubblicato sull’”Avanti! (del 26 maggio) comunicati di questo tipo?: «“Il Congresso dei sindacati russi”. Nella prima seduta del quarto congresso dei Sindacati russi – che sarà presto seguito da due Congressi universali del proletariato, quello dell’Internazionale comunista e quello dei Sindacati rossi internazionali – Miliutine salutò i convenuti a nome del Consiglio superiore dell’economia nazionale. Haywood salutò il congresso in nome dell’IWW. Il delegato inglese Watkis riferì che le masse lavoratrici d’Inghilterra sono sempre più convinte della necessità di marciare d’accordo con gli operai russi. Il delegato tedesco Becker dichiarò che solo il tradimento dei socialisti gialli aveva impedito l’istituzione della dittatura proletaria in Germania. Il Congresso indirizzò un appello agli operai di tutti i paesi, dicendosi convinto che dappertutto il movimento sindacale batterà in un prossimo avvenire la via della rivoluzione, e invitando i proletari stranieri a perfezionare energicamente i loro organismi di lotta e ad armarsi per il prossimo conflitto col capitalismo mondiale».
“Riempi il tuo cranio di vino, prima che si riempia di terra”, disse Omar Kajam.
Il poeta turco Nazim Hikmet fa rispondere all’uomo dalle scarpe rotte, passando davanti al giardino di rose:
“In questo mondo che offre più grano che stelle ho fame,
“tu parli di vino e i miei soldi non bastano a comprare il pane”.
Al Nazim Hikmet il poeta persiano Omar Kajam, vissuto mille anni prima, non restava molto simpatico. Al materialista Hikmet non piaceva il materialismo di Kajam, che era il materialismo delle classi proprietarie detentrici del potere, dominato da un prepotente individualismo.
Il bisogno del comunismo
Prima di essere materialisti noi siamo comunisti: il sentimento comunista viene prima della nostra scienza, prima del nostro materialismo, che non ha nulla a che spartire col materialismo della borghesia. Non ci sono comunisti senza sentimento comunista, anche se non c’è oggi partito comunista senza scienza comunista, senza materialismo scientifico, dialettico e storico. Il nostro materialismo non è quello di Kajam, ma quello dell’uomo con le scarpe rotte. È possibile che l’uomo con le scarpe rotte non sia per niente materialista, e nemmeno comunista: anzi è molto probabile che non lo sia, dato che in ogni epoca le idee dominanti sono le idee della classe dominante.
Dal nostro materialismo discende direttamente la nostra concezione della “cultura”, espressione a cui preferiamo quella di conoscenza. Lo stesso vale per la parola “coscienza”, la cui traduzione con conoscenza è anche più facilmente comprensibile. Su tale tema il partito comunista storico è stato chiaro fin dal suo sorgere, e anche prima, già Babeuf e Blanqui avevano compreso che la forza viene prima della ragione, della cultura e della educazione, nonostante il culto che la borghesia rivoluzionaria del XVIII secolo, assieme alle plebi cittadine rivoluzionarie, riservava alla dea ragione.
Il culto della ragione, assieme al diritto di natura e al contratto sociale, era una potente ideologia rivoluzionaria, un’arma atta a scardinare il vecchio mondo feudale o semi‑feudale. Ma già nella rivoluzione francese alcuni, tra cui Babeuf e Buonarroti, si erano resi conto dei limiti di tale ideologia, del fatto che fosse innanzitutto un’arma nelle mani della borghesia, e quindi della necessità di andare oltre.
La fondamentale questione nella Seconda Internazionale
La Sinistra Comunista italiana, connotazione unicamente geografica che designa la Sinistra Comunista della Terza Internazionale, fin dalle sue origini ha mostrato, anche su tale tema, una chiara impostazione marxista. Nel congresso della Federazione giovanile socialista italiana, tenutosi a Bologna nel 1912, si scontrarono due posizioni: quella della destra detta “culturista” e quella “anticulturista” della sinistra, che viene approvata con 2.730 voti contro 2.465. Le due mozioni furono riportate da “L’Avanguardia”, giornale della Federazione giovanile socialista, sulle posizioni della sinistra, nel n. 257 del 15 settembre.
Questa la mozione della corrente di destra su “educazione e cultura”:
«Il Congresso, ritenendo che, specie nell’attuale periodo che il movimento
socialista attraversa, alla Federazione giovanile spetti di compiere soprattutto una funzione preparativa, svolgendo un’opera di educazione e cultura volta al triplice scopo:
«1) di ingentilire ed elevare l’anima e la mente della gioventù proletaria, con una istruzione generica, letteraria e scientifica;
«2) di dare al Partito militi consapevoli e sicuri;
«3) di creare competenti organizzatori e buoni produttori, mediante una opera di elevamento e perfezionamento tecnico professionale, senza il quale non sarà realizzabile la rivoluzione socialista,
«stabilisce che l’azione degli organi giovanili s’informi a tali criteri direttivi e a tale uopo delibera di trasformare “L’Avanguardia” in organo prevalentemente di cultura, affidandone la redazione a compagni giovani e adulti di maggior competenza;
«invita i circoli giovanili:
«1) a curare la iscrizione dei giovani socialisti nelle associazioni di cultura;
«2) a istituire periodicamente, nei centri più importanti, d’accordo col Partito, corsi di lezioni, che abbiano per oggetto oltre la cultura strettamente socialista, la diffusione di nozioni storiche, economiche e sociologiche, e la trattazione di problemi inerenti alla organizzazione operaia;
«3) a istituire, e dare sviluppo alle biblioteche sociali;
«4) ad adottare, quale mezzo efficace di reciproca istruzione, il sistema delle conversazioni e letture».
Già allora rifiutammo tale concezione, vedendo nei “buoni produttori” la tendenza alla collaborazione di classe, e nelle posizioni di Tasca la genesi dell’ “ordinovismo”, la pretesa immediatista di costruire il socialismo all’interno della fabbrica, e soprattutto all’interno dello Stato capitalista.
Questa invece la mozione della corrente di sinistra:
«Il Congresso,
«considerando che in regime capitalista la scuola rappresenta un’arma potente di conservazione nelle mani della classe dominante, la quale tende a dare ai giovani un’educazione che li renda ligi e rassegnati al regime attuale, e impedisca loro di scorgerne le essenziali contraddizioni,
«rilevando quindi il carattere artificioso della cultura attuale e degli insegnamenti ufficiali, in tutte le loro fasi successive, e ritenendo che nessuna fiducia sia da attribuirsi ad una riforma della scuola nel senso laico o democratico;
«riconoscendo che scopo del movimento nostro è contrapporsi ai sistemi di educazione della borghesia, creando dei giovani intellettualmente liberi da ogni forma di pregiudizio, decisi a lavorare alla trasformazione delle basi economiche della società, pronti a sacrificare nell’azione rivoluzionaria ogni interesse individuale;
«considerando che questa educazione socialista, contrapponendosi alle svariate forme di individualismo in cui si perde la gioventù moderna, partendo da un complesso di cognizioni teoriche strettamente scientifiche e positive giunge a formare uno spirito e un sentimento di sacrificio;
«riconosce la grande difficoltà pratica di dare alla massa degli aderenti al nostro movimento una base così vasta di nozioni teoriche, che esigerebbe la formazione di veri e propri istituti di cultura, e mezzi finanziari sproporzionati alle nostre forze; e, pure impegnandosi a dare l’appoggio più entusiasta al lavoro che intende fare in questo campo la Direzione del P.S., ritiene che l’attenzione dei giovani socialisti debba piuttosto essere volta alla formazione del carattere e del sentimento socialisti;
«considerando che una tale educazione può essere data solo dall’ambiente proletario quando questo viva della lotta di classe intesa come preparazione alle massime conquiste del proletariato, respingendo la definizione scolastica del nostro movimento e ogni discussione sulla sua così detta funzione tecnica, crede che, come i giovani troveranno in tutte le agitazioni di classe del proletariato il terreno migliore per lo sviluppo della loro coscienza rivoluzionaria, così le organizzazioni operaie potranno attingere dalla attiva collaborazione dei loro elementi più giovani e ardenti quella fede socialista che sola può e deve salvarle dalle degenerazioni utilitarie e corporativiste;
«afferma in conclusione che l’educazione dei giovani si fa più nell’azione che nello studio regolato da sistemi e norme quasi burocratiche e in conseguenza esorta tutti gli aderenti al movimento giovanile socialista:
«a) a riunirsi molto più spesso che non lo prescrivano gli statuti, per discutere tra loro sui problemi dell’azione socialista, comunicandosi i risultati delle osservazioni e delle letture personali e abituandosi sempre più alla solidarietà morale dell’ambiente socialista;
«b) a prendere parte attiva alla vita delle organizzazioni di mestiere, facendo la più attiva propaganda socialista fra i compagni organizzati, specialmente diffondendo la coscienza che il Sindacato non ha per unico fine i miglioramenti economici immediati, ma è invece uno dei mezzi per la emancipazione completa del proletariato, a fianco delle altre organizzazioni rivoluzionarie».
Riguardo tali mozioni i rappresentanti delle due correnti socialiste mandano poi una lettera a “L’Unità”, giornale di Gaetano Salvemini, socialista di destra, che le pubblica sul n. 46 del 16 ottobre. Dalla lettera del rappresentante della corrente di sinistra leggiamo:
«Noi non abbiamo dichiarato affatto la guerra alla cultura, noi non neghiamo che il socialismo attraversi oggi fra noi un periodo di crisi, noi non ci nascondiamo la necessità di studiarne le cause e trovare i mezzi adatti ad eliminarle, solo seguiamo in tutto questo una diversa valutazione (...) Non possiamo consentire col Tasca e col suo articolista nel risolvere il vasto problema con la formula semplicistica “crisi di cultura” (...) Noi vediamo la necessità di dare al movimento giovanile un indirizzo che rimedi a questa crisi di sentimento. E ne consegue che dobbiamo farne un movimento di argine vivacemente antiborghese, un vivaio di entusiasmi e di fede, né vogliamo disperdere energie preziose nel tentativo di rimediare, secondo metodi scolastici, a quello che è uno dei caratteri essenziali, incancellabili del regime del salariato: lo scarso livello della cultura operaia. Il partito cattolico, che spende milioni in questo campo, non ha potuto formare una cultura cattolica popolare. Evidentemente noi dissentiamo su questo punto dalla tendenza rappresentata dal suo giornale.
«Riteniamo che la cultura operaia possa figurare nei programmi della democrazia, ma abbia scarso valore nel campo dell’azione sovversiva del socialismo. Questo non vuol dire che noi rinneghiamo la cultura socialista. Al contrario, crediamo che l’unico modo di incoraggiarla sia quello di lasciarla all’iniziativa individuale, senza chiuderla nel campo odioso del regime scolastico. E quella iniziativa può essere eccitata solo portando i giovani proletari nel vivo della lotta e del contrasto sociale, che sviluppa in essi il desiderio di rendersi più adatti alla battaglia.
«Se la nostra Avanguardia assumesse indirizzo di cultura, dopo quattro numeri gli operai non la leggerebbero più. Ma i nostri giovani compagni la cercano e la amano oggi che vedono in essa un segnacolo di lotta, che ritrovano nelle nostre campagne tutta l’anima proletaria, con i suoi slanci e le sue rivolte.
«Ci si potrà dire che l’entusiasmo senza la convinzione è poco duraturo. Ebbene questo è vero sempre, fuori che nel campo dei movimenti di classe. Nell’operaio socialista la convinzione è figlia dell’entusiasmo e del sentimento, e c’è qualcosa che non lascia spegnere questo sentimento: la solidarietà istintiva degli sfruttati. Chi non ha più fiducia in questa e vuole sostituirla con la scuoletta teorica, lo studio, la coscienza dei problemi pratici, si trova, a creder nostro, malinconicamente fuori del socialismo».
Su “L’Avanguardia” n. 283 del 13 aprile 1913 troviamo un articolo titolato “Per la concezione teorica del socialismo”, da cui leggiamo:
«L’estetica del pensiero possiamo lasciarla a chi possiede quella della carnagione rotonda e ben nutrita, e ignora le deformazioni fisiologiche a cui il lavoro eccessivo condanna l’umanità che produce.
«Il nostro pensiero di rivoluzionari è un grande atto di sincerità, contro tutto il pensiero politico della borghesia che è falsificazione e speculazione. Contro il pensiero venduto dal prete, che ingrassa dicendo all’affamato: aspetta un’altra vita; contro il pensiero venduto dal nazionalista, che deruba l’affamato dicendogli: rendiamo forte la patria e tu starai meglio; contro il pensiero anguillesco venduto dalla democrazia, che vuole “l’elevazione delle classi povere, quando saranno educate e redente dalla ignoranza”, sapendo che così essa viene rinviata sine die; contro questo colossale lavorio di menzogna noi opponiamo la grande leva della verità. Noi dobbiamo strappare al proletariato le bende idealistiche e dirgli non ”ascoltaci”, ma “guardati intorno”. Egli guarderà e vedrà il suo posto nella lotta delle classi; e la sua fame, quando egli saprà che non vi rimedieranno mai né dio né la patria né la buona volontà pelosa dei “democratici”, lo spingerà a cercare e a stringere la mano del compagno (...)
«Ma a noi stessi e al proletariato noi non daremo mai la cultura dei manuali storici e letterari scritti sulla falsariga ufficiale (...) Bisogna disfarsi di un monte di porcherie retoriche e letterarie che ci ammorbano, e che purtroppo infiorano spesso i discorsi dei nostri propagandisti. Bisogna convincersi che tutte quelle frasi “nobilissime” sono l’etichetta sotto cui vuol passare l’ingordigia di classe della borghesia, il suo “ideale del tanto per cento” (...)
«Noi riteniamo che la “scienza” attuale non meriti più fede di quanta ne abbiamo attribuita alla filosofia. Crediamo che a quello sviluppo scientifico del socialismo manchi la possibilità di avere gli elementi scientifici genuini, poiché la “scienza” borghese pensa a falsificarli a tempo. Abbiamo forse oltraggiato un’altra deità, la signora Scienza? Non ci importa. Alla scienza vera, come somma dei portati, delle ricerche e dell’attività umana, noi possiamo credere, ma non riteniamo possibile la sua esistenza nella società attuale minata dal principio della concorrenza economica e della caccia al profitto individuale.
«Urtiamo così un altro pregiudizio comune, quello della superiorità del mondo scientifico. Si credono oggi indiscutibili le decisioni delle accademie, come nel medioevo quelle delle sagrestie. Eppure sarebbe necessario un libro e non un articolo per svelar un poco i retroscena miserabili e mercantili della scienza! Il dilettantismo più incosciente, le più audaci ciurmerie, le più vili prepotenze delle minoranze dominanti, trovano con facilità la garanzia dell’etichetta scientifica (...) La scienza borghese è anch’essa al pari della filosofia un ammasso di frottole. Il socialismo scientifico non può respirare questa atmosfera di menzogna.
«Le sue deduzioni possono fallire e anche cedere ai pettegolezzi della critica, perché si devono trarre dalle statistiche falsificate dagli Stati borghesi, e devono chiedere alla scienza ufficiale tutti i necessari elementi di fatto. Ma la concezione socialista nelle sue grandi linee non cade per questo. Le diatribe scolastiche di filosofi o di scienziati non l’hanno uccisa (...)
«Può darsi che il proletariato non abbia sempre il tempo di sottrarsi al lavoro che lo opprime per dimostrare con la penna e la parola la ferrea verità del pensiero socialista, ma esso sta facendo vedere in modo memorabile come possa abbandonare quel lavoro quando voglia dare la prova della sua forza nell’azione concorde che lo condurrà al socialismo.
«Carlo Marx lo aveva detto: “I filosofi non han fatto che spiegare il mondo, ora bisogna cambiarlo”».
Ancora precise e chiare le nostre parole, riportate nell’articolo titolato “Il problema della cultura”, su “Avanti!” del 5 aprile 1913:
«Nessuno accetterebbe l’epiteto di “nemico della cultura” nel senso assoluto, e nessuno ritiene desiderabile per l’avvenire del socialismo lo stato d’ignoranza del proletariato (...) Ma invitiamo i compagni a non dimenticare che questa finalità collettiva (che possiamo chiamare “ideale” se si vuole impiegare questo termine) secondo la concezione marxista ha la sua base nel fatto “materiale” del contrasto esistente tra l’interesse della classe proletaria e le presenti forme di produzione. Quell’ideale è quindi sentito dagli operai in quanto essi vivono nelle strette di quel contrasto reale ed economico. Ed in questo senso il socialismo vuole interessarsi dell’emancipazione intellettuale dell’operaio contemporaneamente a quella economica, sempre ritenendo che la prima è una conseguenza della seconda, e che se si tiene a cuore il progresso e la cultura della massa, non si deve disprezzare, ma accettare nel suo massimo valore il programma della sua redenzione “materiale” (...)
«Il Partito Socialista indica al proletariato in quale senso dirigere le forze risultanti dal suo bisogno economico per raggiungere più presto la finalità di classe, ossia l’abolizione del salariato. Così dunque il partito può e deve guidare la educazione e la “cultura” operaia. E nessun socialista rivoluzionario può essere contro questa seconda parte del programma senza cadere in contraddizione colle sue concezioni anti‑egoistiche e antiriformistiche del movimento operaio.
«Ma il “riformismo” e la “democrazia” vedono il problema della cultura da un punto di vista ben diverso, anzi esattamente capovolto. Nella cultura operaia essi scorgono, anziché la conseguenza parallela dell’emancipazione economica, il mezzo principale e la “condizione necessaria” di quella emancipazione. Quanto un simile concetto sia reazionario e antimarxista, non occorrono molte parole a dimostrarlo. Se noi crediamo che l’ideologia di una classe sia conseguenza del posto che le è assegnato in una determinata epoca della storia dal sistema di produzione, non possiamo “aspettare” che la classe operaia sia “educata” per credere possibile la rivoluzione, perché ammetteremmo in pari tempo che la rivoluzione non avverrà mai. Questa pretesa preparazione culturale educativa del proletariato non è realizzabile nell’ambito della società attuale. Anzi l’azione della classe borghese – compresa in essa la democrazia riformista – “educa” le masse in senso precisamente antirivoluzionario, con un complesso di mezzi col quale nessuna istituzione socialista potrà mai lontanamente gareggiare.
«Ma non è su questo che noi insistiamo. Sorgano pure le scuole socialiste, specie dove occorre formare dei propagandisti, magari... tra la classe intellettuale, che è in fatto di socialismo molto ignorante. Ma non si corra il rischio di diffondere, magari senza volerlo, quel criterio riformistico della “necessità” della cultura. Sarebbe un mezzo poderoso di addormentamento della massa, ed è infatti il mezzo con il quale la minoranza dominante persuade la classe sfruttata a lasciarle nelle mani le redini del potere.
«Noi sappiamo bene che le scuole socialiste sono spesso dirette nel senso rivoluzionario, e che molti compagni che le propugnano non accettano affatto quei criteri che noi additiamo come pericolosi. Va benissimo. Ma resta il pericolo. L’operaio è logicamente restio a frequentare assiduamente queste scuole che gli impongono uno sforzo intellettuale molto grave, date le sue condizioni di lavoro eccessivo e di nutrizione scarsa. Occorre quindi un vivo incitamento per deciderlo a tale sacrificio e il mezzo con il quale si fa questo incitamento finisce coll’essere equivoco. Si dice ai proletari che essi non hanno quasi il “diritto” di essere militanti nel campo sindacale e specie in quello politico per la loro scarsa istruzione, si vuole farli arrossire della propria ignoranza, mentre occorrerebbe convincerli che essa è una delle tante infami conseguenze dello sfruttamento borghese, e la inferiorità intellettuale dell’operaio, che dovrebbe essere una molla per farlo insorgere, al pari della sua inferiorità economica, diviene una causa di titubanza e di viltà (...)
Per conseguenza di questo andazzo rammollitore della nostra propaganda Giolitti ha potuto congratularsi con i nostri rappresentanti al parlamento per l’opera di “educazione” pacifista fatta nelle masse. Il socialismo invece di fare dei proletari i ribelli indomabili alla condizione attuale, finisce col farne le pecore docili, addomesticate, “colte” e... pronte per la tosatura.
«Ma il riformismo va più oltre ed arriva a pretendere dal proletariato la “preparazione tecnica” e la “cultura di problemi concreti”. È notevole che il riformismo che è tutto positivo, tutto “economista”, tutto meccanico, arrivi a questi desiderata molto più irrealizzabili di quelli di cui noi siamo accusati. È l’utopismo della pratica, della tecnica, catalogato nei programmi minimi, gonfiato di réclame elettorale, che richiederebbe per realizzarsi molti secoli di più di quelli che i suoi fautori – gente pratica, e che non pensa ai nipoti! – assegnano cattedraticamente all’avvento della rivoluzione sociale (...)
«La missione del Partito Socialista è quella di sovvertire, di sobillare le masse, agitando una “idea”, certo; ma un’idea abbarbicata con radici profonde nella realtà. L’intransigenza del partito deve divenire una differenziazione profonda dalla metodologia democratica. Per la democrazia il problema economico è il sottosuolo che occorre esplorare con la luce della “cultura” che scende dall’empireo dei filosofi, dei maestri, dei pensatori. Ma il socialismo marxista inverte in teoria e in politica l’equivoco democratico. Esso mostra che il sottosuolo sociale è in fermento e troverà in sé stesso il modo di sprigionare le forze latenti che lo agitano. Il pensiero, l’ideologia operaia si determinano al di fuori della filosofia guidata dalla classe che ha il monopolio dei mezzi di produzione, e il monopolio della “cultura”. L’azione del Partito Socialista riesce a compiere un lavoro di sintesi di quelle forze latenti, a dare al proletariato la coscienza di “tutto” sé stesso e il coraggio di non cercare al di fuori di sé stesso i mezzi della sua ascensione.
«Tutta la nostra propaganda e la nostra sobillazione cozzano quotidianamente contro la sfiducia che i lavoratori hanno nelle proprie forze e contro il pregiudizio della inferiorità e della incapacità alla conquista del potere; errori scaldati dalla democrazia borghese che vorrebbe l’abdicazione politica della massa nelle mani di pochi demagoghi. Ed è appunto il pericolo di favorire questo gioco – tentato nell’interesse conservativo delle istituzioni presenti – che ci fa diffidare delle esagerazioni dell’opera di cultura».
Nello stesso senso va il discorso pronunciato da Lenin al primo Congresso dei soviet di tutta la Russia il 28 agosto 1918, affrontando la funzione dell’educazione in regime di dittatura del proletariato:
«L’educazione è una delle componenti della battaglia che stiamo intraprendendo. Noi possiamo contrastare l’ipocrisia e le menzogne con la completa ed onesta verità. La guerra ha mostrato abbastanza chiaramente cosa la “volontà della maggioranza” realmente significa, una frase usata come copertura dalla borghesia. La credenza che la democrazia borghese serva gli interessi della maggioranza è stata ora completamente smentita. La nostra Costituzione, i nostri Soviet, che sono qualcosa di nuovo per l’Europa, ma coi quali noi siamo già familiarizzati dall’esperienza della rivoluzione del 1905, serve come splendido materiale di propaganda e di agitazione che mette completamente in mostra la natura ipocrita e menzognera della democrazia borghese.
«Noi abbiamo palese il dominio del popolo lavoratore e sfruttato, e lì risiede la fonte della nostra forza e invincibilità.
«Riguardo l’educazione: più acculturato è lo Stato borghese, più sottilmente esso mente quando dichiara che la scuola sta al di sopra della politica e serve la società nel suo intero. Di fatto le scuole erano trasformate in nient’altro che in strumenti del dominio di classe della borghesia. Esse erano completamente imbevute dello spirito borghese di casta. Il loro scopo era quello di fornire ai capitalisti obbedienti lacchè ed abili lavoratori.
«La guerra ha mostrato che le meraviglie della tecnica moderna sono state usate come mezzo per sterminare milioni di operai e per creare favolosi profitti per i capitalisti, che con la guerra stanno facendo fortune (...)
«Noi diciamo che il nostro lavoro all’interno dell’educazione è parte della battaglia per rovesciare la borghesia. Noi dichiariamo pubblicamente che il divorzio dell’educazione dalla vita e dalla politica è menzogna ed ipocrisia. Quale è stato il significato del sabotaggio di cui si sono serviti i meglio educati rappresentanti della vecchia cultura borghese? Questo sabotaggio ha mostrato meglio di ogni agitatore, meglio di tutti i nostri discorsi, meglio di migliaia di opuscoli, che queste persone considerano l’istruzione come un loro monopolio e che l’hanno trasformata in uno strumento del loro dominio sui cosiddetti uomini comuni. Essi hanno usato la loro istruzione per frustrare il lavoro della costruzione socialista, e vengono fuori apertamente contro il popolo lavoratore.
«La lotta rivoluzionaria è stata la scuola degli operai e dei contadini russi. Essi hanno visto che solo il nostro sistema assicura il loro genuino dominio, essi hanno potuto convincersi che lo Stato sta facendo di tutto per assistere gli operai ed i contadini poveri nell’abbattimento completo della resistenza dei kulak, dei proprietari terrieri e dei capitalisti.
«I lavoratori hanno sete di conoscenza perché ne hanno bisogno per vincere. Nove operai su dieci hanno compreso che la conoscenza è un’arma nella loro lotta per l’emancipazione, che i loro fallimenti sono dovuti a mancanza di educazione, e che ora tocca a loro dare realmente a tutti accesso all’educazione. La nostra causa è assicurata perché il popolo stesso ha cominciato a costruire una nuova, socialista Russia. Essi stanno imparando dalla propria esperienza, dai loro fallimenti ed errori, e vedono come l’educazione sia indispensabile per la vittoriosa conclusione della loro battaglia.
«Malgrado l’apparente collasso di numerose istituzioni e l’esultanza degli intellettuali che effettuano sabotaggi, noi troviamo che l’esperienza in battaglia ha insegnato al popolo come prendere il destino nelle proprie mani. Tutti coloro che realmente simpatizzano con il popolo e tutti i migliori insegnanti verranno in nostro aiuto, e questa è una sicura garanzia che la causa socialista trionferà».
Lenin contro il “futurismo”
L’8 ottobre 1920 Lenin scrive un progetto di risoluzione per il Proletkult, organizzazione per la cultura operaia fondata da Bogdanov pochi giorni prima dell’Ottobre, inevitabilmente permeata di idealismo. Gli intellettuali russi che avevano abbracciato la rivoluzione, anche a “sinistra” del Proletkult, anche i migliori e di indubbia fede comunista, come Majakovskij, erano comunque per lo più espressione della piccola borghesia. Questa mezza classe non ha alcuna autonomia ed è destinata ad andare a rimorchio della classe vincitrice. Non a caso i futuristi italiani sono approdati in massa al fascismo, mentre i futuristi russi si sono schierati per lo più con la rivoluzione. I migliori intellettuali russi, per quanto sinceramente comunisti e rivoluzionari, si portavano quindi appresso molti dei pregiudizi caratteristici della classe sociale da cui provenivano. Sia nel Proletkult sia in altre organizzazioni più o meno simili c’era spesso una vaga idea di autonomia della stessa organizzazione dal partito, e anche l’idea, ugualmente vaga, che la vecchia cultura borghese dovesse semplicemente essere gettata nella spazzatura.
Ecco Lenin:
«1. Nella repubblica sovietica degli operai e dei contadini tutto il lavoro educativo, sia nel campo dell’istruzione politica in genere sia nel campo dell’arte in specie, deve essere permeato dello spirito della lotta di classe del proletariato per la realizzazione vittoriosa delle finalità della sua dittatura, cioè per il rovesciamento della borghesia, per l’abolizione delle classi, per la soppressione di ogni sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo.
«2. Per questo motivo il proletariato, rappresentato tanto dalla sua avanguardia, il partito comunista, quanto dall’insieme delle diverse organizzazioni proletarie in genere, deve partecipare nel modo più attivo e determinante al lavoro dell’istruzione pubblica.
«3. Tutta l’esperienza della storia moderna e, in particolare, la lotta rivoluzionaria del proletariato di tutti i paesi, sviluppatasi per più di cinquant’anni dopo la pubblicazione del Manifesto comunista, dimostrano inconfutabilmente che la concezione marxista del mondo è la sola espressione giusta degli interessi, delle opinioni e della cultura del proletariato rivoluzionario.
«4. Il marxismo ha acquisito il suo significato storico mondiale, in quanto ideologia del proletariato rivoluzionario, perché, invece di respingere le conquiste più preziose dell’epoca borghese, ha al contrario assimilato e rielaborato quanto vi era di più valido nello sviluppo più che bimillenario della cultura e del pensiero umani. Soltanto il lavoro svolto su questa base e in questa direzione, ispirato dall’esperienza della dittatura del proletariato, come ultima fase di lotta contro ogni sfruttamento, può essere riconosciuto come lo sviluppo di una cultura effettivamente proletaria.
«5. Attenendosi inflessibilmente a questa posizione di principio, il congresso panrusso del Proletkult respinge nella maniera più energica, come teoricamente sbagliati e praticamente dannosi, tutti i tentativi di inventare una propria cultura particolare, di rinchiudersi in proprie specifiche organizzazioni, di delimitare i campi di attività del commissariato del popolo all’istruzione e del Proletkult o di instaurare l’“autonomia” del Proletkult in seno alle istituzioni del commissariato del popolo all’istruzione, ecc. Al contrario, il congresso impone a tutte le organizzazioni del Proletkult l’obbligo assoluto di considerarsi interamente quali organismi ausiliari della rete di istituzioni del commissariato del popolo all’istruzione e di assolvere, sotto la direzione generale del potere sovietico (e, in particolare, del commissariato del popolo all’istruzione) e del partito comunista di Russia, i propri compiti, come una parte dei compiti della dittatura del proletariato».
Il 17 ottobre 1921, al 2° Congresso dei Centri di educazione politica di tutta la Russia, Lenin presenta un rapporto dal titolo “La Nuova Politica Economica e i compiti dei centri di educazione politica”:
«12. A mio parere tre sono i nemici principali che ciascuno di noi ha di fronte, indipendentemente dalla carica che ricopre; tre sono i compiti che ha di fronte l’educatore politico, se è un comunista, come lo è la maggioranza. I tre nemici principali sono i seguenti: il primo nemico è la presunzione comunista, il secondo l’analfabetismo, il terzo la corruzione (...)
«13. Differenza tra i problemi militari e quelli culturali. Il problema culturale non può essere risolto con la stessa rapidità dei problemi politici e militari. Occorre capire che le condizioni in cui si compie il movimento in avanti non sono più quelle di un tempo. È possibile conseguire una vittoria politica nel volgere di poche settimane in un’epoca di crisi acuta. È possibile vincere in guerra in qualche mese, ma non è possibile vincere sul piano culturale in così poco tempo; qui per la natura stessa delle cose occorre un termine più lungo, e a questo termine più lungo ci si deve adattare, calcolando giustamente il proprio lavoro, dando prova della massima tenacia, costanza e sistematicità. Senza queste qualità non è neppure possibile accingersi al compito di educare politicamente. E i risultati dell’educazione politica si possono misurare soltanto attraverso i progressi economici.
«Non è soltanto necessario distruggere l’analfabetismo e la corruzione, che alligna sul terreno dell’analfabetismo, ma bisogna che la nostra propaganda, i nostri testi, i nostri opuscoli siano effettivamente assimilati dal popolo e che come risultato si abbia un miglioramento dell’economia nazionale. Ecco, con la nostra Nuova politica economica, quali sono i compiti del Centro di educazione politica, e vorrei sperare che, grazie al nostro congresso, grandi successi saranno conseguiti in questo campo».
Ancora sui problemi sorti dopo la presa del potere, un articolo di Lenin sulla cooperazione scritto il 4 gennaio 1923:
«Davanti a noi si pongono due compiti fondamentali, che costituiscono un’epoca. Si tratta del compito di trasformare il nostro apparato statale, che proprio non vale nulla e che abbiamo ereditato al completo dall’epoca precedente; in cinque anni di lotta non abbiamo modificato nulla seriamente in questo campo perché non ne abbiamo avuto il tempo, e non lo potevamo avere.
«Il nostro secondo compito consiste nel lavoro culturale per i contadini. E questo lavoro culturale fra i contadini ha come scopo appunto la cooperazione. Se potessimo riuscire a organizzare tutta la popolazione nelle cooperative, noi staremmo già a piè fermo sul terreno socialista. Ma questa condizione implica un tale grado di cultura dei contadini (precisamente dei contadini come una massa enorme), che è impossibile organizzare tutta la popolazione in cooperative senza una vera rivoluzione culturale.
«I nostri avversari ci hanno detto più volte che noi intraprendiamo un’opera insensata nel voler impiantare il socialismo in un paese che non è abbastanza colto. Ma si sono ingannati; noi abbiamo cominciato non da dove si doveva cominciare secondo la teoria (di ogni genere di pedanti), e da noi il rivolgimento politico e sociale ha preceduto il rivolgimento culturale, la rivoluzione culturale di fronte alla quale pur tuttavia oggi ci troviamo. Ora a noi basta di compiere questa rivoluzione culturale per diventare un paese completamente socialista; ma per noi questa rivoluzione culturale comporta delle difficoltà incredibili, sia di carattere puramente culturale (poiché siamo analfabeti), sia di carattere materiale (poiché per diventare colti è necessario un certo sviluppo dei mezzi materiali di produzione, è necessaria una certa base materiale)».
Un altro articolo di Lenin molto significativo apparve sulla Pravda del 4 gennaio 1923, dal titolo “Pagine di diario”:
«Il lavoro pubblicato giorni or sono sul grado dell’istruzione elementare della popolazione in Russia, secondo i dati del censimento del 1920, costituisce un fatto molto importante. Riporto qui la tabella sul grado dell’istruzione elementare della popolazione in Russia per gli anni 1897 e 1920 (...)
«Mentre noi chiacchieravamo della cultura proletaria e della sua relazione con la cultura borghese, i fatti ci porgono delle cifre le quali dimostrano che anche per ciò che riguarda la cultura borghese le cose da noi vanno molto male. Come si vede, e come era da aspettarselo, noi siamo rimasti molto indietro nell’istruzione elementare generale, e perfino il nostro progresso in confronto ai tempi zaristi (1897) è risultato essere troppo lento. Ciò serve da severo ammonimento e da rimprovero all’indirizzo di coloro che facevano e fanno castelli in aria sulla “cultura proletaria”.
«Ciò dimostra quanto lavoro preliminare, urgente ci resta ancora da fare per raggiungere il livello di un ordinario Stato civile dell’Europa occidentale. Ciò dimostra inoltre quale mole di lavoro ci resta ora da compiere per raggiungere effettivamente, in base alle nostre conquiste proletarie un livello di cultura alquanto elevato (...)
«Ma noi non facciamo l’essenziale. Noi non ci preoccupiamo, ossia ci preoccupiamo in misura molto insufficiente di porre il maestro delle scuole elementari all’altezza senza la quale non si può neanche parlare di una qualche cultura, né proletaria, e nemmeno borghese. Noi dobbiamo trattare dell’incoltezza semiasiatica dalla quale non siamo usciti finora e non potremo uscirne senza sforzi seri, sebbene abbiamo la possibilità di uscirne, perché in nessun luogo le masse popolari non sono così interessate come da noi ad una vera cultura; in nessun luogo i problemi di questa cultura si pongono in modo così profondo e coerente come da noi; In nessun luogo, in nessun paese al mondo il potere dello Stato si trova nelle mani della classe operaia, che nella sua massa comprende benissimo le insufficienze non dico della propria cultura, ma della propria istruzione elementare; in nessun luogo essa è pronta a fare e fa tali sacrifici per migliorare la sua situazione a questo riguardo, come da noi».
Marxismo e scienza
I parolai della rivoluzione sono descritti molto bene da Marx nel Comitato Centrale della Lega dei Comunisti, il 15 settembre 1850:
«Alla concezione materialistica hanno sostituito una concezione idealistica. Invece delle condizioni reali pongono come elemento essenziale della rivoluzione la volontà. Mentre noi diciamo agli operai: dovete attraversare quindici, venti, cinquanta anni di guerra civile per modificare non solo le condizioni esistenti ma voi stessi, e per abilitarvi alla conquista del potere, essi dicono: dobbiamo giungere immediatamente al potere, o possiamo andarcene a dormire. Come i democratici usano la parola popolo, così essi usano la parola proletariato: una semplice frase».
Per noi cultura, scienza, filosofia e coscienza si risolvono nella conoscenza (che ha sempre una base materiale, è sempre conoscenza di), in quanto forme astratte che rispecchiano la divisione del lavoro capitalistica, rispecchiano la separazione dell’uomo dai suoi strumenti di produzione, dal prodotto di tali strumenti, da sé stesso e dagli altri, come conseguenza della sua alienazione al capitalista.
Se la scienza non è l’oggetto principale di questo scritto, non possiamo fare a meno di qualche cenno. Su “Il Programma Comunista” n. 2 del gennaio 1970 troviamo un articolo titolato “Scienza borghese, drogatura ideologica”:
«Per i marxisti è evidente non solo che le applicazioni della scienza e in genere le cosiddette scienze sociali, storiche (“umane”), sono meri strumenti di dominazione rincoglionitrice utili al capitalismo, ma altresì che le stesse scienze pure, nella misura in cui sono costrette, per non ridursi a insignificanti constatazioni sperimentali, a darsi un inquadramento teorico, non possono non attingere dal bagaglio capitalistico. Donde i fenomeni meravigliosamente analizzati da Engels e da Lenin (Antidühring, Dialettica della natura, Materialismo ed empiriocriticismo, Quaderni filosofici) che indicano come la scienza pura o applicata non possa non mettere capo, nell’attuale ordinamento sociale, ad una forma di mistificazione ideologica, che nulla ha da invidiare al vecchio misticismo e che anzi ben spesso attinge motivi da questo medesimo riabilitando il fideismo che il preteso rischiaramento della rivoluzione borghese proclamava sconfitto per sempre».
Su “Il Programma Comunista” n. 22 del dicembre 1968, pag. 4, troviamo un articolo titolato “Marxismo e scienza borghese”:
«Ponendosi come Scienza in sé, pretendendo che una scienza astratta al disopra delle classi debba regolare le questioni sociali, la scienza lotta direttamente contro la presa di coscienza rivoluzionaria del proletariato. Per questo – non per soddisfare meschine vanità – la borghesia leva tanto alle stelle la scienza e gli scienziati: finché i proletari, tenuti dalla divisione del lavoro nell’ignoranza e nell’abbruttimento, ammirano scienza e scienziati e ne attendono salvezza, la borghesia può dormire tra due guanciali.
«Diremo dunque che il proletariato non debba nulla alla scienza borghese? Sarebbe assurdo. Il proletariato deve alla borghesia la distruzione delle forme di produzione sclerotizzate, la realizzazione – a sue spese – di quell’impetuoso sviluppo delle forze produttive che lo pone obiettivamente davanti alla necessità della sua rivoluzione; che rende possibile e necessario il comunismo. Questo aspetto storicamente rivoluzionario del capitalismo si ritrova, beninteso, anche sul piano teorico: la scienza borghese ha avuto anch’essa la sua fase rivoluzionaria, consistente nella demolizione dello schema di un universo raggelato in categorie immutabili, e nella dimostrazione della storicità della natura.
«Questa fase è contrassegnata da due grandi tappe: Galileo e Kant: dalla negazione del moto “assoluto” e del cosmo geocentrico all’affermazione della storicità del sistema solare; Lamarck e Darwin: dimostrazione dell’evoluzione delle specie viventi e avvicinamento alle leggi che la governano; origine della specie umana. Ecco le grandi conquiste della scienza borghese.
«Arrivata di fronte all’uomo, gira al largo: la terza tappa, la dimostrazione della storicità delle forme socio-familiari e delle leggi che reggono la loro evoluzione ad opera di Morgan, esce già dal quadro della scienza borghese (...) Se può accettare la storicità e il determinismo nella natura, la borghesia non può accettarli nella società umana: per lei, la storia è un lento cammino dalle tenebre verso quell’Ideale di Ragione che è la società borghese. E più questo “ideale” svela la sua vera essenza, più la borghesia respinge con orrore il determinismo che ne annuncia la morte, e si rifugia nella superstizione (...)
«Via via che la fase rivoluzionaria della borghesia si esauriva e il capitalismo vittorioso entrava in fase d’espansione, poi cominciava a putrefarsi, la scienza borghese doveva seguire un’evoluzione parallela: essa non poteva che svilupparsi secondo le esigenze del capitale rinculando sul piano dei principi, non poteva che porre la sua razionalità al di sopra delle classi e pretendersi depositaria della salvezza dell’umanità.
«Questa Scienza astratta oggi non è più che un oppio del proletariato, e non c’è da stupirsi se convive in così buona armonia con la sua nemica di ieri, la religione. La borghesia non cerca più la coerenza: nel suo terrore del proletariato, essa utilizza alla rinfusa Dio e la Ragione, il Papa e la Democrazia (...)
«I problemi che attualmente si pongono all’umanità non sono dovuti a insufficiente padronanza delle forze naturali, ma al fatto che l’umanità non padroneggia le proprie forze. Il suo dominio sulla natura, la sua scienza e le sue forze produttive sono sfuggite al suo controllo, sono divenute “autonome” sotto forma di capitale, la dominano e si moltiplicano a sue spese secondo le leggi del capitale (...)
«Il problema non è quindi accrescere quantitativamente le forze produttive (...) si tratta di rivoluzionare qualitativamente le forze produttive, mediante il sovvertimento dittatoriale dei rapporti sociali di produzione.
«Perciò il proletariato, classe oggettivamente chiamata a realizzare questa rivoluzione, capovolge l’ordine “logico” della scienza, che vorrebbe costruire prima una fisica “compiuta”, quindi una biologia “compiuta”, per giungere infine a una scienza sociale. Il proletariato parte dalla scienza della società umana e le subordina tutte le altre. Solo la conoscenza delle leggi dello sviluppo sociale gli permette di realizzare questa rivoluzione imposta dalla storia; solo dopo aver liquidato le contraddizioni sociali, gli uomini, divenuti padroni della propria forza, potranno riprendere efficacemente lo studio della natura. Liberata dalle contraddizioni del modo di produzione capitalistico, la scienza integrata nell’insieme delle attività sociali progredirà allora a passi di gigante (...) La scienza oggi è la marcia in avanti della rivoluzione; è la scienza di classe del proletariato, la teoria e l’organizzazione del proletariato in classe rivoluzionaria; in una parola, la scienza umana oggi è il Partito. Solo il Partito di classe del proletariato rappresenta, difende e mette in azione la sola scienza che conti, e che ingloba tutte le altre».
Ancora su “Il Programma Comunista” n. 12 del 1953 troviamo “Danza di fantocci, dalla Coscienza alla Cultura”:
«Dopo la presa di possesso sociale dei mezzi di produzione, la fine della concorrenza economica e del mercantilismo, ossia molto dopo la conquista del potere politico, allora per la prima volta si avrà un’attività cosciente degli uomini, della collettività umana. Allora, in quanto non vi saranno più classi. In ogni attività di classe quindi, per i marxisti, la coscienza non solo non è una condizione, e tanto meno essenziale, ma è assente, poiché verrà per la prima volta non come coscienza di classe, ma come coscienza della società umana, controllatrice finalmente del proprio processo di sviluppo, che fu determinato dall’esterno fin che vi erano classi oppresse. La rivoluzione è il compito storico della classe proletaria chiamata all’azione da forze di cui è per ora inconsapevole. La consapevolezza dello sbocco non è nelle masse, ma solo nello specifico organo portatore della dottrina di classe: il partito. Rivoluzione, dittatura, partito sono processi inseparabili, e chiunque cerca la via opponendoli l’uno all’altro, non è che disfattista».
La “cultura proletaria”
Lo stesso articolo riporta poi due citazioni di Trotski:
«Il proletariato al più può assorbire la cultura borghese (...) Finché il proletariato resta proletariato esso non può assimilare altra cultura che quella borghese, e quando potrà essere creata una nuova cultura questa non sarà una cultura proletaria, perché il proletariato come classe avrà cessato di esistere».
Trotski era qui perfettamente d’accordo con Lenin su di una impostazione pienamente materialistica, contro le farneticazioni sulla “cultura proletaria”, che spesso comportavano il buttare a mare tutto il passato (il “vecchiume”), in accordo con il futurismo ed altri, ma non certo con il materialismo.
Trotski dice bene. Ma sapeva altrettanto bene che la “nuova cultura” di cui parla non nasce improvvisamente e, in quanto coincide con la dottrina del partito, non può essere fatta propria dal proletariato immediatamente, in quanto nel capitalismo l’ideologia borghese sarà sempre dominante tra il proletariato, ad eccezione della parte di esso influenzata dal partito.
Così anche dopo la presa del potere l’ideologia borghese non scompare immediatamente: ce ne saranno residui forse anche nel partito, e sicuramente nella classe.
Lo sviluppo di un’autentica “cultura proletaria”, di cui parla Lenin, ispirato dall’esperienza pratica della dittatura proletaria, è un processo già iniziato con la nascita stessa del nostro partito, continuato con la dittatura proletaria del 1917‑24 (data ovviamente approssimativa), e che continuerà con le future forme di dittatura proletaria.
Quella che Lenin chiama “autentica cultura proletaria” sta a una cultura pienamente nuova e non più borghese, esattamente come lo Stato del proletariato sta al Comunismo. Lo sviluppo di cui parla Lenin trova la sua realizzazione solo nel pieno comunismo, quando insieme allo Stato si estingueranno gradualmente anche gli inevitabili residui di ideologia borghese.
Su “Il Programma Comunista” n. 22 del 1958 abbiamo uno scritto dal titolo “La teoria della funzione primaria del partito politico, sola custodia e salvezza della energia storica del proletariato”:
«Fin dal loro sorgere i partiti della borghesia hanno espresso e difeso interessi di classe e non cristallizzazioni di opinioni professate: i molti partiti medio borghesi e piccolo borghesi hanno costituito meccanismi per la trasformazione delle richieste dell’alto capitale in superstizioni politiche delle classi medie e della imbelle piccola borghesia. Quelli di essi che maggiormente reclutavano i loro aderenti nei ceti “intellettuali” sono quelli che meno chiaro hanno visto nella storia e nella società, e hanno fornito eroi ingenui alle imprese e conquiste del capitalismo europeo lasciandosi inculcare come ideali i suoi loschi appetiti: in tutto il Risorgimento italiano troviamo solo una grande eccezione a questa corbellata razionalità e “culturismo” della lotta politica, nel marxista che non ebbe tempo di leggere Marx, Carlo Pisacane, che tuttavia dette la vita alla causa nazionale, ucciso prima che dalla sbirraglia dal contadiname analfabeta e aclassista.
«Fu detto contro la sinistra marxista, negatrice del partitone mostruoso e della adulazione delle masse, che noi tenevamo della teoria delle élites intellettuali. Ma noi siamo tanto contro la democrazia nella società, nella classe e nel partito, cui invochiamo una centralità organica, quanto contro la funzione delle élites dirigenti, cattivo surrogato del Capo‑persona, marionetta collegiale messa al posto di quella isolata, il che in dati svolti è un passo indietro. La differenza sostanziale sta nel fatto che la nostra dottrina non considera una costellazione di partiti, ma la funzione di uno solo, il cui dialogo con tutti gli altri non è intellettuale né colturale, e giammai elettorale e parlamentare, ma è affidato alla violenza di classe, alla forza materiale che ha per suo traguardo la sottomissione e la distruzione di ogni altro».
Già prima di Marx
Abbiamo detto che rintracciamo le origini del nostro concetto di cultura prima di Marx, in Babeuf e Blanqui, e anche in Carlo Pisacane, che abbiamo definito “un marxista che non fece a tempo a leggere Marx”. La sostanza delle sue posizioni, socialiste, classiste e materialiste, è sicuramente valida, e non avrebbe senso imputargli le manchevolezze e le imprecisioni che la storia, e la sua tragica fine, non gli hanno permesso di colmare. Leggiamo alcuni brani dai suoi “Saggi storici-politici-militari” editi postumi nel 1858‑60, vol. III:
«Tutti i filosofi del mondo, da Platone ad Hegel, si accordano nel riconoscere l’esistenza di una legge che chiamano idea, sostanza, logica, ecc., che regoli le condizioni e le relazioni degli uomini. Stabilito un tal principio, svolgono i loro ragionamenti; ma le conseguenze non sono d’accordo con il principio d’onde prendono le mosse, imperò quel primo concetto, tutto astratto, è creato dal pensiero indipendentemente dai fatti. Ma una tale astrazione non dura che un istante la realtà riprende il suo imperio (...) Dal principio del mondo il pensiero umano non ha mai potuto procedere nelle sue ricerche indipendente dalla realtà; a pena discende all’applicazione delle idee, esse si adattano ai fatti, e non mai i fatti procedono da esse. Ciò basta per dimostrare ad evidenza quanto sia assurdo il concetto che le rivoluzioni, i mutamenti negli ordini sociali si facciano prima nel pensiero e poi nella realtà (...) Io mi scorgo parte dell’universo; penso, ma penso ciò che è il reale; non si produce nella mia immaginazione nulla che non esista o che non risulti da ciò che esiste. Ho un’idea chiara e distinta, senza conoscerne l’essenza, della materia, del moto, delle sue proprietà; lo spirito è una negazione, ciò che non è materia, un’incomprensibilità; una cosa che, non potendo essere avvertita dai sensi, non può essere né pure immaginata; spirito è una parola che non ha significato (...)
«È innegabile che la presente società può considerarsi divisa in due classi: da una parte capitalisti e proprietari, dall’altra operai e fittaiuoli. Queste due classi sono in un’evidente e continua opposizione: quella prospera al deperire di questa (...)
«Passiamo al suffragio universale, amara derisione pel popolo minuto. L’operaio, il contadino che non votano pel capitalista, pel proprietario, vengono da questi minacciati della fame. I capitalisti fanno monopolio del voto come d’una derrata; il povero nel governo rappresentativo è abbandonato affatto in balia del ricco, i suoi mali giungono al colmo. Il capitale dispoticamente governa: di quinci la codardia politica, coi deboli superba, e coi forti umile; la non curanza per l’avvenire. Guadagni pronti e grossi è la massima dei presenti uomini di Stato; nelle loro mani il telegrafo elettrico ed il vapore, grandi trovate dell’umano ingegno, son volti a perpetuare l’usurpazione e la miseria (...)
«Né questo è tutto: le ricchezze de’ pochi, e la crescente miseria delle moltitudini producono l’ignoranza e fanno abilità agli usurpatori di salariare parte del popolo per opprimere i rimanenti. Quindi le numerose soldatesche ed il militare dispotismo.
«La quistione politica è nulla in faccia all’importanza della quistione economica. Finché vi sono uomini che per miseria si vendono, il governo sarà in balia di coloro che più posseggono; la libertà è un vano nome. Invenzioni, scoverte, ordini nuovi, liberi reggimenti, altro non fanno che sospingere la società in quell’abisso verso cui le leggi economiche inesorabilmente la traggono (...) Sarà un giorno l’affannata umanità governata da una gretta oligarchia di banchieri? (...)
«L’idea, il concetto dominano, è vero, il destino dei popoli: ma esse sono conseguenza dei fatti, e non si traducono in fatti che dalle rivoluzioni compite per forza d’armi; ed il popolo non trascorre mai alla violenza perché animato da un concetto, ma perché stimolato dai dolori. Cosa sono le idee senza le rivoluzioni, senza la guerra che le faccia trionfare? Un nulla: sono le varie forme che i vapori prendono nell’aria, e che uno zeffiro disperde (...)
«”Quando il popolo non avrà più nulla da mangiare, mangerà il ricco”. In questi termini, con queste parole Rousseau ha preveduto e definito la rivoluzione, e così avverrà (...) Dunque, risponderanno esterrefatti gli economisti, la rivoluzione preveduta, desiderata, è la strage, la spogliazione? Si, tale sarà; ma le sue vittime saranno in numero assai minore di quello che voi ne spegnete coi lunghi tormenti della miseria. E fossero più, noi ripeteremo le vostre frasi: non si giunge senza perdite sulla breccia; non possiamo tener conto di coloro che il carro del progresso schiaccia nel suo cammino. Concludiamo: la rivoluzione è inevitabile, essa si avvicina con caratteri chiari e distinti, e procede indipendente dalle discussioni dei dotti (...)
«Chi oggi è così semplice da supporre che un popolo corra alle armi per surrogare qualche scaltro ad un re, per inalberare uno straccio dipinto in un modo piuttosto che in un altro, per ottenere con le stesse miserie un pomposo nome? Chi negherà che il popolo armasi perché spera in cuor suo, senza dirsi il come, migliorare le sue materiali condizioni? Chi negherà che libertà, patria, diritti, sono vani nomi sono amare derisioni per coloro, dannati in perpetuo, dalle leggi sociali, alla miseria ed all’ignoranza inerenti al diritto di proprietà come l’ombra ai corpi? Perché amerà la libertà della persona, del pensiero, della stampa colui che non ha mezzi come esistere, che per ignoranza non pensa e non legge? (...)
«Gli dei antichi erano degli eroi, perché eroico il popolo che li adorava; quelli dei cristiani, dei martiri, perché schiavi ed oppressi gli adoratori (...) e così al padrone che si creavano nel cielo davano gli attributi medesimi che avevano i loro padroni sulla terra (...) In tutte le religioni sino ad ora esistite la fede ha creduto alla certezza e verità obbiettiva della parte sovrumana. La ragione altro non aveva fatto che distruggere un simbolo e sostituirne un altro accettato come verissimo. Ma oggi siamo trascorsi più innanzi: studiando sul passato e scorgendo una successione di simboli religiosi, ogni uno a sua volta dichiarato falso, si è dedotto che tutti erano egualmente bugiardi, che tale è il presente, che tale sarebbe un nuovo simbolo che ad esso si sostituisce. Dunque la nuova fede qual è? Il non aver fede in nessun simbolo perché chimere della nostra immaginazione; ovvero la nostra fede è l’irreligione».
Aggiungiamo a queste parole che il non aver fede in nessun simbolo, qui riguardante soprattutto le divinità e la ragione, viene da noi comunisti allargato agli eventuali statuti di partito, alle formule organizzative e a qualsiasi altra (inesistente) pretesa “garanzia”.
Continuiamo nella lettura:
«Un popolo a cui negasi una patria crede un tal fatto cagione assoluta dei mali suoi, e conquistandola spera alleviarli. Nondimeno i fugaci esperimenti del ’48 e ’49 han fatto scemare fra gl’italiani, e per essi non intendo sètte ma l’intera nazione, il prestigio che aveva il politico concetto (...) ed un tal sentimento, comeché sconfortante pel presente, è pegno indubitato di migliore avvenire, avvegnaché sarebbe impossibile abbracciare nuove idee, nuovi ordini, prima che il fatto non avesse distrutto le passate illusioni e gli antichi pregiudizi (...) Quale interesse possono avere gli italiani di favorire una dinastia piuttosto che un’altra? Il medesimo di un condannato a cui fosse concesso di scegliere il carnefice (...)
«Ora che scrivo, il governo inglese è una piramide alla cui cima pochi sessagenari si spartiscono le cariche dello Stato; più sotto un congresso parteggiato non da principi politici ma dal credito personale di quelle reliquie; quindi gli elettori, commercianti ed industriali, che mercanteggiano eziandio il loro voto; alla base infine una plebe ignorante e misera oltre misura (...)
«Dicono i dottrinari, i quali temono che i marosi della rivoluzione non li sommerga insieme alle lor dottrine, che bisogna educarsi al vivere libero, ottenerlo per gradi e non per salti, ed accettare una mezzana libertà come sgabello all’intera, come pegno di migliore avvenire. Strano ed assurdo argomento. La brama di libertà è sentimento, è aspirazione naturale dell’uomo, e non già dottrina (...) L’uomo, appena sentesi soverchiamente gravato dal peso della tirannide e scorge la probabilità di rovesciarla, senza più insorge; ed i progressi della scienza, lo sviluppo della ragione cosa valgono all’insurrezione e alla battaglia? (...)
«Ghermita la vittoria, il soccorso della scienza sembra indispensabile; essa può, svolgendo i tesori dall’esperienza accumulati, additare i mezzi come fermare le conquiste. Ma questi vantaggi il fatto li dimostra più effimeri che reali, perciocché non accettano le nazioni i suggerimenti della scienza, ed il volgo di niun progresso è capace se non v’è balzato dall’imperiosa necessità; né havvi ragionamento, oltre il fatto, che valga a convincerlo; i mali sofferti, il bene conquistato sono i solo argomenti che fruttano. Le discussioni, le opinioni, i sistemi emergono dai mali che soffre la società; e la dottrina, in politica, segue e non precede i fatti».
Quest’ultima frase è giusta, fino al momento in cui nella storia emerge la nostra teoria, così come una catena montuosa emerge dalle profondità marine sospinta dai movimenti tellurici.
Continuando:
«Né le nazioni si addottrinano e sortono dalla loro semplicità a furia di libri e di giornali, ma progrediscono attraverso una serie di fatti terribili e sanguinosi. L’opinione la più assurda è il supporre che una mezza libertà possa bel bello, e senza veruna scossa, menarci all’intera, mentre cotesto vantato progresso legale mena dritto alla corruzione (...)
«I reggimenti moderati allontanano le cagioni dell’insorgere (...)
«Infatti presso queste nazioni il frutto che si ottiene dalle migliaia di volumi che si pubblicano da tante accademie, da tanti dotti e dottrinari, riducesi a qualche microscopica riforma politica o ritrovato economico in apparenza utile. Gli onori, gli stipendi di cui largheggiano questi governi coi dotti, sono incentivo a tali lavori che, mascherati da qualche umile osservazione, sono le più sfrontate apologie del presente (...)
«Conchiudiamo che la mezza libertà, le concessioni non sono stato di transizione per giungere a francarsi da ogni giogo, ma efficace mezzo di cui giovasi la forza per garentire le sue usurpazioni; è uno stato non di scuola ma di paralisi (...)
«L’uomo (...) per francarsi dalla tirannide che l’opprime, procede a salti: lo schiavo non smaglia lentamente le catene, ma le spezza. Conchiudiamo: la libertà non ammette restrizioni di sorta alcuna, né da d’uopo d’educazione e di tirocinio per gustarla (...)
«L’uguaglianza politica è derisione, allorché i rapporti sociali dividono i cittadini in due classi distintissime, l’una condannata a perpetuo lavoro per miseramente vivere, l’altra destinata a godersi il frutto dei sudori di quelli. L’uguaglianza politica non è che un ritrovato per sgravarsi dell’obbligo di nutrire gli schiavi, per privare il fanciullo, il vecchio, il malato, d’assistenza; è un ritrovato per concedere al ricco, oltre i suoi diritti politici, la facoltà d’avvalersi di quelli dei suoi dipendenti. Sonosi sciolte le catene degli schiavi recidendogli i garretti (...)
«In una società ove la sola fame costringe il maggior numero al lavoro, la libertà non esiste, la virtù è impossibile, il misfatto è inevitabile; la fame e l’ignoranza, sua conseguenza immediata, rendono la plebe sostegno di quelle medesime istituzioni, di quei pregiudizi da cui emergono la loro miseria; rivolgono la spada del cittadino contro i cittadini medesimi, a difesa di una tirannide che opprime tutti (...)
«Alcuni (...) dicono: noi allevieremo, anzi distruggeremo i mali del proletario con l’educazione. Strana utopia di questa buona gente, condannata dalla natura a vivere d’astrazioni. Come vi procaccerete le grandi somme necessarie all’educazione dei proletari, alla loro esistenza durante tale educazione, ed al compenso che bisogna pagare alla famiglia, privata del guadagno che avrebbe fruttato il lavoro del giovane che voi gli rapite per educare? Con le gravezze forse? Ma non sapete che, rispettando il diritto di proprietà, esse ricadono precisamente sul proletario? Voi l’affamerete per educarlo.
«Ma vogliamo ammettere possibile la vostra utopia: cosa guadagneranno con l’educazione? Condannati, come Sisifo, ad un perpetuo lavoro, non avendo che qualche ora necessaria a rinfrancare le forze, l’educazione ricevuta li farebbe più infelici. Se hanno da vivere da bruti, è meglio lasciarli bruti quali or sono.
«I più positivi propongono l’associazione ed esaltano la sua innegabile potenza; ma più che l’associazione è potente il capitale (...)
«Dunque: la causa che volge tutte le riforme in danno del povero, la causa che accrescendo continuamente la miseria, mena, come altrove vedemmo, alla decadenza, alla dissoluzione sociale, e contrasta allo scopo principale che si propone la società, il benessere di tutti o almeno dei più, è il mostruoso diritto di proprietà. La logica dunque impone di rimuovere l’ostacolo, poco curandosi delle conseguenze; la società riprenderà da se l’equilibrio (...)
«Egli è cosa mostruosa vedere scorgere la proprietà del frutto dei propri lavori non solo non protetta dalle leggi, ma annullata, manomessa, in vantaggio dell’usurpazione dichiarata proprietà sacra ed inviolabile. Si garentisce la proprietà, e più tosto che violarla si lasciano migliaia di infelici perire nella miseria; ma non proteggono le leggi il frutto dei lavori d’un operaio, i sudori di un contadino contro l’usura e l’avidità dei capitalisti e dei proprietari. È dichiarato assassino colui che uccide per rapire un pane necessario alla sua esistenza; uomo onesto chi, divorando il vitto sufficiente a dieci famiglie, lascia che queste perissero d’inedia. E ciò avviene in nome della giustizia: prova evidente che essa altro non è che una parola il cui significato cangia al cangiar dei rapporti sociali (...)
«L’individuo, non potendo avere idee che non siano state generate in lui dalla impressione che riceve dal mondo esteriore, non può mai svelare verità il cui germe non si trovi già abbastanza sviluppato nella società. La fama immediata è retaggio di colui che afferra il concetto collettivo e lo svolge all’occhio dell’universale; o di quello che, nel campo dell’azione, non trae la nazione dietro di sé (cosa impossibile), ma la regge in quel cammino che la nazione medesima presceglie. La boria dell’uomo l’induce a credersi creatore di quei concetti che ha semplicemente svolto, inspiratore di quelle imprese che, dall’universale volontà sospinto, produsse a fine (...)
«Ogni altro, non trovando in sé o in altri tali concetti, conferma un tale giudizio; e di quinci la personificazione dei principi, la deificazione degli uomini (...)
«Gli eroi sono effetti, non causa degli avvenimenti sociali (...)
«Il maestrato che dovrà amministrare l’Italia (...) altro non potrà essere che una convenzione o congresso nazionale eletto con suffragio universale (...)
«Il congresso non è governo, ma centro su cui la nazione equilibrasi, verso cui tendono le sue forze; e vigile guardiano del patto nazionale. Esso può, in virtù di quelle medesime leggi che gli danno vita e ne tracciano le funzioni, conferire a pochi individui o ad un solo, scelti dal suo seno o fuori, i propri attributi, onde ottenere la massima energia nel disbrigo delle sue incombenze: basta che non abdichi mai il diritto inalienabile della loro revoca e del sindacato su di essi».
Il congresso di cui parla Pisacane ricorda la Convenzione giacobina. Noi non neghiamo del tutto agli anarchici il diritto di annoverare il rivoluzionario tra i loro precursori, ma in queste parole vediamo profilarsi la necessità della dittatura rivoluzionaria, dittatura che, pur avendo più somiglianze con quella giacobina che con la nostra, è comunque non accettabile per gli anarchici. Neghiamo invece totalmente tale diritto ai nazionalisti e patrioti in genere: anche noi abbiamo visto con favore i processi di unificazione italiano e tedesco, che hanno significato anche unificazione dei rispettivi proletariati, oltre che un pieno sviluppo capitalistico, con conseguente aumento dei numeri e delle forze del proletariato. Anche per Pisacane l’unità nazionale italiana è sicuramente molto importante, ma solo come necessaria base di partenza per la rivoluzione sociale.
Continuiamo:
«Cominciato lo sbaraglio, vedremo il popolo, dai suoi dolori sospinto, con abbandonate redini precipitarsi nei pericoli; ma le sue prime orme saranno incerte, vacillanti; esso non saprà scorgere il vero nemico, né colorire i suoi disegni. In questi momenti la riuscita, l’indirizzo della rivoluzione dipenderà da quella gioventù intelligente, non dotti ma illuminati combattenti, di cui il popolo naturalmente se ne fa testa (...)
«Il suffragio universale è un inganno: come il vostro voto può esser libero, se la vostra esistenza dipende dal salario del padrone, dalle concessioni del proprietario? Voi indubitamente votereste, costretti dal bisogno, come quelli vorranno. Come il vostro voto può essere giusto, se la miseria vi condanna a perpetua ignoranza e vi toglie ogni abilità per giudicare degli uomini e dei loro concetti? Come può dirsi libero un uomo la cui esistenza dal capriccio d’un altro uomo dipende? La miseria è la principale cagione, la sorgente inesauribile di tutti i mali della società (...) Conseguenza immediata della miseria è l’ignoranza, che vi rende incapaci di governare i vostri particolari negozi, non che quelli del pubblico, e corrivi nel credere tutte quelle imposture che vi rendono fanatici, superstiziosi, intolleranti. La miseria e l’ignoranza sono gli angeli tutelari della moderna società (...)
«La cagione dei mali futuri è evidente: la proprietà ha cangiato possessore, ma è rimasta illesa. È dessa che bisogna abbattere, è il principio che bisogna mutare; e perciò è necessario occuparci della soluzione del problema: impedire che i proprietari rinascano. Questo problema, unito agli altri che riguardano l’industria ed il commercio, formeranno l’oggetto delle nostre cure (...)
«Il capitale, come già dicemmo, essendo proprietà collettiva, non può appartenere ad un uomo; l’appropriarsi il capitale è un’usurpazione, non così manifesta, ma simile a quella della proprietà fondiaria. Tutti i capitali verranno dichiarati proprietà della nazione: il denaro potrà in parte involarsi, ma le fabbriche, le macchine rimarranno (...)
«A coloro i quali, riconoscendo i vantaggi di un tal sistema, oppugnassero la rivoluzione asserendo che la società, senza scossa veruna ma con un successivo progresso potrà trasformarsi, noi risponderemo che eglino disconoscono gli effetti inevitabili delle leggi di economia pubblica applicate alle presenti condizioni dei popoli, che eglino disconoscono i fatti che ogni giorno si compiono sotto i loro occhi. Le numerose associazioni di operai che spontaneamente sorgono mostrano la tendenza della società verso un avvenire che comincia a presentirsi, ma non migliorano per ciò le loro condizioni. A queste associazioni si opporranno quelle dei capitalisti, e quelle, con maggiori danni, dovranno soccombere nella concorrenza. Pretendere che potessero sussistere e prosperare istituzioni di utile universale, in una società costituita da forze tra loro riluttanti, che vicendevolmente si distruggono ed il cui sistema è volto a favorire l’utile individuale a danno del pubblico, è pretendere una cosa impossibile (...)
«Queste leggi, questi consigli verranno pubblicati dal governo, non già quando la mente è ottenebrata ed il senso comune pervertito dai pregiudizi, ma quando la spada della rivoluzione ha già rimosso gli ostacoli, quando i contadini e gli operai avranno rotto l’incanto che li mantiene tra i fragili ceppi del proprietario e del capitalista (...)
«Molti osserveranno che per attuare una simile trasformazione sarà necessario far violenza ai proprietari e ai capitalisti. E noi risponderemo che si, e in forza di quel diritto medesimo che hanno gli oppressi di abbattere la tirannide, che ha la società presente contro i ladri. Finalmente, se in cotesta trasformazione, certo meno violenta di quello che molti si vanno immaginando, molti interessi privati soffriranno, e moltissimi cadranno nella lotta, noi risponderemo che le rivoluzioni in cui tutti si salvano esistono solo nella mente dei dottrinanti e degli utopisti. La rivoluzione è sempre una lotta di oppressi contro una classe di oppressori. Quindi se vi sarà vittoria, vi sarà eziandio disfatta; scacciare un re dal trono non è rivoluzione; la rivoluzione si compie quando le istituzioni, gli interessi su cui quel trono poggiava sono cangiati (...)
«Conchiudo con rammentare ai conservatori che la rivoluzione sociale non sarebbe affrettata neppur d’un’ora, eziandio se tutto il mondo riconoscesse attuabile un nuovo ordinamento sociale. Questa crisi della società dipende da cagioni assai più terribili e fatali; essa dipende dalle tendenze che inesorabilmente, in progressione geometrica, si manifestano. Potete voi non già estirpare la miseria, ma evitare che cresca? Potete voi negare che la forza materiale è dalla parte di coloro che soffrono? E se le tradizioni e l’inerzia formano il solo fascino per cui la società presente non crolla, in un istante impreveduto può rompersi l’incanto».
La borghesia, a cui piace molto la cultura e a cui fa orrore la violenza (ragion per cui, in Italia, ha avuto grande successo il concetto gramsciano di “egemonia culturale”), ha condotto le proprie rivoluzioni con la dittatura e col terrore: a Cromwell e Robespierre non bastava l’”egemonia culturale”.
Evidentemente nemmeno Pisacane credeva alla “egemonia culturale” di Gramsci, il quale vide nella alleanza tra operai e contadini una anticipazione della politica dei governi “operai e contadini”. Questo tenendo conto che alla metà del XIX secolo l’alleanza dei proletari con altre classi (piccola borghesia comprendente il contadiname) in determinate aree era ancora necessaria, e ciò rendeva Pisacane un rivoluzionario. Erano invece controrivoluzionari i governi “operai e contadini”, che finirono per trasformare la dittatura proletaria, esercitata anche nell’interesse dei contadini poveri e semi‑poveri, e con il loro aiuto, in un potere interclassista, e quindi borghese, a scapito degli operai come dei contadini.
Nel “Testamento politico” di Pisacane, scritto nel 1857, poco prima di effettuare la spedizione fatale di Sapri, leggiamo:
«Si può non esser d’accordo sulla forma di una cospirazione, sul luogo e sul tempo in cui una cospirazione debba compiersi; ma non essere d’accordo sul principio è un’assurdità, un’ipocrisia, un modo di celare il più basso egoismo. Io stimo colui che approva la cospirazione ed egli stesso non cospira: ma non sento che disprezzo per coloro che non solo non vogliono far niente ma che si compiacciono nel biasimare e nel maledire gli uomini d’azione (...) Io sono persuaso che se l’impresa riesce, otterrò gli applausi generali; se soccombo, il pubblico mi biasimerà. Sarò detto ambizioso, pazzo, turbolento, e quelli che nulla mai facendo passano la loro vita nel criticare gli altri, esamineranno minuziosamente il tentativo, metteranno a scoperto i miei errori, mi accuseranno di non esser riuscito per mancanza di spirito, di cuore e di energia».
Queste parole calzano perfettamente ai borghesi riformisti o parolai della rivoluzione. Leggiamo ancora:
«Io sono convinto che i rimedi temperati, come il regime costituzionale del Piemonte e le migliorie progressive accordate alla Lombardia, ben lungi dal far avanzare il risorgimento dell’Italia, non possono che ritardarlo. Per quanto mi riguarda, io non farei il più piccolo sacrifizio per cambiare un ministero o per ottenere una costituzione, neppure per scacciare gli austriaci dalla Lombardia e riunire questa provincia al regno di Sardegna. Per mio avviso, la dominazione della casa di Savoia e la dominazione della casa d’Austria sono precisamente la stessa cosa. Io credo pure che il regime costituzionale del Piemonte è più nocivo all’Italia di quello che lo sia la tirannia di Ferdinando II (...)
«Questa opinione pronunciatissima deriva in me dalla profonda mia convinzione di essere la propagazione dell’idea una chimera e l’istruzione popolare un’assurdità. Le idee nascono dai fatti e non questi da quelle, ed il popolo non sarà libero perché sarà istrutto, ma sarà ben tosto istrutto quando sarà libero».
Il socialista e materialista Carlo Pisacane condivideva sostanzialmente le nostre posizioni sulla cultura, sulla scienza, sulla filosofia, nonché su altre “sacralità”, come la giustizia, che già il sofista greco Trasimaco, tra V e IV secolo avanti Cristo, definiva “strumento del più forte”. Il tragediografo greco Eschilo, nella sua “Agamennone” dice: «Zeus aprì le vie del sapere ai mortali. Questo, però, è il principio che fissò ben saldo: è col dolore che si impara». Nella Bibbia, libro del Qoelet, o Ecclesiaste, si legge: «Chi accresce il sapere aumenta il dolore».
Dal bisogno del comunismo
alla teoria al programma alla milizia del partito
La conoscenza, la cultura, (ed anche la scienza, la filosofia, l’arte, la coscienza) non sono un sapere astratto, che il proletariato fa proprio serenamente leggendo uno o più libri, magari seduti su una comoda poltrona. Eschilo e il Qoelet hanno ragione: il sapere è un dolore concreto e sedimentato nei secoli, in quanto nasce dalle miserie, dalle sofferenze, dalle rivoluzioni che hanno caratterizzato tutta la storia della specie umana. Storia che da millenni è storia di lotta tra le classi, e che da oltre due secoli è lotta di classe tra borghesia e proletariato.
Quasi tutti conoscono la storia di un uomo crocifisso ingiustamente circa 2.000 anni fa; molti meno sanno, o vogliono sapere, delle circa 30.000 croci erette nell’impero romano, 6.000 delle quali destinate ai superstiti della rivolta di Spartaco, una ogni trenta passi sulla via Appia da Capua a Roma. Ricordarsi di quell’unico crocifisso è un offesa per i 30.000, ma anche per quel solo, così diviso dai suoi compagni di sventura, e infine trasformato nell’immagine del potere politico e religioso, e cioè dei suoi carnefici.
La conoscenza non dimora presso gli eruditi, e ancor meno nelle scuole e nelle università della borghesia. La conoscenza non appartiene neanche ai singoli militanti comunisti. La conoscenza è la storia della specie, che in un certo momento si è condensata, solidificata, come la Terra alcuni miliardi di anni dopo essersi originata dal Sole, dando luogo al programma e alla teoria comunista. La conoscenza, nella società capitalista, risiede solo nel partito comunista e non può risiedere altrove: come gli dei greci prendevano dimora nelle statue scolpite a rappresentarli, così la conoscenza prende dimora nel Partito. La conoscenza è il partito.
La collera esplosa nella "ribelle" Guadalupa, seguita a breve dalla Martinica, da metà novembre è un nuovo episodio della lotta nei Territori Francesi d’Oltremare (TFO) contro il deterioramento delle condizioni di vita della popolazione, aggravato dalla crisi sanitaria.
Viene erroneamente presentato dai nostri media come un movimento di protesta contro la vaccinazione obbligatoria dal Covid19.
È iniziata lunedì 15 novembre in Guadalupa con un appello allo sciopero generale da parte di un collettivo di sindacati e organizzazioni di cittadini, la LKP (in creolo: Liyannaj Kont Pwofitasyon, Collettivo contro lo sfruttamento oltraggioso), e in Martinica lunedì 22 novembre con l’appello di una Intersindacale guidata dalla CGT della Martinica. Ma il movimento è iniziato nel luglio 2021 in entrambe le isole con richieste legate principalmente al degrado delle strutture sanitarie aggravate dal Covid19 e alla disastrosa situazione socio-economica che affligge queste isole da decenni, come la maggior parte dei TFO.
Se a scatenare l’incendio a settembre è stato il certificato sanitario obbligatorio e la conseguente sospensione dal servizio dei vigili del fuoco e di personale ospedaliero, la situazione sociale in Guadalupa e Martinica è una polveriera da ben prima. È una spina nel fianco del governo Macron, già impegnato nella campagna presidenziale.
Dal 4 dicembre la calma sembra essere tornata grazie al dispiegamento di forze repressive, ma rimangono sacche di resistenza. Negoziati sono in corso, soprattutto in Martinica, mentre in Guadalupa il 14 dicembre i sindacati e i parlamentari locali hanno rifiutato di continuare le trattative.
Intanto reparti armati della polizia rimuovono una barricata dopo l’altra, i tribunali lavorano a pieno ritmo per “punire” gli arrestati per violenza, soprattutto giovani.
Quale sarà l’esito di questo nuovo conflitto quando le classi lavoratrici dei TFO non possono contare sulla solidarietà dei proletari in Francia, le cui organizzazioni sindacali si tengono ben alla larga dall’argomento?
Due isole a lungo rivali
Guadalupa e Martinica sono due piccole isole vulcaniche nel Mar dei Caraibi, con un clima, una fauna e una flora molto simili, per una superficie di 1.700 km² la prima e 1.000 km² la seconda, e popolazioni di circa 450.000 abitanti ciascuna.
Tuttavia per secoli le due isole hanno avuto un diverso sviluppo economico. La colonizzazione francese nel XVII secolo partì dalla piccola isola di Saint Christophe, per la coltivazione della canna da zucchero, che richiedeva l’impiego degli schiavi. La colonizzazione della Martinica fu più prospera di quella della Guadalupa perché guidata da imprenditori che dal 1668 fecero della città di Saint Pierre la sede del governo delle Antille francesi, portando a uno sviluppo economico con il commercio di merci e di schiavi per le piantagioni.
La schiavitù fu abolita nel 1794 dalla Rivoluzione in Francia, ma solo in Guadalupa, dove i piantatori furono cacciati o ghigliottinati, mentre in Martinica, occupata dagli inglesi dal 1794 al 1814, i piantatori furono protetti dall’abolizione della schiavitù e mantenuto il loro status sociale. Reintrodotta nel 1802 da Napoleone, la schiavitù fu definitivamente abolita nel 1848 per entrambe le isole.
Tuttavia in Martinica si era sviluppata una casta di piantatori, bianchi-creoli o békés, discendenti dei primi coloni europei, soprattutto francesi, ma anche inglesi e olandesi, che si erano incrociati con schiavi o schiavi affrancati. Con la grave crisi dello zucchero del 1884 i piantatori della Guadalupa furono rovinati e le loro piantagioni acquistate da compagnie metropolitane e da famiglie béké della Martinica. Questi rimangono ancora oggi in entrambe le isole una componente sociale, una “casta” dal peso economico rilevante. Oggi il loro monopolio è minato dall’arrivo di investitori metropolitani e dall’emergere negli anni ‘90 di una grande borghesia meticcia, indiana o cinese. Nella lotta tra operai e padroni, il béké non è più l’unico individuato come sfruttatore!
Una situazione economica e sociale disastrosa
Un gruppo di senatori ha presentato nel novembre 2021 un dettagliato rapporto sulla situazione economica, sociale e sanitaria di tutti i TFO: Martinica, Guadalupa, Guyana francese, Nuova Caledonia, Polinesia, Réunion, Mayotte, ecc, con oltre 2,6 milioni di abitanti. Quell’allarme si è rafforzato quest’anno. La borghesia francese e i suoi tirapiedi al governo conoscono quindi bene il problema!
Questi territori sono caratterizzati da indicatori sociali peggiori della media francese. La disoccupazione nel 2020 è salita a quasi il 19% in Guadalupa, al 13% in Martinica, al 17% alla Réunion, all’11% in Nuova Caledonia (ma il 15% per i kanak), al 15% nella Polinesia Francese. Lo stesso per il tasso di povertà, che raggiunge il 30% nelle Martinica e Guadalupa, il 42% alla Réunion, il 53% nella Guyana Francese e addirittura il 77% a Mayotte. La vita è più cara che in Francia e i salari sono più bassi.
I nostri solerti senatori aggiungono che vi si riscontra un contesto sociale “eruttivo”, un tasso più elevato di reati violenti e di violenza intra-familiare, e una inferiore durata degli studi, che risente dell’inadeguatezza del trasporto scolastico rispetto alla Francia.
L’economia di questi territori dipende dalle sovvenzioni del governo centrale, dalle importazioni e dal turismo. Nel 2021 la ripresa economica nei TFO è stato ostacolata dalle nuove restrizioni sanitarie. Confinamenti e coprifuochi sono stati decisi in agosto e settembre 2021, quando la situazione sanitaria sembrava più favorevole in Francia, mentre questi territori erano meno colpiti dall’epidemia fino all’estate scorsa. Il turismo ha un’importanza cruciale per le economie d’oltremare e determinante nelle Antille: 30% del PIL della Guadalupa, per esempio. Ha un forte effetto a catena su altri settori – trasporti, ristorazione, tempo libero – che rappresentano fino al 10% dei posti di lavoro diretti e altrettanti indiretti. I TFO stanno affrontando la penuria e l’aumento dei prezzi delle materie prime legati all’ingolfamento dei trasporti marittimi e al surriscaldamento dell’economia, anche se l’attività non è tornata al livello precedente.
Al pubblico impiego va gran parte dei posti di lavoro nelle Antille. Il settore in senso lato (servizi civili statali, locali e ospedalieri ed enti parapubblici) beneficia di un sistema retributivo favorito. In applicazione di una legge del 1950 lo stipendio pagato ai dipendenti pubblici francesi distaccati nei Dipartimenti d’Oltremare, che occupano le qualifiche più alte, è maggiorato di un coefficiente fissato al 40% in Guadalupa, Martinica e Guyana, che sale al 53% in Réunion. Si aggiunge una indennità quando il dipendente si è dovuto trasferire. Inoltre in Réunion le pensioni dei pubblici dipendenti sono aumentate del 35%. Questo crea un divario tra il personale civile originario della Francia e quello indigeno.
L’economia dei Dipartimenti d’Oltremare è fortemente dipendente dalla metropoli. Il commercio estero è molto deficitario. La maggior parte di questo commercio è con la Francia continentale (60‑65%), mentre le relazioni commerciali con i paesi vicini rimangono per lo più marginali. Il tasso di copertura delle importazioni con le esportazioni è molto basso e in costante diminuzione: nel 1998, era solo del 7% per la Guadalupa, del 17% per la Guyana, del 17% per la Martinica e dell’8% per la Réunion. Poiché i TFO hanno una base industriale debole, gran parte del consumo delle famiglie e delle imprese proviene dalle importazioni.
Il disordine globale delle catene di approvvigionamento ha sconvolto la produzione di manufatti, ha ridotto il flusso delle importazioni e ha portato alla chiusura dei mercati di destinazione delle aziende d’oltremare con poche possibilità di rifarsi sul mercato locale.
Altra caratteristica della Francia d’Oltremare è l’altissima percentuale di piccolissime imprese, spesso imprenditori individuali di se stessi, e di piccole e medie imprese, che rappresentano circa il 95%. L’84% delle aziende in Guadalupa non ha dipendenti, l’81% in Martinica e il 65% in Guyana francese. Queste piccole imprese sono vulnerabili agli shock economici, specialmente di questa portata, data la loro minore disponibilità di cassa, la minore redditività e la riluttanza delle banche a concedere loro prestiti. La quota di economia informale, non dichiarata agli organi statali come l’economia familiare, o illegale, nel PIL è molto più alta che in Francia. In Guadalupa il settore informale rappresenta tra il 23 e il 26,5% dei posti di lavoro, tra il 19 e il 20% in Martinica e tra il 12,5 e il 16,5% in Réunion. Le imprese del settore informale non hanno accesso agli aiuti di Stato e sono concentrate nelle attività più colpite, come il commercio al dettaglio e l’edilizia.
I sindacati
Mentre la popolazione di entrambe le isole è in stragrande maggioranza contraria all’indipendenza, la Martinica, dopo un referendum nel 2011, gode, come la Guyana francese, di uno status politico più autonomo rispetto alla Guadalupa, essendo passata da Dipartimento a Collettività Territoriale. È governata da un’assemblea controllata da diversi partiti moderati fautori pro‑indipendenza, e meno ostile allo Stato centrale, mentre la Guadalupa è governata da due assemblee, il Consiglio Generale e quello Regionale. Ma di fatto, la situazione sociale è la stessa su entrambe le isole.
In Guadalupa il Collettivo LKP, che riunisce una cinquantina di organizzazioni sindacali, associative, politiche e culturali, guida le lotte dal 2009. Vi prevale maggioritaria la Unione Generale dei Lavoratori di Guadalupa (UGTG, Unyon Général a Travayè Gwadloup, in creolo), un sindacato con rivendicazioni pro‑indipendenza. I principali sindacati in Guadalupa sono la UGTG, indipendentista, e la Confederazione Generale dei Lavoratori di Guadalupa (CGTG), classista.
L’UGTG è il sindacato maggioritario: ha ottenuto il 52% dei voti nelle elezioni sindacali del 2008, contro il 20% della CGTG e il 9% della Centrale dei Lavoratori Uniti.
La UGTG è un sindacato molto centralizzato, fondato nel dicembre 1973, ma che si dà anche obiettivi politici, pro‑indipendenza e “anti‑coloniali”. Dalla nascita è stato guidato da attivisti del movimento indipendentista, ma la maggior parte dei lavoratori che vi aderiscono non sono nazionalisti. Inizialmente basato sull’industria dello zucchero, che poi declinò, il sindacato ha guadagnato forza nel pubblico impiego, nel commercio e nelle piccole imprese. L’UGTG si dichiara patriottica e a presidio della “identità” dell’isola. La CGTG la accusa di difendere più gli imprenditori della Guadalupa che i lavoratori! Infatti il principale nemico dell’UGTG è lo Stato francese.
La CGTG si è separata dalla CGT francese nel 1961, ma ha mantenuto un rapporto di cooperazione e di sostegno reciproco. Per molti anni la politica timida, moderata e non combattiva della direzione della CGTG ha portato a un’emorragia di molti suoi sindacati, che sono andati a rafforzare la UGTG. Per esempio nell’industria della canna da zucchero, negli zuccherifici, nei supermercati, nei grandi alberghi, negli enti locali, nei comuni, ecc. Dal 2004 è guidata da un attivista dell’organizzazione trotskista Combat Ouvrier, legata alla francese Lutte Ouvrière, e si proclama espressione della lotta di classe.
Una delle difficoltà che hanno ostacolato il rafforzamento della CGTG è stato, a partire dagli anni ‘80, il graduale cambiamento della classe operaia dell’isola. Gli zuccherifici hanno chiuso, tranne due ora trasferiti nella piccola isola vicina di Marie-Galante. La superficie delle coltivazioni a canna da zucchero si è ridotta e la meccanizzazione ha fatto quasi scomparire i tagliatori di canna e le moorers (le donne che legavano le fascine). I békés hanno poi riconvertito le piantagioni a banane. Il sindacato dei lavoratori delle banane aderente alla CGTG è rinato e si è rafforzato notevolmente, in particolare durante diversi scioperi e lotte memorabili. Ma da qualche tempo anche diverse piantagioni di banane stanno chiudendo, lasciando centinaia di lavoratori agricoli senza lavoro. Di conseguenza il loro sindacato si è indebolito. Il proletariato non è più concentrato nel settore agricolo.
Altre aree sono in espansione, con i lavoratori concentrati in piccole imprese e in lavori spesso precari. La disoccupazione è aumentata, colpendo in primo luogo le donne e i giovani, che emigrano in massa in Francia o ottengono solo piccoli lavori e contratti a tempo determinato.
In Martinica le organizzazioni sindacali più influenti sono la CGTM (Confederazione Generale del Lavoro della Martinica) la CDMT (Centrale Democratica in Martinica dei Lavoratori). La CGTM è il principale sindacato dell’isola. Dal 1990 è guidata da un attivista di Combat Ouvrier, come la CGTG. Ha roccheforti nei servizi pubblici, nei portuali e nella raccolta delle banane. Separatasi dalla CGT nel 1976, è tornata ad aderirvi nel settembre 2021 a causa di cambiamenti legali che avrebbero limitato la sua rappresentatività.
La CDMT afferma essere un sindacato di lotta di classe, democratico, anticoloniale e anticapitalista. È guidato da un attivista di un partito trotskista vicino all’NPA.
La CSTM (Centrale Sindacale dei Lavoratori della Martinica) è terzo. Si è formato da una scissione di Force Ouvrière dopo lo sciopero dei lavoratori delle banane del febbraio 1974, che fu duramente represso, ed è vicino al movimento indipendentista.
I flagelli del clordecone e del Covid‑19
Il fuoco della rivolta si è levato dalle ceneri di un vecchio scandalo sanitario: quello del clordecone, un pesticida, la cui alta tossicità è nota dagli anni’60, usato nelle Antille con il consenso delle istituzioni dal 1972 al 1993, anche quando vietato negli Stati Uniti dal 1976 e nella Francia continentale dal 1990. Questo pesticida, usato nelle piantagioni di banane minacciate dai tonchi, un parassita, ha causato nelle Antille un inquinamento consistente e duraturo del suolo e delle acque. Il suo impiego ha causato danni sanitari incalcolabili: secondo dati sanitari ufficiali, tra il 1972 e il 1993 nove decimi degli abitanti della Martinica e della Guadalupa sono stati contaminati da questa sostanza, dove si riscontrano fra i più alti tassi di cancro alla prostata del mondo.
Da più di vent’anni sono in corso procedimenti legali contro i proprietari delle piantagioni, che spesso sono famiglie béké molto potenti, ma non sono ancora state pronunciate condanne e ancor meno sono stati risarciti i malati e i danni causati. Da novembre 2019 ogni sabato is hanno dimostrazioni contro le imprese, i supermercati, ecc. appartenenti alle famiglie békés, azioni severamente ostacolate dalle forze dello Stato.
L’epidemia di Covid19 finora non aveva quasi interessato questi territori. Ma la quarta ondata della pandemia ha colpito duramente, aggravata dalle scarse misure sanitarie, dalla mancanza di cure e dalle difficoltà sociali nei Territori d’Oltremare. Il bilancio della quarta ondata è stato pesante: i TFO ospitano il 4% della popolazione francese, ma dall’inizio di luglio alla fine di ottobre più del 30% dei decessi legati al Covid si è verificato nei loro ospedali. Da aggiungere il numero di morti in casa, che non viene contato. Da luglio a ottobre 2021 sono stati registrati in Guadalupa 580 decessi ospedalieri legati al Covid e 520 in Martinica. Questo eccesso di mortalità si spiega non solo con uno stato di co‑morbilità spesso legato alla povertà, ma anche con un settore sanitario in pieno degrado, ancora più grave che nella Francia metropolitana (mancanza di personale, di letti, di attrezzature, soprattutto respiratorie, disorganizzazione, ecc).
Nonostante l’aumento della capacità dei reparti di rianimazione, l’invio massiccio di rinforzi (4.600 infermieri in 3 mesi) e più di 150 trasferimenti dei malati in Francia, gli ospedali sono stati sopraffatti. Le Antille sono state investite da uno “tsunami” epidemico. Negli ospedali si è dovuto scegliere fra quali pazienti curare. Più di un migliaio sono stati costretti a casa, con i medici privi di aiuto o in mancanza di ossigeno. La diagnosi e il trattamento delle patologie non virali sono stati notevolmente ritardati, con un impatto sulla mortalità che deve ancora essere valutato. I lavoratori degli ospedalieri sono stati oggetto della protesta per il fallimento sanitario.
Lo stato di emergenza sanitaria doveva rimanere in vigore in Guadalupa fino al 15 novembre 2021, alla Guyana francese e alla Martinica fino al 31 dicembre. Al 15 novembre 2021 solo il 33% aveva ricevuto le 2 dosi di vaccino in Guadalupa e il 34% in Martinica. In Guyana, il tasso di vaccinazione a due dosi è del 25,5%.
L’ostilità, la riluttanza o i dubbi sul vaccino sono molto più diffusi lì che in Francia per una serie di ragioni: la preferenza per la farmacopea tradizionale, l’esperienza di altri rischi alla salute che relativizzano quelli legati al virus, l’importanza sproporzionata dei forum in rete vettori di false informazioni. Ma soprattutto si impone la sfiducia di una parte della popolazione verso lo Stato e le verità istituzionali, per ragioni che hanno a che vedere con la storia di conflitti sanguinosi, per lo scandalo del clordecone, per l’incapacità delle autorità di garantire l’approvvigionamento idrico (con uno stato disastroso delle reti di distribuzione), per i trasporti e il sistema sanitario inefficienti.
L’annuncio dell’obbligo per gli operatori sanitari a vaccinarsi entro il 16 novembre è stato di innesco alla rivolta. Per molti antillani la imposizione dell’obbligo alla vaccinazione da parte delle istituzioni statali tende solo a mascherare i problemi. Anche i sindacati hanno approfittato dell’opposizione ai vaccini per mobilitare i lavoratori.
Tra il personale sanitario dell’isola il tasso di vaccinazione a novembre era già dell’85%, ma rimangono sacche di resistenza tanto che il 22 novembre all’ospedale di Pointe‑à‑Pitre ci sono state 566 sospensioni dal lavoro per mancata vaccinazione.
Ma altro è ciò che realmente alimenta la frustrazione e la rabbia degli abitanti. A Pointe‑à‑Pitre ogni giorno cresce la miseria. Intere arterie commerciali sono ormai in abbandono con i bandoni dei negozi abbassati o danneggiati. Il sindaco della città, Harry Durmel (del partito ecologista EELV). lamenta «sfiducia nei pubblici poteri». Elie Domota, segretario della UGTG aggiunge «noi della Guadalupa siamo un popolo, abbiamo una storia, e chiediamo di essere ascoltati quando abbiamo dei dubbi, dubbi legittimi. Puoi venire a dirci quello che vuoi, non ci fidiamo di te».
Inizia il movimento
Per decenni la situazione economica ha regolarmente provocato sommovimenti sociali, che lo Stato centrale e locale ha represso, il più delle volte molto duramente.
Prima del 1947 Guadalupa e Martinica erano sotto il controllo di governatori, simbolo coloniale, che furono sostituiti da prefetti. Ma la legislazione metropolitana, nei settori della previdenza sociale (salute, famiglia, pensione), a seguito del cambiamento dello stato di queste isole da colonia a dipartimento, fu applicata solo molto lentamente e incontrò l’ostilità dei padroni dell’industria e dell’agricoltura delle Antille. In effetti ancora oggi il potere economico rimane nelle mani dei grandi proprietari terrieri, discendenti dei primi coloni, bianchi o békés, o delle grandi imprese esterne alle Antille.
Le lotte iniziarono alla fine del XIX secolo con la crisi della produzione di zucchero, e poi nel XX con un duro sciopero nei campi di canna da zucchero nel febbraio 1961, fino al movimento del maggio 1967, quando gli indipendentisti divennero più attivi e una brutale repressione fece molti morti, soprattutto in Guadalupa, che ancora oggi lo ricorda. Questo episodio segnò una rottura con il Partito Comunista Francese, molto cauto contro il potere centrale. Si svilupparono movimenti autonomisti e indipendentisti, influenzati dai movimenti algerini e cubani.
Nel 1973 fu fondata in Guadalupa la UGTG, che doveva essere un sindacato di massa, di classe e anticoloniale, affermandosi nel settore della canna da zucchero, che avrebbe diretto numerosi scioperi nel contesto di una crisi di sovrapproduzione.
Gli anni ’80 videro un declino delle lotte.
Nel 2002 in Guadalupa, la più ribelle delle due isole, fu presentata una piattaforma di rivendicazioni con lotte negli anni successivi. In Martinica nel 2005 si ricostituì una intersindacale, dopo diversi precedenti tentativi.
Il grande movimento sociale del 2008‑2009 in Guadalupa e Martinica fu il culmine di una moltitudine di conflitti riguardanti i salari, la sanità, le scuole e la repressione antisindacale e l’arroganza di un padronato spietato, costituto dai residui della "casta" dei béké, dai capi delle imprese della Francia metropolitana, dalle multinazionali, dai padroni locali antillani o indiani.
Nacque il Collettivo della Guadalupa LKP, che ha guidato il movimento iniziato nel dicembre 2008 in seguito all’aumento dei prezzi della benzina, si è diffuso in Martinica e ha colpito anche la Guyana francese. Uno sciopero generale illimitato fu indetto in Guadalupa dal 20 gennaio al 4 marzo 2009. Iniziò in Martinica il 5 febbraio, ma lì la forza del movimento guidato dall’Intersindacale fu minore. Furono presentate dal LKP 140 richieste, contro l’alto costo della vita e la disoccupazione. Lo sciopero durò 44 giorni in Guadalupa e 38 in Martinica. Ci furono molti scontri con la polizia, con la partecipazione dei quartieri popolari. Le trattative, sulla base della piattaforma, furono condotte fra lo Stato, i datori di lavoro, le autorità locali e i sindacati. Questi invitarono al ritorno al lavoro dopo alcuni magri guadagni.
Da quel massiccio sciopero generale contro l’alto costo della vita nel 2009 la situazione non è migliorata. E il Covid‑19 non ha aiutato. Tutti i prodotti che passano attraverso la Francia per arrivare nelle Antille costano molto di più, a causa del trasporto e dei dazi marittimi (una tassa doganale riscossa dai Territori d’Oltremare sui prodotti importati). Alcune compagnie hanno un monopolio sulle isole e non permettono la concorrenza, il che fa aumentare i prezzi. E l’offerta di alloggi non è sufficiente. È soprattutto il prezzo degli alimentari un problema: nonostante i meccanismi messi in atto dallo Stato per proteggere i consumatori d’oltremare, i prodotti alimentari in Martinica e Guadalupa continuano a costare circa il 40% in più rispetto alla Francia continentale.
Gli scioperanti chiedono quindi un aumento dei salari, delle pensioni e delle prestazioni sociali minime, oltre che un limite al prezzo della benzina e del gas. Il prezzo di una bombola di gas, che molti antillani usano per cucinare, è aumentato di quasi 11 euro in due anni, raggiungendo i 30 euro in ottobre!
Inoltre lo scandalo dell’interminabile processo contro i responsabili degli effetti del clordecone aumenta la sfiducia della popolazione verso uno Stato centrale che apertamente protegge i piantatori.
Nel mezzo del movimento attuale, in risposta a una delle richieste del movimento, il governo ha annunciato il riconoscimento del cancro alla prostata come malattia professionale per i lavoratori agricoli. I sindacati chiedono anche test di screening gratuiti per l’avvelenamento da clordecone per tutta la popolazione: promesso dal governo lo scorso marzo, è stato concesso solo per i lavoratori e le donne incinte. Per gli altri il test costa 140 euro.
Le restrizioni imposte dal confino e dalle altre misure sanitarie hanno peggiorato significativamente le condizioni di vita di gran parte della popolazione, con il settore turistico molto colpito, aumento dei prezzi di gas, carburante e alimenti, chiusura di piccole imprese, ecc.
Il movimento attuale è iniziato il 17 luglio. Manifestazioni organizzate dalla LKP in Guadalupa e dall’Intersindacale in Martinica contro le misure sanitarie e la gestione della crisi del Covid si sono svolte ogni sabato nei comuni dell’arcipelago, nell’indifferenza e nel silenzio delle autorità. Quest’estate hanno mobilitato fino a diverse migliaia di guadalupani e martinicani.
Negoziati con le autorità locali sono iniziati a luglio. L’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e dei medici professionisti e del certificato sanitario per l’accesso ai ristoranti ecc., previsto dalla legge del 5 agosto 2021 e pienamente in vigore in Francia metropolitana dal 16 ottobre, è stato oggetto di un calendario modificato per i Territori.
Per i vigili del fuoco l’obbligo della tessera sanitaria è iniziato il 15 settembre: chi lo rifiuta è minacciato di sospensione. Questo obbligo ha dato luogo a forti proteste, in particolare nelle Antille e nella Guyana francese, portando a conflitti in molti ospedali.
In Guadalupa la LKP ha presentato il 2 settembre una piattaforma di 32 punti, tra cui: «aumento generale dei salari, eliminazione di tutti i lavori precari e massicce assunzioni, fine della repressione giudiziaria e padronale». Infine l’abrogazione dell’obbligo al libretto sanitario e alla vaccinazione per alcune professioni. Ma alla fine di settembre il prefetto ha interrotto le trattative. L’unica risposta dello Stato e dei padroni sono stati arresti arbitrari, molestie ai lavoratori, violenze della polizia, condanne, sospensione dei contratti di lavoro e dei salari, chiusura di studi professionali con sospensione dei dipendenti, messa in mora per il personale infermieristico e i pompieri recalcitranti.
Se a metà settembre l’85% dei 251.000 vigili del fuoco non era stato vaccinato, il 15 ottobre si sono ridotti al 7%. In Guadalupa nei vari ospedali il tasso di vaccinazione del personale è fra l’85% e quasi il 100%. Ma nell’insieme dei servizi sanitari si arriva appena al 50% in Martinica e al 64% in Guyana.
L’appello per lo sciopero generale
Dopo quattro mesi di mobilitazione e richieste di trattative senza esito la pressione è infine esplosa. La LKP indice uno sciopero generale illimitato da lunedì 15 novembre (data della fine dello stato di emergenza sanitaria in Guadalupa). Lunedì 22 novembre è la data per la Martinica su chiamata di una Intersindacale che riunisce 17 sindacati. Il segretario generale dell’UGTG, Maïté Hubert M’Toumo, in un comunicato stampa congiunto con la LPK denuncia «il deterioramento del clima sociale risultato del marciume deliberato orchestrato dallo Stato con la complicità dei parlamentari e dei media», che la mobilitazione riflette «la profondità delle sofferenze, le disuguaglianze, la povertà e l’esclusione subite dalla popolazione, in particolare dai giovani e dagli anziani», che reagisce a «tutto il disprezzo e la violenza che abbiamo subito per anni», e all’entrata in vigore delle sanzioni contro gli operatori sanitari non vaccinati. Quest’ultima questione sarebbe stata solo “l’ultima goccia”.
Félix Flémin, segretario generale del Partito Comunista della Guadalupa, ha ricordato che «ci sono state manifestazioni ogni settimana da luglio su questo tema, ma la mobilitazione è molto più ampia», provocata da una situazione sociale disastrosa. Perfino il presidente della regione della Guadalupa (de La République en Marche, il partito del presidente Macron) ha “deplorato” il disprezzo dello Stato centrale.
Su entrambe le isole sono stati imposti blocchi stradali su molte strade e in Guadalupa l’accesso agli ospedali è stato filtrato da picchetti organizzati dall’LPK. In diverse occasioni di notte la mobilitazione è degenerata in violenza urbana, con la partecipazione di molti giovani. La prefettura di Guadalupa ha imposto un coprifuoco sull’isola tra le 18 e le 5 del mattino. I vigili del fuoco in sciopero, tra cui sindacalisti della FO, hanno occupato il 21 novembre una grande rotonda a Pointe‑à‑Pitre presso la principale stazione dei pompieri dell’isola. Si sono affiancati lavoratori sanitari e della scuola. Questa rotonda, bloccata da mezzogiorno a sera, il 17 e il 18 novembre è stata teatro di scontri tra i manifestanti e la polizia; molte auto sono state incendiate.
Il coprifuoco è stato esteso ad entrambe le isole. Circa 100 colpi sono stati sparati contro la polizia e la gendarmeria. Rinforzi tra cui 5 unità della Forza Mobile, del Raid (unità scelte della polizia nazionale) e il Gruppo d’Intervento della Gendarmeria sono stati inviati nelle due isole. Solo questa la risposta dello Stato!
La piattaforma della LPK
Le rivendicazioni della LPK assomigliano a quelle del 2009. In una trentina di punti si richiamano i problemi e le disfunzioni più volte denunciati.
Richieste sociali:
- Risoluzione di tutti i conflitti in corso;
- Rispetto di tutti gli accordi firmati, compreso quello del 2014 sul
reclutamento di vigili del fuoco e ancora non applicato;
- Aumento generale dei salari, dei minimi sociali, dei sussidi di disoccupazione
e delle pensioni di anzianità legato all’aumento dei prezzi;
- Sostituzione di tutti i lavoratori pensionati;
- Stop ai licenziamenti nel settore privato e ai tagli nel settore pubblico;
- Assunzione massiccia di personale permanente in tutti i servizi pubblici,
nelle poste, nelle scuole, nelle università;
- Fine della repressione giudiziaria e padronale contro i militanti, i
lavoratori e le organizzazioni sindacali;
- Abrogazione dei condizionamenti al recepimento dell’indennità di
disoccupazione;
- Mantenimento di tutte le compensazioni per l’aumento del costo della vita;
- Apertura di trattative collettive, in tutte le categorie, sui salari,
l’occupazione, la formazione, l’orario di lavoro, la protezione sociale,
l’occupazione prioritaria per i giovani, i disoccupati e i lavoratori della
Guadalupa, e sul movimento sindacale della Guadalupa;
- Eliminazione di tutti i lavori precari e forti assunzioni nel settore privato.
Riguardo la gestione della crisi per il Covid e la situazione sanitaria locale:
- Abrogazione della legge del 5 agosto 2021, sulla gestione della crisi
sanitaria;
- Abolizione dell’obbligo di vaccinazione;
- Abolizione della tessera sanitaria;
- Mantenimento degli esami gratuiti;
- Protocolli sanitari rigorosi, applicati nei luoghi di lavoro pubblici e
privati;
- Reclutamento di operatori sanitari e personale negli ospedali, nelle cliniche
private, nel settore sociale e medico-sociale;
- Un piano di emergenza per l’assunzione e la formazione dei giovani;
- Risorse materiali per il settore sanitario, sociale;
- Creazione di una assistenza sanitaria di qualità per cure dignitose ed
efficienti;
- Fornitura immediata di ossigeno alle strutture sanitarie.
Richieste specifiche per i vigili del fuoco:
- Assunzione immediata dei 15 vigili del fuoco volontari;
- Assunzione di personale amministrativo e tecnico specializzato;
- Riparazione, manutenzione e rinnovo dei veicoli di emergenza e, soccorso;
- Concorsi per vigili del fuoco professionisti;
- Nuova turnazione: 12 ore di lavoro diurno e 24 ore di riposo, 12 ore di lavoro
notturno e 72 ore di riposo.
Esigenze sociali ed educative:
- Risorse aggiuntive per le scuole e assunzione di personale tecnico e di
sorveglianza per il raddoppio delle classi e il rispetto delle misure sanitarie;
- Edifici scolastici e strutture sportive e culturali rinnovati, in conformità
con le norme antisismiche; derattizzazione;
- Accesso garantito all’acqua potabile, senza pesticidi, senza clordecone, ad un
prezzo unico e basso;
- Sanificazione dei serbatoi dell’acqua in tutti gli edifici pubblici;
- Condanna di coloro che hanno avvelenato con il clordecone a disinquinare i
terreni;
- Un servizio di trasporto pubblico che permetta a tutti di viaggiare in
qualsiasi momento su tutto il territorio.
Il 29 novembre è arrivato a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, Le Cornu, ministro per i TFO. Ma le trattative si sono presto interrotte perché i sindacati si sono rifiutati di condannare le violenze e i “tentativi di assassinio di poliziotti e gendarmi", come Le Cornu aveva posto a loro condizione preliminare. Gli incontri sono continuati quindi solo con i parlamentari locali. In Martinica, dove il ministro si è recato il giorno dopo, i sindacati hanno accettato le sue condizioni.
Ma in entrambe le isole rimane la tensione. Le prefetture hanno annunciato il 30 novembre la revisione dei prezzi del carburante e del gas, una delle richieste del movimento, ma è solo una briciola.
Autonomia o indipendenza?
Come ha detto il portavoce del collettivo LKP e dell’attuale movimento della Guadalupa: «La questione dei contratti collettivi che non vengono applicati, la questione dell’acqua che non arriva al rubinetto o che è avvelenata dal clordecone, la questione dei giovani con il 60% degli under 25 disoccupati: come, oggi, aprire il dibattito sull’autonomia può risolvere questi problemi? Quando sarà il momento, potremo parlare di tutto quello che vogliamo, ma oggi la questione cruciale sono i sospesi dal lavoro – ormai quasi 3.000 su un’isola di 380.000 abitanti – i 250 piccoli laboratori che sono stati chiusi. Questo sta causando un problema di salute pubblica. Questo è ciò che deve essere affrontato».
Il ministro, appena arrivato, ha cercato invece di introdurre la questione dell’autonomia delle isole, benché il movimento sia concentrato prevalentemente su questioni sociali e non abbia mai incluso l’autonomia fra le sue rivendicazioni, anche se, di fatto, ha un certo carattere anticoloniale. Ma gran parte della popolazione è sfavorevole a qualsiasi indipendenza e sospetta delle offerte di autonomia. Quello che sta succedendo ad Haiti, di cui le potenze imperialiste e coloniali sono le principali responsabili, è da tempo ammonimento contro qualsiasi desiderio di indipendenza in queste isole.
La questione dell’autonomia è già stata sollevata ed è stata oggetto di due referendum nel 2003 e nel 2010 in Guadalupa. In entrambe le occasioni è stata respinta dalla popolazione, una gran parte della quale la percepisce non come un passo verso una vera indipendenza ma come una ulteriore riduzione degli investimenti del governo centrale in settori come la sanità, l’istruzione e l’assistenza sociale. Insomma, l’atteggiamento verso l’autonomia, niente affatto condiviso nella società, potrebbe portare a una divisione all’interno del movimento attuale. Questa rivendicazione, e i referendum, hanno un solo obiettivo: rafforzare la legittimità dello Stato francese in questi territori.
Come in Nuova Caledonia, dove il terzo referendum il 12 dicembre ha segnato un alto tasso di astensione, come richiesto dalle organizzazioni pro‑indipendenza.
Il richiamo della questione dell’autonomia delle Antille da parte del governo è una manovra per indebolire il movimento di lotta. L’imperialismo francese non può permettersi di perdere posizioni strategiche importanti, punti di appoggio del suo sistema militare globale, basi militari con 1.000 soldati nelle Antille, e in particolare la base di lancio aerospaziale di Kourou in Guyana. Intorno alle Antille francesi si estende un dominio marittimo di 500.000 km². La zona è uno scalo per il trasporto di petrolio dal Medio Oriente, dall’Africa occidentale e dal Venezuela al Nord America, e per la fornitura di ferro, bauxite e alluminio...
Per spazzar via le vestigia coloniali di questi territori e il duro sfruttamento del proletariato, l’unica via è quella della lotta di classe, dei lavoratori dei territori d’oltremare alleati con gli sfruttati e gli oppressi di Francia e altrove. Per sopravvivere al caos del sistema capitalista, l’umanità non ha altra strada e il Prometeo proletario non altra via d’uscita! Il proletariato internazionale, in un contesto di crisi economica mondiale che mina le basi del modo di produzione capitalista, ritroverà la via rivoluzionaria attraverso lotte sempre più violente, organizzandosi in sindacati di classe che guideranno scioperi e manifestazioni di rivolta in modo centralizzato e nei quali potrà esprimersi la voce del Partito Comunista Internazionale, fedele guida e portatore della coscienza proletaria ed erede di tutte le lezioni delle lotte di classe della storia!
Nonostante il silenzio dei media, che nasconde le rivendicazioni sociali dei manifestanti delle Antille, nonostante la repressione e i tribunali di classe, nonostante l’apatia del proletariato in Francia, impantanato nelle sue contraddizioni e nell’isolamento delle sue lotte locali, salutiamo il coraggio e l’ostinazione del proletariato di quelle isole che faticosamente si sta aprendo la strada verso lo ineluttabile scontro di classe.
Estraiamo dalla prefazione di Lenin a una ristampa del carteggio di Marx ed
Engels con F.A.Sorge e altri.
Engels scrive nella lettera del 23 aprile 1887: «In Germania hanno luogo persecuzioni su persecuzioni [dei socialisti]. Sembra che Bismarck voglia preparare tutto, affinché nel momento in cui in Russia scoppierà la rivoluzione, cosa che, si può dire, è questione di pochi mesi, la Germania possa immediatamente seguirne l’esempio [losgeschlagen werden]».
Quei mesi sono stati davvero molti di più. Non c’è dubbio che si troveranno dei filistei i quali, con la fronte corrugata e il viso accigliato, criticheranno aspramente il “rivoluzionarismo” di Engels, oppure rideranno con aria di condiscendenza delle vecchie utopie dell’anziano rivoluzionario emigrato.
Sí, Marx e Engels sbagliarono molto e spesso i loro pronostici circa l’avvicinarsi della rivoluzione, la speranza nella vittoria della rivoluzione (così, ad esempio, nel 1848 in Germania), sbagliarono nel credere prossima la “repubblica tedesca” («morire per la repubblica», scriveva Engels a proposito di quell’epoca, rammentando il suo stato d’animo di partecipante alla campagna militare per la Costituzione dell’impero nel 1848‑49). Sbagliarono nel 1871, quando si occupavano di «sollevare il mezzogiorno della Francia, per la qual cosa essi [Becker scrive “noi” parlando di sé stesso e dei suoi amici piú intimi: lettera n. 14, del 21 luglio 1871] sacrificarono e arrischiarono tutto quanto è umanamente possibile...». Nella stessa lettera: «Se in marzo e in aprile avessimo disposto di maggiori risorse, avremmo sollevato tutta la Francia meridionale e avremmo salvato la Comune di Parigi [p. 29]. Ma tali errori dei giganti del pensiero rivoluzionario, di coloro i quali elevano e hanno elevato il proletariato di tutto il mondo al di sopra del livello dei compiti minuti, quotidiani, insignificanti, sono mille volte piú nobili, piú imponenti e storicamente piú preziosi e piú veri della banale saggezza del liberalismo ufficiale che canta, grida, implora e proclama la vanità delle vanità rivoluzionarie, l’inanità della lotta rivoluzionaria, la bellezza delle fandonie “costituzionali” controrivoluzionarie...
La classe operaia russa conquisterà la propria libertà e darà impulso all’Europa con le sue azioni rivoluzionarie sia pur piene di errori; e lasciate che i filistei si vantino dell’infallibilità della loro inazione rivoluzionaria.
6 aprile 1907
Nella serie di articoli del 1970 del nostro giornale di allora “Il Programma Comunista“, col titolo “Riprendendo la questione cinese”, si anticipa il compito del partito di approfondire i rapporti fra il giovane partito comunista di Cina e l’Internazionale Comunista e le lotte e gli scioperi della giovanissima classe operaia di quel paese.
Sappiamo dalla scienza e passione della teoria marxista che la rivoluzione, la capacità del proletariato di rovesciare il potere della borghesia e instaurare la propria dittatura rivoluzionaria, è possibile dall’incontro fra le rivoluzionarie masse proletarie e il partito di classe, il partito comunista. Senza questo ricongiungimento, risolutivo, storico, programmatico, quanto fisico organizzativo, non c’è rivoluzione, ma la sua illusione, che porta il movimento alla sconfitta.
Con la costituzione della Terza Internazionale venne ad affermarsi il partito comunista mondiale, soggetto della rivoluzione, tendente all’incontro con le masse proletarie di tutti i paesi. Nelle sue tesi sulla questione nazionale e coloniale affermava che nei paesi a doppia rivoluzione era da applicare la tattica di alleanza con i ceti rivoluzionari della borghesia democratica. La Seconda Internazionale invece, colpevole del tradimento di aver partecipato alla prima carneficina mondiale, era del tutto indifferente e inerte di fronte alla ribellione delle plebi dei paesi coloniali e semi‑coloniali, difendendo le aristocrazie operaie in occidente, che da quello sfruttamento imperialista traevano quei pochi vantaggi che le legavano al giogo del capitale della metropoli.
La Conferenza di Baku, del 1920, confermò questa tattica per l’Oriente. La Conferenza dei Toilers dell’Estremo Oriente, dei partiti comunisti e delle organizzazioni rivoluzionarie, si tenne fra Mosca e Pietrogrado nel gennaio del 1922.
Il risveglio delle masse di Cina, Corea, Giappone imponeva ai partiti della Terza Internazionale di tender loro la mano al fine di lasciar esplodere la lotta finale al capitalismo mondiale. Si stavano formando dei partiti comunisti quei paesi, piccoli partiti suscitati dall’entusiasmo che la rivoluzione sovietica stava ovunque sollevando e dai compiti storici progressivi colà imposti dallo sviluppo del modo di produzione.
Era compito prioritario della Internazionale impostare la corretta tattica, per sostenere tanto la difesa della rivoluzione in Russia, quanto le masse diseredate dei paesi coloniali e semi‑coloniali. Queste si scontravano nelle resistenze precapitalistiche, rappresentate dai Dutziun, dagli eserciti privati dei Signori della Guerra, ma anche in quella di tutti gli imperialismi, Stati Uniti, Germania, Francia, Giappone, ecc. alleati ognuno con un Signore della Guerra. Nemica era anche la borghesia indigena, bloccata nella sua naturale espansione dalle potenze imperiali ma ad esse alleanza.
In questa difficile situazione, di continua guerra civile, il compito del Partito comunista di Cina era conquistare le avanguardie operaie, organizzate dei sindacati, e legarsi al proletariato di tutti i paesi tramite l’Internazionale Comunista.
Afferma Zinoviev nelle conclusioni: «È compito dell’Internazionale Comunista di creare un ponte fra l’avanguardia del proletariato dell’Europa occidentale e dell’America e le centinaia di milioni di lavoratori del lontano e del vicino oriente. Il Comintern ha realizzato questo compito l’anno scorso a Bakù, e lo sta realizzando adesso a Mosca e Pietrogrado». «Per essere vittoriosa la rivoluzione deve comprendere i popoli dell’Estremo Oriente, deve destare i 400 milioni della popolazione cinese, la giovane e vigorosa classe operaia del Giappone. Tutto ciò sta iniziando a prendere forma davanti a noi. L’Internazionale Comunista è stata la prima ad entrare a stretto contatto con il movimento dei lavoratori giapponesi e questo ha preso nuovo alimento dalla Internazionale Comunista, ciò garantisce che l’Internazionale Comunista non è una organizzazione per l’Europa e l’America, ma per il mondo intero, come lo sono i suoi obbiettivi».
Presentiamo qui dal Congresso dei Toilers il Rapporto di Safarov, rappresentante dell’esecutivo della I.C. sulla questione nazionale e coloniale, e tre rapporti sulla situazione economica, politica e sindacale di membri della delegazione cinese al Congresso.
I rapporti pubblicati sono qui in nostre traduzioni dall’edizione originale “The First Congress of the Toilers of the Far East” pubblicato a Pietrogrado nel 1922 e ripubblicato nel 1970 da The Hammersmith Bookshop Limited per la collana “Documenti rari”.
Gennaio 1922
Primo congresso dei comunisti e delle organizzazioni rivoluzionarie dell’Estremo Oriente
Terza Sessione
23 gennaio, 1922, ore 18:20
Rapporto di Li‑Kieng della delegazione cinese
Presidente: Compagno Safarov.
PRESIDENTE. Compagni, dichiaro aperta la terza sessione del Congresso dei lavoratori dell’Estremo Oriente. Per la decisione di questa mattina riceviamo adesso i rapporti dai diversi paesi in ordine di rotazione, chiamo ora il compagno Li‑Kieng della delegazione cinese.
LI‑KIENG. Cari compagni, Vi voglio parlare delle sofferenze dei molti milioni della nostra gente, è anche mio piacere spiegarvi lo sviluppo del nostro movimento rivoluzionario.
La più importante ed essenziale questione a questo proposito è la questione della posizione politica della Cina. Sapete che la Cina nella sua composizione è il paese più popoloso ed il più eterogeneo. Ha una popolazione di circa 350 milioni, ma prima di qualche centinaio di anni fa era sconosciuto agli europei e agli stranieri in generale. Il rapporto con gli europei era estremamente debole. Tuttavia era convinzione degli stranieri che la Cina fosse il più abbondante e ricco paese. Infatti, la Cina ha goduto di una relativa prosperità.
Il primo conflitto con gli europei avvenne nel 1839, maggiormente con gli inglesi, sulla questione del traffico di oppio. Come risultato di questo conflitto gli inglesi sconfissero i cinesi, dopo di che gli stranieri iniziarono ad invadere la Cina in forze. Quel periodo può essere considerato come l’inizio dell’oppressione economica della Cina, che ha continuato a crescere per gradi fino all’inizio del XX secolo. Il XX secolo, dal 1904 circa, trova la Cina già nella condizione di paese assoggettato. Dall’inizio della guerra russo-giapponese, gli stranieri iniziano a mostrare appieno i loro piani di spartizione della Cina. Nel 1914, mentre l’attenzione delle potenze europee era volta alla guerra in occidente, l’imperialismo giapponese beneficiò di una veramente favorevole opportunità di mettere il cappio al collo della Cina, e nel 1916 presentò alla Cina il famoso ultimatum consistente in 21 punti. Questo ultimatum portava la Cina al completo assoggettamento economico e politico; ma anche prima di ciò, come detto, la Cina era già un paese dipendente.
Tassazione pesante, ferrovie, dazi doganali – tutto ciò, come risultato della influenza europea, creata in una atmosfera di totale sudditanza e completa dipendenza. Tutti i maggiori paesi imperialisti condussero in Cina la più accanita lotta economica fra di loro, cercando di utilizzare le sue ricchezze naturali, e per raggiungere questo obbiettivo, fecero ricorso ad ogni possibile mezzo, particolarmente di natura politica. Sapete che i giapponesi, come gli inglesi e gli americani, da prima provarono ad utilizzare gruppi politici e di conseguenza formarono dei governi. Sappiamo che gli inglesi sostennero definitivamente il generale U‑Bei‑Fu. Sappiamo che i giapponesi hanno sostenuto il partito Anfu. Tutto questo ha gradualmente portato alla scomparsa di qualsiasi governo che avrebbe potuto difendere il paese.
Insieme allo sviluppo della competizione economica, gli europei investirono in Cina ingenti somme dei loro capitali, le imprese europee in Cina iniziarono a crescere, e insieme a questa crescita ci fu un salto in avanti della classe operaia cinese. Adesso noi possiamo già parlare di due milioni di operai cinesi, la cui posizione è la meno invidiabile. La giornata lavorativa è di 12 ore, spesso di più; sappiamo che questo implica il bestiale sfruttamento di donne e giovani lavoratori.
Gli operai cinesi sono divisi in grandi categorie; ci sono categorie operaie dell’industria, conosciute come operai qualificati, e ci sono categorie operaie non qualificate le cui condizioni sono assai peggiori. Una speciale categoria di lavoratori, che non ha eguali ovunque nel mondo, sono i cosiddetti coolies. Lavorano duramente dalla mattina presto fino a tarda notte, o anche dall’alba all’alba, senza avere assicurato un minimo di sussistenza. Sono i lavoratori più diseredati del mondo. C’è anche un altro gruppo di lavoratori artigiani che, congiuntamente con lo sviluppo delle macchine e dell’industria meccanica, stanno perdendo la loro indipendenza sprofondando al livello dei coolies.
C’è poi un altro gruppo della popolazione, la cui esperienza angosciante è di natura similare ai coolies. Sono i contadini. I contadini in Cina rappresentano il 70% dell’intera popolazione e da tempo immemorabile hanno sviluppato un alto grado di agricoltura. Nei tempi passati possedevano terre a sufficienza, e potevano vivere con relativa facilità. Ma da quando gli stranieri hanno iniziato a invadere il paese la Cina è venuta a dipendere economicamente dagli europei; l’industria ha iniziato a svilupparsi, la condizione dei contadini ha subito un cambiamento verso il peggio, e dopo il 1911 troviamo il contadiname in condizioni disperate. Questo fu l’anno della prima rivoluzione cinese, quando i contadini, rovinati dalle privazioni imposte dalla dominazione straniera, che trovò la sua massima espressione nelle pesanti tassazioni dirette e indirette e nel restringimento delle aree coltivabili, furono costretti a cercare un lavoro più leggero, creando così un sottoproletariato, o richiedendo un miglioramento della loro condizione.
Ma nessun miglioramento avvenne. Le aziende contadine gradualmente si ridimensionarono. Nel 1920 sostennero un duro colpo per una calamità naturale – la siccità – e si può dire che non rimase nessuna traccia della passata prosperità del contadiname. I contadini rimasti stanno soffrendo enormi stenti a causa della guerra civile che dilania la Cina. La guerra nella provincia dei Laghi dell’Hunan e dell’Hubei ha messo a repentaglio l’esistenza delle coltivazioni in quelle regioni, mentre la carestia del 1920 ha avuto lo stesso effetto sulle coltivazioni in molte province del Nord. Conflitti con gli europei, tassazioni per milioni che gravano sulle proprietà contadine, tutto questo ha accelerato la finale rovina economica della classe contadina.
Il mercato cinese è adesso totalmente preda degli stranieri. Nel passato i contadini potevano portare il proprio prodotto e la merce fatta in casa nelle città e scambiarli con articoli di cui necessitavano; adesso non possono fare così, perché tutto è stato fatto proprio dagli stranieri e i cittadini possono acquistare le merci manufatte più comodamente e al prezzo più basso. Così il contadino, come unità economica, diviene incapace del proprio sostentamento, e nell’ultimo decennio osserviamo la conquista graduale del mercato da parte degli stranieri e il declino dell’economia contadina.
Questo è stato accompagnato da continui rialzi dei prezzi, e da un sempre crescente costo della vita. Durante gli ultimi 15 anni c’è stato un aumento del 100% e anche del 150% sui prezzi dei generi alimentari. Diventa così estremamente difficile per molti cinesi arrivare al minimo della sussistenza, che trova la sua espressione nelle tremende privazioni della popolazione più povera.
Sfiorerò adesso un’altra questione che è importante in Cina in questo periodo. È la questione religiosa. Sappiamo che i capitalisti stranieri hanno iniziato la loro propaganda religiosa nello Shantung e gradualmente hanno diffuso su tutta la Cina una rete di loro comunità religiose di varie tendenze ma di carattere simile. La loro religione non persegue affatto la funzione con la quale si maschera. Per il cinese convertito basta andare in chiesa la domenica per farsi perdonare ogni reato commesso nella settimana. Così la religione in Cina appare come qualcosa che protegge i furti, o addirittura li favorisce.
Inoltre mi domando se il Giappone ha mandato i suoi agenti a comprare le terre dei contadini rovinati per imporre così una stabile presenza sul continente. Con facilità i contadini, sotto il pungolo delle ristrettezze economiche, vendono di buon grado le loro terre.
Una volta i contadini pagavano le tasse che ammontavano a solo l’uno per cento delle loro entrate, adesso queste tasse sono aumentate a un terzo del ricavato dei contadini. È un insopportabile fardello di tassazione, insieme alle altre privazioni descritte, che spinge i contadini ad arruolarsi negli eserciti, alla ricerca di un guadagno facile. È così che soldataglia e bande di rapinatori crescono. I banditi sono uno dei più grandi mali in Cina, e non è possibile sbarazzarsi di loro, in quanto i loro ranghi vengono continuamente alimentati da nuove reclute contadine.
L’unica via per sbarazzarsi di questo male è elevare il livello di vita dei contadini. Toccherò brevemente la questione dell’educazione, delle case dei bambini, che un tempo esistevano in Cina. Grazie alle cause economiche e politiche, cioè all’assenza di organi che possano organizzare e sostenere queste istituzioni, queste hanno una difficile esistenza. La questione dell’educazione è un’altra molto importante che rimane insoluta in Cina.
La situazione economica in Cina peggiora, e la condizione della Cina insopportabile. Questa difficile situazione non ha colpito soltanto quei gruppi di popolazione che ho enumerato, ma anche i piccoli e medi padroni che non possono lottare contro i capitalisti stranieri, e non riescono neppure a mantenere il loro mercato domestico.
L’indebitamento cinese con i capitalisti stranieri ha raggiunto l’enorme cifra di svariati miliardi di dollari, e questo indebitamento è il fattore principale nello sviluppo del capitalismo straniero in Cina. Più cresce l’indebitamento, più c’è la stretta del dominio capitalista sulla Cina e più diventa reale la questione della rivoluzione contro il giogo straniero.
Sappiamo che il primo movimento importante contro gli stranieri si è avuto nel 1911. La rivoluzione in Cina è stata combattuta sulla base della lotta contro la penetrazione straniera. Nel 1915 i 21 punti del ben noto trattato con il Giappone fu causa di una potente ondata di moti contro i giapponesi, moti che sconvolsero l’intero paese. Ricordiamo bene il grande movimento studentesco in Cina del 1919 che fu della stessa natura. Questo movimento si è continuamente rafforzato.
Inoltre il proletariato oggi esistente si sta risvegliando. Sappiamo che nel 1919 c’era già una rivolta contro gli stranieri. Sappiamo che c’è stato a Shanghai uno sciopero l’anno scorso, charamente diretto contro gli inglesi. Lo sciopero delle Ferrovie Pechino-Hankow fu similare.
L’atteggiamento contro gli stranieri si è fatto più chiaro per nuove vicende, la Conferenza di Washington, le cui segrete intenzioni stanno diventando evidenti.
Questo ci dà l’opportunità di discutere della nostra difesa dall’imperialismo mondiale. Abbiamo l’opportunità di discutere i problemi del movimento rivoluzionario. Sappiamo che, nella misura in cui la vita in Cina diventa sempre più insopportabile, il movimento rivoluzionario si rafforzerà. Dobbiamo seguire l’esempio della rivoluzione russa, dobbiamo cercare il modo di scuotere il giogo straniero dello sfruttamento in Cina, per emancipare i più poveri della popolazione cinese.
In primo luogo è necessario realizzare l’unificazione del proletariato più povero. A questo Congresso l’unificazione deve essere il nostro maggiore interesse. Sappiamo che nessuna forza potrà essere abbastanza forte da resisterci se siamo uniti.
La Terza Internazionale è l’organo della rivoluzione mondiale. Uniamoci sotto la sua bandiera! Sfianchiamo gli imperialisti. È solo così che realizzeremo i nostri scopi.
Dico: Viva il Congresso dei partiti rivoluzionari dell’Estremo Oriente, Viva la Terza Internazionale Comunista, Viva il proletariato mondiale.
[Applausi].
Terza Sessione
23 gennaio, ultimo intervento
Rapporto di Wong‑Kien‑Ti
PRESIDENTE: Il Compagno Wong‑Kien‑Ti farà adesso il suo rapporto – un’ora.
WONG‑KIEN‑TI ha parlato della situazione degli operai cinesi. Per prima cosa ha trattato degli operai dell’industria. Solo ottanta anni fa per la prima volta l’imperialismo mondiale è arrivato in Cina, e i lavoratori cinesi sono diventati dei potenziali schiavi. Da quel tempo l’industria cinese è cresciuta giorno dopo giorno. Si è grandemente sviluppata ed espansa. È cresciuta fino a due milioni di operai.
Questi due milioni di nuovi schiavi del capitale sono nuovi veri schiavi. Le loro condizioni sono pessime e molto dure. Le masse lavoratrici cinesi sono numerose, ma non c’è una singola legge che protegga gli operai cinesi, quindi i capitalisti stranieri e il capitale straniero, possono sfruttarli e sottometterli senza limiti. Se alcuni lavoratori muoiono di super lavoro o per fame il capitale non ci perde niente. Ed per questo il lavoratore cinese deve lavorare duramente più di dodici ore al giorno, si, anche di più, penso che la maggioranza lavora dodici ore. Alcuni lavorano nove o dieci o undici ore, ma sono appena duecentomila. Gli altri lavorano più di dodici ore al giorno.
Il loro salario è abbastanza basso, mediamente circa trenta centesimi d’argento al giorno. Il costo della vita è di almeno sette dollari al mese, se l’operaio vive per sé stesso e da solo, forse può riuscire ad esistere, ma quando c’è una famiglia deve e devono soffrire la fame. In più non c’è una legislazione del lavoro. Non ci sono ospedali per gli operai, specialmente gli operai delle fabbriche che sono occupati in quelle fabbriche che hanno bisogno di questi istituti di assistenza. La maggioranza delle fabbriche sono misere, manca l’aria e la luce, ma nessuno ci bada. I capireparto reprimono i lavoratori, e per questo il capitale straniero aumenta in Cina, vogliono asservire i lavoratori cinesi anche più crudelmente del capitale locale ed assumono speciali caposquadra a questo fine. Gli operai sono più soggiogati dei soldati. Sono oppressi dai caposquadra, e adesso i capitalisti stranieri usano degli appaltatori. Questi caposquadra e gli appaltatori rendono la vita dei lavoratori molto dura e così aggiungono maggiore sofferenza.
Solo il 5 per cento degli operai legge un po’, il resto è illetterato ed ignorante. Ci sono anche dieci milioni di donne e bambini che lavorano in diverse fabbriche, le donne operaie sono occupate come gli uomini in diverse fabbriche. Le condizioni di lavoro a cui sono sottoposte sono peggiori di quelle degli uomini. Anche i bambini hanno condizioni dure infatti lavorano anche in industrie pericolose. Lavorano anche dodici ore al giorno e spesso lavorano la notte come gli uomini. Non ci sono leggi dello Stato o delle aziende che li proteggano.
A proposito dei lavoratori artigiani, prima dell’arrivo del capitalismo straniero, essi vivevano, sebbene con difficoltà, ma potevano sopravvivere come lavoratori indipendenti, potevano lavorare liberamente. Ma dopo l’arrivo del capitale straniero in Cina, ovviamente, gli artigiani furono colpiti non potendo competere con i capitalisti stranieri. Così le loro condizioni andarono peggiorando di giorno in giorno. Giorno dopo giorno la vita e il lavoro diventavano più dure. Un grande numero di artigiani delle grandi città e dei paesi sono adesso disoccupati. Sono tutti diventati veri schiavi dei capitalisti stranieri o degli interessi di questi capitalisti, e non esiste una legge del lavoro che li protegga. Anche loro lavorano dodici ore al giorno o almeno dieci ore al giorno. Lavorano dall’alba al tramonto, ed il loro salario è di circa venticinque centesimi al giorno.
Arriviamo adesso alla questione dei coolies [operai non specializzati]. Come aumenta ogni giorno il costo della vita, così anche il numero dei coolies aumenta quotidianamente. In ogni grande città si può trovare un gran numero di coolies in cerca di lavoro. Il loro salario è incerto. Alcune volte trovano lavoro, possono per alcuni giorni rimanere senza e allora patiscono la fame. Come si sviluppano in Cina nuove industrie, varie fabbriche attraggono un grande numero di coolies, così come gli operai aumentano andando ad incrementare l’esercito degli schiavi, anche l’esercito dei coolies aumenta quotidianamente. Anche le peggiori fabbriche attraggono un gran numero di coolies.
Gli operai organizzano corporazioni. Ci sono corporazioni separate per ogni tipologia di lavoratori. Queste corporazioni non sono organizzazioni per combattere il capitale. Esse sono organizzati per limitare l’aumento degli operai in quel particolare mestiere. La corporazione è l’organo interessato alla lotta all’interno del mestiere, per quelli che già ne fanno parte. Questo significa che non è un organo di combattimento. Ma adesso alcune corporazioni si sono riorganizzate come sindacati e quelle rimaste come corporazioni non sono molte. Inoltre non hanno grande influenza sul movimento dei lavoratori. Ma è il semi‑proletariato che crede ancora nelle corporazioni che rimangono i loro organi. Comunque quelle rimaste non occupano importanti posizioni. Queste corporazioni, però, potrebbero essere usate correttamente per organizzare gli artigiani.
In questi pochi anni – praticamente dal 1919 – diversi sindacati si sono costituiti. Questo, e forse lo possiamo dire, da una parte sono influenzati dalla rivoluzione russa e anche dal movimento degli studenti e dal movimento degli intellettuali in Cina. Prima del 1919 c’erano alcuni segnali di un movimento in Cina ma non a larga scala. Quello che ho appena menzionato ha stimolato gli operai ad aderire al movimento dei lavoratori. Costituito questo movimento la loro attività ha avuto inizio. Adesso gli operai hanno una discreta fiducia nella loro propria forza organizzata. Dal 1919, in diversi posti, i sindacati hanno iniziato ad essere organizzati, per esempio a Tang‑Shan dove fu organizzata l’Unione dei Lavoratori delle Ferrovie. All’inizio era una sorta di unione patriottica ma adesso è un unione di combattimento. Anche nell’Hunan adesso c’è un sindacato. Il sindacato a Tang‑Shan ha 2.500 aderenti. Nell’Hunan sono circa 5.000. Il Sindacato dei lavoratori meccanici a Canton era il più grande della Cina. L’Unione degli operai metalmeccanici fu organizzata durante l’ultimo anno. Questi sono i più grandi sindacati in Cina. Possiamo dire che questi sindacati sono dei veri e propri organi di combattimento degli operai. Il successo di questi sindacati, come ho già detto, è stato influenzato dal movimento degli studenti e dalla rivoluzione russa. Ovviamente è stato anche influenzato dall’attività dei comunisti.
Veniamo adesso all’attività degli operai cinesi – al movimento degli operai cinesi. Durante questi ultimi anni ci sono stati larghi, numerosi e importanti scioperi. Nel 1920 i lavoratori metalmeccanici scioperano a Canton. Fu un grande sciopero – circa 14.000 operai vi presero parte. Nel maggio 1921 ci fu un altro sciopero di circa 20.000 operai, che migliorò la condizione operaia. Fu aumentato il salario e ridotto l’orario di lavoro. A Fula, nel 1921, gli operai dell’industria tessile scioperarono per prendere il controllo delle fabbriche. Questo sciopero non riportò una vittoria, ma fu comunque molto importante. C’erano 5.000 operai attivi. A Shanghai ci sono stati recentemente lo sciopero degli operai del tabacco e delle ferrovie. Questi sono gli scioperi più importanti che noi conosciamo negli ultimi anni. Questo mostra che gli operai cinesi stanno iniziando a risvegliarsi. Dopo che queste forze saranno organizzate e concentrate al fine di combattere con gli imperialisti, avranno successo.
La Cina adesso ha una posizione molto importante. Il mondo imperialista considera la Cina e l’Estremo Oriente come il luogo più importante e si sono concentrati nello sfruttamento e nel rendere schiave le masse lavoratrici cinesi ad una scala più elevata e con maggiore intensità di sempre. Le masse diseredate cinesi ammontano a 300 milioni. Queste masse, con le loro ricche materie prime hanno grande importanza per l’imperialismo, così come sono molto importanti per le nostre finalità rivoluzionarie. Dal nostro punto di vista, inoltre, è adesso il nostro obbiettivo di organizzarle visto che iniziano a risvegliarsi, per combattere l’imperialismo.
Questo Congresso si svolge per la finalità di organizzare le masse diseredate dell’Estremo Oriente.
Speriamo che questo Congresso porterà le masse sfruttate dell’Estremo Oriente insieme sotto i vessilli della Terza Internazionale, per combattere contro il nemico comune – l’imperialismo mondiale.
Viva l’unione delle masse sfruttate dell’Estremo Oriente con il proletariato mondiale! Viva la Russia Sovietica! Viva l’Internazionale del Sindacato Rosso! Viva la Terza Internazionale Comunista!
(Fine della sessione)
Quarta Sessione
24 gennaio, ore 11:30
Continuazione del rapporto della delegazione cinese
Ping‑Tong rappresentante della società “Giovane Cina”
Presidente: compagno Safarov.
SAFAROV: dichiaro la sessione aperta. Primo punto del programma è la continuazione del rapporto della delegazione cinese. Il compagno Ping‑Tong rappresentante della società “Giovane Cina” ha la parola.
PING‑TONG: Vi relazionerò sulla situazione economica in Cina che, come sapete, è oppressa dall’imperialismo di tutto il mondo. Sapete che gli operai cinesi e i contadini non sono sfruttati solo dall’imperialismo straniero ma sopportano il giogo dei loro capitalisti e anche della burocrazia militare. La situazione delle masse cinesi è di conseguenza estremamente difficile, così che il compito principale dei rivoluzionari cinesi è di realizzare l’emancipazione economica del popolo cinese, quando questa questione sarà risolta in modo soddisfacente, sarà facile risolvere tutte le altre questioni. Se il popolo cinese si renderà libero adesso dalla propria dipendenza dal capitale finanziario straniero, tutte le altre questioni relative alla sua esistenza potrebbero apparire minime e poco importanti. Inizierò il mio rapporto soffermandomi sulla questione economica, e prima di tutto, sul suo sviluppo storico.
L’anno 1839 vede la nascita del primo conflitto militare fra Cina e Inghilterra. Questo conflitto è stato causato dal contrabbando di oppio che fu portato dai predoni inglesi. La Cina ha subìto una sconfitta, dopo di che la diplomazia cinese non ha avuto alcun successo nelle relazioni con gli Stati stranieri, che venivano in Cina con appetiti sempre maggiori. Questo conflitto ha mostrato agli stranieri che la Cina era un paese pacifico, che poteva essere offeso impunemente, e perciò potevano iniziare le loro aggressioni.
Molto è accaduto da allora. Toccherò solo gli eventi più importanti. Nel 1895 scoppiò la guerra fra Cina e Giappone, nel 1900 ebbe luogo la Rivolta dei Boxer. Questi due eventi furono sfruttati dagli europei, uniti nella cosiddetta “Unione delle Otto Potenze“, per mandare le loro truppe a Pechino. Dopo la rivolta dei Boxer escogitarono vari piani per la divisione della Cina. Gli stranieri ottennero varie concessioni sul territorio cinese: la concessione inglese a Wei‑Hai‑Wei, alla Russia nella penisola di Lou‑Dun, alla Germania nello Shantung, etc.
In questa parte della Cina gli appetiti americani non si erano ancora fatti valere, in quel momento questo paese ne stava fuori, ma il cappio economico si stava stringendo intorno alla Cina.
La guerra fra la Cina e il Giappone fu il più grande stimolo per lo sviluppo delle sfere di influenza in Cina. Queste sfere di influenza sono come una corda che strangola la Cina.
Gli americani, quando la situazione in Cina divenne insopportabile, chiaramente invidiosi dei successi dei concorrenti, iniziarono ad applicare la loro politica in modo apparentemente favorevole agli interessi cinesi, la cosiddetta politica della “porta aperta”. Questa politica era in realtà intesa per trarre i maggiori profitti per gli americani, i quali, messi in una migliore posizione economica, avrebbero potuto battere i loro concorrenti in Cina.
I fatti del 1914, che hanno gettato tutta l’Europa nel tormento della Grande Guerra, hanno temporaneamente oscurato la questione dell’Estremo Oriente, hanno distolto l’attenzione dell’Europa e hanno dato al Giappone mano libera in Cina. Durante la guerra il Giappone ha alzato le sue richieste sulla Cina, esteso la sua influenza e minacciato di schiavizzare e conquistare la Cina intera. Per neutralizzare questo tentativo fu riunito un consorzio di Stati stranieri per domare i predoni giapponesi, destinati a mettere la Cina sotto il loro controllo economico e politico.
Con la crescita del capitale straniero in Cina inizia lo sviluppo di una giovane classe operaia che si sta risvegliando e inizia a prendere coscienza dei propri interessi. Questa classe operaia cinese sarà presto pronta ad abbracciare la lotta aperta contro l’oppressione straniera, contro l’intervento straniero. Questo è il contesto storico dell’attuale situazione economica in Cina che vado a descrivere.
Voglio iniziare con le grandi industrie. Alcune fabbriche e industrie appartengono a stranieri, altre apparentemente a cinesi, in realtà anche queste appartengono a stranieri. Dei cementifici, per esempio, in tutto 51, 30 appartengono a stranieri, gli altri apparentemente a cinesi. Nella industria chimica e nelle tintorie 11 su 20 appartengono a stranieri. Delle 33 di frutta essiccata e uova in polvere, 16 sono di proprietà straniera. Ci sono 13 cantieri navali che sono quasi tutti di proprietà straniera. Mulini, fabbriche tessili, tabacco e altre industrie, sono sia nominalmente che effettivamente di proprietà di stranieri. In questo modo tutte le grandi fabbriche, tutta l’industria cinese è strettamente connessa con il capitale straniero e non ha una esistenza indipendente. Per quanto riguarda l’industria mineraria del carbone su un totale di 19 milioni di tonnellate portate alla superficie, 9.380.000 appartengono direttamente a compagnie straniere. Osserviamo la stessa cosa nell’industria del ferro. Da una produzione di 400.000 tonnellate di ferro la parte rappresentata dagli stranieri è di 150.000. Tutte queste cifre dimostrano chiaramente la condizione dell’industria cinese, che è totalmente dipendente dal capitale straniero. Su circa 7.000 miglia di ferrovia cinese, 2.600 sono state costruite direttamente dagli europei, il rimanente con prestiti stranieri, cioè con capitale straniero. A proposito dei servizi postale e telefonico possiamo dire che sono direttamente sovvenzionati e gestiti da stranieri.
Per quanto riguarda la questione della condizione finanziaria e politica della Cina, si può dire che la Cina è stranamente sovvenzionata da un pesante debito. Le entrate sono ottenute dalla tassazione diretta che assomma a 3‑4 miliardi di tael, che si stanno gradualmente riducendo, e nel 1911, l’anno della rivoluzione cinese, si ebbe una rapida riduzione delle entrate statali, che ha reso irrisolvibile qualsiasi soluzione di politica finanziaria. Per alleggerire la situazione finanziaria il governo cinese, durante il breve periodo dal 1912 al 1918, contrasse 23 prestiti stranieri. Ma tutti questi prestiti non hanno portato alcun miglioramento. Al contrario, hanno portato ad ipotecare i dazi doganali e molti altri redditi internazionali (come i dazi su sale, tabacco etc.) ai capitalisti creditori stranieri che stanno assumendo il controllo diretto sulle rendite. Ciò comporta per la Cina una disperata schiavitù finanziaria.
Il commercio con gli stranieri è espresso dalle seguenti cifre: dal 1910 al 1912 un export pari a 4.600.000 che è stato superato da un import da 80 a 200 milioni. Questa è una differenza colossale fra una insignificante esportazione e una gigantesca importazione. Questo bilancio dissestato del commercio ha causato ingenti perdite per la popolazione, in particolare per i commercianti che furono portati frequentemente alla totale rovina. Inoltre, questo ha dato ai capitalisti stranieri la possibilità di controllare i costi finanziari e di conseguenza il commercio governativo. L’export cinese consisteva esclusivamente di quelle materie prime necessarie alle fabbriche e alle officine straniere. L’operazione per cui i capitalisti stranieri convertivano le materie prime cinesi in merci manufatte, rivendendole ai cinesi, fu altamente remunerativo per gli stranieri.
Si deve aggiungere che i commercianti cinesi, per timore di lunghi viaggi, preferivano stare a casa e commerciare all’interno del paese. Questo causò loro perdite colossali, e queste perdite non sono state sostenute solo dai commercianti ma anche dalla massa della popolazione, perché le perdite sopportate dal commercio si scaricavano direttamente sull’intero paese.
Vorrei inoltre dire poche parole sui contadini. I contadini in Cina non hanno la stessa diretta esperienza di oppressione come il resto della popolazione, ma indirettamente si. Va detto che da tempo immemorabile i contadini cinesi lavoravano sempre con l’impiego dei figli. Durante l’inverno avrebbero lavorato al mestiere che dava loro ulteriori mezzi di sussistenza. In questo modo si sono sviluppate tutta una serie di industrie casalinghe che fiorirono ampiamente. Da sottolineare in modo particolare l’industria della tessitura che impiega molte donne contadine. Con l’inizio della nuova era, da quando la Cina è caduta sotto la dominazione economica straniera, che importa i loro manufatti in Cina, la domanda delle merci artigianali, che sono di bassa qualità e richiedono più lavoro, è in continua caduta. Tutti gli artigiani così come i contadini stanno iniziando a rinunciare a queste occupazioni supplementari, perché non ne vale la pena. Questo porta alla rovina molti contadini che iniziano a dipendere da una sola fonte di reddito, la terra, della quale ne hanno veramente poca.
I prodotti che quando il paese dipendeva dalla loro produzione erano a basso prezzo, adesso che l’industria straniera fornisci gli articoli di prima necessità, i prezzi si rialzano. A causa di ciò la condizione dei contadini sta diventando sempre peggiore.
Questo è aggravato dagli eventi politici come le insurrezioni all’interno del paese, e anche dalla siccità che ha colpito cinque province del Nord due anni fa. La siccità ha minacciato la vita di molti milioni di contadini cinesi. Per alleviare la situazione il governo ha deciso di mettere l’embargo all’esportazione dei cereali. In quel periodo le relazioni fra Giappone e America erano particolarmente tese. Considerando la necessità di preparare la guerra il Giappone voleva comprare i cereali proprio dove vigeva l’embargo, in Manciuria. La Cina era così debole allora che non resistette alla domanda giapponese. Così gran parte dei cereali cinesi furono portati fuori dal paese. Gli imperialisti, interessati esclusivamente al mantenimento del loro potere, ovviamente, non si preoccuparono del fatto che molti milioni morissero di fame. Erano molto poco turbati da questo fatto anche al pensiero che le sofferenze del popolo erano enormi.
Questa, nel complesso, è la situazione economica attuale in Cina, rappresentando il quadro di crudele oppressione e impareggiabile sfruttamento degli imperialisti stranieri. L’attuale Congresso dovrebbe darci i mezzi per liberarci da questo giogo. Tutti noi qui siamo uniti dal fatto che rappresentiamo paesi nei quali l’imperialismo imperversa. Compagni, spero che tutti voi, qui riuniti, esaminerete la questione per trovare i mezzi efficaci per liberarci dall’oppressione imperialista.
[Applausi].
Il compagno Ping‑Tong è chiamato a parlare della storia del Consorzio e della sua influenza.
PING‑TONG: Il Consorzio fu organizzato nel 1917 per iniziativa dell’America, ma finora non è stato ancora messo in pratica. C’è stata una Conferenza a Parigi nel 1919 sulla questione di rendere il Consorzio più efficace, ma non ha dato alcun risultato tangibile. Ha più una vita nominale che reale. Le cause del fallimento di questo Consorzio si possono trovare negli interessi divergenti dei diversi gruppi imperialisti, in particolare quelli di America e Giappone. La Conferenza di Washington è stata indetta in parte allo scopo di dare un po’ di vita al Consorzio e farlo funzionare.
Ottava Sessione
26 gennaio 1922 (mattina)
Rapporto di Safarov sulla posizione dei comunisti nella questione nazionale e coloniale e sulla collaborazione dei comunisti con i partiti
nazional-rivoluzionari
Presidente: compagno Din‑Dib
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la sessione, e chiamo il compagno Safarov a leggere il suo rapporto su “la questione nazionale e coloniale ed il conseguente atteggiamento comunista”.
SAFAROV. Compagni, il sistema capitalistico mondiale non è mai stato in uno stato così precario come adesso. La guerra imperialista del 1914‑18 ha portato la vittoria a quelle nazioni che hanno partecipato in minima parte avendo una parte fittizia in essa.
Mentre questa guerra ha rovinato la gran parte d’Europa e ha scosso il sistema capitalistico europeo nelle proprie fondamenta, in America e Giappone si è creato da prima, sulla base di pesanti ordini di guerra per l’Europa, una dimostrazione di prosperità industriale. Dopo un esame delle statistiche commerciali di America e Giappone, possiamo vedere che durante il periodo di guerra la prosperità ha fatto grandi progressi in questi paesi, pareva che questi paesi fossero in grado di godere dei frutti della vittoria, che sarebbero davvero usciti vittoriosi dalla guerra imperialista. La crisi cominciò nel marzo 1920, iniziò nell’intera industria capitalistica in Giappone. Ci fu un rapido crollo della borsa con numerose bancarotte di importanti istituti bancari. Le crisi, che partirono inizialmente nell’industria filiera della seta in Giappone, si allargò agli Stati Uniti. L’America, il paese del fiorente capitalismo, il paese dalle immense risorse di materie prime, e grandi riserve di forze produttive accumulate nel passato, per la prima volta si ritrovò con un enorme esercito di sei milioni di disoccupati. Gli ultimi resoconti indicano nessun miglioramento nella situazione economica degli Stati Uniti.
La guerra imperialista ha indebolito l’economia capitalista europea e di conseguenza ha messo l’imperialismo americano e giapponese a un livello ancora più basso. L’economia capitalista mondiale ha perso il suo equilibrio. Da una parte un’enorme produzione, dall’altra, grazie alla rovina europea, non ci sono abbastanza mercati per piazzare la merce americana. Così le basi del sistema capitalista si sono ristrette.
Il Secondo Congresso del Comintern ha approvato una speciale risoluzione sulla questione nazionale e coloniale. Questa risoluzione ha definito molto chiaramente che la politica imperialista in Europa e in America porta inevitabilmente alla rovina non solo larghi strati della classe operaia ma anche una considerevole parte della classe rurale e della piccola borghesia urbana, mentre il capitalismo deve mantenere una politica coloniale predatoria per cercare di conquistare nuovi continenti e combattere per la cattura di nuove colonie. In quanto la guerra imperialista e la crisi post‑guerra del capitalismo ha ristretto le basi della produzione capitalista, è assolutamente inevitabile che la questione coloniale divenga adesso il più importante fattore della politica mondiale dell’imperialismo.
In quanto l’estremo oriente è stato finora un po’ al di fuori della competizione imperialistica, della lotta generale fra le singole grandi potenze, è naturale che adesso tutti gli sguardi si volgono verso l’estremo oriente, con la speranza di utilizzare le sue enormi riserve di materie prime e lavoro a basso costo con l’obbiettivo di ristabilire la loro influenza imperialista tanto nel campo politico come in quello economico. Mai il capitalismo ha passato una crisi così acuta, mai i capitalisti sono stati così intrisi di voglia di saccheggio.
La risoluzione del Secondo Congresso del Comintern ha dichiarato in forme dirette e chiare, che la parola d’ordine della borghesia democratica a proposito della uguaglianza formale di tutte le nazioni, l’idea che i popoli di tutti i paesi sono tutti uguali, sia dei paesi che sono entrati sulla via dello sviluppo capitalistico come dei paesi arretrati, sia liberi o paesi coloniali assoggettati, è un’illusione. Questa illusione è stata svelata dalla risoluzione del Comintern che ha spiegato che è una politica che nasconde se stessa dietro una fraseologia pseudo democratica.
Durante i rapporti dei vari paesi e la discussione sul rapporto del compagno Zinoviev, i compagni hanno rappresentato in modo devvero dettagliato il significato della parola d’ordine borghese democratica dell’uguaglianza di tutte le nazioni. I compagni hanno fornito un chiaro quadro di cosa rappresenta veramente la parola d’ordine della uguaglianza delle nazioni in una società borghese. Sotto il dominio della borghesia, sotto la dominazione del capitalismo non ci può essere uguaglianza fra le nazioni, perché il capitale dei più potenti paesi borghesi cerca sempre di sottomettere le nazioni oppresse, perché il capitale dei poteri forti cerca di sfruttare le nazioni arretrate per il lavoro a basso costo, per sfruttare le ricchezze naturali di questi paesi.
E quello che è più importante, che deve essere presentato ed evidenziato anche nelle decisioni di questo congresso è la comprensione del fatto che la strada della conciliazione con la borghesia mondiale, la strada della conciliazione con i grandi poteri imperialisti, non offre alcuna salvezza per i paesi coloniali e semi‑coloniali. Molti di loro che solo fino ad un anno fa o diciotto mesi fa confidavano su Versailles, che si aspettavano l’aiuto di un gruppo o l’altro di predoni imperialisti, adesso sono venuti tutti da noi, convinti della inutilità di aspettarsi qualcosa dalle grandi avide potenze che vorrebbero alleviare la loro situazione. Nessuna nazione può essere libera se opprime un’altra nazione e nessun governo capitalista o proprietario fondiario può dare agli oppressi quella libertà che è loro necessaria come la luce, come il pane, come l’aria.
Compagni, in contrapposizione ai politici borghesi, in contrapposizione ai rappresentanti delle grandi potenze, le borghesie di America e di Europa, l’Internazionale Comunista dichiara alle nazioni oppresse: La vostra liberazione sta nelle vostre mani. Ma potete vincere la vostra libertà solo stando spalla a spalla con il proletariato internazionale che sta combattendo per la sua liberazione sociale. Il proletariato internazionale sa bene che non si può distruggere il giogo capitalista su tutta la Terra, che non si può instaurare la dittatura proletaria sul globo intero senza avere attratto a questa grande battaglia per la libertà gli strati più arretrati della società, gli strati più arretrati del proletariato, le risorse ultimissime dell’umanità. L’imperialismo mondiale ha legato le sorti delle masse lavoratrici del Giappone, della Cina, Corea, Mongolia, Manciuria, e adesso nessuno di questi paesi può garantire la propria libertà ed il libero sviluppo nazionale senza lottare spalla a spalla nelle file del proletariato internazionale.
Per capirlo noi dobbiamo analizzare le condizioni prevalenti in questi paesi.
Molti paesi dell’estremo oriente sono paesi arretrati e stanno appena facendo i primi passi sulla strada dello sviluppo capitalistico. Stanno facendo i primi passi sulla strada dello sviluppo capitalistico sotto la pressione delle potenze straniere, sotto la frusta dei conquistatori stranieri. Nella maggioranza di questi paesi prevale una forma di agricoltura che è della piccola proprietà contadina. Gli invasori stranieri sono andati in questi paesi per sfruttarli. Non hanno sconvolto le vecchie arretrate tradizioni, non hanno distrutto queste tradizioni che si sono formate nel corso dei secoli, a cui tutti i lavoratori sono legati mani e piedi, negando loro la libertà, ogni possibilità di sviluppo indipendente di una forza cosciente. Il capitalismo nei paesi arretrati fa uso del feudalesimo medievale della Cina, della Corea e degli altri paesi dell’estremo oriente per sfruttare le loro ricche risorse naturali, le loro grandi riserve di forza lavoro e materie prime, con l’obbiettivo di procurarsi grandi profitti. È del tutto evidente che in queste condizioni è dovere obbligato per ogni comunista, ogni rivoluzionario, o qualsiasi onesto democratico, formare una chiara concezione della fase di sviluppo sociale ed economico delle nazioni oppresse dell’estremo oriente.
In un primo momento la borghesia originaria cinese giocò soltanto la parte di intermediario fra il capitale europeo e il mercato interno. Il commerciante cinese era l’agente commissionario fra i capitalisti europei che conducevano le loro operazioni nel mercato locale, fra i contadini ignoranti, e aiutava a distruggere l’industria locale che sosteneva molti milioni di persone. Il capitale straniero, come una specie di sovrastruttura, fondava il suo potere su gli arretrati nativi, sulle masse lavoratrici arretrate. Il rappresentante della Cina del sud che ha partecipato alla discussione, ci ha detto come il capitale straniero in Cina ha gradualmente catturato le risorse fondamentali di sussistenza delle masse lavoratrici. Il compagno ci ha dato i dettagli per ogni industria e la vastità di ciò che è stato conquistato dal capitale straniero.
Il capitale straniero, nella conquista della campagna arretrata e fondando là il suo dominio, ha causato una certa classificazione del lavoro, ha impiantato una differenziazione fra gli aristocratici europei e le masse arretrate lavoratrici locali. Il cinese deve rimanere per sempre un contadino servo legato alla terra, che ha dato via agli usurai del villaggio i suoi ultimi possedimenti, e da ultimo ha dato il suo sudore ed il suo sangue al capitalismo straniero. Gli artigiani locali devono eliminare le loro capacità, i loro primitivi attrezzi non possono sfidare le manifatture europee e americane nella competizione del mercato aperto, perché questa è la legge della società capitalistica. Gli artigiani, i contadini rovinati, sono buttati fuori dal loro elemento economico per sbarcare il lunario in una miserabile esistenza come sottoproletari, come un indigente che è incapace di migliorare la sua condizione sotto la dominazione imperialista europea.
Il capitale europeo ha conquistato i porti più importanti, le più importanti strade di comunicazione dell’entroterra, i centri politici più importanti, e ha impiantato la sua autorità ovunque. Come esempio di dominazione borghese si potrebbero citare le varie concessioni basate sul principio della extra territorialità in Cina. L’imperialismo straniero ha preso tutto ciò che si sarebbe potuto prendere, ha preso tutti i punti strategici dell’economia e della politica. Il capitale straniero ha progredito nel controllo sul destino delle masse oppresse, e obbliga le masse oppresse a lavorare sotto il suo comando. Il capitalismo, che ha compiuto un grande obbiettivo rivoluzionario in Europa con la concentrazione delle masse contadine arretrate nelle fabbriche, insegnando a queste masse il lavoro collettivo, organizzandoli e impregnandoli dello spirito di lotta, e poi facendoli combattere per i loro interessi, questo capitalismo non sviluppa l’industria nei paesi arretrati, questo capitalismo si propone di mantenere tutti questi paesi nella loro arretratezza come fornitori di materie prime. Mentre in Europa il capitalismo ha convertito i contadini in proletari, qui converte i contadini in vagabondi che, privi di un lavoro utile, sono obbligati ad ingaggiarsi in bande di ladri per la ricerca dei mezzi per la sussistenza per loro e la loro famiglia.
Il destino accaduto a Cina e Corea dimostra il totale egoismo di europei, americani, lo scopo del capitalismo internazionale non è quello di sviluppare le industrie dei paesi arretrati ma, al contrario, di ritardarne lo sviluppo industriale con ogni mezzo possibile, in modo da perpetuare i loro interessi predatori a spese degli interessi vitali delle larghe masse lavoratrici. E così, quando gli ingenui rappresentanti nazional-rivoluzionari delle organizzazioni della borghesia democratica si aspettavano un aiuto da Versailles e da similari inaffidabili, hanno avuto a che fare ogni volta con dei grossolani equivoci dei loro interessi, con odio e rancore. Non potevano capire perché queste conferenze erano indette proprio dalla classe che è interessata allo sfruttamento di questi paesi.
In Cina ci sono diversi gruppi che sostengono l’anarchia feudale. Fin dal tempo della rivoluzione del 1911. Il feudalesimo in Cina si presenta nella forma di una organizzazione burocratico-militare che regna su di un sistema economico patriarcale del piccolo contadino. Il capitalismo straniero sta trovando dei vantaggi dalla guerra e dalle sue conseguenze, in modo da lacerare il corpo della Cina in più parti, in modo da spaccare l’integrità del territorio cinese, deliberatamente incoraggia l’insurrezione e la guerra civile in quel paese per assicurarsi i suoi predatori interessi tramite il disordine e l’anarchia.
La politica giapponese è una politica di svergognata rapina, una politica di aperta violazione che fu ben esemplificata in un documento emanato dal partito giapponese patriottico dei Cento Neri, del “Dragone Nero”, fin dall’inizio della guerra imperialista mondiale. In questo documento i maggiori capi della politica imperialista giapponese scrissero apertamente e svergognatamente come segue:
«Dobbiamo immediatamente prendere delle misure per indurre i rivoluzionari cinesi, gli imperialisti ed ogni tipo di elementi insoddisfatti in Cina a causare disordini, e questo porterà al rovesciamento del governo Huan. Allo stesso tempo, dobbiamo selezionare, fra i più influenti e alti circoli della popolazione, una persona che potrebbe aiutare nella realizzazione di una nuova forma di governo e pacificazione del paese. Questo lo possiamo fare solo con l’aiuto del nostro esercito e se all’inizio proteggeremo la vita e le proprietà della popolazione cinese, non ci saranno obbiezioni nel riconoscimento di un governo che sarà pronto a formare l’ unione con il Giappone.
«Il momento attuale è una opportunità per istigare disordini. È solo questione dei mezzi finanziari che mancano. Ma se il governo giapponese userà la situazione spingendo per dei prestiti questi arriveranno subito. Così potremo procedere con i nostri piani e facilmente raggiungeremo i nostri obbiettivi. Tuttavia, in base alla tendenza della guerra europea, è necessario agire presto, perché le condizioni che oggi si presentano favorevoli non si ripeteranno.
«Studiando l’attuale forma di governo in Cina, dobbiamo considerare quanto una forma di governo repubblicana possa adattarsi a quella gente. Fino ad oggi non abbiamo visto altro che delusione in ogni occasione di pratico inizio dell’instaurazione di un sistema repubblicano. Anche quelli che, all’inizio, erano a favore della repubblica, hanno ammesso che si erano sbagliati. Quindi il mantenimento, in futuro, dell’attuale forma di governo renderà sempre più difficile il riavvicinamento fra la Cina ed il Giappone. Le ragioni di questo sono le seguenti: i principi di base, gli obbiettivi sociali e morali della repubblica sono in conflitto con i principi di base e gli obbiettivi della monarchia costituzionale. Tutte le leggi e l’intero sistema di amministrazione ha un diverso carattere. Quindi, se il Giappone si avvantaggia, come dovrebbe, delle attuali opportunità, la Cina dovrà cambiare il suo sistema statale d’accordo con il modello giapponese, e solo dopo sarà possibile arrivare ad una soluzione soddisfacente della politica dell’Estremo Oriente.
«Poi, è nell’interesse della politica giapponese, che deve mirare ad una unione permanente con la Cina, che insieme al cambiamento del governo cinese, ci sarà anche un completo cambiamento del sistema e la trasformazione in una monarchia costituzionale, che corrisponderà in ogni dettaglio, al sistema monarchico esistente in Giappone» (Der Neue Orient, Vol. V, No. 7/8 pag. 234‑235).
Questa gente tira fuori le loro opinioni apertamente.
Prima di imbarcarsi nella loro politica predatoria, prima di condurla su larga scala più di quanto non fosse già fino a quel momento, espressero i loro obbiettivi e portarono avanti il loro programma del governo giapponese e dell’imperialismo giapponese, per creare disordine nel paese, per prevenire ogni possibilità di sviluppo per un buon ordinamento economico, per impadronirsi delle risorse economiche del paese oppresso. Quello che successe successivamente fu soltanto il diretto risultato di quel piano. Consisteva nel sostenere la feccia della popolazione cinese, i delinquenti, i Dutsiun, incoraggiando la guerra civile e provocando la rovina nella nazione cinese. Il rappresentante del Partito del Kuomintang ha descritto in modo molto appropriato i vari governi del Nord che si sono succeduti l’un l’altro durante il 1918. Ha detto: «Questa gente viaggia in automobile, emette prestiti stranieri e non fa niente. La loro maggiore occupazione consiste, prima di tutto, nella vendita del loro paese, pezzetto dopo pezzetto, agli stranieri accaparratori e secondariamente nella vendita di loro stessi a questi stranieri accaparratori, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto».
Va da sé che dietro ogni predone militarista, ogni Dutsiun che sostiene la guerra in Cina, c’è un capitalista straniero, che si muove astutamente sulla scacchiera. Non c’è niente di sorprendente nel fatto che l’imperialismo giapponese si è espresso con così notevole franchezza e notevole cinismo nel documento che ho citato. Sono guidati dagli interessi dell’imperialismo giapponese. L’esportazione dal Giappone verso la Cina, nel 1908, ammontava a 52 milioni di tael, e, nel 1917, a 221 milioni. Mentre nel 1906 le esportazioni giapponesi in Cina ammontavano al 14%, nel 1917 ammontavano al 42% delle esportazioni totali, tre volte tanto. Dopo il 1917 le esportazioni dal Giappone verso la Cina hanno continuato ad aumentare. Proprio perché l’imperialismo giapponese voleva disfarsi delle sue merci avariate, era necessario istituire un dominio giapponese nel sud della Manciuria e nel nord della Cina il più velocemente possibile per approfittare del fatto che gli altri furfanti imperialisti erano occupati su altri fronti ad annettersi una parte considerevole del territorio cinese. Il tentativo del Giappone di intrappolare la Cina nella guerra imperialista del 1914 e successivamente, a causa della sua debolezza, prendendo su di sé la nobile missione di proteggere gli interessi cinesi contro la Germania, non era altro che un trucco diplomatico dell’aggressione imperialista ben esemplificata nella sua occupazione dello Shantung.
Nella misura in cui il capitalismo straniero penetra in questi paesi arretrati come la Cina, crea così le condizioni del lavoro, nelle imprese e in tutte le industrie che non mancano di sfruttare nel modo più brutale le masse lavoratrici indigene. Così, per esempio, nei due più grandi cantieri ferroviari, che occupano 6.000 uomini, nel 1920 il 3% dei lavoratori è morta di tubercolosi. Troviamo fino a un 9% di mortalità per la tubercolosi fra i minatori.
Si dovrebbe pensare che il capitalismo giapponese, il quale, insieme con gli altri, crea delle condizioni così disumane per il lavoro nei paesi arretrati, potrebbe trattare meglio i lavoratori nella madrepatria e dare loro migliori condizioni di lavoro. In realtà, noi vediamo le condizioni seguenti: per ogni mille donne in Giappone, nelle filature di cotone, ci sono ogni anno 266 casi di tubercolosi polmonare e 217 di altre forme di tubercolosi. Nelle tessiture di seta ci sono 34 casi ogni mille di tubercolosi polmonare e 47 di altre forme di tubercolosi; nelle tessiture ci sono 210 casi di tubercolosi polmonare; altre forme 280. Nell’industria della canapa, 114 di tubercolosi polmonare e 114 di altre forme. Quindi l’eccesso di profitto che si ottiene dalla linfa vitale delle masse lavoratrici della Cina non va nell’interesse degli operai e dei contadini giapponesi, ma va interamente nelle tasche dei capitalisti e dei proprietari fondiari giapponesi, che incrementano i loro profitti derubando un altro paese, e attraverso l’aumento di questi profitti, si permettono di sfruttare i loro operai e contadini in modo più brutale. La mortalità della classe operaia giapponese e di quella cinese assume proporzioni allarmanti. Questi dati ci ricordano quelli citati da Marx quando ha descritto il periodo chiamato accumulazione primaria del capitalismo.
È ovvio che, a causa della enorme scarsità di materie prime, specialmente per l’industria metallurgica, che regna ormai sul mondo intero, il capitalismo britannico, americano, giapponese ed anche francese volga i loro bramosi sguardi verso la Cina. Vi leggerò una lista delle riserve di carbone del mondo intero. Negli Stati Uniti d’America ci sono 3.838 miliardi di tonnellate, in Canada 1.234, in Cina 996, in Germania 423, e in Gran Bretagna 189 miliardi di tonnellate. Così possiamo vedere che il continente americano è il più ricco, per quanto riguarda il carbone. Allo stesso tempo si può vedere da questa lista, che l’Europa è il doppio più povera di carbone della Cina. La Gran Bretagna, che per molti decenni ha avuto le miniere di carbone per l’industria europea, la Germania, che era capace, data la sua ricchezza di carbone, di svolgere un enorme progresso nel campo industriale, questi due paesi insieme posseggono soltanto la metà di quanto ce n’è in Cina. In Cina sono impiegati metodi primitivi nell’industria carbonifera, che è soltanto nella sua fase iniziale. Nel 1900 la produzione raggiunse 5 milioni di tonnellate, 20 milioni di tonnellate nel 1917. L’industria cinese è solo all’inizio delle sue capacità.
Nel 1913 il numero di fabbriche e di cantieri equipaggiati con moderne tecnologie conformi agli standard sommavano a 1913 [sic]; il numero degli operai occupati, 630.962. Delle 21.713 imprese ce ne sono 347 equipaggiate con motori meccanici, delle quali 298 a vapore; inoltre 141 con motori elettrici e 212 imprese con altre tipologie di motori. I lavoratori maschi sono 478.000, le donne 212.000. Verso la fine del 1913 c’erano 365 compagnie proprietarie di impianti industriali, mentre la somma del capitale investito ammontava a 69.857.000 dollari, con un capitale di riserva di 1.857.000 dollari. Secondo le ultime statistiche, le fabbriche e le officine erano divise nelle seguenti branche:
| Fabbriche | Operai | |
| Macchinari agricoli | 6.030 | 34.745 |
| Filature e tessiture | 4.652 | 249.324 |
| Prodotti alimentari | 6.175 | 181.739 |
| Cartiere e stamperie | 2.134 | 64.352 |
| Metallurgia | 158 | 4.049 |
| (Der Neue Orient, Volume II, N°2, pag.10) | ||
Le fabbriche di proprietà di imprenditori indigeni assumono solo lavoratori manuali. Tutti i grandi giri industriali sono nelle mani dei capitalisti stranieri. Se consideriamo la Cina dal punto di vista economico, dobbiamo ammettere che nel campo dello sviluppo industriale ha un grande futuro davanti a sé. Nessun altro paese al mondo possiede tali ricchezze naturali. Nessun altro paese al mondo è così densamente popolato come la Cina e nessun altro paese al mondo è così brutalmente sfruttato, a eccezione, forse, per l’India. I capitalismi di America e Gran Bretagna hanno uguale interesse nel rapace sfruttamento delle materie prime cinesi, ma non sono interessati allo sviluppo delle industrie cinesi. Per esempio la Conferenza di Washington, insieme alla Quadruplice Alleanza, che si formò allora, ci mostra che non solo noi comunisti ma nemmeno i democratici borghesi e i rappresentanti della borghesia cinese possono nutrire speranze in quella direzione. Le industrie cinesi e il capitalismo cinese non può essere sviluppato con il sostegno del capitalismo americano, britannico e giapponese, perché non è nell’interesse delle grandi potenze, perché è il contrario dei loro interessi coloniali e capitalistici.
Consideriamo adesso i compiti che le masse lavoratrici cinesi hanno di fronte. Il compito principale con il quale si devono confrontare è di raggiungere la loro emancipazione dal giogo straniero. È il compito non solo dei comunisti ma di tutti gli onesti democratici cinesi, di criticare in modo implacabile i vari politicanti cinesi che si stanno comunque accordando con una delle bande imperialiste. Il compagno Zinoviev ha completamente ragione dicendo (naturalmente, non intendendo i migliori rappresentanti del Partito del Kuomintang, e alcuni circoli politicamente collegati, più o meno, con il governo del sud della Cina) che ci sono molti simpatizzanti dell’America in questi circoli. Ha anche completamente ragione dicendo che anche la borghesia cinese non ha speranza che la Cina possa essere capace di entrare a entrare nei ranghi delle grandi potenze con l’aiuto del capitalismo britannico, americano e giapponese. Tali speranze non possono esistere in quanto il capitalismo americano è, soprattutto, interessato allo sfruttamento della Cina come bacino di mano d’opera e come magazzino di materie prime.
È imperativo condurre una lotta energica per il superamento di questo regime che sostiene l’anarchia feudale all’interno del paese. Tutti i democratici cinesi devono lottare per la Repubblica Federale Cinese, non devono accontentarsi di lavorare negli strati superiori della società, i cosiddetti intellettuali, devono andare giustamente nelle masse ed organizzare queste masse contadine sotto la parola d’ordine del governo democratico, che ridurrà il costo della vita. Ogni avventuriero sta derubando il contadino cinese, che è derubato dal capitalista straniero, dal funzionario giapponese, dai Dutsiun cinesi, e dagli usurai indigeni. È imperativo risvegliare la massa del popolo cinese che è il fondamento della Cina, e la parte principale della popolazione cinese, e senza il risveglio di queste masse contadine, non c’è alcuna speranza di emancipazione nazionale. I piccoli gruppi di operai e gli elementi radicali della borghesia democratica non saranno capaci di fare alcunché senza aver destato le masse contadine e senza aver detto loro che al posto di quelle tasse che stanno rovinando il paese e stanno scavando la fossa al futuro del popolo cinese, che al posto di queste tasse e requisizioni, sarà istituita una tassa uniforme e una amministrazione eletta dal popolo e responsabile verso il popolo.
Senza aver conquistato queste larghe masse al movimento sarà impossibile raggiungere alcun risultato. I contadini cinesi sono sfruttati nelle piantagioni gestite dagli europei, sono anche sfruttati dagli usurai indigeni che, approfittando dei diritti della proprietà della terra, li sfruttano nelle loro qualità di piccoli affittuari. Dobbiamo lanciare la parola d’ordine della nazionalizzazione della terra, di una maggiore tassazione delle concessioni straniere. Questa non è soltanto una parola d’ordine comunista; questa parola d’ordine può essere sostenuta da ogni onesto democratico realmente interessato alla lotta delle larghe masse e a guidarle nella rivoluzione. I democratici borghesi devono capire che non arriveranno a una rivoluzione se non saranno in grado di abbattere il dominio degli stranieri tramite la conquista delle grandi masse. In questa questione non ci sono dubbi, lo devono capire in modo incontrovertibile. Il primo compito con cui si devono confrontare le masse lavoratrici cinesi e i loro elementi avanzati – i comunisti cinesi – consiste nella liberazione della Cina dal giogo straniero, nella nazionalizzazione della terra, nel rovesciamento dei Dutsiun, nella istituzione di una unica federazione, una repubblica democratica, nella introduzione di una tassa uniforme sul reddito. Devono fondare una federazione, una repubblica unita negli interessi delle grandi masse contadine cinesi, che da una parte sono vittime dei Dutsiun e dall’altra sono usati come carne da cannone.
Queste masse contadine devono essere conquistate alla parte della rivoluzione. Il movimento operaio cinese sta appena imparando i primi passi. Non stiamo costruendo nessun castello in aria per il prossimo futuro, non ci aspettiamo che la classe operaia cinese prenda la posizione dominante che gli operai giapponesi saranno in grado di raggiungere nel prossimo futuro. Ma il giovane movimento operaio cinese sta crescendo. I sindacati esistenti sono legati da pregiudizi di mestiere, che sono ancora per molti aspetti le vecchie organizzazioni professionali, vanno riorganizzati come genuini sindacati proletari. Questo è il primo compito. Noi dobbiamo iniziare una lotta implacabile contro le vecchie forme di sfruttamento che in Cina vengono effettuate con l’aiuto dei padroni, dove l’imprenditore cinese è il responsabile diretto dello sfruttamento capitalistico.
Allo stesso tempo deve essere stabilito definitivamente che il movimento dei lavoratori, gli operai cinesi devono percorrere la loro strada, non devono collegarsi con alcun partito democratico o con qualsiasi elemento borghese. Non abbiamo intenzione di nascondere la verità. Sappiamo perfettamente bene che nel prossimo futuro non ci potranno essere forti conflitti fra noi e questi elementi borghesi democratici organizzati nella organizzazione nazionale rivoluzionaria. Ma allo stesso tempo dobbiamo dire a questi elementi democratici borghesi che – poiché si adopereranno a schiacciare il movimento operaio cinese, poiché proveranno ad usare i sindacati cinesi per i loro propri meschini interessi e terranno questi sindacati nel vecchio spirito di mestiere, predicando la concordia di classe fra lavoro e capitale – al quel punto noi faremo una lotta determinata contro di loro.
Noi sosteniamo ogni movimento nazionale rivoluzionario, ma lo sosteniamo solo nella misura in cui non è diretto contro il movimento proletario. Dobbiamo affermare: è un traditore della causa della rivoluzione proletaria comunista chi non sostiene il movimento nazionale rivoluzionario. Ma dall’altra parte dobbiamo esser consapevoli che è traditore della causa nazionale chi combatte contro il risveglio del movimento proletario, è traditore del suo popolo e della causa nazionale, chi ritarda la classe operaia cinese nei suoi sforzi per alzarsi sulle sue gambe e parlare il suo proprio linguaggio.
Ho davanti a me il rapporto del sindacato cinese dei metallurgici della città di Canton. Il rapporto si conclude così: «Bertrand Russel disse: “se mi si chiedesse come può la Cina sviluppare le sue industrie senza il capitalismo, risponderei prima di tutto attraverso il socialismo di Stato”. L’autore di queste righe, che è un delegato di questo sindacato, è della stessa opinione del famoso filosofo inglese». Bertrand Russel è il rappresentante del corrotto socialismo della armonizzazione sociale. È chiaro che gli operai cinesi devono rifiutare la strada indicata dai capi di questo corrotto socialismo del compromesso dei colonizzatori europei, e seguire la strada intrapresa dalle grandi masse di operai del mondo intero, la strada del comunismo. Resta inteso che ogni parola da Stato socialista in Cina senza trasformare la Cina in una repubblica cinese, prima che le masse lavoratrici della Cina siano mature per la repubblica dei Soviet, è solo un inganno. È necessario che la classe operaia non si isolati dalle masse contadine cinesi. È necessario che stringa le mani con quelle delle masse contadine e porti loro la luce, la cultura, e le idee comuniste.
Naturalmente la Cina non si trova di fronte a una imminente rivoluzione comunista, e ad una immediata sovietizzazione, ma allo stesso tempo si deve ammonire che la luce dell’idea dei Soviet è la forma più adeguata di organizzazione per la lotta rivoluzionaria delle masse e per il controllo rivoluzionario di queste masse sugli organi democratici di potere. I Soviet sono il miglior armamento nelle mani dei lavoratori di ogni paese, tanto che abbia una predominanza di popolazione proletaria quanto che sia invece un paese contadino. L’esperienza del movimento rivoluzionario nel vicino Oriente e nell’Asia centrale lo prova in modo convincente e questa esperienza non può passare nell’estremo Oriente senza lasciare traccia.
I problemi che stanno affrontando le masse lavoratrici della Corea sono più semplici. Là, così come in Cina, sosterremo ogni movimento rivoluzionario nazionale che si oppone a ogni compromesso con l’imperialismo ed è pronto a muoversi ostinatamente verso l’obbiettivo dell’emancipazione nazionale. Non ci turberemo né esiteremo di fronte al fatto che alcune di queste organizzazioni sono società contadine ed altre sono sette religiose, ecc. Ci rendiamo perfettamente conto che questo movimento è borghese democratico, tuttavia lo sosteniamo come sosteniamo ogni movimento nazionalista per l’emancipazione, in quanto è diretto contro l’imperialismo e perché è in accordo con gli interessi del proletariato internazionale. E chiediamo questo anche agli operai coreani. Là c’è l’imperialismo giapponese che è il potere imperialista che ha distrutto l’aristocrazia coreana. Quindi è giusto parlare colà del fronte unito nazionale, ma, allo stesso tempo, si deve denunciare nel modo più determinato ogni tentativo di realizzare l’emancipazione del paese attraverso il compromesso e il pacifismo.
La rivoluzione del marzo 1919, il maggiore evento nella vita del popolo coreano, fu una rivolta di queste masse schiacciate che non poteva portare alla vittoria. Il popolo coreano avanzava pieno di entusiasmo davanti ai ranghi serrati delle baionette giapponesi e si immolava in una morte eroica, ma fu una rivolta che non poteva avere successo. Ogni onesto democratico deve riconoscere che è solo nella lotta armata e marciando spalla a spalla con il proletariato comunista del mondo intero, che gli operai possono raggiungere la vittoria sugli annessionisti e oppressori stranieri guadagnandosi una reale libertà. La conferenza di Washington ha eliminato ogni illusione sul fatto che la Corea sia capace, in un modo o nell’altro, con l’aiuto dei paesi imperialisti di America o Francia o di qualche altro paese, di liberarsi da sé della oppressione giapponese. La Corea o rischia la sua totale cancellazione o si deve emancipare da sé nel cammino rivoluzionario.
Non ci sono altre possibilità. Il regime giapponese in Corea è comparabile solo con quello inglese in India. Qui ci sono alcuni dati interessanti riguardo alle spese dal 1919 al 1920.
Secondo la versione ufficiale del governo generale giapponese in Corea, le spese sono state le seguenti, in Yen:
| Per: | 1919 | 1920 |
| L’ex casa imperiale di Corea | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Il governat. giapponese in Corea | 3.192.000 | 7.202.000 |
| La polizia e gendarmeria | 19.826.000 | 41.940.000 |
| La costruzione di prigioni | – | 850.000 |
| Le scuole | 773.000 | 1.228.000 |
| La salute pubblica | 709.000 | 912.000 |
| Le guarnig. giapponesi in Corea | 17.259.000 | 15.383.000 |
Così, mentre il militarista giapponese, l’ufficiale giapponese fa il conto delle sue spese, assegna la gran parte delle sue entrate alla continuazione della sua politica predatoria e vessatoria verso il popolo coreano. La Corea è stata saccheggiata e conquistata dal Giappone, e la lotta per l’emancipazione nazionale della Corea, così come quella per l’emancipazione nazionale della Cina, è il principale obbiettivo della classe operaia giapponese. La classe operaia giapponese deve riconoscere che il nemico è nel proprio paese. È la forza rivoluzionaria più avanzata nell’Estremo Oriente, e deve essere la prima a dare un colpo decisivo all’imperialismo giapponese, senza il quale, non sarà libera dalle sue catene, le catene dell’imperialismo giapponese. Questo non si può ottenere senza spezzare le catene della Cina e della Corea, senza fare a pezzi la politica dell’imperialismo giapponese.
Compagni, non ho molto tempo, mi piacerebbe però parlare molto brevemente sui compiti che ci troviamo di fronte in Giappone.
Il Giappone è un paese al più alto sviluppo capitalistico e con una classe operaia numerosa che ha un grande futuro davanti. Due milioni e mezzo di operai d’industria, sei milioni di proletari non riconducibili alla grande industria, oltre 5.000.000 piccoli affittuari, semi‑lavoratori – sono cifre che se calcolate con l’aritmetica rivoluzionaria appaiono fatali per il capitalismo. Il Giappone si sta sviluppando sulla linea prussiana. I funzionari giapponesi si sono adattati allo sviluppo borghese e sono stati assimilati all’interno della frazione più ricca della borghesia giapponese. Attualmente il blocco fra i Genro [statista navigato, oligarca, ndt] e i capitalisti della finanza rappresentano il potere supremo. È un ordine sociale plutocratico mascherato da forme costituzionali. In realtà, il potere che appartiene al Mikado, alle vecchie famiglie feudali, è collegato con diverse imprese, che tengono nelle loro mani il destino del popolo giapponese, come nel passato. Così, un settore di queste famiglie feudali è collegato con l’esercito, l’altro con la marina, e il terzo con numerosi porti e cantieri navali, ecc. I proprietari fondiari giapponesi e la nobiltà sono diventati più borghesi degli altri e anche il Mikado che, come si sa, “discende dal divino”, è proprietario di un hotel di lusso.
Ciò significa che oggigiorno tutto è possibile, che anche il popolo del divino può possedere case di tolleranza e grandi cantieri navali, ecc. Siamo testimoni dell’unione della plutocrazia con i resti della società feudale. La borghesia giapponese, educata nello spirito del servilismo, nello spirito dell’adulazione del militarismo dell’ordine sociale monarchico, questa borghesia non è capace di risolvere il problema nazionale. I partiti borghesi del Giappone sono in natura dei gruppi e delle cricche e niente altro. Una frazione della borghesia è principalmente collegata con i grandi latifondisti ed è una frazione della “Sei‑Yu‑Kai”, che è il partito dell’aggressione militarista. L’altra frazione, che è una parte di questo partito, occasionalmente indulge al liberismo, è il partito plutocratico, piccolo borghese, che sta opprimendo le masse lavoratrici.
Mentre l’imperialismo giapponese ha raggiunto i livelli delle potenze imperialiste e il capitalismo giapponese è diventato una potenza, la classe operaia sta iniziando a fare il suo primo timido passo sulla via del movimento operaio. La maggiore organizzazione sindacale in Giappone, che comprende 50.000 iscritti, è l’organizzazione Yu‑A‑Kai, ed è stata organizzata dal tipico finto sindacalista, il Signor Suzuki, l’amico di Gompers. La federazione venne fondata nel 1911, e Suzuki l’ha dominata fino al 1920, insieme ad intellettuali direttamente collegati con i rappresentanti dell’industria e del commercio, e ci hanno girato intorno anche rappresentanti del socialismo di Stato, generali in pensione, a predicare la collaborazione fra capitale e lavoro sotto il giogo della monarchia imperialista.
Ma prima le rivolte del riso, che sono state degli scoppi spontanei del malcontento delle masse dopo la crisi della guerra a causa dello stato di cose del capitalismo, poi l’ondata degli scioperi hanno portato alla liberazione dei lavoratori giapponesi dalla tutela degli intellettuali borghesi. Ci furono 50 scioperi nel 1914, ce ne sono stati ben 185 nel 1920. Nel 1914 gli uomini coinvolti negli scioperi furono circa 158, nel 1920 il numero crebbe a 878. Cosa significa? Significa che la classe operaia si sta risvegliando, significa che i lavoratori stanno diventando un potere cosciente.
Le grandi masse lavoratrici giapponesi non sono permeate dall’idea della lotta di classe. Durante un certo numero di scioperi le classi dominanti terrorizzarono gli operai radunati nei templi a pregare Dio e ne uscivano gridando: viva il Lavoro e Bansai Mikado. Ciò mostra che la classe operaia giapponese non si regge ancora su basi solide. Ma il Signor Suzuki ha già perso la sua influenza.
Nel 1920 fu organizzata un’ala radicale della classe, i sindacati e questa ala sono rappresentata a questo Congresso. Questi compagni che sono venuti qui prima si chiamavano anarco-comunisti e sindacalisti. Dopo aver parlato a lungo con noi, dopo essere riusciti a sentirsi a proprio agio nella rivoluzione russa e aver capito il movimento rivoluzionario internazionale, sono arrivati alla conclusione di aderire alla rivoluzione proletaria, di essere comunisti. Il compagno Katayama ha dichiarato che mentre una volta usavano definirsi anarco-comunisti, adesso hanno gettato l’anarco e sono semplicemente comunisti. Questa è una grande vittoria. Veramente, quando la parte migliore della classe operaia giapponese elabora un sicuro atteggiamento verso gli intellettuali e le loro politiche non è nient’altro che una reazione contro il compromesso sociale e lo spirito autocratico che fu introdotto nei sindacati dal Signor Suzuki. Resta inteso, che questi anarco-comunisti e sindacalisti sono giustamente membri della Internazionale Comunista, così come lo è chiunque.
Compagni, l’unione che qui si sta saldando fra gli elementi più influenti del movimento dei lavoratori è di grande importanza per il destino dell’Estremo Oriente. Il proletariato giapponese inizia ad essere una forza rivoluzionaria. Sta vivendo in condizioni peggiori di quelle che noi abbiamo dovuto sopportare, e tuttavia sta organizzandosi in forza indipendente. Gli operai giapponesi non possono sperare di superare il peso dell’oppressione e fare la rivoluzione sociale proletaria direttamente. Devono sconfiggere gli avversari, usare tutti i mezzi per battere la loro classe nemica, e prima di tutto, sconfiggere il blocco dei plutocrati, il blocco dei proprietari fondiari. Questo blocco deve affrontare la stessa decisiva tempesta che si è avuta da noi, cioè la classe operaia russa, in particolare nel 1917. La prima richiesta deve essere: “una repubblica democratica, nazionalizzazione della terra, nazionalizzazione della grande industria, con la imposizione del controllo operaio sulla produzione”.
Se diamo uno sguardo ai dati vedremo che c’è abbastanza materiale infiammabile nell’ambito giapponese da fare un buon servizio al momento della rivoluzione sociale democratica e proletaria.
Secondo il censimento del 1916/18, 219.859 famiglie, il 4% della popolazione agricola, possedeva più di 3,18 ettari di terra; 1.449.340, il 26,5%, aveva più di 2 ettari; 3.696.168, il 69%, aveva meno di 1 ettaro [2 ettari?]. I grandi proprietari terrieri, con possessi di più di 50 ettari, erano soltanto 3.495, lo 0,07%. Circa il 70% dei contadini aveva meno di 2 acri di terra. A questo miserabile lotto di terra erano condannati in una condizione di inedia continua. Naturalmente questi poveri mezzadri e lavoratori sono i nostri alleati naturali nella nostra lotta contro gli oppressori. L’organizzazione di un sindacato indipendente dei mezzadri che si formò per unire le lotte per migliori condizioni d’affitto è la migliore prova del fatto che si stanno risvegliando. Il fatto che stanno iniziando a entrare in contatto con la classe operaia, che stanno cercando il suo aiuto, prova che la classe operaia giapponese seguirà la stessa strada dell’unione fra operai e contadini che noi operai e contadini russi abbiamo sostenuto all’inizio della nostra rivoluzione.
Hanno un grande futuro davanti, anche se dobbiamo rilevare che benché giovane come classe operaia, e difficile la sua posizione, non si sottrarrà al dovere di unire il nodo dell’Estremo Oriente. Circa il 50% dei lavoratori giapponesi sono donne, il 25% del proletariato si è unito all’esercito degli operai durante la guerra. La variegata composizione della classe operaia giapponese è ostacolata nell’uso del proprio linguaggio, il linguaggio della rivoluzione proletaria, ma d’altra parte, quando l’avanguardia si esprime, è assolutamente chiaro, che l’unità fra le masse operaie giapponesi e la piccola borghesia, le masse semi‑proletarie, sarà il gioco determinante, questa unione assicurerà la posizione principale alla classe operaia per la comune lotta rivoluzionaria per un regime politico completamente democratico, e gli darà il ruolo principale nella rivoluzione sociale proletaria. Deve essere risolutamente evidenziata la parola d’ordine che i Soviet sono l’organo della lotta rivoluzionaria per il potere delle masse giapponesi.
I compagni che si dicono anarco-comunisti e sindacalisti esprimevano il timore che una tale lotta attraverso la democrazia, dove noi non separiamo mai i settori e non incontriamo i nostri avversari singolarmente, avrebbe potuto portare al compromesso e alla diffusione delle illusioni democratiche. Non è così e i compagni ne sono convinti. A casa, in Giappone, non hanno mai incontrato veri comunisti, comunisti rivoluzionari che usano l’arma della politica negli interessi della lotta proletaria.
Se noi adesso diciamo alla classe operaia che attraverso il rovesciamento del Mikado, del militarismo e dell’ipocrisia, deve marciare verso la rivoluzione, non significa che stiamo invitando al compromesso con i partiti borghesi, non importa come essi si fanno chiamare. Questo non significa che stiamo invitando la classe operaia a non avere un suo proprio ruolo politicamente indipendente. Questo significa, è dimostrato, scioperi e, se necessario, lotta armata, deve condurre alla lotta per l’abolizione del regno plutocratico e militarista del Giappone. Significa che si prenderà possesso di tutti i mezzi di produzione per sbarazzarsi del coercitivo capitalismo e imperialismo giapponese.
Il compito con il quale la classe operaia giapponese si confronta è un compito internazionale, che richiede che si accolli la parte maggiore di responsabilità nella lotta. Il destino dell’Estremo Oriente, della Corea e della Cina, dipende dal risveglio del movimento operaio giapponese e dal suo irrobustimento. Questo esempio dovrebbe rendere chiaro a ogni borghese che solo l’unione con il movimento proletario e solo con l’aiuto dato a questo movimento proletario può condurre i popoli oppressi verso la loro emancipazione.
Perciò, l’obbiettivo con il quale le masse operaie si stanno confrontando consiste soprattutto nell’emancipazione dei paesi oppressi. Dobbiamo appoggiare ogni movimento nazionale diretto contro l’oppressione imperialista, e condurremo una lotta implacabile contro tutte le tendenze e organizzazioni che danno un minimo contributo agli imperialisti o alla diplomazia imperialista internazionale. L’obbiettivo fondamentale consiste nella distruzione dell’edificio dell’imperialismo giapponese dall’interno. Crediamo che la classe operaia giapponese si affermerà in questo con onore.
Mi soffermerò adesso sui paragrafi separati del Congresso riguardo alle questioni nazionale e coloniale, tenterò di adeguarli alla situazione attuale nell’Estremo Oriente.
Deve essere molto chiaro a tutti che solo l’indirizzo dei Soviet russi, solo l’indirizzo dell’Internazionale Comunista e delle forze internazionali operaie, come una forza internazionale dei lavoratori e che solo un indirizzo del genere può salvare le masse oppresse di Corea, Cina, Manciuria e Mongolia. Ed è solo con questo indirizzo che si possono liberare dal giogo imperialista.
Compagni, il principale risultato del nostro Congresso e del nostro dibattito potrebbe essere che tutti coloro che hanno partecipato al Congresso dovrebbero avere una effettiva comprensione della correlazione fra il movimento nazionale rivoluzionario e quello dei lavoratori. Non desideriamo imporre a nessuno la nostra visione, non desideriamo imporre a nessuno il nostro programma, non invitiamo nessuno che non sia pronto ad entrare nelle file del Partito Comunista, non desideriamo alcuna sovietizzazione forzata, ma d’altra parte diciamo che più sosteniamo il movimento nazionale democratico più chiediamo un atteggiamento di lealtà verso il movimento dei lavoratori, verso il Partito Comunista, verso la classe operaia.
Chiamiamo ad una lotta implacabile contro l’imperialismo. Questo Congresso deve creare un rafforzamento della solidarietà internazionale di tutte le nazioni dell’Est. Questo Congresso deve realizzare l’unione degli operai giapponesi con gli operai e contadini rivoluzionari cinesi e anche con tutti gli elementi democratico borghesi che intendono sinceramente combattere. Il proletariato rivoluzionario non può prendere in considerazione l’idea sbagliata che noi sosteniamo solamente il movimento proletario delle colonie. Non è una colpa ma piuttosto la sfortuna dei paesi arretrati di non possedere una classe proletaria numerosa. Solo in alleanza con il movimento proletario delle nazioni oppresse si otterrà la loro libertà.
Il risultato della nostra discussione deve essere una chiara visione, naturalmente, che le possibilità di vittoria per il movimento rivoluzionario nazionale aumenteranno notevolmente se le masse proletarie svolgeranno un ruolo indipendente in questo movimento, se gli elementi proletari delle nazioni oppresse si affermeranno come capi e alfieri in questa lotta nazional-rivoluzionaria. Il risultato della nostra discussione deve essere una chiara visione del fatto che il proletariato giapponese è la forza principale che risolverà il problema dell’Estremo Oriente, che la solidarietà fraterna con il proletariato giapponese, con i comunisti giapponesi, con il proletariato rivoluzionario giapponese, è la condizione indispensabile non solo per vincere una battaglia ma anche per una reale e definitiva liberazione delle masse oppresse della Cina e della Corea sotto il giogo dell’imperialismo.
Viva la liberazione degli operi dell’Estremo Oriente! Viva l’unione degli operai dei contadini dell’Estremo Oriente sotto il vessillo della Internazionale Comunista!
[applausi scroscianti]