|
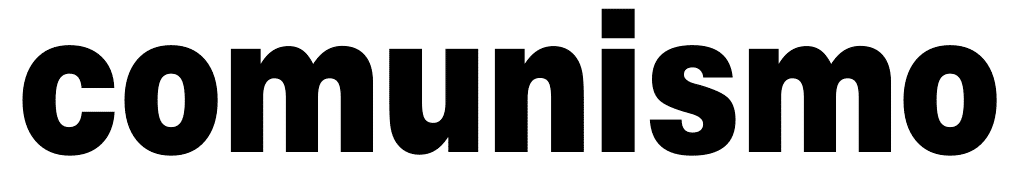 |
n. 94 - dicembre 2022 - Anno XLIV aggiornato al 28 dicembre 2022 |
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Una cosa ci è assolutamente chiara, per noi che siamo ormai storicamente contro ogni guerra tra imperialismi e combattiamo da oltre un secolo solo per la guerra tra le classi: ogni guerra tra gli Stati borghesi è la cifra del mondo capitalistico, giunto alla sua completa diffusione sull’intero orbe terracqueo, al suo punto più basso di degenerazione.
Noi comunisti non ci schieriamo per la vittoria di alcuna borghesia rispetto all’altra, ma non siamo indifferenti agli accadimenti del dramma storico in atto. Analisti, militari di carriera, giornalisti venduti alle indicazioni dei grandi proprietari borghesi o disciplinati dalle veline statali e dei grandi gruppi editoriali legati al grande capitale nazionale, si danno un gran daffare per spiegarci gli intricati rapporti delle truppe sul campo, le strategie in atto, le prospettive più o meno favorevoli all’una o all’altra delle parti.
Quale “vittoria”, termine che può essere ormai soltanto relativo, o quale cessate il fuoco o armistizio, devono per noi essere motivo di studio e di analisi, perché la rivoluzione è anche prodotto storico di come evolve lo scontro tra i capitalismi del mondo, tra i mostri imperialistici, oltre che dalla dinamica del capitalismo in quanto modo universale di produzione. Ma su tutto si impone la assolutamente necessaria rinascita del partito della rivoluzione. Il partito ha l’obbligo di capire, analizzare, ovviamente nelle condizioni delle sue capacità, tutto ciò che sta accadendo, di chiaro e di nascosto.
Ma senza la sua “guerra alla guerra” c’è un solo vero sconfitto, il proletariato internazionale, in specie quello ucraino e quello russo. Questa guerra è contro di loro, uomini portati su fronti opposti dai capitalisti, camuffata da un lato a difesa della libertà nazionale contro l’invasore, dall’altro della integrità nazionale russa minacciata.
Su questi temi che non sono propri dei proletari delle due nazioni, ma opposti ai loro interessi di classe, sia nella nazione invasa sia in quella che ha invaso, prende forza e risuona la medesima menzogna che si è sempre riproposta nelle guerre precedenti e ha dato sostanza giustificatrice alle carneficine della prima e della seconda guerra mondiale. Su questo infame cumulo di falsità patenti, imposto al grande pubblico delle platee di oriente ed occidente, si sta giocando il massacro in atto.
Ad occidente è di gran lunga preponderante la propaganda a favore dell’invaso, fino a giungere a livelli disgustosi per stupidità, mentre la sanguinaria e altrettanto bugiarda pubblicità dell’invasore è rigorosamente silenziata. Tornano alla memoria i resoconti di celebri pennivendoli sui giornali per l’edificazione delle popolazioni durante la prima e la seconda guerra mondiale. I toni sono gli stessi, stesse le bugie propalate per spingere i proletari al macello, per attizzare l’odio fra i proletari infamando i “nemici”. Quelle di adesso godono di tecniche non meno imbonitrici e sfacciate.
Ciò che manca, in entrambe le parti, e non può essere diversamente, è una lettura non nazionale ma di classe, di quel che accade nel loro seno, la realtà dei loro opposti interessi, prospettive, sofferenze, scontro. Le famiglie proletarie che vedono i propri cari mandati al massacro e costrette al freddo e alla fame per la difesa degli egoismi dei grossi borghesi. Di queste notizie pochissimo filtra nella narrazione dell’uno e dell’altro Stato. Tutto si vorrebbe sepolto sotto il manto del “patriottismo” e della lotta per la “libertà”. Ma al di là della propaganda borghese già serpeggia, non ancora organizzato, un movimento proletario contro la guerra, nascosto e represso.
Soltanto ad un Partito che si mette incondizionatamente dalla parte dei proletari, che “non hanno patria” né bandiera, ed è contro patrie e bandiere borghesi, soltanto a questo Partito, che nella tempesta della guerra non perde di vista il fine della rivoluzione comunista internazionale, che è lontana e vicina, solo a questo Partito, che è assolutamente al di sopra e contro ogni parte combattente, è dato individuare le conseguenze storiche di un esito o di un altro delle guerre borghesi.
Questo è il senso della nostra “non indifferenza”.
Nell’aretino
Il movimento socialista aretino aveva sempre avuto una connotazione spiccatamente di estrema sinistra, tanto che si dovettero «invitare alla coesione e alla calma» gli «ottimi compagni aretini» che avrebbero voluto «costituir subito il Partito Comunista Astensionista» (Il Soviet, 3 ottobre 1920).
A dimostrazione di questa impostazione di sinistra ci basterà dare un’occhiata ai risultati dei congressi socialisti di Bologna e Livorno.
Bologna 1919 – Dai dati pubblicati dall’Avanti! del 17 ottobre si evince che la mozione comunista-astensionista raccolse, a livello nazionale il 5,11% dei voti, in Toscana il 3,54%, a Firenze il 4,63%, ad Arezzo il 19,05%. Inoltre, secondo quanto pubblicato dal giornale locale, La Falce, organo della federazione socialista aretina del 16 agosto, nella riunione della sezione di Arezzo per la nomina dei delegati al congresso di Bologna gli astensionisti risultarono maggioritari, fu nella provincia contadina che le altre correnti ebbero la maggioranza.
Livorno 1921 – Dai dati pubblicati dall’Avanti! del 22 gennaio risulta che la mozione comunista di Imola raccolse, a livello nazionale il 34,86%, in Toscana il 42,28%, a Firenze il 49,79% e ad Arezzo il 51,30%. Al partito comunista aderiranno 34 delle 60 sezioni del vecchio partito socialista. Inoltre, dei 1.400 iscritti ed aderenti alle correnti rimaste nel vecchio partito, ad aprile 1921, solo 317 avevano rinnovato la tessera.
La chiara impostazione di classe del proletariato della provincia di Arezzo si intuisce anche da come veniva affrontato il problema dei “combattenti”: «Chi sono i combattenti? Una casta? Una classe? Una categoria? Sono per consenso unanime cittadini che la guerra ha fatto vestire tutti di grigioverde. Ma venuta meno questa divisa, tutti questi cittadini hanno ripreso il loro posto, ciascuno nella propria classe sociale. Nella precipitosa china della sua decadenza il capitalismo tenta la più sfrontata speculazione sui combattenti. Un partitone, accozzaglia senza colore definito, nel quale sono scarsamente smussate tutte le angolosità di classe, ed è mascherato l’abisso che divide gli sfruttati dagli sfruttatori, si va agitando al suono degli inni patriottici, per attirare nella propria orbita, in un mostruoso abbraccio di Giuda, i lavoratori della guerra. Le fila di questa artificiosa agitazione sono tenute dalla plutocrazia e dal militarismo» (La Falce, 27 novembre 1919).
Riguardo all’uso della violenza La Falce, divenuto, dopo la scissione, organo provinciale del partito comunista, scriveva: «Il predicare il disarmo mentre dalla parte opposta si preparano armi sempre più micidiali a danno delle classi lavoratrici, sarebbe un tradire gli interessi del proletariato [...] Il partito comunista riconosce alla borghesia il diritto, anzi l’inevitabilità, di ricorrere all’uso delle armi per la propria difesa di classe e perciò appunto non nasconde ai lavoratori la necessità dell’uso della violenza per strappare il potere politico dalle mani dei suoi oppressori» (19 marzo 1921).
I minatori di San Giovanni
Abbiamo già ricordato la reazione del proletariato aretino a seguito dell’incendio del settimanale comunista fiorentino La Difesa. La notizia di quanto accaduto a Firenze giunge ad Arezzo la mattina del 27 gennaio 1921; la Camera del lavoro si era limitata a convocare una riunione per la sera, ma gli operai della Sacfem, non abituati a simili prudenti reazioni, abbandonarono il lavoro e con un corteo di circa un migliaio di dimostranti si avviarono verso il centro della città. Riportiamo il seguente trafiletto da L’Ordine Nuovo del 28 gennaio: «Verso le ore 12, essendo giunta nella nostra città la notizia dell’avvenimento di Firenze, le masse operaie hanno abbandonato gli stabilimenti, riversandosi in città. Prima che le autorità potessero in qualche modo intervenire, una colonna di operai ha invaso la sede del Fascio giovanile liberale e l’ha completamente distrutta, gettando tutti i mobili nella strada. In seguito è stato proclamato lo sciopero generale il quale dura tutt’ora, senza che altri gravi incidenti si siano creati».
Parlando dei fatti di Bari abbiamo accennato alla manifestazione nazionale indetta per la domenica del 20 febbraio dal partito comunista. Riguardo al suo svolgimento nella città e provincia di Arezzo, Il Comunista del 27 febbraio scriveva: «La prima manifestazione nostra, in questa città, non poteva avere più lusinghiero successo, il quale sarebbe stato addirittura splendido se i compagni del Comitato provinciale provvisorio non avessero creduto di far risuonare le parole del compagno Gennari nell’importante centro industriale di San Giovanni Valdarno anziché ad Arezzo. In complesso, ottima ad Arezzo e meravigliosa a San Giovanni. Gli ex compagni e tutti gli altri avversari che speravano nella nostra debacle si disilludano, il Comunismo ad Arezzo e provincia dilaga e dilagherà fino a conquistarlo interamente».
Restiamo nel Valdarno aretino dove la situazione per la classe operaia si faceva di giorno in giorno sempre più tragica. La più importante industria di Montevarchi, il cappellificio “La Familiare”, il 1° febbraio chiudeva gettando i suoi cento operai ad ingrossare le file della disoccupazione. Il 15 marzo l’Ilva di San Giovanni Valdarno annunciava di non essere in grado di pagare gli operai prospettando la sua chiusura, seppure temporanea. Da parte sua il prefetto di Arezzo, al fine di prevenire una eventuale occupazione dello stabilimento da parte operaia, faceva intervenire l’esercito. Il 19 marzo, nel vicino centro minerario di Castelnuovo dei Sabbioni, la Società Mineraria prospettava il pericolo di una imminente chiusura della miniera e della centrale elettrica, cosa che sarebbe equivalsa al licenziamento di circa 3.600 lavoratori, tra minatori ed operai.
Era il 23 marzo, a Milano scoppiavano le bombe al teatro Diana, lo stesso giorno i fascisti festeggiavano il secondo anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. Quella stessa mattina a Firenze, dopo essersi concentrati in Piazzale Donatello, tre camion di camicie nere partivano alla volta di Perugia per dare man forte ai camerati umbri nella loro opera di assassinio. Ma a Perugia, quel giorno non arrivarono. A San Giovanni Valdarno, raccontava il fascista Mario Piazzesi «ci accolsero a pernacchie e rispondemmo a moschettate». Ma, come vedremo tra poco, non andò proprio così.
Intanto, poco distante, a Castelnuovo dei Sabbioni i minatori, che nella quasi loro totalità erano iscritti al Sindacato Minatori aderente all’USI, avevano appena ripreso il lavoro dopo una giornata di sciopero a sostegno di Enrico Malatesta ed altri dirigenti anarchici illegalmente detenuti. Quel 23 marzo avrebbe dovuto essere giorno di paga della seconda quindicina. Contemporaneamente al salario la Società «avrebbe dovuto versare anche il retroattivo di quattro mesi di carovita, secondo un accordo che era stato stipulato poco tempo prima [ma] si rifiutò di pagare sia questa somma che la normale quindicina» (Filippo Nibbi, “Come Nacque il Fascismo ad Arezzo”). La Società Mineraria annunciava inoltre il licenziamento in tronco di 430 operai, naturalmente scelti tra i più combattivi.
Un clima di eccitazione serpeggiava tra la massa dei minatori. In più si aggiunse l’allarme dato per l’arrivo dei fascisti. L’Ordine Nuovo, relazionando degli scontri avvenuti nel Valdarno in quel 23 marzo, scriveva:
«I fatti hanno avuto origine da spedizioni punitive compiute dai fascisti di Firenze [...] Le spedizioni punitive dei fascisti [vengono fatte] da camion armati e presidiati nella maggioranza non da borghesi, ma dalla forza pubblica, cioè da guardie regie e carabinieri. Abbiamo visto alcuni di questi camion uscire da Firenze partiti dalla sede del Fascio, carichi completamente di guardie regie, accompagnate soltanto da un paio di borghesi per guidare la spedizione.
«La spedizione che ha dato origine alla reazione del Valdarno venne annunciata a Firenze da un avviso pubblico dei fascisti e partì nelle solite condizioni. A San Giovanni Valdarno scoppiò il primo incidente [...] Entrarono in azione in seguito i minatori di Castelnuovo dei Sabbioni».
Noi invertiremo il nostro resoconto parlando dapprima del distretto minerario.
«Castelnuovo dei Sabbioni è il centro minerario lignitifero del Valdarno dove si produce anche una potente forza elettrica che provvede ai bisogni di gran parte della Toscana e di una parte anche dell’Umbria, quindi la massa operaia vi è numerosissima. In questi ultimi anni le disposizioni al proficuo lavoro e il benessere generale furono turbati da una intensa propaganda che sotto la parvenza di rivendicazione di diritti entrava nell’animo degli operai come spinta al malcontento e alla conseguente insubordinazione. Dissensi tra operai e la Società delle Miniere furono frequenti ed uno, che ebbe per conseguenza un ristagno non breve di lavoro, era stato da poco composto quando accaddero i fatti per cui è processo» (Regia Corte d’Appello di Firenze, Sentenza 24 maggio 1922).
Infatti i minatori del valdarnese avevano una lunga tradizione di lotte e di conquiste sindacali. A titolo d’esempio possiamo ricordare come, primi al mondo assieme ai cavatori di Carrara, si erano conquistati un orario di lavoro giornaliero di 6 ore e mezza.
Ma oltre ad una forte organizzazione sindacale i minatori si erano anche armati ed organizzati militarmente. Diversi furono i depositi di armi in seguito individuati dalle forze dell’ordine. «Uno dei ritrovamenti più considerevoli effettuati in Valdarno dai carabinieri riguarda il cosiddetto “arsenale del Comitato segreto” così composto: una quantità imprecisata di bombe confezionate artigianalmente con rottami di ferriera ed esplosivo delle miniere, una mitragliatrice Fiat nuova di zecca; una cassa di rivoltelle e fucili a ripetizione Mauser; decine di bombe Sipe, fucili da caccia, moschetti e pugnali» (Giorgio Sacchetti, “Sovversivi e squadristi”).
Quel 23 marzo «nelle miniere valdarnesi l’allarme per l’arrivo delle squadre fasciste fiorentine viene portato da alcuni operai [...] giunti trafelati in bicicletta dalla vicina San Giovanni».
Temendo l’arrivo dei fascisti i lavoratori si dispongono alla difesa: «Sono appena trascorse le due e mezza del pomeriggio, all’improvviso tutti i minatori escono dalle gallerie, scendono dai casolari; il lavoro viene sospeso mentre la sirena a vapore della Centrale inizia a fischiare in modo insistente ed “insolitamente prolungato”, quasi fosse un segnale convenuto [...] Ad un successivo fischio ecco che avviene la presa di possesso, manu militari, dell’intera area lignitifera; la gran massa dei manifestanti [...] assedia minacciosa la palazzina della direzione mentre altri erigono barricate rovesciando le chiatte da trasporto sulla via per Castelnuovo [...] Qui in molti si soffermano armati di bastoni, fucili da caccia e candelotti di dinamite sbarrando [...] il passaggio [...] Altri ancora [...] salgono invece sul trenino per San Giovanni per recarsi a dare manforte ai compagni. Ormai si era sparsa la voce che i fascisti fossero giunti [...] a pochi chilometri da Castelnuovo. Un gruppo di una trentina di minatori irrompe intanto negli uffici del direttore [...] intimandogli la consegna dei camion della Società Mineraria nonché di tutte le armi in possesso degli impiegati “spie dei fascisti” [...] Nel frattempo i rivoltosi occupano anche il centralino telefonico [...] isolando in tal modo [...] gli uffici da qualsiasi comunicazione con l’esterno. Dalla stessa cabina il segretario del sindacato [...] – presente a Castelnuovo per discutere dei licenziamenti con la direzione – [cerca] di avere notizie più precise dalla Ferriera di San Giovanni; viene risposto che la persona cercata non può essere chiamata e che “fuori si spara” [...] Alcuni manifestanti, dopo aver prelevato secchi di benzina dal deposito della miniera, appiccano fuoco al vicino (odiato) ufficio-infortuni, svaligiano il casotto della dinamite. Il direttore decide allora di intervenire di persona per riportare la calma e rassicurare gli astanti circa il timore dell’arrivo delle squadre fasciste in miniera [...]
«“Infilai la scala di corsa – racconterà al processo – [...] non persi la mia calma. E ancora ricordai agli operai che gli impianti e le macchine più che della Società erano i loro perché col lavoro davano vita a tante famiglie e invitai gli operai a coadiuvarmi a spengere l’incendio”».
“Quando bruciano le nostre cooperative voi ne godete” fu la risposta dei minatori.
Il paventato arrivo dei fascisti, la decimazione per licenziamento dei più politicizzati e combattivi tra gli operai, il rifiuto della corresponsione del salario, tutto questo fa sì che ben presto gli animi si surriscaldino, scoppia la rissa nel corso della quale qualche impiegato e il direttore sono feriti, anche con arma da fuoco, mentre un altro ingegnere che si trova presente per puro caso, scambiato per un commissario di polizia è ucciso dalla folla inferocita.
I camion degli squadristi, partiti da Firenze, senza incidenti hanno attraversato tutto il Valdarno fiorentino, però a San Giovanni si sa del loro arrivo e ci si prepara.
Nella zona della Ferriera viene allestito un blocco stradale abbassando il passaggio a livello, manovrando una locomotiva e ostruendo la strada con altri materiali, carri e pali telegrafici. I fascisti sul primo camion, giunti prima che lo sbarramento sia completato, riescono a passare e attraversare il centro del paese, urlando e sparando colpi di moschetto contro i circoli ricreativi e ritrovi proletari, o i passanti che si rifiutano di gridare “Viva l’Italia”.
«Tra le 14 e le 15 del 23 marzo corrente anno – così relazionava il procuratore del re di Arezzo – passò per il corso Vittorio Emanuele di San Giovanni Valdarno un camion di fascisti proveniente da Firenze e diretto a Perugia. In un attimo, sparsasi la voce [...] i sovversivi del luogo si radunarono sulla pubblica via e rapidamente preordinarono un’aggressione».
Intanto la popolazione, dopo aver sfondato a colpi di piccone la saracinesca di una armeria del centro, si rifornisce di fucili, rivoltelle e cartucce. Mentre in tutta la vallata risuonano le sirene della Società delle Miniere, molti minatori con i trenini locali accorrono in soccorso dei compagni di San Giovanni. Nel frattempo in paese i fascisti sono accolti con una gragnola di sassate e di scariche di fucile.
Le due automobili che seguono il primo camion con a bordo i massimi dirigenti del fascismo fiorentino e perugino sono bloccate, mentre gli occupanti, fatti bersaglio di mattoni e di colpi di arma da fuoco, anche se alcuni lievemente feriti, riescono a mettersi in salvo all’interno della caserma dei carabinieri. Dagli angoli delle case, dai tetti si spara contro i fascisti e contro i carabinieri che tentano di intervenire in loro aiuto. Vistisi a mal partito fascisti e forze dell’ordine se ne stettero rintanati all’interno della caserma fino a circa le 10 della sera, ossia fino a che non arrivarono contemporaneamente tre camion di squadristi da Firenze e una folta squadra di soldati e poliziotti da Arezzo. A quel punto aiutati anche dalle guardie, dai sorveglianti e dai mazzieri al servizio dell’Ilva, i fascisti assediati abbandonano il loro rifugio e insieme alle forze dell’ordine danno l’assalto alla camera del lavoro e ai circoli operai.
Ma il proletariato continua a combattere con la medesima determinazione; dalle cantonate e dai tetti delle case si risponde al fuoco. Gli spari, gli scontri e gli assalti si susseguirono ininterrotti fino a notte. L’indomani seguono rastrellamenti, arresti in massa e bastonature indiscriminate ai danni di sovversivi, veri o presunti.
La reazione contro la popolazione proletaria di San Giovanni Valdarno sarà feroce, ma più ancora quella subita dai minatori.
La mattina del 24 i carabinieri del battaglione mobile di Firenze giungono con le autoblinde e con camion di fascisti al loro seguito. «Partiti da Firenze nella mattinata del 24, al grido “morte ai comunisti”, gli squadristi attaccarono e devastarono i circoli operai, incendiarono le sedi delle cooperative, dopo aver fatto man bassa di formaggio, prosciutti, marsala; il tutto sotto gli occhi della polizia, con grida di vittoria e di morte. In tutto il Valdarno venne sferrata la rappresaglia» (“Come Nacque il Fascismo ad Arezzo”).
A Castelnuovo dei Sabbioni i minatori tentano in una ultima battaglia di opporsi alle autoblinde, dopo di che, di fronte al dispiegamento dell’esercito devono arrendersi.
«Mentre soldati e carabinieri cominciano il rastrellamento dei minatori che si sono nascosti nei boschi per sfuggire all’arresto, i fascisti, che fino a quel momento sono rimasti a guardare attendendo che la forza pubblica liberi la strada, assalgono i simboli ormai deserti delle organizzazioni rosse. Il circolo socialista e la casa del popolo sono devasti e bruciati» (Mannino, “Origini e avvento del fascismo ad Arezzo”).
Dal canto suo la Società Mineraria del Valdarno mette subito a disposizione di chiunque avesse collaborato con le forze di polizia ben cinquemila lire di taglia per ogni latitante che sarà catturato. Inoltre effettua la serrata, o meglio, licenzia in tronco tutto il personale, circa 3.500 lavoratori, trattenendo sia il salario relativo alle 20 giornate lavorate nel mese sia gli arretrati dell’indennità caroviveri mai corrisposti. La disoccupazione indotta dai licenziamenti arriva a coinvolgere oltre diecimila persone. Poi, per completare la disperazione operaia i licenziamenti sono accompagnati dagli immediati sfratti dalle abitazioni di proprietà dell’amministrazione delle miniere.
Dopo due mesi di serrata la Società Mineraria ed Elettrica procede a riassumere 1.800 operai, circa la metà della forza lavoro espulsa, ma a condizioni capestro: «1) Ritenuta da parte della Società del 45% dell’importo di 23 giornate lavorative che gli operai avevano fatto prima della serrata, e ciò a titolo di risarcimento dei danni che la Società aveva patito in seguito agli incidenti del 23 marzo. 2) Riduzione dei salari di circa un terzo di quelli che erano prima di questa data. 3) Rinuncia ad un arretrato caro viveri dal 1° novembre e che si doveva ricominciare a pagare appunto alla fine di marzo [...] 4) Aumento delle ore di lavoro. 5) Perdita di tutti i benefici straordinari goduti dagli operai in caso di malattia di licenziamento ecc.» (Il Soviet, 7 gennaio 1922).
«Alle miniere ed in ferriera si procede al reclutamento forzato degli operai nel sindacato fascista CISE» (G. Sacchetti, “Sovversivi e Squadristi”).
A seguito dei fatti del 23 marzo le forze congiunte di esercito, forze dell’ordine e fascisti scatenano in tutto il Valdarno la più brutale delle reazioni ed i giornali borghesi riportano entusiastiche relazioni di questo tipo: «La sede della cooperativa degli operai, nota come un centro di bolscevismo, è stata subito presa di mira. Essa è situata in un bello stabile di nuova costruzione. I fascisti hanno forzato le porte e si sono precipitati nei locali. È cominciata allora una stranissima pioggia, dappertutto di sedie, panche e scaffali che andavano accatastandosi sul terreno [...] e tutto ha fatto presto a mutarsi in un grandioso falò. Mentre divampavano le fiamme altissime, un altro episodio del genere si svolgeva poco più in basso alla casa del popolo. Anche qui le porte furono sfondate a colpi di calcio di moschetto: irruzione violenta, rottura di vetri, distruzione e poi le fiamme che incominciarono ad uscire anche dalle finestre del primo piano [...] Al fuoco interno faceva riscontro quello esterno alimentato da una parte dei mobili gettati al suolo. Poco dopo anche nello spaccio dei generi alimentari, al piano terreno cominciarono a bruciare gli scaffali» (Il Giornale d’Italia, 24 marzo 1921).
All’opera di repressione intrapresa dai fascisti e dalla forza pubblica seguirà quella della magistratura. Per i fatti di San Giovanni Valdarno nel mese di novembre 1921 il tribunale di Arezzo emetterà 50 condanne con pene variabili da 8 mesi a 5 anni.
Il processo per i fatti di Castelnuovo dei Sabbioni inizierà nel maggio 1923 per concludersi a luglio. Guerra di classe, organo dell’USI, scriverà il 1° agosto 1923: «Giustizia è fatta! La Società Mineraria del Valdarno ha avuto l’intera soddisfazione: per un morto, per qualche ferito e per danni ai propri uffici, ha fatto scaricare sui disgraziati minatori oltre 425 anni di galera, mentre restano impuniti tutti gli incendiari delle case del popolo, delle abitazioni dei minatori e gli assassini dei nostri compagni. Uno dei tanti episodi della guerra civile iniziata dai “ricostruttori” ha avuto il suo epilogo tragico gettando nelle tombe dei vivi 55 proletari che avevano speso la loro giovane esistenza nelle viscere della terra, affrontando ogni ora, ogni minuto il pericolo della morte per estrarre quel fossile che ha arricchito i pescecani della Mineraria».
All’epoca del processo 10 imputati risulteranno ancora latitanti: Otello Gaggi assieme all’amico Vittorio Curzi, come già due latitanti della strage di Empoli, cercheranno riparo in Unione Sovietica. Il Gaggi troverà la morte in un Gulag staliniano, del Curzi non sappiamo quale fu il destino, certo non c’è da sperare niente di buono dal momento che sarà denunciato dal regime staliniano per “attività trotsko-bordighiste”.
Guerra di classe ad Arezzo
Conquistato il Valdarno ed instaurato un regime di terrore, l’offensiva fascista si spostò verso Arezzo dove la borghesia locale attendeva con impazienza il ritorno all’ordine. Il locale giornale borghese, L’Appennino, con il titolo «Via di qua, fate orrore», scriveva: «In questa gentile e mite plaga toscana la cronaca ha da registrare avvenimenti di efferatezza bestiale [...] Da tempo brulicava lassù nei sotterranei meandri delle popolose miniere di Castelnuovo dei Sabbioni un triste fermento d’odio [...] Ma che la triste semenza [...] potesse dare dei frutti di tanta nequizia, questo non potevamo supporlo [...] Via, la gentil Toscana si vergogna, turpissime fiere, di voi» (26 marzo 1921). E a liberare il terreno dalle turpissime fiere intervennero prontamente le squadre fasciste.
Il 6 aprile Mussolini era stato informato della fondazione del fascio aretino con il seguente telegramma: «Il fascio di combattimento aretino oggi costituito invia triplice alalà creatore fascismo».
Nella serata di domenica 10 aprile avvenne uno scontro a fuoco tra operai e fascisti, uno dei quali rimase gravemente ferito. Venuti a conoscenza del ferimento di un loro camerata, i fascisti immediatamente si davano alla caccia degli operai e degli elementi notoriamente sovversivi, aggredendo a bastonate sulla pubblica via numerosi passanti. Giunti in piazza San Iacopo irruppero sparando nel “Bar Americano”, noto ritrovo di proletari. Il giovane comunista Nello Ercolani, che si trovava a passare con la fidanzata, cadeva fulminato da una pallottola e pure la fidanzata rimaneva ferita.
Scriveva Il Comunista: «Più tardi il questore ha fatto uscire forti nuclei di carabinieri e di agenti, allo scopo, inconfessato ma palese, di parare una eventuale reazione dei popolani esasperati. Sono stati operati numerosi arresti» (11 aprile).
Verso mezzanotte arrivarono da Firenze altri camion di fascisti, accolti e salutati dal sindaco con queste parole: «Ricambio cordialmente il saluto dei fascisti fiorentini, espressione del patriottismo italiano» (La Nazione, 12 aprile). Ed i patrioti si misero subito al lavoro assaltando e devastando la Camera del lavoro ed il Circolo ferrovieri.
Il Corriere della Sera con immensa soddisfazione descriveva la devastazione della Camera del lavoro: «I fascisti si sono recati alla sede della Camera del lavoro e l’hanno completamente devastata. Mobili, trofei, registri, bandiere rosse, sono stati gettati dalle finestre [...] trasportati in piazza Guido Monaco quivi alle masserizie venne appiccato il fuoco. Ultimato l’incendio, i fascisti, indrappellati, percorsero le vie della città, cantando i loro inni e chiedendo l’esposizione del tricolore [...] Hanno girato per Arezzo, compiendo perquisizioni nelle abitazioni di qualche individuo sospetto» (12 aprile). Il giornale deve comunque ammettere che «i fascisti sono stati fatti segno a numerose fucilate da parte di alcuni comunisti». Dopodiché squadre di camicie nere irrompono nelle case del deputato Mascagni, del segretario della Federterra e del segretario della Camera del lavoro, i quali furono presi, sequestrati e condotti a forza all’albergo Stella d’Italia, dove i fascisti avevano installato il loro provvisorio quartier generale, e costretti, sotto la minaccia delle armi, a firmare sconfessioni e ritrattazioni. È da notare la delicatezza del Corriere della Sera quando scrive che i tre «furono accompagnati». Non c’è dubbio, i borghesi sanno scegliere sempre le parole più adatte.
Dopodiché l’insieme delle squadre fasciste, coadiuvate dai carabinieri, lanciarono l’attacco al quartiere operaio di Colcitrone. Ma qui il fuoco proletario non fu da meno di quello degli assalitori; la battaglia durò tutta la notte, ma i fascisti non riuscirono a penetrare nelle tortuose stradine dell’Arezzo medievale.
Colcitrone non venne espugnato, ma i fascisti erano comunque ormai padroni della città, non rimaneva che portare il terrore e la distruzione nelle rosse campagne della Valdichiana, e soprattutto Foiano, vera roccaforte rivoluzionaria.
Foiano della Chiana era un centro agricolo, fortemente politicizzato con una buona diffusione della stampa operaia locale e nazionale, soprattutto anarchica e comunista.
Un episodio degno di nota è che ad inizio 1920 si era svolto uno spettacolo teatrale a sfondo “antimilitarista e di beneficenza a favore dei bambini austriaci orfani di guerra”. [Per farsi una idea dell’opera svolta dalle organizzazioni socialiste italiane a sostegno dei bambini affamati di Vienna e di Austria sarà sufficiente vedere il 1° numero del gennaio 1920 di “In Difesa delle Lavoratrici” e l’ Avanti! del 31 dicembre 1919]. Oltre alla sezione socialista, dal maggio 1920 si era costituita quella anarchica, ma «ancora più incisiva si era dimostrata la nascita di una sezione locale del Partito Comunista d’Italia [...] Degli oltre 70 iscritti al PSI in paese, una buona parte (oltre 50), specie i giovani, era passata al PCd’I. Altri ancora, seguaci di Serrati, aderiranno successivamente» (“Sovversivi e Squadristi”). Oltre alle organizzazioni politiche, esistevano quelle di classe: La Società Operaia, la Lega Colonica, le Cooperative Badilanti e quella di consumo. Il sindaco era comunista, così come la maggioranza del consiglio comunale.
La sezione comunista, nel suo rapporto mensile alla Federazione provinciale di Arezzo, il 31 marzo 1921, tra l’altro scriveva: «si è tenuto delle riunioni di capi gruppi delle organizzazioni per studiare un piano di difesa nella evenienza di una visita fascista nella quale riunione ci siamo trovati concordi, e regna molto spirito di vendicazione verso questa marmaglia [...] Il comune politicamente funziona bene, nella Giunta vi è sempre due membri del partito socialista però la maggioranza è nostra [...] Nelle organizzazioni economiche, come vi sarà noto, la maggioranza è nostra».
I contadini di Foiano
Da Arezzo, la mattina del 12 aprile 1921, su 4 camion partirono alla volta di Foiano 150 fascisti, accompagnati da decine di militari in divisa. Il piano dei fascisti era ben noto alle istituzioni tant’è che il questore inviava al Ministero questo fonogramma: «Giunto questa notte Arezzo primo numeroso nucleo fascisti da Firenze. Attende altri nuclei dal Valdarno e da Perugia che giungeranno stamane. Loro proposito è di operare in Valle di Chiana contro le Amministrazioni ed Organizzazioni sovversive».
Al fine di evitare atti di violenza, il maresciallo dei carabinieri aveva consigliato agli esponenti politicamente più in vista, di non accettare le provocazioni e quindi di non farsi trovare in paese. E così avvenne.
I fascisti iniziarono la loro opera vandalica devastando il municipio, passarono poi alle sezioni politiche, alla Camera del lavoro, alla Cooperativa badilanti e terrazzieri, alla cooperativa di consumo dove, oltre che devastare, fecero man bassa di prodotti alimentari. Poi dopo avere bastonato quanti mal capitati si fossero imbattuti in loro e devastato le abitazioni private degli esponenti politici del paese, se ne tornarono alle rispettive sedi senza che le forze dell’ordine nemmeno avessero fatto finta di un minimo intervento. Anzi il prefetto di Arezzo ammise la partecipazione delle forze dell’ordine alla “gita di propaganda” fascista.
Il parroco don Pilade Bigazzi, nel suo Liber chronicus scriveva: «La corrente nazionale contraria al comunismo in particolare e al socialismo in generale, nota sotto il nome di Fasci di combattimento ha fatto la sua comparsa anche in questo paese [...] I fascisti sono giunti in paese con le rivoltelle in pugno, hanno devastato la camera del lavoro, la sede delle leghe, la cooperativa di consumo e perquisito il palazzo comunale nonché varie persone sospette obbligandole a gridare viva l’Italia [...] Che tempi! Che Vergogna! Che barbarie!».
Ma gli agrari fiorentini, i Budini Gattai e altri, proprietari di grandi fattorie nelle vallate aretine, non avevano nessuna vergogna di questa barbarie; covavano un sordo rancore verso quelle amministrazioni comunali che pretendevano di imporre tasse da loro considerate esose ed assecondavano le rivendicazioni delle Leghe contadine. «Per questo, da qualche settimana ormai, il marchese Perrone Compagni aveva iniziato l’invio alle varie giunte comunali di una minacciosa “circolare” con la richiesta perentoria delle dimissioni entro la settimana e della consegna dei “luridissimi vessilli rossi”». L’ultimatum sarebbe scaduto la domenica successiva, il 17 aprile.
Quel giorno prima dell’alba da Arezzo parte un camion con una ventina di fascisti, sono comandati ed armati dal capitano di fanteria G. Fegino, in servizio ad Arezzo. «Ma anche l’armaiolo di Foiano [...] fa del suo meglio concedendo in prestito e in “prova” un imprecisato numero di rivoltelle del tipo buldog» (“Sovversivi e squadristi”).
Giunti a Foiano invadono e devastano nuovamente gli uffici comunali. Poi andando nelle case degli esponenti politici, alcuni dei quali presi nei loro letti, vengono trascinati in strada e selvaggiamente malmenati. Dopodiché si dirigono verso i paesini limitrofi di Pozzo e Marciano portando anche lì la loro opera, invadendo e distruggendo i circoli proletari e percuotendo chiunque gli capitasse tra le mani. Galvanizzati nella loro esuberanza patriottica i fascisti, cantano, urlano e sparano in tutte le direzioni tanto che uno di loro viene colpito all’avambraccio destro. L’incidente li costringe a tornare a Foiano per ricoverare il ferito in ospedale. Nel pomeriggio una parte della squadra resta a tutela del camerata ferito, mentre gli altri componenti della spedizione, dopo aver fatto un’ultima scorribanda per le strade del paese, riprendono la via del ritorno.
Nel frattempo i contadini decidono una risposta e in pochissimo tempo organizzano una imboscata. Racconta Bruno Bini: «Ci organizzammo [...] Andammo per le case ad avvisare la gente. Si fu una trentina. Il nostro armamento consisteva in fucili da caccia» (F. Nibbi, “Antifascisti raccontano”).
Alla frazione Renzino la strada corre tra due siepi di fitto bosso, e lì nascosti dietro le siepi i contadini attendono l’arrivo dei fascisti. Alfredo Burri: «Verso le 3 del pomeriggio ero stato avvisato che si faceva l’imboscata. La cosa non era organizzata, ma fu spontanea, fu un fatto di ribellione ai soprusi e violenze dei fascisti che avevano distrutto le organizzazioni e le cooperative [...] I fascisti arrivarono con un camion, ci mettemmo in posizione, poi si sparò». All’arrivo dei fascisti i contadini da dietro le siepi cominciano a sparare, è colpito l’autista. Il camion fuori controllo finisce in un fosso, sbatte contro un albero e si rovescia. Il capitano Fegino, a capo della spedizione, rimane con una gamba imprigionato sotto il camion. Tre di loro sono uccisi, Fegino si finge morto. Chi non è ferito si dà alla fuga attraverso i campi fino a raggiungere e mettersi in salvo presso una fattoria di proprietà degli agrari Budini Gattai.
La rappresaglia congiunta di carabinieri e fascisti è immediata e soprattutto spietata. Le armi usate dai fascisti per la loro incursione su Foiano erano state fornite dal 19° artiglieria, del 1° genio e dall’84° fanteria. Per quanto riguarda il 19° fanteria risulta che ai fascisti furono dati, in prestito, 50 moschetti e mille proiettili di tipo austriaco.
Il quotidiano fiorentino scriveva: «È vero che concentratesi nel territorio di Foiano imponenti forze fasciste da ogni parte della Toscana e persino da Roma [...] scoppiarono qua e là dei conflitti isolati, ma questi fatti sono una conseguenza della viltà e della ferocia così praticamente e criminalmente dimostrate dai comunisti» (La Nazione, 23 aprile).
Quelli che La Nazione definiva “conflitti isolati”, in realtà furono dei raccapriccianti episodi di brutale violenza. Troppo lungo sarebbe narrare la ferocia (questa sì) scatenata dalla rappresaglia fascista, ci limiteremo a citare quanto, a un anno dai fatti, venne scritto sul nostro quotidiano di partito, Il Comunista del 23 aprile 1922: «Foiano della Chiana! Ad un anno da quelle giornate di terrore e di sangue noi non sappiamo ancora, interamente, quello che fu compiuto laggiù [...] Dopo il conflitto di Renzino, dove un gruppo di contadini esasperati dalle violenze delle squadre fasciste e spinti da un incontenibile, irriflessivo, senso di disperata vendetta, tese un’imboscata a degli autocarri carichi di squadristi, Foiano e le frazioni vicine vennero prese d’assalto da centinaia di fascisti venuti da ogni dove. Corsero qua gli avanguardisti aretini, i primi ad essere sul posto, e poi subito dopo si seguirono nella tragica invasione le squadre fiorentine e quelle della provincia di Siena, e gli uomini di Castellani della lontana Grosseto, e gli schiavisti della provincia di Perugia. Ogni squadra che entrava in Foiano pretendeva la sua parte di vittime [...] I giovani squadristi, con la rivoltella in pugno, ubriachi di violenza e di sangue, misero a ferro e fuoco il povero paese della Chiana. Si uccise senza ragione e senza pietà. I contadini di Renzino dovettero abbandonare tutti, con le loro donne, coi loro bambini, le case prese d’assalto devastate e incendiate. Fuggirono per i campi [...] inseguiti a fucilate da pattuglie di schiavisti. [...] Diversi furono raggiunti e fucilati abbandonati morti o feriti gravemente in mezzo ai loro campi.
«A Foiano, in paese, fu peggio. Tutte le case delle famiglie operaie vengono frugate da cima a fondo [...] I fascisti irrompendo nelle abitazioni revolverarono, sotto gli occhi dei famigliari, questi poveri operai che non erano fuggiti [...] Qualcuno venne trascinato sulla piazza del paese e lì, dopo un orribile giudizio sommario di un ridicolo tribunale improvvisato, addossato ad un muro e fucilato.
«Qualcosa di inimmaginabile e di infernale. Si ricordano degli episodi terribili. Anche una donna [...] fu bastonata ferocemente prima e poi impiccata.
«Così si vendicarono tre caduti fascisti! Quanti furono i morti? [...] Forse trenta, ma c’è chi dice che siano stati invece più di quaranta.
«I fascisti sotterravano, squadra per squadra, rappresaglia per rappresaglia, le vittime. Così che di quelli che mancano nelle famiglie [...] non si conosce la sorte. Forse sono fuggiaschi lontano, [...] forse invece sono sepolti in qualche campo vicino. C’è tanto orrore in questa gesta di banditi che non si sa ridire».
107 saranno i denunciati, contadini ed operai, per l’agguato di Renzino e secoli di galera verranno inflitti con sentenza dell’11 dicembre 1924 dal tribunale ai ritenuti colpevoli della morte dei tre assassini fascisti. Per le gesta fasciste non ci sarà nessuna condanna, nessuna denuncia, nessuna indagine.
«Il fascio fiorentino ha deliberato di insignire di medaglia argentea quanti fra i suoi soci hanno partecipato a quelle gesta gloriose [...] I fascisti celebrano la vittoria. Saranno premiati, colla memorabile medaglia sedici egregi galantuomini, i quali potranno portare, d’ora innanzi, alteramente sul petto il segno del loro valore con sopra inciso il motto: “A chi ardì, Non ordì - Arezzo, Foiano”» (Avanti!, ed. romana, 10 luglio 1921).
La complicità del Partito Socialista
Abbiamo qui solo una breve e molto incompleta sintesi del coraggio generoso dei lavoratori e dei comunisti, sopraffatti solo dalla forza maggiore della classe dominante, che, nel suo terrore mortale, si volse ad atroci vendette di classe borghese contro il proletariato, perpetrate, anche nella provincia di Arezzo, dalle milizie regolari e irregolari al suo servizio. La stessa cosa ogni giorno si ripeteva in ogni parte d’Italia.
Ma per completare il quadro della situazione dobbiamo pure evidenziare quale fosse l’atteggiamento del partito socialista di fronte a questo terrore dispiegato e quali le sue direttive al proletariato.
Il giornale delle donne socialiste, “La Difesa delle Lavoratrici”, scriveva il 14 maggio 1921: «La borghesia già pregusta la vittoria: i pugnali, le bombe, gli incendi sono state le sue armi [...] Donne proletarie, sapete che si combatte una lotta a sangue: sarà questa l’avanzata verso maggiori conquiste e radiose vittorie, oppure la ritirata disastrosa [...] Ricordate, o donne proletarie, che la borghesia non si è arrestata dal sacrificare in questa lotta, alla propria ferocia, donne e bambini proletari [...] Compagne, oggi diciamo soltanto: Guai ai vinti! Perciò si deve ricordare e ricordando si deve vincere!». Quale comunista non avrebbe potuto far proprie queste parole e questi incitamenti!
Ma in che modo il partito socialista auspicava la vittoria e “l’avanzata del proletariato verso maggiori conquiste e radiose vittorie”? È il titolo stesso dell’articolo a tutta pagina che lo dice: «Donne lavoratrici, mandate alle urne i vostri uomini perché salvino il proletariato dalla violenza borghese».
Il santone Filippo Turati non cessava di ripetere il rifiuto di ogni tipo di violenza, perché «tutti i morti di questa incivilissima guerra civile, qual che sia la loro coccarda, sono tutti innocenti, sono tutti vittime di pari grado. E gli assassini, tutti assassini ad un modo». L’operaio o contadino, prelevato in piena notte nella sua abitazione e ucciso a freddo, e lo squadrista fatto fuori nel pieno di un’azione criminale, per i socialisti erano entrambi vittime innocenti.
Ma per di più Turati accusava gli operai di avere essi provocato questa sanguinosa guerra civile. «Quando voi, operai [...] decideste la violenta occupazione delle fabbriche [...] era fatale che, passato il primo sgomento, gli avversari si prevalessero di ogni arme per mettervi, per un lungo periodo, nella impossibilità di ricominciare». Come dire: ve la siete cercata. Per Turati era chiaro che la classe operaia era vittima di «una infatuazione di violenza [che] ci venne dall’estremo nord-est dell’Europa» (Citazioni tratte da “Critica Sociale” del 16 aprile 1921).
Il medesimo santone, dopo un eccidio di contadini pugliesi, il 26 aprile indirizzava questa lettera al sindaco di Barletta: «Un’ora lugubre passa su di voi, contadini delle Puglie; passa ugualmente sui vostri fratelli di quassù. Nel Polesine, nel ferrarese, in tutta la valle Padana, nella mite Toscana, nella Umbria gentile, e altrove e altrove [...] infuria l’uragano [...] Non raccogliete le provocazioni, non fornite pretesti, non rispondete alle ingiurie. Siate buoni, siate pazienti, siate santi [...] Tollerate, compatite, perdonate». Il testo di questo appello “evangelico” fu pubblicato sull’Avanti! del 3 maggio dell’edizione romana e del 4 maggio dell’edizione nazionale. La sintesi della dottrina del santone: «Io ho sempre predicato che è meglio essere uccisi che uccidere».
Ma a Turati dobbiamo dare atto di non aver mai ipocritamente nascosto il suo pensiero, a differenza dei dirigenti del socialismo massimalista, rivoluzionari a parole e, di fatto, complici della borghesia.
(continua al prossimo numero)
L’operazione Faustschlag
La situazione per l’Ucraina si complica, durante le trattative di pace a Brest-Litovsk, con la firma della pace separata tra l’effimero governo della Rada ucraina e gli Imperi Centrali. I tedeschi, con il pretesto di difendere l’indipendenza degli ucraini, scesero in campo in una offensiva militare con due obiettivi: primo far pressione sul governo bolscevico per una pace immediata, al fine di liberare truppe dal fronte orientale e trasferirle sull’occidentale, secondo instaurare a Kiev un governo fantoccio e impadronirsi delle materie prime e del grano ucraino, necessari a sostenere l’impegno militare ad occidente.
L’operazione Faustschlag (punzone), anche detta Guerra degli undici giorni, fu lanciata il 18 febbraio 1918 solo 9 giorni dopo la pace con la Rada ucraina. Mobilitò 29 divisioni di fanteria e 4 di cavalleria per un totale di 230.000 uomini della milizia territoriale agli ordini del generale Max Hoffmann. Una innovativa tattica prevedeva l’utilizzo sulla rete ferroviaria russa di convogli blindati e mezzi motorizzati per un rapido avanzamento di stazione in stazione in territorio sovietico. L’attacco si sviluppò lungo tre direttrici: a nord nei Paesi baltici in direzione della capitale Pietrogrado, al centro attraverso la Bielorussia alla volta di Smolensk, a sud nell’Ucraina con obiettivo Kiev.
Le truppe di Hoffmann avanzarono con rapidità, per la debole resistenza russa, a causa anche dello sfavorevole rapporto numerico, in alcune situazioni di circa 1 a 10.
Le 16 divisioni assegnate alla direttrice settentrionale già il primo giorno occuparono l’importante città di Daugavpils, e il 28 febbraio avevano completato l’occupazione della Lettonia e dell’Estonia, attestandosi lungo la linea che congiungeva Narva con Pskov. Il 25 febbraio i tedeschi avevano occupato Tallin, in Estonia, inserendola nell’amministrazione militare del Ober Ost.
Al centro, la 10a armata tedesca avanzò in profondità in Bielorussia occupando il 21 febbraio Minsk, dove fu fatto prigioniero il quartier generale delle forze locali russe.
Più a sud, gli austro-tedeschi misero rapidamente in rotta le forze sovietiche del settore meridionale, conquistando Žytomyr il 24 febbraio e Kiev il 2 marzo. Il giorno dopo fecero il loro ingresso in città le truppe della Rada ucraina, nonostante i precedenti accordi con gli attaccanti avessero stabilito il contrario.
Le forze degli Imperi Centrali nel giro di poche settimane erano penetrate per più di 240 chilometri in territorio russo, arrivando ad attestarsi a poco più di 100 chilometri da Pietrogrado. Il governo comunista decise di trasferirsi a Mosca.
Dopo il crollo del fronte, e nonostante la grave situazione generale interna, non solo sul terreno militare, una consistente parte della dirigenza bolscevica era ancora intenzionata a proseguire la guerra. Solo dopo un faticoso travaglio alla fine si giunse alla decisione di rinviare la delegazione russa a Brest-Litovsk, per infine firmare il 3 marzo 1918 il trattato di pace definitivo, a condizioni ancor più sfavorevoli delle precedenti.
Riassumiamo lo sviluppo delle trattative per quanto riguarda questa esposizione.
Dopo un primo armistizio generale nel dicembre 1917 tra gli Imperi Centrali e l’appena formato governo della Repubblica Socialista Federativa Sovietica, le trattative per un trattato di pace tra i due contendenti si aprirono a Brest-Litovsk il 22 dicembre.
Fin dall’inizio le parti rimanevano su posizioni molto distanti: il governo russo puntava su una pace “senza annessioni e senza indennità”, mentre gli Imperi Centrali avanzarono pretese sui territori occupati tra il 1914 e il 1916 e sottratti all’ex Impero russo: la Polonia, la Lituania e la parte occidentale della Lettonia.
Da parte dello Stato tedesco, che aveva già iniziato un consistente ritiro di truppe, c’era invece la fretta di concludere l’offensiva finale e risolutiva sul fronte occidentale prima che le truppe degli Stati Uniti d’America, da poco entrati nel conflitto, partecipassero ai combattimenti. Nella necessità di pacificare il fronte russo, si cercava mediante un rapido e deciso attacco di forzare il governo dei Soviet a una pace immediata.
All’apertura dei colloqui per il trattato di pace, e di fronte alle sue gravose responsabilità, il partito bolscevico giunse con due posizioni contrapposte: firmare la pace subito, ad ogni costo, per salvare la rivoluzione in Russia, e dare un segnale di discontinuità rivoluzionaria e di classe ai proletari che marcivano nelle trincee di Europa, sostenuta da Lenin, e quella di proseguire la guerra ritenendo imminente la rivoluzione in Germania, con la quale saldarsi ed estendere la rivoluzione.
Trotski, capo delegazione, puntava a ritardare il più possibile le trattative nell’attesa della rivoluzione in Germania la quale, saldandosi con quella russa, avrebbe, oltre che costretto il governo tedesco a una precipitosa uscita dalla guerra, inflitto una pesante sconfitta al capitalismo europeo, ormai giunto alla sua fase suprema dell’imperialismo. Trotski, secondo la sua formula “né pace né guerra”, senza sanzionare una formale conclusione delle ostilità, annunciò il 28 gennaio 1918 che la RSFS Russa considerava la guerra finita. Questa posizione, che aveva maggior seguito, era sostenuta principalmente da Bucharin.
Era chiaro a tutto il partito che la rivoluzione in Russia e la fine della guerra con una pace accettabile e la rivoluzione in Europa erano parti di un processo unico e inseparabile. Diverso era solo il modo di conseguirlo.
Il trattato di Brest-Litovsk
Nel settembre 1917, Lenin in “Il marxismo e l’insurrezione” così si era espresso nel caso che nessun Stato belligerante accettasse la proposta di armistizio: «Se la nostra offerta di pace sarà respinta e se non otterremo neppure un armistizio allora noi diventeremo “difensivisti”, ci porremo alla testa dei partiti della guerra, diventeremo il principale partito “della guerra”, faremo la guerra in modo veramente “rivoluzionario”. Noi toglieremo ai capitalisti tutto il pane e tutte le scarpe. Non lasceremo loro che delle croste, non daremo loro che dei lapti (calzature dei contadini poveri russi fatte di scorza d’albero n.d.r.). Il pane e le scarpe li invieremo al fronte».
Subito dopo la rivoluzione, l’8 novembre, il partito ordinò al generale Duchonin, comandante in capo sul fronte tedesco, di avanzare al comando nemico una proposta di armistizio su tutti i fronti. Al suo rifiuto, fu immediatamente sostituito dal bolscevico Krylenko. Duchonin fu poi linciato da una folla inferocita di soldati. La proposta venne accolta e il 19 novembre la delegazione sovietica per l’armistizio, diretta da Joffe, con Kamenev, Sokolnikov, alcuni esperti militari, un operaio e un contadino si incontrò a Brest-Litovsk di fronte ad un’imponente delegazione tedesca agli ordini del generale Hoffmann, l’ideatore della recente operazione della guerra degli 11 giorni.
L’armistizio, valido 28 giorni, fu firmato il 2 dicembre; lasciava ai tedeschi tutto il territorio da loro occupato comprese le strategiche isole dello stretto di Moon, ora Muhu, in Estonia. Furono introdotte due importanti clausole non militari: nella prima il comando tedesco accettava di non approfittare della cessazione delle ostilità per trasferire truppe sul fronte occidentale, nella seconda di permettere la fraternizzazione di gruppi di 25 soldati alla volta da entrambi i fronti, lo scambio di giornali e generi di consumo.
Le trattative formali per il trattato di pace iniziarono a Brest-Litovsk il 9 dicembre.
Il governo di Londra protestò vigorosamente contro la firma di una pace separata con gli Imperi Centrali perché ciò contravveniva ai precedenti accordi tra i paesi della Triplice Intesa accettati dallo zar Nicola II.
Nel primo giro di consultazioni i tedeschi accettarono formalmente la pace senza annessioni né riparazioni, ma reclamavano che la Lituania, la Curlandia e parti della Lettonia, 18 provincie, fossero distaccate dalla Russia. Inoltre Hoffmann contestò la clausola della propaganda comunista e la fraternizzazione verso le armate tedesche.
Trotski applicò subito la tattica di allungare nel tempo le trattative nella attesa che la rivoluzione potesse scoppiare anche in Austria e Germania prima che il governo sovietico fosse costretto a prendere decisioni critiche che avrebbero potuto ostacolarla.
Ma il 5 gennaio il generale Hoffmann, spazientito, presentò una carta su cui era segnata una linea oltre la quale le armate tedesche non intendevano ritirarsi: in mano tedesca era tutta la Polonia, la Lituania e la Bielorussia; la Lettonia tagliata in due con le isole dello stretto di Muhu, che permettono il controllo dell’accesso settentrionale al golfo e al porto di Riga.
Trotski riuscì ad ottenere un altro rinvio di 10 giorni per le necessarie consultazioni col governo dei soviet, dove si aprì un acceso dibattito.
Nella riunione dell’8 gennaio nel comitato centrale del partito si delinearono tre posizioni. Quella di Lenin, consapevole che in quel momento, con un esercito del tutto disgregato, la rivoluzione russa sarebbe stata schiacciata dalle baionette tedesche, concludeva che bisognava firmare la pace come esigenza momentanea per difendere una rivoluzione ancora fragile.
Così ammonisce Lenin nello scritto “Su un terreno pratico”: «Il solo entusiasmo non basta per fare la guerra contro un avversario come l’imperialismo tedesco. Sarebbe una grandissima ingenuità, addirittura un delitto, prendere alla leggera questa che è una guerra vera, dura e sanguinosa. La guerra bisogna farla sul serio, o non farla affatto. Vie di mezzo non ce ne possono essere [...] Per fare la guerra seriamente sono necessarie retrovie fortemente organizzate. Il migliore degli eserciti, gli uomini più fedeli alla causa della rivoluzione saranno senza scampo battuti dal nemico, se non verranno armati, riforniti, addestrati in misura sufficiente [...] In che stato si trovano le retrovie del nostro esercito rivoluzionario? Nello stato più pietoso per non dire di peggio [...] L’Esercito rosso è indubbiamente un magnifico materiale da combattimento, ma è un materiale grezzo, non rifinito. Per non farne carne da cannone per le armi tedesche, bisogna istruirlo e disciplinarlo» (Opere, Vol. 27).
Poi abbiamo la posizione di Trotski: “finire la guerra senza firmare la pace”, con cui affermava che, benché la guerra non dovesse essere ripresa, non era giusto né necessario concludere una pace sulla base dei termini tedeschi.
A questa posizione Lenin poi rispose nel “Discorso conclusivo al dibattito sulla guerra e la pace” pronunciato l’8 marzo pochi giorni dopo la firma della pace: «Nella attività di Trotski bisogna distinguere due aspetti: quando cominciò le trattative di Brest, sfruttandole magnificamente per l’agitazione, noi eravamo tutti d’accordo con il compagno. Egli ha citato una parte di colloquio avuto con me, ma io aggiungo che fra di noi era stato stabilito di tenere duro fino all’ultimatum dei tedeschi e di cedere però dopo l’ultimatum [...] La tattica di Trotski, fin tanto che portava a tirare in lungo le trattative, era giusta: essa è diventata sbagliata quando si dichiarò cessato lo stato di guerra senza che la pace fosse stata firmata. Io proposi in modo assolutamente preciso di firmare la pace. Non potevamo ottenere una pace migliore di quella di Brest».
Infine abbiamo i “comunisti di sinistra” guidati da Bucharin che proponevano di respingere il diktat tedesco e iniziare una guerra rivoluzionaria.
Lenin in “Strano e mostruoso” scrive alcuni giorni prima della firma del trattato: «Forse gli autori che ritengono che gli interessi della rivoluzione internazionale esigono che questa venga stimolata, e che un tale stimolo potrebbe essere soltanto una guerra e in nessun modo la pace, che potrebbe produrre nelle masse l’impressione di una specie di “legittimazione” dell’imperialismo? Una simile “teoria” sarebbe in assoluto contrasto con il marxismo, che ha sempre negato la possibilità di “stimolare” le rivoluzioni, le quali si sviluppano a mano a mano che si inaspriscono le contraddizioni di classe che si generano. Una simile teoria equivarrebbe ad affermare che l’insurrezione armata è una forma di lotta obbligatoria sempre ed in qualsiasi condizione [...] Il rifiuto di firmare la più obbrobriosa delle paci quando non si ha un esercito è un’avventura, di cui il popolo accuserà a buon diritto il potere che abbia opposto un tale rifiuto».
Ancora Lenin in “Una lezione seria e una seria responsabilità”: «I nostri pseudo-“sinistri” [...] tentano di eludere la lezione o le lezioni della storia [...] si fanno in quattro [...] per presentare la teoria della “tregua” come una “teoria” cattiva e senza fondamento. Ahimè! I loro sforzi non riescono a confutare i fatti. I fatti sono testardi. È un fatto che dal 3 marzo, quando i tedeschi hanno cessato le operazioni militari, fino al 5 marzo [...] noi abbiamo già approfittato di questi due giorni per la difesa pratica (non con le frasi, ma con i fatti) della patria socialista. Questo è un fatto che diverrà ogni giorno più evidente alle masse. È un fatto che, nel momento in cui l’esercito al fronte fugge in preda al panico abbandonando i cannoni, senza riuscire a far saltare i ponti, incapace di combattere, la difesa della patria e il rafforzamento della sua capacità difensiva si attuano non con chiacchiere sulla guerra rivoluzionaria (chiacchiere che sono semplicemente vergognose, mentre l’esercito fugge in preda a un tale panico e i fautori della guerra rivoluzionaria non sono riusciti a trattenere nemmeno uno dei suoi reparti), ma compiendo una ritirata in buon ordine per salvare i resti dell’esercito, e approfittando a questo scopo di ogni giorno di tregua».
Il Comitato centrale, tre giorni dopo, l’11 gennaio, prese le decisioni da impartire a Trotski: Lenin riaffermò il suo atteggiamento in favore di una pace immediata.
Mentre Trotski era in viaggio da Pietrogrado, il 15 gennaio a Berlino scoppiarono dimostrazioni contro la guerra diffondendosi anche in altri centri; sembrò per un momento che l’ottimismo dei bolscevichi e la politica di procrastinazione di Trotski stessero per essere validati dagli avvenimenti.
Malauguratamente i moti in Germania, che costituivano la forza invisibile di sfondo ai negoziati, si esaurirono e il 28 gennaio, mentre i tedeschi spazientiti preparavano un ultimatum, Trotski intervenne annunciando: «la Russia, mentre si rifiuta di firmare una pace annessionistica, da parte sua dichiara finito lo stato di guerra con la Germania, l’Austria-Ungheria, la Turchia e la Bulgaria. La sera stessa i delegati sovietici lasciarono Brest-Litovsk per Pietrogrado. Giudicando dallo stato di confusione ed irritazione in cui lasciarono i loro avversari, ad essi sembrò di avere riportato una notevole vittoria» (Carr).
Invece da parte tedesca ciò fu considerato come una rottura dei negoziati e la fine dell’armistizio. Il 17 febbraio Hoffmann comunicò ai russi per il giorno seguente la ripresa delle operazioni militari. Si verificava la situazione prevista da Lenin.
La prospettiva di Bucharin circa l’impossibilità per i tedeschi di attaccare cadeva miseramente. Questa è la dura critica di Lenin in “Una lezione seria e una seria responsabilità” scritta alcuni giorni dopo: «I fatti sono testardi. E i fatti dicono che Bucharin ha negato la possibilità dell’offensiva tedesca, ha seminato illusioni con cui di fatto, contro la sua volontà, ha aiutato gli imperialisti tedeschi e ha ostacolato i progressi della rivoluzione tedesca. Appunto in questo consiste l’essenza della frase rivoluzionaria. Credere di andare in una direzione e va in un’altra [...] N. Bucharin mi rimprovera di non esaminare concretamente le condizioni della pace attuale [...] Mi bastava dimostrare che il nostro dilemma reale, non immaginario, era uno solo: o queste condizioni che ci lasciavano un momento di respiro almeno per qualche giorno, o la situazione del Belgio e della Serbia [...] Vi avevano dato le condizioni di Brest, e voi avete risposto con fanfaronate e rodomontate, facendo sì che le condizioni son divenute peggiori. Questo è un fatto. E la responsabilità di questo non ve la potete togliere [...] (Abbasso le fanfaronate! Lavoro serio, disciplina e organizzazione!» (5 marzo).
Il 23 febbraio Hoffmann alza la posta, richiedendo al governo sovietico di ritirare le truppe dall’Ucraina e di concludere la pace con la Rada ucraina, inoltre di evacuare la Lettonia e l’Estonia per permetterne l’occupazione dalle forze tedesche.
Abbiamo scritto nella nostra “Struttura” russa, del 1956:
«La delegazione Trotski ritornò con la notizia che non aveva accettato di firmare la pace il 10 febbraio. Ma già la questione era stata discussa in una conferenza di 63 bolscevichi, tenuta il 21 gennaio cui era stato chiamato Trotski. La tesi di Lenin di firmare la pace come i tedeschi volevano fu battuta avendo avuto solo 15 voti. Ne ebbe 16 la tesi né guerra né pace di Trotski. La maggioranza assoluta, 32 voti, seguì la tesi Bucharin per il rifiuto della firma e la proclamazione di una guerra rivoluzionaria. Il 24 gennaio la discussione tornò avanti al Comitato Centrale del Partito. Lenin propose di non rifiutare la firma, ma tirare in lungo le trattative: 12 sì, 1 no. Trotski insistette nella proposta: rifiuto di firma, smobilitazione, con 9 sì e 7 no.
«Il 25 gennaio si discute ancora in una riunione comune agli esserre di sinistra. La maggioranza decide di sottoporre al Congresso dei Soviet la formula: né guerra né pace.
«Il 10 febbraio, come detto, rientra la delegazione che ha applicato questo indirizzo, contro il parere di Lenin ma non contro quello della maggioranza. Krilenko che aveva il comando supremo ordina la smobilitazione. Le condizioni militari in linea tecnica erano così palesi, che nessuno si oppose.
«Quando si seppe che i tedeschi, dopo una conferenza presieduta dal kaiser Guglielmo ad Amburgo, avevano ripresa l’avanzata, fu ancora riunito il Comitato Centrale il 17 febbraio. La proposta tedesca di riprendere i negoziati e firmare fu rigettata con 6 voti contro 5. Non vi furono voti per la guerra rivoluzionaria, ma solo l’astensione di Bucharin, Joffe e Lomov.
«Il 18 febbraio in una lunga seduta, prima sostennero la firma Lenin e Zinoviev, il diniego Trotski e Bucharin, e la proposta di trattare fu respinta con sette voti contro sei: più tardi si decise l’invio di un telegramma che offriva la pace alle vecchie o anche diverse condizioni, con l’approvazione di Lenin, Smilga, Stalin, Sverdlov, Trotski, Zinoviev, Sokolnikov, con 5 no e un’astensione. La risposta venne il 23. Il Comitato Centrale votò l’accettazione con 7 voti contro i quattro di Bucharin, Bubnov, Uritsky e Lomov. Si votò tuttavia la preparazione alla guerra rivoluzionaria. Il 3 marzo si ebbe la pace.
«Al 6-9 marzo la polemica scoppiò violenta al settimo Congresso del Partito, e fu approvata, contro la viva opposizione della frazione Bucharin, l’accettazione della pace di Brest. La risoluzione di Lenin ebbe 30 voti, contro 13 no e 4 astenuti. A questo congresso il partito prende il nome di Comunista (bolscevico), come proposto un anno prima da Lenin.
«Al Terzo Congresso dei Soviet la questione ritorna e, stavolta, sono all’opposizione anche i socialrivoluzionari di sinistra: la coalizione viene rotta e questi passano all’opposizione più decisa contro il governo bolscevico. Siamo al 15-17 marzo; viene formato diversamente il governo, con Cicerin Commissario per gli Esteri, Trotski per la Guerra».
Lenin in “Una lezione dura ma necessaria”, pubblicato sulla Pravda il 24 febbraio, in modo molto chiaro esplicita il concetto di difesa della patria socialista:
«Appunto perché siamo per la difesa della patria, esigiamo un atteggiamento serio nei confronti della capacità difensiva e della preparazione militare del paese. Noi dichiariamo una guerra implacabile alla frase rivoluzionaria della guerra rivoluzionaria [...] È un delitto, dal punto di vista della difesa della patria, intraprendere un conflitto armato con un avversario infinitamente più forte e preparato quando è evidente che non si ha un esercito. Noi siamo costretti a firmare, dal punto di vista della difesa della patria, la pace più dura, iugulatoria, crudele, vergognosa, per non “capitolare” di fronte all’imperialismo, ma per imparare e prepararci a combattere contro di esso in modo serio ed efficace [...] Un paese contadino, condotto a un impressionante sfacelo da tre anni di guerra, che ha cominciato la rivoluzione socialista, deve evitare il conflitto armato – deve evitarlo finché è possibile, anche a costo dei più duri sacrifici – proprio per avere la possibilità di fare qualcosa di serio nel momento in cui divamperà “l’ultima, decisiva battaglia”.
«Questa battaglia divamperà solo quando la rivoluzione socialista si diffonderà nei paesi imperialisti avanzati. Questa rivoluzione, non v’è dubbio, matura e si rafforza ad ogni mese, ad ogni settimana che passa. Questa forza che si matura deve essere aiutata. Bisogna saperla aiutare. Non la si aiuta, ma la si danneggia, mandando alla disfatta la vicina repubblica socialista sovietica nel momento in cui essa manifestamente non ha un esercito.
«Non bisogna trasformare in una vuota frase la grande parola d’ordine “Noi puntiamo sulla vittoria del socialismo in Europa”. Questa è la verità, se si ha in mente la lunga e difficile via che il socialismo deve percorrere per vincere fino in fondo. È una verità indiscutibile, storico-filosofica, se si prende tutta “l’era della rivoluzione socialista” nel suo complesso. Ma ogni verità astratta diventa vuota frase se la si applica in qualsiasi situazione concreta. È indiscutibile che “in ogni sciopero si nasconda l’idra della rivoluzione sociale”. È assurdo però pensare che da ogni sciopero si possa subito passare alla rivoluzione. Se noi “puntiamo sulla vittoria del socialismo in Europa” nel senso che ci prendiamo la responsabilità di dire al popolo che la rivoluzione europea divamperà e vincerà immancabilmente nelle prossime settimane, immancabilmente prima che i tedeschi riescano a raggiungere Pietrogrado, Mosca, Kiev, riescano a “distruggere” i nostri trasporti ferroviari, allora agiamo non come seri internazionalisti rivoluzionari ma come avventurieri.
«Se Liebknecht vincerà la borghesia in due o tre settimane (la cosa non è impossibile), ci libererà da tutte le difficoltà. Questo è indubbio. Ma se noi determiniamo la nostra tattica di oggi nella lotta con l’imperialismo di oggi in base alla speranza che Liebknecht con tutta probabilità debba vincere proprio nelle prossime settimane, allora ci meriteremo solo la derisione. Trasformeremo le più grandi parole d’ordine rivoluzionarie della nostra epoca in una vuota frase rivoluzionaria».
Trotski espose ancora una volta le sue obiezioni ma per quanto non fosse convinto, quando ebbe luogo la votazione decisiva, Trotski, Joffe, Krestinskij e Dzerzhinski, si astennero, permettendo così che la mozione di Lenin per l’accettazione delle condizioni tedesche venisse approvata con 7 voti (Lenin, Zinoviev, Sverdlov, Stalin, Sokolnikov, Smilga, Stasova) contro 4 (Bucharin, Lomov, Bubnov e Urickij).
La notte stessa alle 4,30 di mattina del 24 febbraio, dopo un efficace discorso di Lenin, la proposta fu approvata. La delegazione diretta questa volta da Sokolnikov, e Čičerin partì per Brest-Litovsk per firmare il trattato di pace, che fu siglato il 3 marzo.
Continuammo a scriveremo nella “Struttura”:
«Si sperava nella reazione dei proletari di Germania ed Austria, si sperava che l’esercito tedesco non avrebbe ripreso una avanzata di invasione. Ma così non fu. Il generale Hoffmann, cinque giorni dopo l’ultima seduta, violando il convenuto termine di sette giorni, dichiarò spirato l’armistizio e ricominciò le operazioni. Il fronte russo si sfaldò totalmente. I controrivoluzionari finlandesi e ucraini invocarono le baionette tedesche per resistere ai bolscevichi che li avevano sopraffatti. La minaccia gravava su Pietrogrado. Il 19 febbraio per radio il governo russo si dichiara pronto a firmare una qualunque pace dettata dai tedeschi, che non si arrestano e solo il 23 comunicano le nuove tremende condizioni. Il 28 febbraio la terza delegazione, diretta da Sokolnikov, giunge a Brest Litovsk: il 3 marzo 1918 finalmente la pace-capestro è firmata. Passavano alla Germania Estonia, Lettonia e Polonia, l’Ucraina ne diveniva Stato vassallo, una indennità doveva venire pagata dalla Russia. Ma tutto ciò sul quadrante della storia era destinato a durare solo pochi mesi, fino al crollo tedesco nel novembre e all’armistizio generale con gli occidentali vittoriosi. La crisi di Brest Litovsk aveva in sostanza fiaccato internamente la Germania e non la Russia [...]
«La chiusura della guerra era un traguardo fondamentale, forse il più vitale, di una lunghissima lotta, che durava dal 1914 e in un certo senso dal 1900. Era indispensabile che questo caposaldo fosse a qualunque costo stabilito: la guerra imperialista e zarista è finita: il tradimento social-sciovinista è stato stritolato; ed era tanto un caposaldo della rivoluzione russa quanto, e sopra ogni altra cosa, della rivoluzione internazionale. Non sarebbero mancate lotte e guerre civili per la difesa della rivoluzione e delle vittorie di Ottobre: Lenin lo sapeva e chiaramente lo disse.
«Ma Brest fu una tappa del cammino che doveva condurre dalla guerra imperialista alla guerra civile in ogni paese, come dichiarato nel 1914, e anche prima, dal marxismo rivoluzionario. E il proletariato tedesco dette con Spartaco nel 1918, alla fine di quel tremendo anno, la prova di avere inteso l’impegno che gli derivava dallo strazio consumato con la “pace obbrobriosa”, cui il bolscevismo e Lenin ebbero il gigantesco coraggio di mettere deliberatamente la propria firma nello storico tre marzo di Brest. Fu la controparte stipulante e trionfante, che presto la storia pose al tappeto.
«Alla tappa di Brest la Rivoluzione Europea era in marcia gloriosa. Sulla linea politica rivoluzionaria, il potere russo di Ottobre ne teneva in pugno da solo, e con tutti i crismi, la rossa bandiera».
Alla firma del trattato l’esercito degli Imperi Centrali era avanzato fino ad una linea che partiva a nord da Narva fino a Kiev. In forza di alcune clausole i tedeschi poterono estendere l’occupazione all’intera Ucraina fino a Rostov sul Don. Truppe tedesche furono inviate in Finlandia che, proclamatasi indipendente dalla Russia, era in preda ad una guerra civile tra nazionalisti e comunisti locali. Un altro contingente tedesco fu inviato nelle regioni del Caucaso, e successivamente in Crimea, occupando la strategica base di Sebastopoli. La Russia sovietica dovette inoltre cedere la Finlandia, i tre paesi baltici, la Polonia, la Bielorussia e l’Ucraina.

La Germania intendeva costituire una cintura di Stati satellite attorno alla Russia rivoluzionaria, formalmente indipendenti ma subordinati ai suoi interessi economici e politici; progetto poi annullato dalla sconfitta della Germania nel novembre 1918. Altra importante clausola riguardava le basi navali russe, esclusa Kronštadt, acquisite dalla Germania con le navi colà riparate. Molte di queste furono autoaffondate dagli equipaggi russi. Al governo dei Soviet fu richiesto di rilasciare immediatamente 630.000 prigionieri di guerra austro-ungarici, che secondo le intenzioni di Vienna avrebbero dovuto rimpiazzare le perdite sul fronte occidentale.
Condizioni pesanti ed inaspettatamente umilianti per la Russia, che perderà la Polonia Orientale, la Lituania, la Curlandia, la Livonia, l’Estonia, la Finlandia, l’Ucraina e la Transcaucasia, quasi un quarto della sua superficie con circa 56 milioni di abitanti, un terzo della propria popolazione. La Turchia inoltre impose all’ultimo momento delle richieste territoriali nel Caucaso con la cessione dei distretti strategici di Kars, Batum e Ardahan. Ad eccezione dell’Ucraina, il territorio più vasto e culla dell’impero russo, gli altri territori erano abitati da popolazioni non russe, conquistati dallo zarismo in epoche recenti. In termini produttivi significa un terzo del raccolto, l’80% delle fabbriche di zucchero, del 73% della produzione di ferro, il 75% della produzione di carbone e di 9.000 imprese industriali su un totale di 16.000 e un terzo delle strade ferrate, in tutto circa il 27% del reddito dello Stato.
In seguito ai vari decreti del governo sovietico sul non riconoscimento del
debito estero delle obbligazioni zariste, della nazionalizzazione delle
proprietà dei cittadini stranieri e della confisca delle attività estere, la
Germania impose alla Russia una clausola addizionale, firmata il 27 agosto 1918,
con cui la Russia avrebbe corrisposto 6 miliardi di marchi come compensazione
alle perdite degli interessi tedeschi.
(continua al prossimo numero)
Con l’opera di Smith inizia nella storia della scienza economica quella fase che ebbe il suo centro in Inghilterra e i cui limiti cronologici possono essere fissati dal 1776 al 1848, anno di pubblicazione dei Principi di Politica Economica di John Stuart Mill. Questa corrente di pensiero viene comunemente definita la Scuola Classica, anche se il termine mal si adatta ad economisti che non hanno un vero e proprio “maestro” in comune. A formarne l’edificio è il tentativo di sintetizzare in un modello teorico le tendenze evolutive del sistema elaborando – ognuno con le proprie specificità – una teoria dello sviluppo che si conclude, anche se non esplicitamente e coerentemente, nella legge della caduta tendenziale del saggio di profitto.
A differenza degli epigoni volgari i classici, incentrano lo studio, sull’analisi del sistema economico considerato in costante evoluzione. Le idee liberiste di Smith si adattavano perfettamente al periodo del capitalismo rampante e contribuirono a formare la mentalità capitalistica dei grandi borghesi, a cui sembravano fornire una giustificazione scientifica. I presupposti filosofici di Smith conducono ad implicazioni liberiste: «Ogni individuo cerca per quanto più può d’impiegare il suo capitale nel sostegno dell’industria nazionale e di dirigere questa industria in modo che il suo prodotto possa essere del più gran valore; così necessariamente lavora per rendere l’annuale entrata della società quanto più grande egli può. Veramente in generale egli non intende promuovere il pubblico bene, né conosce quanto egli sia per promuoverlo [...] Col dirigere quell’industria in maniera che il suo prodotto possa essere del più gran valore, attende solamente al suo proprio guadagno, e in questo caso come in molti altri è guidato da una mano invisibile al promuovere un fine al quale non partecipa in nulla per sua intenzione [...] Andando dietro al suo proprio interesse spesso promuove quello della società più efficacemente che quando realmente attendesse a promuoverlo» (“Ricerche sopra la Natura e le Cause della Ricchezza delle Nazioni”).
È vero che crede negli effetti benefici per il singolo e per la società della condotta guidata dalla tendenza a massimizzare il guadagno pecuniario e mette in luce i pericoli degli interventi statali, ma non manca di rilevare i possibili antagonismi fra interesse personale e sociale così giustificando l’azione regolatrice dei poteri pubblici. A tal proposito sostiene che, se nello sviluppo del sistema l’interesse dei proprietari terrieri e quello dei lavoratori coincide sempre con quello della società, quello dei capitalisti comunemente diverge dall’interesse generale. Indica allora come doveri del governo, non solo il provvedere alla difesa dello Stato e alla protezione di ogni membro della collettività dall’ingiustizia, ma anche quello di «fondare e mantenere quelle pubbliche istituzioni e opere le quali, benché possano essere in grado eminente vantaggiose ad una grande società, pure sono di tale natura che il profitto non potrebbe mai rimborsare la spesa ad un piccolo numero di individui o ad uno di loro, e che perciò non può mai sperarsi ch’essi le fondassero o mantenessero».
L’intervento dell’autorità pubblica qui non solo non è dannoso ma è considerato necessario e a tal proposito Smith elenca quelle “opere e istituzioni” che il governo deve sostenere. Per smentire la tesi semplicistica di uno Smith liberista indiscriminato si legga questo brano sulla divisione del lavoro: «Nel progresso della divisione del lavoro l’impiego della maggior parte di coloro che vivono di quello, cioè della massa del popolo, viene ad essere ristretto a poche semplicissime operazioni, sovente ad una o due [...] L’uomo di cui l’intera vita è spesa nel praticare poche semplici operazioni, di cui gli effetti sono fors’anche sempre gli stessi o quasi gli stessi, non ha opportunità di esercitare la sua intelligenza o la sua inventiva nel trovare degli espedienti per rimuovere difficoltà che mai gli occorrano. Egli dunque naturalmente perde l’abitudine di spiegare le sue facoltà e in generale diventa così stupido e ignorante come a creatura umana sia possibile di esserlo [...] Egli è affatto incapace di giudicare dei grandi e vasti interessi del suo paese e, a meno che si siano sopportate delle speciali pene per renderlo altrimenti, egli è ugualmente incapace di difendere il suo paese nella guerra [...] Ora, in ogni società civilizzata ed avanzata questo è lo stato in cui il povero lavorante, cioè la massa del popolo, deve necessariamente cadere, a meno che il governo non si prenda la cura di impedirlo».
2.2. - Due determinazioni del valore
Smith accetta la teoria fisiocratica del salario medio, che egli chiama prezzo naturale del salario. «Un uomo deve necessariamente vivere del proprio lavoro, e il suo salario deve essere almeno sufficiente alla sua sussistenza [...] deve anche essere un po’ superiore, altrimenti egli non avrebbe la possibilità di allevare una famiglia [...]». Lo sviluppo delle forze produttive del lavoro però non va a beneficio dell’operaio. «Il prodotto del lavoro rappresenta la naturale ricompensa o salario del lavoro. In quello stato originario delle cose che precede tanto l’appropriazione della terra quanto l’accumulazione del capitale, l’intero prodotto del lavoro appartiene al lavoratore. Egli non ha né un proprietario fondiario né un padrone con cui dividerlo. Se tale stato di cose fosse continuato, con tutti quegli accrescimenti nella forza produttiva del lavoro a cui la divisione del lavoro ha dato luogo, il salario del lavoro sarebbe aumentato [...] Ma questo stato di cose [...] non poteva durare oltre l’inizio dell’appropriazione della terra e dell’accumulazione del capitale. Pertanto esso ebbe fine molto prima che fossero realizzati i più notevoli accrescimenti nelle forze produttive del lavoro».
L’effettivo grande sviluppo della forza produttiva del lavoro ha inizio solo dal momento in cui questo è trasformato in lavoro salariato e le condizioni di lavoro gli si contrappongono da un lato come proprietà fondiaria, dall’altro come capitale.
Marx scopre che Smith confonde e talora soppianta la determinazione del valore delle merci mediante la quantità del lavoro, necessario e pluslavoro, per la loro produzione, con la quantità di valore di scambio del lavoro con cui il lavoratore salariato le può comprare, che è minore, solo il lavoro necessario. In questo caso egli fa del valore di scambio del lavoro la misura del valore delle merci.
Questo passare dall’uno all’altro modo di spiegazione, dipende da un fattore profondo. Supponiamo che tutti i lavoratori siano produttori di merci. Il valore di queste merci è determinato mediante il tempo di lavoro in esse contenuto. Dunque se le merci vengono vendute al loro valore, il lavoratore, con una merce che rappresenta il prodotto di un tempo di lavoro di dodici ore, ricompra un tempo di lavoro di dodici ore nella forma di un’altra merce. Il valore del suo lavoro è dunque uguale al valore della sua merce. In base a questa ipotesi il valore del lavoro (la quantità di merce che si può comprare con una data quantità di lavoro) potrebbe servire come misura del valore della merce al pari della quantità di lavoro contenuta nella merce, poiché il valore del lavoro rappresenta sempre, oggettivata, la stessa quantità di lavoro richiesta al lavoro vivo per la produzione di questa merce.
Ora però, in tutti i modi di produzione – e particolarmente nel modo capitalistico – nei quali le condizioni oggettive del lavoro appartengono a una o più classi, e la capacità lavorativa a un’altra classe, alla classe lavoratrice, avviene il contrario. Il prodotto, ossia il valore del prodotto del lavoro, non appartiene al lavoratore. La quantità determinata di lavoro oggettivato nella merce è maggiore di quella che è contenuta nel salario.
Poiché Smith parte giustamente dalla merce e dallo scambio di merci in cui i produttori si contrappongono originariamente solo come possessori di merci, gli sembra che nello scambio tra capitale e lavoro salariato, la legge generale venga immediatamente abolita e le merci non si scambino in rapporto alla quantità di lavoro che rappresentano. Da ciò egli conclude che il tempo di lavoro non è più la misura immanente che regola il valore di scambio delle merci, dal momento in cui le condizioni di lavoro si contrappongono al lavoratore salariato nella forma di proprietà fondiaria e capitale.
Sente perciò la difficoltà di dedurre dalla legge che presiede allo scambio delle merci lo scambio tra capitale e lavoro, scambio che, apparentemente, si fonda su principi opposti. La contraddizione però non poteva essere chiarita, finché il capitale veniva contrapposto al lavoro invece che alla capacità lavorativa, alla forza lavoro.
2.3. - La concezione generale del plusvalore
Si passa dal rapporto in cui si suppone che i produttori si trovino di fronte come semplici possessori e venditori di merci, al rapporto di scambio tra possessori delle condizioni di lavoro e possessori della semplice capacità lavorativa. «In quel primo stato informe della società che precede l’accumulazione dei capitali e la proprietà della terra, la quantità di lavoro necessaria per acquistare i diversi oggetti di scambio è, a quel che sembra, la sola circostanza che possa fornire qualche regola per gli scambi».
Dunque il tempo di lavoro necessario alla produzione delle diverse merci determina la proporzione in cui esse si scambiano reciprocamente, ossia il loro valore di scambio. «In questo stato di cose l’intero prodotto del lavoro appartiene al lavoratore, e la quantità di lavoro comunemente impiegata per [...] produrre una merce è la sola circostanza che possa regolare la quantità di lavoro che questa merce dovrebbe comunemente comprare».
Secondo Smith nell’ipotesi in cui il lavoratore è un semplice venditore di merci, con la sua merce egli comanda tanto lavoro dell’altro quanto ne è contenuto nella propria merce, poiché essi si scambiano tra di loro unicamente merci, e il valore di scambio delle merci è determinato dal tempo di lavoro. Ma: «Non appena si sarà accumulato del capitale nelle mani di singole persone, qualcuno [...] lo impiegherà [...] per dar lavoro a persone industriose, fornendole di materie prime e di mezzi di sussistenza, allo scopo di ritrarre un profitto dalla vendita del loro prodotto, ossia da ciò che il loro lavoro aggiunge al valore delle materie prime».
Sorge perciò la domanda sulla provenienza delle “persone industriose” che non possiedono né mezzi di sussistenza né materiali di lavoro. La sua tesi in fondo non significa altro che la produzione capitalistica ha inizio dal momento in cui le condizioni di lavoro appartengono a una classe e a un’altra classe appartiene la possibilità di disporre della capacità lavorativa. Inoltre cosa intende dicendo che coloro i quali impiegano il lavoro utilizzano gli operai «allo scopo di ritrarre un profitto dalla vendita del loro prodotto»? Che il profitto deriva dalla vendita, che la merce viene venduta al di sopra del suo valore? Seguiamolo: «Il valore che gli operai aggiungono alle materie prime si risolve [...] in due parti, di cui l’una paga i loro salari e l’altra paga i profitti dell’imprenditore sulla somma di capitale che gli è servita per anticipare questi salari e le materie prime».
Qui si dichiara apertamente che il profitto che si realizza con la vendita del prodotto finito non deriva dalla vendita stessa, dal fatto che la merce viene venduta al di sopra del suo valore, non è profit upon alienation. Il valore, cioè la quantità di lavoro, che gli operai aggiungono alla materia prima, si divide invece in due parti. L’una paga i loro salari. Con essa gli operai restituiscono una quantità di lavoro pari a quella che hanno ricevuto sotto forma di salario. L’altra parte costituisce il profitto del capitalista; cioè una quantità di lavoro che egli vende senza averla pagata. Dunque, se egli vende la merce al suo valore, cioè la scambia con altre merci secondo la legge del valore, il suo profitto deriva dal fatto che una parte del lavoro contenuto nella merce egli non l’ha pagata.
Smith perciò confuta l’opinione che la circostanza per cui non appartiene più al lavoratore l’intero prodotto del suo lavoro abolirebbe la legge secondo la quale la proporzione in cui le merci si scambiano tra loro, ossia il loro valore di scambio, è determinata dalla quantità del tempo di lavoro in esse materializzato. Egli invece fa sorgere il profitto del capitalista proprio dal fatto che questi non ha pagato una parte del lavoro aggiunto alla merce. Smith fa derivare il profitto dal lavoro che l’operaio compie in eccedenza rispetto alla quantità di lavoro con cui egli ripaga il salario. In tal modo individua la vera origine del plusvalore. In pari tempo ha constatato che il plusvalore non deriva dai fondi anticipati, dal capitale costante, il cui valore riappare tale e quale nel prodotto, ma che deriva esclusivamente dal nuovo lavoro che gli operai aggiungono alle materie prime nel corso del processo di produzione.
Immediatamente però si confonde ed afferma: «Quando il prodotto finito viene scambiato o contro denaro o contro lavoro o contro altre merci». Se il capitalista scambia la merce contro denaro o contro merce, il suo profitto deriva dalla vendita di una quantità di lavoro superiore a quella che ha pagato, dal fatto che egli non scambia una uguale quantità di lavoro oggettivato con una quantità uguale di lavoro vivo. Smith non può dunque mettere sullo stesso piano lo scambio o contro denaro o contro altre merci e lo scambio del prodotto finito contro lavoro in quanto nel primo il plusvalore deriva dall’essere le merci scambiate al loro valore, del quale però una parte non è pagata. Dunque il profitto non è altro che una parte del valore che gli operai hanno aggiunto al materiale con il lavoro. Essi non aggiungono però al materiale altro che una nuova quantità di lavoro.
Il tempo di lavoro dell’operaio si scompone dunque in due parti: l’una per la quale egli ha ricevuto dal capitalista un equivalente, l’altra che egli dà al capitalista gratuitamente e che costituisce il profitto. Smith mette giustamente in rilievo che solo quella parte del lavoro che l’operaio aggiunge al materiale si divide in salario e profitto; dunque il plusvalore creato non ha niente a che fare con la parte di capitale anticipata sotto forma di materiale e di strumenti.
La superiorità di Smith rispetto a Ricardo consiste nell’aver sottolineato come questo si verifichi con l’avvento della produzione capitalistica. È invece inferiore a Ricardo per l’opinione da cui non riesce mai a liberarsi, ossia che con questo mutamento nel rapporto tra lavoro materializzato e lavoro vivo si verificherebbe un cambiamento nella determinazione del valore relativo delle merci, le quali invece non rappresentano altro che lavoro materializzato, quantità date di lavoro prestato.
Dopo aver rappresentato il plusvalore nella sua forma di profitto come parte del lavoro che l’operaio compie oltre alla parte del lavoro che ripaga il suo salario, Smith fa la stessa cosa con l’altra forma del plusvalore, con la rendita fondiaria. Il capitale è una delle condizioni di lavoro oggettive estraniate dal lavoro, e che perciò gli si contrappongono come proprietà altrui; l’altra è la terra in quanto proprietà fondiaria. «Dal momento in cui il suolo è divenuto tutto proprietà privata, piace ai proprietari fondiari, come a tutti gli altri uomini, di raccogliere dove non hanno seminato, ed essi esigono una rendita perfino per il prodotto naturale della terra», così l’operaio «deve cedere al proprietario del suolo una porzione di ciò che raccoglie o che produce col proprio lavoro. Questa porzione [...] costituisce la rendita fondiaria». Smith concepisce dunque il plusvalore, l’eccedenza del lavoro prestato, e realizzato nella merce, sul lavoro pagato, come la categoria generale di cui il profitto e la rendita fondiaria non sono che diramazioni. Tuttavia egli non ha distinto il plusvalore come tale, in quanto categoria particolare, dalle forme specifiche che esso assume nel profitto e nella rendita fondiaria.
Un’altra forma in cui si presenta il plusvalore è l’interesse, definito «un reddito derivato che, se non è pagato dal profitto che si ottiene con l’uso del denaro, deve essere pagato da qualche altra fonte di reddito». L’interesse è dunque, o una parte del profitto realizzato col capitale imprestato; quindi è in tal caso una forma secondaria del profitto, una ulteriore ripartizione fra diverse persone del plusvalore di cui ci si è appropriati sotto forma di profitto. Oppure l’interesse è pagato dalla rendita. Anche in questo caso è valida la stessa spiegazione. Oppure il mutuatario paga l’interesse col proprio capitale o col capitale altrui. In questo caso l’interesse non rappresenta in generale un plusvalore, ma semplicemente una diversa ripartizione della ricchezza esistente.
Ad eccezione dell’ultimo caso l’interesse non è che una forma secondaria del plusvalore. «Il denaro prestato a interesse viene sempre considerato dal mutuante come capitale. Egli attende che gli venga restituito al tempo stabilito e che per l’uso di esso il mutuatario gli versi nel frattempo una certa rendita [...] Il mutuatario può usarlo o come capitale o come fondo destinato al consumo immediato. Se lo usa come capitale, egli lo impiega per il mantenimento di lavoratori produttivi che ne riproducono il valore con l’aggiunta di un profitto. Egli può, in questo caso, restituire il capitale e pagarne l’interesse senza [...] intaccare un’altra fonte di reddito. Se lo usa come fondo destinato al consumo immediato, egli agisce come dissipatore [...] In questo caso egli non può restituire il capitale né pagarne gl’interessi senza [...] intaccare un’altra fonte di reddito».
Chi prende in prestito del denaro e lo impiega come capitale per ciò stesso ne trae un profitto. In questo caso l’interesse che egli paga al mutuante non è che una parte del profitto espressa con un nome diverso. Oppure consuma il denaro preso in prestito. Allora accresce il patrimonio del mutuante diminuendo il proprio. Si verifica solo una diversa distribuzione della ricchezza, ma non si ha nessuna creazione di plusvalore.
Allo stesso modo Smith osserva che tutti gli introiti delle persone che vivono sulle imposte, o vengono pagati dal salario o trovano la loro origine nel profitto e nella rendita, dunque non sono che titoli in base ai quali ceti diversi partecipano al profitto e alla rendita fondiaria che, a loro volta, non sono altro che forme differenti del plusvalore. «Tutte le imposte e tutti i redditi che sono fondati sulle imposte [...] derivano dall’una o dall’altra di queste tre fonti originarie del reddito e vengono pagati, direttamente o indirettamente, o dai salari del lavoro, o dai profitti del capitale, o dalla rendita fondiaria».
2.4. - Identificazione di plusvalore e profitto
Secondo la sua esposizione, la parte del capitale che è costituita da materie prime e mezzi di produzione non ha direttamente niente a che fare con la produzione del plusvalore. Questa deriva esclusivamente dalla quantità addizionale di lavoro che l’operaio fornisce in eccedenza alla parte del suo lavoro che costituisce l’equivalente del suo salario. Dunque, è unicamente dalla parte del capitale anticipata come salario che deriva direttamente il plusvalore, poiché essa è l’unica parte del capitale che non solo si riproduce, ma che produce anche un sovrappiù. Nel tasso del profitto, invece, il plusvalore è calcolato in rapporto alla somma totale del capitale anticipato. Poiché Smith spiega sì il plusvalore in modo esatto, ma non esplicitamente nella forma di una categoria determinata, distinta dalle sue forme particolari, dopo lo confonde in pratica con il profitto.
Questo errore permarrà in Ricardo, e in modo più marcato, per il fatto che la legge fondamentale del valore viene da lui elaborata con più sistematica unità.
La confusione s’introduce subito non dove Smith tratta del profitto o della rendita fondiaria, ma dove le concepisce solo come forme del plusvalore in genere. Dopo aver detto che «il valore che gli operai aggiungono alle materie prime si risolve in due parti, di cui l’una paga i loro salari, e l’altra paga i profitti dell’imprenditore sulla somma di capitale che gli è servita per anticipare questi salari e le materie prime», dopo cioè aver ridotto il plusvalore alla parte del lavoro aggiunta dagli operai alla materia prima oltre la quantità che ripaga i loro salari, concepisce invece questo sovrappiù immediatamente nella forma del profitto, cioè non in rapporto alla parte del capitale da cui essa scaturisce, ma come eccedenza sul valore totale del capitale anticipato. Il capitalista «non avrebbe interesse a impiegare questi operai, se non si attendesse dalla vendita del loro prodotto qualcosa di più di ciò che gli è necessario per sostituire il suo capitale».
Presupposto il rapporto capitalistico, ciò è giusto. Il capitalista non produce per soddisfare col prodotto i propri bisogni; egli, soprattutto, non produce direttamente in vista del consumo. Produce per produrre plusvalore. Smith non spiega il plusvalore, come faranno scioccamente i suoi successori, partendo da questa premessa, non spiega l’esistenza del plusvalore con l’interesse del capitalista. Egli ha invece dedotto questo plusvalore dal valore che gli operai aggiungono alla materia prima, oltre al valore da essi aggiunto in cambio del salario ricevuto. Ma poi prosegue che il capitalista non avrebbe alcun interesse a impiegare un capitale maggiore. Qui il profitto non viene più spiegato con la natura del plusvalore, ma con l’«interesse» del capitalista.
Smith non si accorge che confondendo il plusvalore col profitto e il profitto col plusvalore capovolge la sua legge sull’origine del plusvalore. Se il plusvalore non è che la parte del valore che l’operaio aggiunge oltre la parte aggiunta alla materia prima per ripagare il salario, perché mai questa seconda parte dovrebbe crescere in conseguenza immediata del fatto che il valore del capitale costante anticipato è in un caso maggiore che nell’altro?
La contraddizione diviene ancora più evidente nell’esempio che porta per confutare l’opinione secondo cui il profitto rappresenterebbe il salario per il cosiddetto lavoro di direzione. Leggiamo che i profitti del capitale «sono diversi dai salari e non stanno in alcun rapporto con la quantità di questo preteso lavoro di direzione. Essi si regolano interamente secondo il valore del capitale impiegato, e sono più o meno elevati in proporzione alla grandezza del capitale [...] Supponiamo che in un particolare luogo, dove il profitto del capitale impiegato nelle manifatture è in media del dieci per cento all’anno, ci siano due diverse manifatture, in ognuna delle quali vengono impiegati venti operai con un salario di 15 sterline ciascuno [...] supponiamo inoltre che i materiali grossolani che vengono lavorati annualmente nell’una costino solo 700 sterline, che invece i materiali più raffinati lavorati annualmente nell’altra costino 7000 sterline; il capitale impiegato annualmente nella prima sarà [...] di 1000 sterline [...], mentre [...] nell’altra [...] 7300 sterline. Quindi, considerando il tasso del dieci per cento, l’imprenditore della prima conterà su un profitto annuale di sole 100 sterline [...], mentre l’imprenditore dell’altra su un profitto di circa 730 sterline».
Dal plusvalore nella sua forma generale giungiamo subito a un saggio generale di profitto che, direttamente, non ha niente a che fare con esso. In ciascuna delle due fabbriche vengono impiegati 20 operai; il loro salario è il medesimo. Nell’una non è stato impiegato un genere di lavoro più elevato che nell’altra, nel qual caso un’ora di lavoro, quindi anche un’ora di pluslavoro nell’una sarebbe uguale a parecchie ore di pluslavoro nell’altra. Invece si suppone in entrambe lo stesso lavoro medio. Come può il pluslavoro che gli operai aggiungono oltre il prezzo dei loro salari valere in una fabbrica sette volte di più che nell’altra? La legge del profitto, secondo la quale questo è in rapporto alla grandezza del capitale anticipato, è quindi in contraddizione, apparentemente, con la legge del plusvalore, o del profitto (dato che Smith li considera entrambi come immediatamente identici), secondo la quale il plusvalore consiste unicamente nel pluslavoro non pagato dagli operai.
Dato che Smith risolve il plusvalore non soltanto in profitto, ma anche in rendita fondiaria avrebbe dovuto rendersi conto che non poteva assimilare la forma generale astratta con alcuna delle sue forme particolari.
In tutti i successivi economisti borghesi la mancanza di senso teorico per la comprensione delle differenze di forma dei rapporti economici permarrà nella loro tendenza ad afferrare il materiale empirico che si trovano dinanzi e nel loro interesse per questo.
(continua al prossimo numero)
Al suo primo congresso il Partito Comunista di Cina aveva avanzato la necessità di definirsi partito del proletariato cinese, il cui atteggiamento di indipendenza politica e netta separazione rispetto agli altri partiti fu espresso nell’intransigenza delle sue tesi, che escludevano alleanze con altre organizzazioni, rafforzate dal divieto per i militanti comunisti di aderire a partiti, circoli, associazioni contrari ai principi comunisti.
Come evidenziano bene i documenti da noi pubblicati il campo rivoluzionario in Cina amalgamava anarchici, democratici, nazionalisti, era quindi un ambiente confusionario e spesso conciliatorio, a cui si aggiungeva l’arretratezza della giovane classe operaia cinese. Tutto ciò rendeva il lavoro comunista difficile e da condursi con la massima risoluzione e critica verso le altre tendenze che si atteggiavano a rivoluzionarie, e principalmente contro la borghesia democratica del Kuomintang, nell’assoluta certezza del prossimo sviluppo, quantitativo e qualitativo, della classe operaia indigena.
Infatti nel giro di un anno, dal ‘21 al ‘22, la lotta di classe del proletariato si accese in Cina con imponenti scioperi, come quello di Hong Kong agli inizi del 1922, e in generale si moltiplicarono i sindacati, dando corso alla costituzione di sindacati di industria e non più professionali; nel giro nemmeno di un lustro i lavoratori passarono dall’essere assoggettati alle gilde professionali, e ad altre arretrate forme associative, ad organizzarsi e riconoscersi come classe operaia unita al di sopra delle professioni, delle categorie e delle divisioni provinciali. Il PCdC, in questo incandescente movimento di forze sociali, aveva l’assoluta necessità di tracciare netti i propri confini per definirsi e per costituirsi nel seno e con l’Internazionale Comunista.
Per percorrere la propria strada in maniera autonoma il PCdC aveva la necessità di delimitarsi principalmente nei confronti del Kuomintang, che avrebbe tentato di assumere il ruolo di guida del movimento rivoluzionario in sviluppo nel paese.
Nelle tesi elaborate dal PCdC al suo primo congresso non si trovano riferimenti alle decisioni del Secondo Congresso dell’Internazionale Comunista sulla questione nazionale e coloniale, benché la presenza di Maring come inviato dell’IC in Cina faccia ritenere che dovessero essere conosciute dai delegati. Dal primo congresso uscì una linea incentrata sul ruolo indipendente del proletariato che non contemplava unioni con altri partiti e tendeva alla formazione di un partito di classe autonomo dall’influenza borghese e piccolo borghese.
Se non aveva ancora recepito la corretta tattica da adottare nel contesto di una rivoluzione doppia, come quella che si profilava in Cina, questa iniziale mancanza avrebbe potuto essere superata senza particolari difficoltà per allinearsi al corpo programmatico, tattico e organizzativo così com’era stato magnificamente restaurato dall’Internazionale.
Intanto il piccolo Partito procedeva a sviluppare il suo lavoro rivoluzionario. Una Circolare del novembre del 1921, emanata dall’organo centrale del Partito, rende bene l’idea della condizione del PCdC ai suoi albori. La Circolare era rivolta al superamento delle difficoltà iniziali e indicava i principali punti, riguardanti la formazione e lo sviluppo del Partito, la Lega giovanile e quella delle donne, l’organizzazione dei lavoratori e il lavoro di propaganda, verso i quali indirizzare le esigue forze.
Una rilevante difficoltà riguardava il finanziamento del Partito, che nella sua fase iniziale dipendeva quasi completamente dall’Internazionale. Si chiedeva ai gruppi di Shanghai, Pechino, Canton, Wuhan e Changsha di reclutare almeno 20 compagni entro il prossimo congresso del Partito, e si puntava a portare la Lega dei giovani socialisti a più di 2.000 membri. Cifre che ben testimoniano la debolissima forza originaria del PCdC. Si puntava anche a sviluppare la propaganda del Partito con la pubblicazione di almeno 20 scritti.
Chiaro era tuttavia l’indirizzo d’azione del Partito, incentrato sul lavoro sindacale, che puntava alla guida dei sindacati, che intanto stavano diffondendosi in Cina, e in ogni caso a sviluppare solide relazioni con il resto delle organizzazioni sindacali. Riguardo al movimento sindacale, un punto preciso della Circolare stabiliva di «usare tutta la nostra forza per organizzare il Sindacato nazionale dei ferrovieri».
Infine le organizzazioni locali del Partito avrebbero dovuto sviluppare la loro azione anche nel movimento giovanile e femminile.
L’indirizzo della Circolare si inseriva sul solco di quanto già stabilito dal primo congresso del Partito, che rivolgeva inequivocabilmente la sua azione verso la classe operaia, individuando nel lavoro sindacale il principale strumento per entrare in relazione col proletariato. Il PCdC aveva ben presente il suo compito primario, così come lo aveva definito Safarov al Congresso dei Comunisti e delle Organizzazioni Rivoluzionarie dell’Estremo Oriente, dell’organizzazione di genuini sindacati classisti che sorgevano in Cina differenziandosi dalle vecchie forme organizzative. A tal riguardo, aveva detto Safarov al Congresso dei Comunisti e delle Organizzazioni Rivoluzionarie dell’Estremo Oriente: «Il giovane movimento operaio cinese sta crescendo. I sindacati esistenti sono legati da pregiudizi di mestiere, che sono ancora per molti aspetti le vecchie organizzazioni di mestiere, vanno riorganizzati come genuini sindacati proletari. Questo è il primo compito. Noi dobbiamo iniziare una lotta implacabile contro le vecchie forme di sfruttamento che in Cina vengono effettuate con l’aiuto dei capi reparto, dove l’imprenditore cinese è il capo diretto dello sfruttamento capitalistico».
Già nel luglio del 1921 era stato formato il “Segretariato del Lavoro”. Alla sua guida c’era Zhang Guotao. Il quartier generale fu stabilito a Shanghai con sezioni locali nel Nord della Cina, a Wuhan, nell’Hunan e a Canton. Pubblicava la rivista “Il settimanale del lavoro”. La formazione di tale organismo faceva seguito alle decisioni del primo congresso del Partito, che aveva stabilito suo principale obiettivo l’organizzazione dei lavoratori attraverso la formazione di sindacati d’industria. Tale obiettivo era ribadito con forza nel primo Manifesto del Segretariato che ne annunciava la formazione, che abbiamo pubblicato nel numero 90 di questa rivista. Mentre le vecchie organizzazioni, come le gilde e le organizzazioni a carattere provinciale, finivano per dividere i lavoratori, solo coalizzandosi in sindacati d’industria e senza distinzioni di provenienza territoriale, di sesso e di età, la classe operaia poteva lottare contro il capitale.
Subito l’attività del Segretariato fu rivolta al sostegno del movimento di scioperi e allo sviluppo delle organizzazioni dei lavoratori. Già nell’autunno del 1921 il Segretariato fu coinvolto in prima linea in una serie di scioperi a Shanghai, come per esempio alla B.A.T., l’industria del tabacco, su una tratta ferroviaria a Wuhan, e a dicembre nello sciopero dei tiratori di risciò a Hankow, dove il Segretariato fornì un contribuito concreto alla costituzione del loro sindacato.
In generale, il radicamento del Segretariato variava da un posto all’altro. Considerando la sua attività dalla sua fondazione, luglio 1921, al congresso dei sindacati cinesi nel maggio del 1922, l’influenza del Segretariato, mentre rimase estremamente debole al Sud, si affermò a Shanghai (dove però a partire dall’estate del ’22 si abbatté la reazione padronale e del potere politico locale), nelle ferrovie della Cina centrale e settentrionale e in alcune grandi fabbriche e miniere della Cina centrale. Il Segretariato fu in grado di sostenere una serie di scioperi e di contribuire alla formazione di sindacati, azione svolta facendo risuonare in Cina le parole d’ordine dell’Internazionale Sindacale Rossa.
Come detto il Segretariato del Lavoro stabilì la sua sede a Shanghai, il principale centro industriale cinese, dove svolse un intenso lavoro per espandere la sua influenza sul movimento operaio. Ciò permise al Partito di penetrare in numerose fabbriche di Shanghai e contribuì alla organizzazione sindacale che prendeva piede soppiantando le vecchie forme di organizzazione. Ad esempio, già nel febbraio del 1922 nella sede del Segretariato si riunirono operai di una ventina di tipografie per discutere della formazione del loro sindacato. In questo modo il Partito fu alla testa di alcuni scioperi come, per esempio, quello che coinvolse gli operai dei cotonifici e quello dei marittimi dello Yangtse che seguiva il vittorioso sciopero dei marittimi di Hong Kong.
Nel nord della Cina il Segretariato sviluppò una vasta attività tra i ferrovieri. Anche grazie al lavoro dei comunisti furono organizzate sezioni sindacali in circa una trentina di stazioni ferroviarie. Dall’unione di queste sezioni nascerà l’organizzazione dei ferrovieri ma già dall’autunno del 1921 una serie di scioperi ben organizzati e diretti avevano coinvolto le linee ferroviarie del Nord e del Nord-Est.
Nell’Hunan, invece, persisteva una certa influenza degli anarchici, come per esempio nell’Associazione dei Lavoratori dell’Hunan. Durante la seconda metà del 1921 il Segretariato continuò verso questa organizzazione un’azione di avvicinamento, che era già stata intrapresa prima della fondazione del PCdC, non facendo mancare critiche rivolte alla sua timidezza nel lanciare scioperi industriali, alla trascuratezza sulle questioni finanziarie, alla necessità della raccolta di fondi di sciopero, e ai suoi statuti troppo larghi che ammettevano sia lavoratori sia studenti. Comunque, i comunisti riuscirono a stabilire una buona relazione con questa organizzazione, e al tempo della Conferenza di Washington, nel novembre 1921, nelle dimostrazioni operaie organizzate dall’Associazione risuonarono anche le parole d’ordine dell’opposizione a Washington, all’imperialismo e ai signori della guerra. Inoltre sulla rivista dell’Associazione, accanto alle classiche tesi anarco-sindacaliste, trovavano spazio anche le posizioni comuniste, come per esempio la necessità di organizzare sindacati d’industria. Nel gennaio 1922 un rappresentante dell’Associazione fu inviato al Congresso dei Comunisti e delle Organizzazioni Rivoluzionarie dell’Estremo Oriente.
Ma agli inizi del ’22, in seguito ad uno sciopero in un cotonificio a Changsha, l’Associazione, che era alla testa degli scioperanti, subì una feroce repressione da parte del governatorato locale con l’arresto e l’esecuzione di due giovani capi della protesta. L’Associazione fu sciolta e le sue pubblicazioni vietate. L’episodio ebbe una vasta risonanza tra le organizzazioni dei lavoratori di tutta la Cina e l’indignazione per l’uccisione dei due giovani compagni diffondendosi in tutti i centri industriali costituì un primo segnale di quella tendenza all’unificazione del proletariato cinese.
In generale nell’Hunan, e anche nell’Hubei, il Segretariato riuscì ad ottenere importanti risultati. L’influenza del sindacalismo comunista, con l’indirizzo di formare di sindacati d’industria, era favorita dalla presenza dell’industria pesante che concentrava il proletariato in grandi fabbriche e da un peso minore delle vecchie organizzazioni a carattere corporativo e di quelle più moderne a carattere misto e di stampo riformista.
A Canton, invece, il Segretariato incontrò maggiori difficoltà. Il Kuomintang si era interessato al movimento operaio già da diversi anni e aveva il suo centro d’attività proprio a Canton, sede del governo del Sud, e a Hong Kong. In quest’area il Kuomintang aveva stabilito una certa influenza su molte organizzazioni sindacali che vi si erano formate, ma nelle quali persistevano ancora alcuni caratteri tipici delle vecchie gilde, in particolare la presenza all’interno della stessa organizzazione di rappresentanti della proprietà della fabbrica. Inoltre era praticamente assente un reale collegamento tra i vari sindacati. Nonostante i limiti dell’intervento del Kuomintang tra i lavoratori, il Segretariato non riuscì a stabilire la sua influenza a Canton, e all’inizio del 1922 non ebbe successo il tentativo di creare un sindacato generale del Guangdong, contrapposto alla già operante federazione provinciale di tendenza conservatrice.
Ma nel momento in cui la classe operaia in Cina scendeva in lotta in una vasta ondata di scioperi e si dava le sue prime organizzazioni moderne, il Kuomintang, che pur aveva da tempo relazioni con settori operai, non si mise alla testa di questo movimento, che procedeva in direzione di una unificazione in tutto il paese, e lo mantenne confinato a Canton e Hong Kong. Dall’altro lato gli anarchici, dati i limiti della loro dottrina, ignorarono la necessità di estendere e rafforzare le organizzazioni operaie e si limitarono a guidare scioperi economici che restarono isolati. In questo contesto, attraverso il Segretariato i comunisti poterono entrare in contatto con la classe operaia e influenzare il processo in corso di organizzazione dei lavoratori in moderni sindacati di classe, tanto da svolgere un ruolo fondamentale nella convocazione del primo congresso nazionale dei sindacati nel maggio 1922. Mettendosi alla testa dell’organizzazione di questo primo congresso dei sindacati, il PCdC, nonostante le esigue forze, si aprì la strada ad un ruolo di guida della classe operaia cinese, fattore che risulterà di enorme rilevanza per lo sviluppo del Partito.
La convocazione del congresso dei sindacati avvenne sull’onda di un vasto movimento di scioperi che si levò a partire dagli inizi del 1922, e che favorì anche un rapido e intenso processo di organizzazione, con sindacati che si formavano in tutti i centri industriali. Alla base di questa ondata di scioperi fu l’imponente sciopero dei marittimi di Hong Kong, iniziato nei primi di gennaio. La sua grande importanza fu cementare l’unità del proletariato cinese, che fino ad allora era rimasto avvolto in divisioni di ogni sorta, da quelle di stampo regionale a quelle per azienda. A questo processo di unificazione il Segretariato contribuì con il suo indirizzo, le sue forze e la sua attività, come dimostra lo stesso sciopero di Hong Kong. Mentre la sezione cantonese si adoperò per provvedere al sostegno degli scioperanti, il Segretariato si fece principalmente tramite nei principali centri industriali del paese per la solidarietà verso lo sciopero in corso.
In particolare da Shanghai fu il PCdC che espresse per primo il sostegno allo sciopero e attraverso il Segretariato fornì un pratico aiuto: quando i padroni provarono a reclutare crumiri per rimpiazzare gli scioperanti, per bloccare questa mossa il Segretariato si adoperò a dissuadere i marittimi di Shanghai da farsi ingaggiare, e l’iniziativa ebbe successo. Inoltre il Segretariato fu anche attivo nella raccolta di fondi di sostegno allo sciopero e per estendere la solidarietà verso di esso. Da tutto il paese organizzazioni operaie inviarono soldi e messaggi di sostegno. Particolarmente rilevante fu l’appoggio dei ferrovieri, tra i quali forte era l’influenza comunista, considerando anche la peculiarità del lavoro che permetteva collegamenti tra le diverse località: sulla linea Pechino-Hangkow i ferrovieri avevano innalzato sui treni lo stendardo “Appoggiamo lo sciopero dei marittimi di Hong Kong”.
Data la situazione il Partito ritenne che la solidarietà verso lo sciopero dei marittimi di Hong Kong aveva avvicinato le organizzazioni operaie di tutto il paese e che quindi il momento fosse propizio per un congresso di carattere nazionale per cementare questa unità. Inoltre l’intervento del Partito nello sciopero ne aveva aumentato il prestigio fra i lavoratori.
Il congresso nazionale dei sindacati fu quindi convocato sotto l’egida del Segretariato, che si era anche impegnato ad assistere i sindacati nell’invio dei delegati. Dato che il congresso si svolgeva a Canton, dove il Kuomintang controllava importanti sindacati, come quello dei meccanici del Guangdong, una delle organizzazioni più forti tra le presenti, ci fu un’ampia partecipazione di delegati membri o simpatizzanti del Kuomintang. Nonostante questo la direzione e l’indirizzo del congresso furono praticamente nelle mani del PCdC. Le principali risoluzioni adottate erano state proposte dai comunisti: quelle di carattere politico, che riguardavano la partecipazione del movimento operaio alla rivoluzione nazionale e democratica, che si sintetizzavano negli slogan “abbasso l’imperialismo” e “abbasso i signori della guerra”; e quelle di carattere economico, in particolare riferite alla lotta per la giornata di otto ore, al sostegno degli scioperi, e soprattutto ai principi sull’organizzazione dei sindacati, con la condanna delle vecchie gilde e delle società segrete, e la necessità di sindacati di industria e non di mestiere. Infine si stabiliva la necessità di stringere stretti legami tra le organizzazioni sindacali, prima a livello cittadino e provinciale, con la formazione di strutture unitarie, per poi arrivare ad una federazione nazionale delle organizzazioni operaie.
In quella fase il congresso, benché ne accettasse la necessità, ritenne prematuro stabilire una federazione nazionale. Intanto, però, fu affidato al Segretariato il compito di funzionare da centro per la corrispondenza tra i sindacati del paese. Inoltre gli fu affidata la responsabilità della convocazione del secondo congresso.
Nel giugno del 1922 la sede del Segretariato fu spostata da Shanghai a Pechino. Alla base di tale decisione contribuivano una serie di considerazioni, tra cui l’azione repressiva svolta a Shanghai dalla polizia della concessione internazionale, in accordo con la cricca militarista che controllava la città. Inoltre Pechino, benché industrialmente arretrata rispetto ad altri centri industriali cinesi, aveva il vantaggio di migliori collegamenti ferroviari, in quanto tutte le linee ferroviarie convergevano verso la capitale del Nord, a differenza di Shanghai che era dotata principalmente di collegamenti marittimi e fluviali. Le ferrovie divennero “l’ossatura” del Segretariato, che utilizzando i treni riusciva a mantenere costanti legami con le altre sezioni locali e ad inviare forze nelle località in cui scoppiavano scioperi.
Nei mesi che seguirono il congresso dei sindacati di Canton, fino alla repressione dei ferrovieri nel febbraio del 1923, l’influenza del Segretariato raggiunse l’apogeo. Tra i suoi punti di forza erano certamente le ferrovie: verso la fine del 1922 controllava le più importanti tratte e i numerosi club operai nelle stazioni (va precisato che non c’è opposizione tra i termini di “club” e “sindacato”: il più delle volte il club era il primo passo verso la fondazione di un vero sindacato). Alla fine del ’22, questo lavoro tra i ferrovieri sarà coronato dalla formazione di una loro Federazione nazionale.
A Shanghai, nel luglio del ’22, il Segretariato sostenne lo sciopero dei marittimi, che ottennero gli stessi vantaggi dei loro compagni di Hong Kong quattro mesi prima. Questa importante vittoria rafforzò l’indirizzo della formazione di sindacati a base industriale e permise al Segretariato di poter stabilire nuovi sindacati, come quello dei postali e degli operai delle industrie tessili giapponesi. Importanti successi furono ottenuti nell’Hubei e nell’Hunan. A partire dal maggio del ’22 i comunisti formarono un club operaio nelle miniere di Anyuan che alla fine dell’anno superò i diecimila membri. Intanto in queste province club operai sorsero tra i ferrovieri, tra i metallurgici dell’Hubei, e tra i minatori di Shuikoushan, a Changsha tra i tipografi e i tiratori di risciò, tra gli operai delle fabbriche di cotone e tabacco a Wuhan. Alla fine dell’estate fu costituita a Wuhan la federazione provinciale dei gruppi operai dell’Hubei, con l’adesione di oltre 20 sindacati e club operai in rappresentanza di circa 40.000 iscritti. Successivamente, all’inizio di novembre, anche nell’Hunan nacque la federazione provinciale che raggruppava i gruppi operai della ormai disciolta Associazione dei lavoratori di tendenza anarchica e dei minatori di Anyuan e di Shuikoushan legati al Segretariato. Numerosi furono gli scioperi nell’Hunan e nell’Hubei a partire dal luglio del 1922 che a differenza dei precedenti, caratterizzati da azioni spontanee e isolate, furono organizzati, coordinati e diretti di sindacati, e in generale si conclusero con un successo per gli operai.
Il Partito Comunista di Cina tramite il Segretariato del Lavoro interveniva nel movimento operaio cinese portando i nuovi principi di organizzazione e di azione: il sindacalismo industriale e la lotta di classe. L’intervento organizzato del Segretariato avveniva in un contesto caratterizzato dai grandi scioperi del ’22, che mostravano chiaramente il vigore della classe operaia cinese. La forza sprigionata dal proletariato nel corso del 1922 rappresentava l’apice di un movimento che aveva fatto la sua entrata in scena nel maggio del 1919, ma in subordine agli interessi della Cina borghese, e finalmente si levava nella sua autonomia di classe con le proprie rivendicazioni e l’aspirazione a dotarsi di sue organizzazioni di lotta.
Il Segretariato si collegò a questo vasto movimento di scioperi e alla tendenza all’organizzazione. Così nel corso del 1922 la tattica sindacale del PCdC poteva ottenere importanti successi, permettendo al piccolo Partito di stringere legami col movimento operaio, mentre l’influenza delle altre tendenze che pretendevano di rappresentare il proletariato pian piano veniva emarginata perché non corrispondente al processo in corso, diretto verso la formazione di veri sindacati di classe. In questo modo, passando attraverso la riuscita del congresso nazionale dei sindacati, il PCdC aumentò la sua influenza sul movimento operaio.
Poiché si rendeva storicamente inevitabile la formazione di un fronte democratico rivoluzionario, il Partito vi si sarebbe presentato come l’unica forza alla guida della classe operaia, come l’avanguardia del proletariato, in quanto unico partito in Cina che effettivamente era nella condizione di poter dirigere la classe operaia e alla sua testa prendere parte al movimento nazional-rivoluzionario seguendo il programma e la tattica stabiliti a livello internazionale dal Comintern.
(continua al prossimo numero)
41. Soccombono i principi regionali
Con il declino dell’impero Moghul nel diciottesimo secolo emersero nel subcontinente diverse entità regionali, una frammentazione che favorì la successiva dominazione straniera, così come era accaduto dopo la caduta dell’impero Gupta.
Il primo a dichiararsi indipendente fu il nawab (governatore provinciale) del Bengala, seguito da quello dell’Awadh, mentre il Nizam di Delhi fondava una propria dinastia a Hyderabad nel Deccan. I maratti conquistarono gran parte dell’India nord occidentale mentre il meridione era dominato da diversi piccoli regni i cui predecessori ne erano stati i governatori durante l’impero di Vijayanagara. L’influenza delle potenze europee si limitava alla periferia marittima del subcontinente.
Fino a metà del secolo i sovrani indiani erano soprattutto preoccupati dalle incursioni dell’afgano Ahmad Shah Durrani, ritenuto il fondatore del moderno Stato dell’Afghanistan, che invadeva ripetutamente le pianure indiane.
Nel corso degli anni emerse però sempre più che gli eserciti organizzati secondo il modello europeo costituivano uno strumento di guerra di straordinaria potenza. Le prime prove di questo maggiore potenziale bellico si manifestarono durante la guerra del 1744-48 tra britannici e francesi.
Joseph François Dupleix, amministratore coloniale del re di Francia in India, utilizzò questa forza contro i sovrani locali, in modo da ritagliare un nuovo impero d’oltremare alla corte di Parigi, aggiunto a quello nordamericano. Addestrò mercenari indiani facendoli diventare fanti esperti ai metodi di guerra europei. Tali truppe erano relativamente economiche e ben organizzate potevano sferrare un colpo fatale alla cavalleria indiana. I guerrieri indiani, audaci cavalieri abituati a irrompere nelle linee dei fanti nemici, ma mal equipaggiati e spesso indisciplinati militarmente, furono falcidiati dalla fanteria addestrata dagli europei che faceva fuoco con la precisione di una macchina. Così come Babur aveva fondato l’impero moghul sulla maggiore potenza dei moschetti e dell’artiglieria, su questo tipo di fanteria si basò il potere degli Stati europei in India.
Il loro successo poggiava sull’addestramento e sull’organizzazione poiché tutti gli armamenti potevano essere reperiti anche dai sovrani indiani. Concentrandosi sulla fanteria gli europei avevano risparmiato sugli alti costi di mantenimento degli squadroni di cavalleria, in India dove le varie compagnie europee non avrebbero mai stanziato i fondi necessari. Al contrario la paga dei fanti era irrisoria.
Con un non numeroso ma ben preparato ed equipaggiato esercito franco-indiano Dupleix ottenne alcune vittorie sugli inglesi e sui principi indiani loro alleati; assediò e conquistò Madras nel 1746, ma la dovette riconsegnare nel 1748, in cambio dell’isola di Cap Breton in America, a seguito del trattato di pace di Aquisgrana, che pose fine alla guerra di successione asburgica.
42. Le conquiste della Compagnia delle Indie
Quando nel 1748 fu firmato in Europa il trattato di pace, a Hyderabad moriva il vecchio Nizam: i due figli, seguendo la tradizione moghul, cominciarono a combattersi per la successione. Parallelamente a questa lotta dinastica ne divampò una simile tra i discendenti del nawab di Arcot. Francesi e inglesi si unirono al conflitto: vi furono due alleanze ciascuna composta da un principe di Hyderabad, uno di Arcot e una potenza europea. Alla fine i francesi prevalsero a Hyderabad, gli inglesi ad Arcot, dove si distinse un giovane britannico al servizio della compagnia delle Indie, Robert Clive.
Il conflitto tra Francia e Inghilterra in India continuò fino alla fine della guerra dei sette anni in Europa (1756-63). Gli inglesi nel 1757, dopo la battaglia di Plassey, conquistarono tutto il Bengala, e due anni dopo l’importante città portuale di Surat. La battaglia decisiva tra le due potenze europee fu combattuta nel 1760 nel Coromandel, al forte di Wandiwash, nei pressi di Madras, dove gli inglesi, guidati da Eyre Coote sconfissero l’esercito francese. Il sogno di un Inde francais si chiudeva definitivamente.
Negli anni successivi ci fu una fase di stallo fra i contendenti alla supremazia in India. Gli afghani, i maratti e gli inglesi dopo aver sconfitto i francesi si erano trincerati nel Bengala, occupazione che ebbe un’importanza decisiva.
Le conquiste inglesi non erano derivate da un piano strategico elaborato a Londra ma da iniziative della Compagnia in India, in questo periodo costituita da mercanti che trattavano con altri mercanti, finanzieri e mediatori indiani. Fin dall’inizio infatti questi funzionari-mercanti avevano avuto l’irresistibile tentazione di far uso dei propri poteri per promuovere i loro interessi privati: un atteggiamento di cui i direttori della Compagnia a Londra erano a conoscenza ma che potevano – e volevano – controllare solo in parte. Di fatto la conquista inglese del Bengala, che aveva determinato un aumento del potere della East India Company, rese irresistibile la tentazione dei suoi funzionari al saccheggio indiscriminato, estorsioni di denaro ai membri della classe dirigente moghul e monopolio dei traffici commerciali.
Questa realtà portò ad una nuova guerra, che vide sconfitte le truppe del nawab in una serie di scontri culminati nel 1763 nella decisiva battaglia di Udhuanala, vicino a Rajmahal, nell’attuale Stato del Jharkhand.
Il nawab riuscì a rifugiarsi in Awadh con un considerevole tesoro e una parte delle sue truppe. Qui chiese aiuto a Shuja-ud-Daulah, il più potente principe moghul nel Nord dell’India, e al suo ospite, il giovane imperatore Shah Alam II, di fatto in esilio. I tre prìncipi uniti marciarono contro l’esercito della Compagnia e, dopo alcune scaramucce, il 24 ottobre 1764 si scontrarono nella battaglia decisiva di Baksar, nel Bihar sud occidentale: da una parte la cavalleria di Shuja-ud-Daulah con circa 40.000 uomini, mentre la fanteria britannica contava 850 inglesi e 5.800 sepoys, i soldati di fanteria indiana al servizio della Compagnia, guidati dal comandante Hector Munro. La battaglia, vinta dagli inglesi, decise ciò che la terza battaglia di Panipat, del 1761, che aveva visto contrapposti l’Impero maratta e le forze d’invasione del re afghano Ahmad Shah Durrani, vittoriose, non aveva sancito, l’effettiva e duratura supremazia di uno dei contendenti.
Dopo la vittoria le truppe della Compagnia marciarono nel cuore dell’Awadh, regione del moderno Stato dell’Uttar Pradesh, conquistandone la capitale Lucknow. Questo territorio fu trasformato in uno Stato vassallo, alleato della Compagnia, in cambio del versamento di una congrua somma e dell’impegno di pagare in futuro il mantenimento di un corpo militare inglese. Shuja Ud Daulah mantenne quindi la sua sovranità.
43. La pace di Versailles in aiuto agli inglesi
La corruzione tra i funzionari della Compagnia, che saccheggiavano a piacimento ampi territori, era sempre più diffusa. Lo stesso Clive, pur non esitando a riempirsi le tasche, disapprovava la corruzione, non per principi morali ma per ragioni strategiche sostenendo che, non essendo pianificata, minava la disciplina collettiva necessaria alla conservazione del potere della Compagnia.
Mentre la Compagnia rinsaldava il controllo nel Bengala e sul confinante Bihar e portava nella sua orbita l’Awadh, la situazione nel resto dell’India era nuovamente in movimento. Nel meridione Hyder Ali aveva intrapreso nel 1761 una politica d’espansione ai danni di piccole monarchie. Giunse fino a minacciare Madras, imponendo condizioni di pace agli inglesi il 4 aprile 1769. Nel frattempo, nel 1770, Mahadaji Sindhia, maharaja di Gwalior, uno dei maggiori signori della guerra maratti, riprese l’avanzata verso il Nord. I maratti, ancora una volta, si trovavano l’uno contro l’altro.
Fin dal 1772 gli inglesi di Bombay avevano invece esteso i loro confini nel Gujarat, ai danni di alcuni piccoli Stati sopravvissuti al crollo del potere moghul. Fu colta l’opportunità d’intromettersi nella nuova guerra civile maratta, con la prospettiva di un considerevole ampliamento dei domini, senza consultare il governo del Bengala che, secondo recenti disposizioni da Londra, avrebbe dovuto esercitare una supervisione sugli altri governi della Compagnia in India.
Ma la guerra di Bombay contro Pune (1773-82) si rivelò tutt’altro che una passeggiata. Nel tempo si allargò a tutta l’India meridionale. Nel 1779 Ali Khan, il Nizam del Deccan, provocato dai tentativi d’ingerenza del governo di Madras, si fece promotore di una grande alleanza in chiave anti-inglese comprendente sia i maratti sia il Mysore. Bombay e Madras furono costrette ad appoggiarsi alle risorse del governo del Bengala in quella che divenne una guerra per l’egemonia in India.
I prìncipi indiani, apprese le lezioni di San Thomé e di Buxar, individuarono una debolezza negli eserciti organizzati all’europea: la cavalleria. Invincibili in campo aperto, erano vulnerabili a una strategia che privilegiasse la mobilità. I maratti e il Mysore controbilanciarono la superiorità europea sul campo di battaglia ricorrendo alla strategia della terra bruciata e della guerriglia.
Inoltre durante le guerre precedenti gli inglesi avevano potuto contare su cospicui rinforzi dall’Europa, mentre ora il grosso delle loro forze era impegnato in occidente dove dal 1775 era incominciata la fase armata della ribellione delle colonie americane. Nel 1778 la Francia, seguita dalla Spagna e dall’Olanda, aveva congiunto le sue forze a quelle dei ribelli americani. Tra il 1782 e il 1783 una flotta reale francese fece la sua comparsa nell’Oceano Indiano, costringendo gli inglesi alla difensiva.
Sotto l’urto di una così vasta coalizione l’intero sistema di potere inglese in India sembrò vacillare, i maratti sconfissero gli inglesi prima che i rinforzi britannici dal Bengala potessero raggiungere il campo di battaglia. Ma alla fine del 1781, grazie soprattutto agli sforzi economici, militari e diplomatici del governo del Bengala, i maratti vennero nuovamente sconfitti. La fase più acuta della crisi era superata. Nel 1782 la pace di Saibai pose fine alla guerra fra i maratti e la Compagnia.
L’ammiraglio francese Suffren riuscì a mantenere il suo spazio sul mare facendo sbarcare truppe francesi nell’India meridionale per congiungersi alle forze di Haider, mettendo a rischio la supremazia britannica.
Ma in aiuto degli inglesi arrivò la pace di Versailles del 1783, anche nota come trattato di Parigi, che, oltre a definire la nascita degli Stati Uniti d’America, determinò il ritiro delle truppe francesi e della flotta francese dall’Oceano Indiano. La guerra si prolungò fino al marzo 1784, data degli accordi di pace sanciti a Mangalore.
Gli inglesi, senza aiuti esterni, erano sopravvissuti alle guerre del 1772-84 non sconfitti, chiara indicazione della potenza da loro raggiunta.
44. La crescita militare della Compagnia
Fateh Ali Tipu, chiamato la tigre del Mysore e dipinto a Londra come un tiranno, era un avversario troppo pericoloso per la Compagnia. La nuova guerra, iniziata alla fine del 1789, vide il sultano opposto alla triplice alleanza formata dagli inglesi, da Pune e dal Nizam. Seguirono altre battaglie e Tipu fu costretto a firmare un nuovo trattato di pace che trasferiva metà dei suoi domini agli alleati e gli imponeva il pagamento di un’enorme indennità di guerra.
Il 1789 è l’anno della rivoluzione francese.
Nel 1793 l’Inghilterra entrò a far parte della coalizione antifrancese. Del 1796 è la campagna d’Italia di un giovane generale francese d’origine italiana, Napoleone Bonaparte. Il successivo trattato di Campoformio fra Francia e Austria lasciò l’Inghilterra sola in campo contro le forze della rivoluzione. Divenne presto chiaro che Napoleone intendeva rivolgere le sue armate vittoriose verso oriente, con il probabile obiettivo finale di colpire gli inglesi in India.
Mentre Napoleone andava ultimando i preparativi per quella che sarà l’invasione dell’Egitto, un nuovo governatore generale inglese, Lord Wellesley, salpava per l’India. Il suo governatorato, dal 1789 al 1805, fu di ininterrotta espansione, consentita da una robusta riorganizzazione dell’esercito. Nello stesso tempo in cui i più potenti prìncipi indiani rafforzavano gli eserciti con distaccamenti di fanteria organizzati all’europea, e spesso comandati da ufficiali europei, gli inglesi si dotavano di un’efficiente cavalleria, affiancata dall’artiglieria leggera trasportata su carri.
La prima prova del nuovo esercito della Compagnia avvenne nel 1799 contro Tipu, che rimaneva il nemico più pericoloso. La notizia di un trattato di alleanza fra il sultano del Mysore e la Francia rivoluzionaria, scioccamente reso pubblico dal governatore dell’Isle de France (Mauritius), fu il casus belli. Nel 1799 due eserciti della Compagnia, rafforzati da alcuni battaglioni del Nizam, marciarono su Seringapatam, nell’attuale distretto di Mandya, nello Stato federato del Karnataka. Gli inglesi ottennero una vittoria decisiva dopo aver fatto breccia nelle mura della fortezza, conquistandone la cittadella. Il sultano Tipu, che per compiacere i francesi si faceva chiamare cittadino Tipu, morì a difesa della propria capitale.
Gli inglesi si annetterono il Kanara settentrionale e meridionale, il distretto di Wayanad, le città di Coimbatore e Dharapuram e nel Mysore reinsediarono l’antica dinastia indù Wodeyar il cui trono era stato conquistato da Hyder Ali.
In questo momento storico, nel panorama indiano l’unico potere ancora in grado di sfidare quello inglese era rappresentato dai maggiori prìncipi maratti, i quali però non furono mai in grado di mettere da parte le loro discordie per unirsi contro il nemico comune. Furono combattute numerose battaglie, l’ultima nel Deccan, ad Argaon, dove gli inglesi, dopo aver aperto un negoziato di pace, attaccarono a tradimento un esercito congiunto di alcuni principi maratti. Nei trattati di pace che conclusero questa fase della guerra, vennero imposte le consuete “alleanze sussidiarie”, ovvero il controllo sui principati del nord passava dai maratti alla Compagnia, comprese Delhi e Pune. Inoltre la Compagnia si arrogava il diritto d’arbitrato in eventuali dispute fra i prìncipi maratti. Alcuni di loro decisero di continuare la resistenza, anche con un discreto successo, ma senza poter cambiare il corso della storia. A sud dell’Himalaya il potere dei maratti era spezzato per sempre per far posto a quello inglese e all’era coloniale.
45. L’India coloniale
Intorno al 1765 la inglese Compagnia delle Indie Orientali, pur mantenendo il ruolo di grande società per azioni dedita alla gestione dei commerci, si era di fatto trasformata in una potenza territoriale. I suoi possedimenti in India erano ben più ampi e popolosi di tutto il regno d’Inghilterra. Le risorse legate al connesso gettito fiscale ne divennero il principale introito. Gli inglesi avevano appreso la fondamentale importanza della finanza militare, una materia che invece fu sempre estranea ai sovrani indiani, che spesso si trovavano sui campi di battaglia con truppe insufficienti delle quali non potevano più sostenere il pagamento. Una supremazia questa inglese anche in Europa nel diciottesimo secolo, con i britannici che meglio sapevano finanziare le guerre.
Guerre di conquista che però spesso non rappresentavano un buon affare perché, qualunque ne fosse l’esito, erano talmente onerose da mettere in crisi, quantomeno a breve termine, i bilanci della Compagnia. Inoltre il mantenimento e l’amministrazione dei territori conquistati, se portavano ad un aumento enorme degli introiti, causavano una equivalente crescita delle spese, in parte perché una quota piuttosto elevata dei guadagni finiva nelle tasche dei funzionari locali della Compagnia, che risultava gravemente indebitata. Ciononostante i direttori premevano per riscuotere i loro dividendi privati. Le spese belliche e i limitati guadagni innescarono così una crisi finanziaria che costrinse la Compagnia a chiedere sostanziosi aiuti alla Corona. Furono concessi, ma comportarono un costo pesante: i poteri discrezionali della Compagnia sarebbero stati inesorabilmente erosi da una serie di leggi promulgate dal Parlamento inglese.
46. Le riforme della classe dominante inglese
La prima di queste, il Regulating Act del 1773, fece del governo del Bengala il “governo supremo” in India, con compiti di supervisione nei confronti dei governi di Madras e di Bombay. Ma il potere effettivo era attribuito a un Consiglio ristretto formato da quattro membri nominati nello stesso Regulating Act, la cui scelta era espressione del governo di Londra.
Nel 1784, attraverso una nuova legge, venne creato in Inghilterra un Comitato di Controllo (Board of Control) con ampi poteri avverso le iniziative della Compagnia, una sorta di ministero per l’India, attraverso il quale il governo di Londra le sottrasse la gestione della politica indiana, lasciandole solo le attività commerciali e il “patronato”, ovvero la cooptazione dei funzionari e le decisioni sulla loro carriera. Limitando il potere di patronato dei direttori, la nomina del Governatore generale doveva essere approvata dal Comitato di controllo: i Governatori generali non vennero più scelti fra le file dei funzionari della Compagnia bensì delle classi dominanti britanniche. I Governatori godevano quindi di una libertà d’azione pressoché illimitata, accresciuta dal fatto che le comunicazioni tra Calcutta e Londra impiegavano in quell’epoca circa un anno.
È in questo periodo che venne mandato in India un “gentiluomo”, da sempre al servizio della corona, Charles Cornwallis. Dal 1790 iniziò una profonda riforma del sistema di governo indiano accentrando su di sé tutti i poteri giudiziari. Nel 1791, alla morte del nawab regnante, con l’appoggio della compagnia pose fine una volta per tutte al regno nominale dei discendenti di Mir Jafar, primo governatore del Bengala.
Le nuove leggi britanniche rappresentarono un potente contributo alla “ribrahmanizzazione” della società indiana, cioè alla sua definizione secondo le norme dell’ordine castale ortodosso, per l’ovvia convenienza dei nuovi dominatori.
Un’altra grande riforma di Cornwallis riguardò l’esazione dell’imposta fondiaria nel Bengala. Dal 1772 era stata data in appalto ai migliori offerenti. Al di fuori del territorio maratto e del sultanato del Mysore, questi esattori non erano nelle condizioni di preoccuparsi dello sviluppo produttivo delle terre. Unica prestazione loro richiesta era versare ogni anno nelle casse dello Stato una data somma di denaro senza alcun obbligo di promuovere lo sviluppo dell’agricoltura. Un sistema che risultò poco proficuo per la rapacità della classe dominante inglese. Inoltre gli appaltatori del periodo 1772-77 erano in genere estranei al mondo rurale e incapaci di stabilire un rapporto di cooperazione con i ceti che lo dominavano, in particolare con gli zamindar, tant’è che spesso non furono neppure in grado di far fronte al loro obbligo verso gli inglesi.
47. La terra agli zamindar
Di fatto in Inghilterra poco si sapeva dell’effettivo funzionamento dello sterminato mondo rurale indiano e delle sue peculiarità.
È in questo periodo che si sviluppò un serrato dibattito sulla questione di chi fosse l’effettivo detentore del diritto di proprietà sulla terra nel subcontinente. Secondo una scuola di pensiero la proprietà era appartenuta ai sovrani, quindi adesso doveva passare nelle mani della Compagnia, per arrivare alla Corona; un’altra teoria, vedeva negli zamindar l’equivalente indiano dei proprietari terrieri europei. L’influenza di Cornwallis, egli stesso grande proprietario terriero, fece prevalere quest’ultima tesi, di fatto una necessità della classe dominante inglese.
Poiché l’India Act del 1784 prevedeva l’abbandono del sistema d’appalto annuale delle imposte, Cornwallis introdusse nel 1789 un’imposizione fiscale fissa per dieci anni del cui versamento sarebbero stati responsabili gli zamindar, considerati da questo momento i proprietari di fatto della terra.
Nel 1793, alla vigilia del rientro in Inghilterra, Cornwallis si convinse della necessità di rendere permanente l’imponibile sui terreni. La sua proposta divenne legge il 23 marzo 1793, dando origine al cosiddetto permanent settlement, sistemazione definitiva. Il proprietario terriero, riconosciuto nel suo pieno diritto di proprietà sulle terre coltivate dai contadini, doveva corrispondere un ammontare fisso come imposta agraria.
Questa disposizione conferì altresì a coloro che erano soggetti a tale tassazione il diritto dell’ereditarietà e della alienabilità della terra, considerata quindi come bene di proprietà privata. A goderne non furono quindi i contadini che nei villaggi coltivavano queste terre ma gli zamindar, che fino ad allora avevano svolto soltanto la funzione di esattori dell’imposta, riuscendo in tal modo a trattenere una parte del denaro che spremevano alla classe contadina. Solo grazie a queste leggi divennero proprietari terrieri.
Questa disposizione mirava anche alla soluzione di un problema immediato. Sin dalla grande carestia del 1770 una massa di contadini abbandonava la terra e vagabondava alla ricerca di ingaggio come braccianti. Gli zamindar quando erano ancora solo esattori, giunto il momento del pagamento dell’imposta erano soliti lamentarsi della fuga degli agricoltori dai quali non erano riusciti a riscuotere alcunché. Tali lamentele rispondevano spesso alla realtà dei fatti, che le autorità britanniche non erano in grado di verificare. La disposizione del 1793 venne a risolvere il problema, con gli zamindar unici responsabili del pagamento pena la vendita all’asta delle loro proprietà. I contadini, in qualità di fittavoli, erano tenuti al pagamento di un affitto ai nuovi proprietari terrieri, tale contratto di locazione rappresentava una transazione privata e quindi di nessun interesse per le autorità.
48. La rivoluzione industriale e le nuove classi
Il permanent settlement e il riconoscimento degli zamindar avevano inoltre il fine di creare una classe di proprietari terrieri, sul modello degli squires britannici. Ci si aspettava infatti, proprio come con i proprietari britannici, che gli zamindar avrebbero investito i loro guadagni nei loro fondi agricoli.
Nel Bengala, dove l’imponibile risultò inizialmente troppo elevato, provocò per oltre un decennio seri problemi a questa classe. C’erano tuttavia molti territori ancora vergini che poterono essere messi progressivamente a coltivazione; su questi non gravavano le imposte, il che fece sì che la regione diventò una sorta di “paradiso degli zamindar”. Ma, salvo poche eccezioni, gli zamindar bengalesi non si trasformarono in imprenditori rurali, dato che spesso non erano loro ad organizzare la coltivazione della terra bensì i gruppi di famiglie contadine che gestivano i singoli villaggi.
Il graduale aumento della rendita terriera che andava agli zamindar fu essenzialmente consumato in spese improduttive e, in diversi casi, finì per essere suddivisa fra molti eredi. Dal punto di vista politico l’introduzione del permanent settlement comportò comunque la trasformazione della classe degli zamindar in un pilastro del nascente ordine coloniale.
In questi anni la Compagnia fece un largo uso delle forze armate per mantenere l’ordine nelle campagne, instaurando un regime d’occupazione militare. A dimostrazione delle difficoltà incontrate dallo Stato coloniale nel controllare l’entroterra rurale fu lo straordinario aumento del banditismo nel Bengala nei cinquant’anni successivi alla conquista inglese.
Alcune parti della nobiltà moghul erano state importanti per l’affermarsi della dominazione inglese, mentre gruppi di ricchi finanzieri e mercanti indiani sovvenzionavano le attività economiche e politiche della Compagnia. Al tempo della prima guerra anglo-maratta (1773-82), ad esempio, fu l’intermediazione di questi grandi finanzieri indigeni a permettere al “governo supremo” del Bengala di muovere le enormi somme necessarie a finanziare lo sforzo bellico sul lato occidentale dell’India. L’appoggio economico dei grandi finanzieri indiani fu indispensabile al funzionamento della Compagnia, prima ente commerciale, poi, almeno fino alla fine del Settecento, un quasi-Stato.
Con il passare degli anni i cambiamenti strutturali socio economici facilitarono l’ascesa di una nuova classe di finanzieri le cui fortune erano strettamente legate a quelle degli inglesi. I nuovi finanzieri erano quei funzionari della Compagnia che si erano arricchiti ma che per diverse ragioni, invece di rimpatriare le proprie ricchezze, avevano trovato più vantaggioso e meno rischioso reinvestirle in India. Spesso si riunirono in cooperative gestendo attività economiche di vario genere. Accanto ad essi nacque una nuova classe di mercanti e finanzieri indigeni che, in gran parte, avevano accumulato le loro fortune in qualità di mediatori d’affari dei funzionari inglesi della Compagnia. Questi due nuovi gruppi riuscirono a sostituirsi ai finanzieri moghul solo all’inizio dell’ottocento, quando le basi economiche a cui erano legati iniziarono ad indebolirsi.
Fra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, Europa e America settentrionale furono caratterizzate da una grande trasformazione conseguenza di una serie di rivoluzionari mutamenti. L’economia mondiale fu radicalmente cambiata dalla rivoluzione industriale, in corso in Inghilterra dalla seconda metà del Settecento ma destinata a influenzare in un modo o nell’altro il resto del mondo a partire dall’inizio dell’Ottocento, India compresa.
(Continua al prossimo numero)
4.
Amsterdam scinde il movimento sindacale
L’opera subdola dei dirigenti della Confederazione Generale del Lavoro, a parole dichiarava di voler aderire alle iniziative della costituzione dell’Internazionale sindacale rossa, di fatto si trovava pienamente integrata nella controrivoluzionaria Organizzazione gialla che, ricordiamoci bene, era, oggettivamente, legata a doppio filo alla Società delle Nazioni, definita da Lenin “covo di ladroni”.
Scriveva Il Comunista del 5 giugno 1921: «Si hanno notizie sull’ultima riunione del comitato direttivo della Internazionale sindacale di Amsterdam [...] Le prove che la Confederazione è più che mai legata ad Amsterdam, se ancora ne abbisogniamo, possono trovarsi nella notizia sulla riunione suaccennata, che troviamo nello stesso Avanti!. Da essa si rileva anzitutto che del Comitato direttivo dei gialli fa parte l’italiano Baldesi, che non assisteva solo perché intento a farsi eleggere deputato». Si leggeva infatti sull’organo di stampa socialista dello stesso giorno: «I giorni 18, 19 e 20 maggio si riunì ad Amsterdam il Comitato direttivo della Federazione Sindacale Internazionale [...] Si scusarono di non poter intervenire Thomas, Lian, Caballero e l’italiano on. Baldesi, il quale fu trattenuto in Italia dalla campagna elettorale».
Ma continuiamo a leggere il giornale socialista: «Si approvò la proposta di spedire L.50.000 alla Confederazione Generale del Lavoro d’Italia per appoggiarla alla lotta contro la reazione fascista».
Di questo tratteremo più avanti, adesso ci interessa vedere quale fu la deliberazione più importante di questo convegno di Amsterdam: «Si adottò una mozione affermante che le organizzazioni aderenti alla Terza Internazionale o alla Internazionale Sindacale di Mosca non possono essere affigliate alla Internazionale Sindacale di Amsterdam [...] e finalmente si votò la seguente mozione: “Il Comitato direttivo approva l’opera del Bureau contro l’azione di scissione delle forze operaie intrapresa dai dirigenti della Terza Internazionale; e di fronte all’intensificarsi del pericolo reazionario derivante dal persistere della campagna condotta da Mosca, considerando il principio della unità come indispensabile al movimento operaio, dichiara inammissibile il diritto per le organizzazioni sindacali di appartenere contemporaneamente a due diverse internazionali sindacali; quindi ogni organizzazione che farà atto d’adesione all’Internazionale politico-sindacale di Mosca, si metterà da sé fuori della Federazione Sindacale Internazionale”».
L’Avanti! riportava questa mozione senza nessun commento, nemmeno di fronte all’affermazione secondo cui “la campagna condotta da Mosca determinava l’intensificarsi del pericolo reazionario”, ossia era Mosca che rappresentava il centro della reazione internazionale. La mozione votata ad Amsterdam, per porre rimedio all’azione “scissionista” intrapresa da Mosca e per mantenere “l’unità” della classe operaia, deliberava l’espulsione dalla Internazionale sindacale, e quindi dalle organizzazioni sindacali aderenti, ogni sindacato che avesse aderito all’Internazionale sindacale rossa. Una logica veramente stringente!
Riportiamo ora diffusamente quale fu il commento del nostro partito.
«La tattica sindacale di Mosca è stata da noi mille volte esposta. Secondo le direttive della Terza Internazionale, ogni scissione nei sindacati e nelle loro Confederazioni nazionali deve essere evitata dai comunisti. Si deve restare nelle grandi centrali sindacali nazionali, anche aderenti ad Amsterdam, allo scopo di conquistare in esse la maggioranza, e una volta assicuratane la direzione agli elementi comunisti, staccarle da Amsterdam per farle aderire alla Internazionale dei sindacati rossi di Mosca. Non dunque scissione delle forze sindacali, ma loro liberazione dalla nefasta influenza dei gialli. Quando una lega, un sindacato si dichiara per Mosca, esso non esce dalla propria confederazione nazionale, ma va ad ingrossare la [una parola illeggibile, ndr] comunista nel movimento sindacale, i gialli si propongono di scindere questo organizzando l’ostracismo dei lavoratori rei di non subire supinamente le loro direttive reazionarie.
«Che ne dicono i confederalisti italiani? Essi che per giocare sull’equivoco partirono dalla falsa affermazione che una centrale sindacale potesse appartenere a Mosca e ad Amsterdam, e fingevano di preconizzare la tattica di organizzare nel seno della Internazionale di Amsterdam una frazione di sinistra facente capo a Mosca? [...]
«Adesso interviene Amsterdam e dice: Appena una organizzazione si dichiara per l’adesione a Mosca, deve uscire dalla Internazionale di Amsterdam, ossia dalla propria confederazione nazionale. Questo vuol dire che per evitare che si formi in ciascun paese una mag- [mancano una o più righe nel testo, ndr].
«[Non è] più Mosca che pone l’alternativa: con la Terza Internazionale o coi gialli (ponendola s’intende, alle confederazioni nazionali considerate in blocco inscindibile) ma è Amsterdam che dice incompatibile la presenza nelle sue file, non solo ad una organizzazione sindacale nazionale, ma a qualunque sindacato, che si pronunci per Mosca, che atteggiamento prendono i riformisti sindacali italiani?
«La risposta è facile. Benché si siano fraudolentemente e demagogicamente avvalsi della risorsa di far credere che erano per Mosca, essi resteranno con Amsterdam, solidali nella campagna contro i comunisti, tendente a farli uscire dalla confederazione. Questa campagna in Italia “si è già iniziata”. Il partito comunista se ne occuperà ampiamente, il partito comunista, ed i suoi militanti organizzati e organizzatori accettano la sfida dei riformisti confederali e si vedrà chi ne verrà fuori colle ossa rotte.
«Bisogna porre i socialdemocratici con le spalle al muro in ciascuna organizzazione dove ancora pontificano. Bisogna sempre presentare innanzi a loro il dilemma: Mosca o Amsterdam? Oggi soprattutto che non solo noi comunisti esigiamo una risposta chiara, ma che la stessa Internazionale di Amsterdam, deponendo ogni maschera, esige la scelta. Approvano i confederalisti italiani la recente mozione dei loro degni colleghi d’oltr’Alpe? Forse se essi si fossero trovati alla riunione avrebbero debolmente proposto di non stabilire l’incompatibilità, salvo ad uniformarsi alla decisione della maggioranza gialla. Il che dimostra che tra i turlupinatori delle masse i nostri bonzi italiani avrebbero buon diritto di primeggiare.
«In ogni modo la decisione dei loro amici viene a diminuire le risorse del loro gioco. Fino a quando riusciranno tacendo quando dovrebbero parlare e mentendo quando dovrebbero dire la verità, a reggersi al timone della nave proletaria, di cui puntan la prora nelle secche della collaborazione di classe e della controrivoluzione» (Il Comunista, 5 giugno).
Sempre dal nostro quotidiano apprendiamo come i capi sindacali si affrettassero a mettere in pratica le direttive di Amsterdam. L’articolo iniziava riportando un ordine del giorno del C.D. della CGL, approvato all’unanimità, in cui si diceva che «udite le comunicazioni della Segreteria circa la posizione di alcuni organizzatori e di alcune Organizzazioni denuncianti l’atteggiamento di gruppi di minoranze le quali [...] si abbandonarono alla più ignobile delle diffamazioni verso uomini e Organizzazioni confederali svalutando e mettendo in cattiva luce tutta l’azione della Confederazione Generale del Lavoro [...] affida al Comitato esecutivo l’incarico di mettere fuori del quadro della Confederazione quelle Organizzazioni e quei gruppi che agissero in contrasto alle direttive sindacali [...] invitando le Camere del Lavoro e le Federazioni provinciali ad agire in conformità». Il concetto era molto chiaro: ogni opposizione alle direttive bonzesche doveva essere automaticamente considerata come “ignobile diffamazione”, tale da espellere tutti coloro che, individui od organizzazioni, criticassero le direttive ufficiali.
Il nostro articolo continuava: «Invece i bonzi riuniti in concilio a Roma, hanno colta l’occasione per rendere un servizio ai Fimmen di Amsterdam. Ed hanno votato un o.d.g. nel quale è detto che il C.E. della CGL ha l’incarico di mettere fuori dei quadri quelle organizzazioni e quei gruppi che agissero in contrasto alle direttive sindacali approvate dall’enorme maggioranza del proletariato italiano (?). Tale provvedimento non riguarda più le denigrazioni e le calunnie ma le direttive sindacali. [...] Al grido confederale di: Via i comunisti dalle organizzazioni, rispondiamo con le tre parole semplici: Via i bonzi!» (Il Comunista, 31 luglio).
Passando alla lettura dell’altro organo di stampa del partito, L’Ordine Nuovo dell’8 giugno, si trova: «Amsterdam ha deciso che piuttosto che lasciare i posti direttivi ai comunisti, i sindacati debbono essere scissi, che si deve rinunciare all’unità proletaria piuttosto che alle cariche tenute attualmente dai riformisti nelle Organizzazioni. Secondo questi principii operano i capi sindacali della Germania e della Francia. È di oggi infatti la scissione del Sindacato dei ferrovieri francesi perché la minoranza non ha voluto sottostare al voto e alla volontà della maggioranza comunista.
«La tattica della scissione che viene usata contro i comunisti non serve però ancora a raggiungere quello che nel momento attuale deve essere lo scopo principale dell’Internazionale gialla: riconquistare la fiducia delle masse. Le masse hanno abbandonato i gialli di Amsterdam e si sono rivolte verso Mosca per la convinzione che il programma comunista, il programma della conquista del potere, è il solo adeguato ai bisogni attuali della classe lavoratrice. Di qui la necessità per Amsterdam di tirar fuori un altro programma, il quale sia capace di distogliere le masse da quello rivoluzionario, capace di addormentarle con la prospettiva del raggiungimento sollecito di vantaggi immediati e capaci in pari tempo di allontanare la crisi rivoluzionaria del potere e della rivoluzione. Nei convegni internazionali dei capi riformisti delle Organizzazioni si è trovato che nulla poteva meglio servire al contemporaneo raggiungimento di tutti questi scopi quanto il porre i Sindacati e le masse in essi organizzate sul terreno di una effettiva collaborazione, trasformando lentamente, ma in modo esteso ed inorganico gli organi di resistenza in organi regolatori della produzione nello stesso regime borghese [...]
«I rivoluzionari non sostengono forse che nella pura resistenza non può oggi esaurirsi l’azione di classe, che è necessario uscire dai limiti di essa e dare un carattere costruttivo all’opera di ogni organismo operaio? La rivoluzione russa non ha dimostrato praticamente l’enorme valore dei sindacati come mezzo di costruzione economica e non solo di difesa? I controrivoluzionari fingendo di parlare agli operai lo stesso linguaggio, fingendo di portar loro gli stessi esempi portati dai comunisti, parlano essi pure di trasformazione degli organismi di resistenza e di un loro più diretto aderire al processo produttivo, ma la sostanza è completamente diversa. Sono fondamentalmente diverse le premesse: gli uni dicono che si deve anzitutto pensare alla conquista del potere e lavorare per essa e solo in seguito, quando tutto il potere sarà passato nelle mani dei lavoratori, solo allora gli operai e i contadini dovranno considerare il problema della produzione come il problema essenziale della vita loro e centro dell’azione dei loro organismi; gli altri vogliono invece che fin d’ora le energie operaie siano volte a ricostituire il mondo economico che la volontà dei capitalisti ha distrutto e che senza la collaborazione dei lavoratori non si può ricostituire [...]
«In Italia l’accettazione di questo programma si è potuto leggere fra le righe dei discorsi fatti da Ludovico D’Aragona a Livorno e a Milano quando ha parlato di un avvicinamento della cooperazione alla resistenza e della necessità di stringere più stretti legami fra gli organi di questi due rami dell’attività di classe. Il programma di Amsterdam appariva così seminascosto, ricoperto del velo d’ipocrisia che è proprio dei capi sindacali del nostro paese [...]
«Ma le apparenze sono salve. A Livorno la Confederazione ha votato una platonica adesione all’Internazionale di Mosca. Intanto è rimasta con Amsterdam e agli operai che sono, per le loro aspirazioni, rivoluzionari e comunisti, fa applicare il programma dei gialli. Domani quando attraverso a questi esiziali esperimenti si sarà disfatto lo spirito di combattimento delle masse, i capi getteranno la maschera e grideranno che la rivoluzione non si può farla perché i lavoratori non la vogliono e non sono pronti per essa. Occorre fin d’ora smascherarli e mettere gli operai sull’avviso».
Per rendersi conto dello strettissimo legame che univa la CGL, e il partito socialista, all’internazionale di Amsterdam sarebbe sufficiente leggere l’articolo apparso sull’Avanti! dell’11 maggio, che portava il titolo: “Solidarietà internazionale”. Teniamo sempre ben presente che il quotidiano socialista era in mano ai massimalisti, a quei presunti rivoluzionari che continuavano a rivendicare il loro diritto di appartenere all’Internazionale Comunista.
Nell’articolo si legge che «se vi è una reazione che si porge la mano al di sopra di tutte le frontiere per abbattere con identici mezzi le classi lavoratrici, vi è anche una solidarietà operaia internazionale che guida e protegge il proletariato nella dura lotta per la propria emancipazione. Coloro che negano ostinatamente l’internazionalismo veggano anche in tali esempi come questa generosa idea di affratellamento di tutte le genti permanga e si rafforzi anche attraverso le più violente bufere. Coloro che hanno creduto di poter soffocare nei cuori dei lavoratori il grande principio ed il sentimento della solidarietà internazionale contrapponendogli, ciecamente ed a torto, il principio ed il sentimento patriottico, veggano come anche nel buio delle più tetre tempeste [...] la fiamma ideale della solidarietà internazionale [...] risplenda a mille doppi più viva [...] Ecco perché noi esultiamo alla lettura dell’attestato di affetto che giunge da Amsterdam al proletariato italiano». L’articolo continua la sua esaltazione dell’Internazionale gialla per i suoi tangibili attestati e contributi alla causa del proletariato internazionale.
In cosa consistesse quella grandiosa solidarietà internazionale lo possiamo leggere dall’ordine del giorno dell’Internazionale gialla approvato nella riunione del 28 e 29 aprile: «Per dimostrarvi i nostri sentimenti mettiamo a vostra disposizione la somma di 50.000 lire sperando che essa vi servirà ad intensificare la vostra propaganda, a fortificare la vostra posizione, e ad alleviare i vostri danni» (Avanti!, 11 maggio).
Come abbiamo visto l’Avanti! affermava che le famose 50.000 lire erano state inviate alla CGL «per appoggiarla alla lotta contro la reazione fascista». Notiamo invece che nelle motivazioni di Amsterdam questa finalità non è menzionata, anzi noi, con i nostri compagni di allora, crediamo che altra sia stata la finalità del generoso finanziamento, più che alla lotta contro il fascismo sia servito «per coprire le spese della elezione di Baldesi e della trombatura di D’Aragona» (Il Comunista, 5 giugno).
Sabotato il congresso di Mosca
Torniamo ora a considerare l’atteggiamento della Confederazione Generale del Lavoro nei confronti della costituenda Internazionale sindacale rossa.
Dalla lettera di Baldesi, pubblicata dall’Avanti! del 9 luglio, siamo informati che la CGL, già ai primi di giugno aveva richiesto che la data del Congresso sindacale internazionale fosse rinviata e che il congresso si tenesse non a Mosca, ma in Estonia o in Svezia. Questo il dispaccio confederale: «La Confederazione Generale del Lavoro propone di convocare il Congresso dei sindacati rossi a Stoccolma o a Reval ritardandolo fino ad agosto per conoscere le decisioni del Congresso della Terza Internazionale e per allargare l’ordine del giorno aggiungendo ad esso la discussione di ordine generale sulla situazione generale dei Sindacati e sul programma dell’Internazionale sindacale a questo proposito» (riportato da L’Ordine Nuovo del 7 luglio).
A questo evidente tentativo di sabotaggio della costituzione dell’Internazionale sindacale rossa, i delegati di molti sindacati risposero che «ritardare il Congresso quando i tre quarti dei delegati sono già presenti, ritardare il Congresso dopo che i più grandi sforzi e le più grandi spese sono state fatte per venire a Mosca attraverso ai reticolati posti dai Governi di tutti i paesi, ritardare il Congresso mentre numerosi delegati hanno impiegato dei mesi per venire a Mosca (dall’America, dall’Argentina, dall’Australia), per intendersi coi loro fratelli di classe, ritardare ora il congresso vorrebbe dire recare un considerevole pregiudizio al movimento operaio e disorganizzarlo per lungo tempo [...] Ritardare per conoscere le decisioni del Congresso della III Internazionale? Ma noi abbiamo la facoltà di assistere come delegati o uditori al Congresso comunista [...] Ritardare il Congresso perché bisogna allargare l’ordine del giorno. Ma ciò si può fare senza che nessun ritardo sia portato alla apertura del Congresso [...] Ogni delegazione, anzi ogni delegato, può proporre di allargare o limitare l’ordine del giorno e chiedere che figurino in esso tutte le questioni che interessano i proletari dei rispettivi paesi.
«Il nostro stupore diventa sdegno quando leggiamo [...] di trasportare il Congresso a Stoccolma o a Reval [...] Avete iniziato delle trattative col Governo estone o svedese per ottenere l’autorizzazione a tenere sul loro territorio il Congresso dei sindacati rivoluzionari? Assumereste su di voi la garanzia della sicurezza di tutti i delegati i quali giungono spesso per via illegale dai paesi “democratici”? [...] I delegati dei Sindacati operai [...] arrivati al Congresso costitutivo dell’Internazionale dei sindacati rossi sono certi che il proletariato italiano respingerà ogni idea di pace sociale e di collaborazione di classe; esso si allontanerà dall’Internazionale di Amsterdam che organizza il sabotaggio della rivoluzione sociale».
A prescindere dal fatto che già fossero a Mosca molti delegati provenienti da tutto il mondo, la richiesta della Confederazione italiana di tenere il congresso fuori della Russia avrebbe potuto essere accettata? Rispose Losowski: «In questa lettera D’Aragona esprime il parere che il Congresso si svolga a Reval o a Stoccolma. Ebbene, anche noi vorremmo che il Congresso si tenesse a Stoccolma o a Reval e non soltanto in queste città; ma a Milano, a Berlino o a Parigi. Ma questo non dipende da noi. Esiste ancora la borghesia, e il compagno Bianchi lo sa che non permetterebbe al nostro Congresso, che non si occupa soltanto della socializzazione, ma anche di qualche altra questione un po’ più pericolosa per il capitalismo mondiale, di riunirsi in una città in suo potere, prima che sia compiuta e vittoriosa la rivoluzione. E del resto ci date voi, proponendoci di trasferire il nostro Congresso a Reval, o a Stoccolma, le garanzie che ciò si possa fare?».
Secondo quanto riportato dal quotidiano socialista, invece, «la richiesta era fatta per due ragioni: 1) perché la Confederazione voleva essere sicura – come prescritto dalla deliberazione del congresso di Livorno – che il Partito socialista non sarebbe stato messo alla porta a Mosca, per non cadere nell’imbarazzante situazione di appartenere ad una Internazionale che muove guerra al Partito che ha un Patto di alleanza con la Confederazione; 2) che il Congresso avvenisse in una città ove i delegati fossero in condizione di liberamente comunicare con le loro centrali per sottoporre loro i quesiti che potrebbero impegnare le organizzazioni al di là delle deliberazioni del Congresso». Inoltre Baldesi ammetteva che la CGL non aveva nessuna intenzione di uscire dall’Internazionale gialla di Amsterdam: «I nostri rappresentanti sono andati in Russia col preciso mandato d’invitare tutte le organizzazioni rappresentate ad entrare nella Internazionale di Amsterdam, per combattervi lì la battaglia socialista». Alla faccia! E si lamentavano di non avere la possibilità di “liberamente comunicare”. Chissà cosa non avrebbero “comunicato” dalla città di una nazione “neutrale”!
Dunque la CGL era andata a Mosca con il preciso compito di sabotare la nascita dell’Internazionale sindacale rossa.
Nello stesso numero di giornale socialista possiamo leggere in quale considerazione era tenuta l’Internazionale Comunista dal “glorioso” Partito socialista italiano. Si tratta di poco più di un trafiletto dal titolo “Notizie a vanvera”. Prende le mosse dalla notizia apparsa su alcuni giornali secondo cui «in seguito alla decisa esclusione del PSI dalla III Internazionale, ai delegati italiani è stato notificato dal Governo dei Soviet che essi dovranno abbandonare immediatamente la Russia dando loro poche ore di tempo». Giustamente l’Avanti! giudica questa notizia come una “frottola”, tant’è che i telegrammi inviati, da Mosca, dai loro compagni non avevano fatto accenno a simile ingiunzione, dimostrando che da Mosca c’era libertà di comunicazione. Ma l’Avanti!, dopo aver smentito la frottola, continuava che nel caso la notizia, riportata dai giornali borghesi, fosse stata vera, «starebbe a dimostrare in che razza di condizioni di libertà si possa svolgere un Congresso internazionale nella capitale dei Soviet». Sono sufficienti queste poche parole per stabilire il grado d’infamia dei redattori dell’Avanti!. La notizia era falsa, ma nel caso fosse stata vera dimostrerebbe etc, etc...
L’articoletto continuava: «Il Congresso di Mosca, come già osservammo altra volta, si svolge fuori d’ogni controllo della opinione pubblica internazionale. I suoi deliberati giungono a pezzi e bocconi attraverso le fonti più diverse: da Riga da Helsingborg, da Stoccolma, da Londra, da Berlino, e qualche volta, persino da... Mosca. I resoconti dei discorsi che vi si tengono sono brandelli di ragionamenti senza sugo [...] Intanto nell’Europa occidentale – mentre non si conosce nulla o quasi delle attuali discussioni – non si hanno ancora neppure i resoconti del Congresso tenutosi l’anno scorso. In tali condizioni di cose [...] noi ci domandiamo come può procedere innanzi il movimento internazionalista».
Così veniva presentata l’Internazionale comunista dal giornale di quel partito che aveva inviato i suoi “pellegrini” (Lazzari, Maffi, Riboldi) a piatirne la riammissione, dichiarando che «Turati, Prampolini, Treves e altri sono brava gente, persone oneste», al contrario dei comunisti «che sono in generale dei fanfaroni [...] I dirigenti sono un gruppo di giovani ambiziosi, dei teorici colti ma senza pratica alcuna e assolutamente mancanti di sentimenti di solidarietà e di fraternità [...] Non avete fatto una grande conquista facendovi rappresentare da questi elementi» (Costantino Lazzari, “Il mio ultimo colloquio con Nicola Lenin”).
Però Lazzari, bontà sua, si dichiarava disposto a chiudere un occhio affermando che i “fanfaroni” «comunisti potranno rientrare nelle file del partito socialista dalle quali nessuno li aveva cacciati».
Torniamo al congresso del Profintern.
Ai dirigenti italiani Bianchi e Azimonti, arrivati a congresso iniziato, venne subito contestato il comportamento tenuto dalla CGL: «I delegati della Confederazione italiana hanno firmato, l’anno scorso, con la Confederazione del Lavoro russa e con i rappresentanti di altri paesi, un accordo sulla questione dell’organizzazione dell’Internazionale Rossa dei sindacati. Avevano affermato che il proletariato italiano porta un vivissimo interesse a questa grande questione. Ma la delegazione italiana non ha preso parte ai lavori del Consiglio internazionale provvisorio dei sindacati. Ha effettivamente partecipato invece ai lavori dell’Internazionale di Amsterdam. Al congresso [sindacale, ndr] di Livorno il movimento sindacale italiano si è chiaramente espresso per l’Internazionale sindacale rossa, ma ciò non ha impedito ai dirigenti della CGL di orientarsi verso Amsterdam evitando in tutti i modi di lavorare con l’Internazionale rossa. In questi ultimi tempi i capi della CGL hanno fatto tutto il possibile per rinviare o impedire il nostro congresso. Così stando le cose, crediamo necessario esigere dai compagni Bianchi e Azimonti una spiegazione sulle ragioni della loro tattica».
I caporioni italiani tennero subito a mettere in chiaro che la loro partecipazione al congresso era esclusivamente a livello “informativo”. Affermava Bianchi: «Assistiamo al congresso semplicemente per informare in seguito i compagni italiani sui lavori del Congresso stesso [...] Le organizzazioni italiane sono abituate a discutere preventivamente tutti i documenti che interessano i congressi ai quali sono chiamate a partecipare. Solo quando questa discussione è terminata nelle organizzazioni, solo quando le masse hanno manifestato la loro opinione sulle quistioni dibattute, la CGL, ispirandosi allo stato d’animo dei suoi due milioni e mezzo di aderenti, si assume il compito di esprimere la loro opinione nei congressi mondiali».
Insomma i bonzi italiani avevano la faccia tosta di affermare che «non sapendo ciò che realmente sarebbe avvenuto al congresso» limitavano la loro partecipazione a quella di semplici spettatori. A Bianchi non mancò di rivendicare il carattere rivoluzionario della CGL che, durante il biennio rosso, avrebbe voluto «impadronirsi di tutte le industrie e prendere possesso delle proprietà terriere», senonché il movimento rivoluzionario era stato spezzato da quei compagni passati poi al partito comunista. «Gli elementi di estrema sinistra hanno la responsabilità di aver paralizzato il movimento in un momento critico». Affermava inoltre l’intenzione di rimanere nell’Internazionale di Amsterdam per combatterla dall’interno, cosa che la CGL avrebbe già fatto, molto prima che Mosca si fosse posta il problema.
Bianchi ebbe infine il coraggio di accusare l’Internazionale sindacale rossa, di avere causato l’arrivo in ritardo della delegazione italiana. «Essa attendeva il momento in cui sarebbe stato possibile sapere ciò che realmente sarebbe avvenuto al congresso», inoltre attendeva «i documenti dei quali avrebbe dovuto prendere conoscenza».
«Ciò che ci interessa – replicò giustamente Losowski – non è sapere perché i delegati italiani sono arrivati in ritardo; ma perché sono venuti a questo congresso costitutivo con voto consultivo, mentre vanno ad Amsterdam con voto deliberativo».
Riguardo al fatto che gli italiani erano stati inviati a Mosca solo a titolo “informativo”, Losowski ribatteva: «Di che volete informarvi, compagni? Volete sapere se siamo per la rivoluzione sociale e per la dittatura proletaria? Credo che ormai lo sappiate. Ma non siete venuti a fare un’inchiesta sulla situazione della Russia, bensì al Congresso costitutivo dell’Internazionale Sindacale Rossa. Quali informazioni volete dunque attingere a questo Congresso?»
Molto più chiare e dirette furono le affermazioni di Azimonti, che senza mezzi termini si permise di dare il suo aut aut a Mosca: «Da parte nostra non si poteva aderire a Mosca finché il Partito socialista era fuori della III Internazionale: non bisogna mai dimenticare che il movimento sindacale è strettamente collegato col movimento politico e che, solo la unione di questi due movimenti sotto la direzione sperimentata di militanti provati, potrà dare al movimento operaio e internazionale un carattere di sviluppo offensivo [...] Noi non saremo uniti dal punto di vista internazionale che quando il Partito [socialista, ndr] italiano entrerà nella III Internazionale. E quando ciò sarà fatto, la CGL che dipende dal Partito, entrerà automaticamente nella Internazionale Sindacale Rossa».
Sulla questione italiana diversi furono i delegati stranieri che presero la parola: lo svizzero Bloch, lo spagnolo Ibagnès, l’inglese Tom Mann; il tedesco Fabig, tutti quanti censurando il comportamento dei dirigenti della Confederazione italiana, che partecipavano come osservatori al congresso di fondazione dell’Internazionale sindacale rossa, mentre a pieno titolo erano intervenuti al congresso di Londra dell’Internazionale gialla. Dal momento che tutti quanti i delegati formularono all’incirca le medesime critiche, ci limiteremo a riportare soltanto alcuni brani dell’intervento del rappresentante spagnolo, Ibagnès.
«Il compagno Bianchi ha esposta la situazione della CGL d’Italia, dicendo che questa CGL agiva sempre da rivoluzionaria. Egli ci ha ricordato l’atteggiamento della CGL di Italia durante la guerra. Ci ha parlato della rappresentanza di questa CGL alla conferenza di Zimmerwald, alla conferenza di Kienthal, ove si preparava il movimento rivoluzionario. Ma, caro compagno Bianchi, non si tratta del passato, si tratta del presente. Non è sul passato che si può contare per fare una rivoluzione mondiale, per venire in aiuto alla rivoluzione russa. Bisogna contare sull’azione presente, sui fatti che possano aiutare il proletariato di Russia, che corre forse il pericolo di essere schiacciato dal movimento capitalista internazionale. Non ci si può riparare dietro il paravento di quello che si è fatto durante la guerra o ciò che si è fatto prima della guerra. Bisogna stare alla realtà rivoluzionaria del momento [...]
«Il trattato concluso dalla CGL e il Partito socialista da una parte e gli elementi fascisti d’Italia dall’altra è la prova più rimarchevole che la CGL, come il Partito socialista italiano, è alleata con gli elementi borghesi, ha tradito il principio della rivoluzione sociale nettamente, chiaramente, e noi non possiamo comprendere che gli elementi rappresentanti della CGL, che hanno detto che agivano sempre da rivoluzionari, possano ora firmare dei compromessi con gli elementi che uccidono i compagni sindacalisti rivoluzionari, che impugnano le armi contro le organizzazioni operaie, che infine obbligano il proletariato d’Italia ad emigrare in massa perché non può più vivere nella libertà che gli garantivano le stesse leggi dello Stato italiano. E voi avete firmato un trattato con questi elementi; e firmando quel trattato avete decapitato tutti i principi rivoluzionari ed avete uccisa anche la vostra dignità [...]
«Questo fatto, compagni, ben comprova che voi non siete mai stati all’altezza delle circostanze rivoluzionarie. Voi avete detto che il movimento rivoluzionario di settembre non era stato tradito da voi, che c’erano elementi comunisti allora alla testa del movimento; ma il compagno che ha parlato poco fa ha messo bene i puntini sulle i, dimostrando che la colpa non è stata degli elementi rivoluzionari, ma degli elementi riformisti, dei quali voi siete la rappresentanza in questo congresso. Io mi attengo piuttosto alle manifestazioni del compagno Repossi che alle manifestazioni controrivoluzionarie dei rappresentanti degli interessi della borghesia, poiché voi siete stati rappresentati alla conferenza di Amsterdam e alla conferenza di Washington, ove la maggior parte dei delegati erano rappresentanti dei borghesi [...]
«Le vostre manovre per stringere relazioni con Mosca non miravano ad altro che ingannare le masse; ma questo non vi riuscirà mai, malgrado che vi chiamate loro rappresentanti [...] Compagni, credo che noi dobbiamo avere un po’ meno di fraseologia rivoluzionaria. Il compagno Bianchi, terminando il suo discorso ha detto: “Viva la rivoluzione sociale”, preferisco fare la rivoluzione sociale, e quando sarà fatta, sarà tempo di gridare: “Viva la rivoluzione sociale internazionale”».
Il compagno Repossi, rappresentante della frazione comunista, dichiarò di parlare a nome della minoranza della CGL, ma solo perché «a Livorno, nel febbraio 1921, grazie ad una politica abile dei dirigenti della CGL il voto non rispecchiò i veri rapporti delle forze in seno al proletariato d’Italia», perché in quel caso avrebbe di certo rappresentato la maggioranza. «Il mezzo milione di voti, che fu dato ai comunisti, non rappresenta il numero degli operai che hanno adottato il punto di vista comunista. Così pure il 1.200.000 voti dati alla CGL è ben lungi dal testimoniare la sua vera importanza nella massa operaia». Dopo questa utile premessa Repossi procedeva nel confutare tutte quante le affermazioni fatte dal bonzo Bianchi. Da un lato dimostrava la responsabilità dei dirigenti confederali che avevano portato alla sconfitta del movimento di un proletariato che marciava sulla via della rivoluzione, dall’altro negava che le conquiste ottenute fossero da attribuirsi alla politica confederale quando altro non erano che frutto della «pressione delle masse operaie dirette dagli elementi più radicali, raggruppati nella CGL e fuori di essa».
Riguardo alla scelta tra le due internazionali sindacali, Repossi ribadiva che il proletariato italiano non aveva avuto esitazioni: «In molte conferenze, riunioni, congressi, meetings, ha adottato delle risoluzioni che esigevano una adesione a Mosca senza condizioni e senza riserve. In queste risoluzioni non si faceva questione di Amsterdam, perché era chiaro che l’adesione a Mosca significava l’uscita da Amsterdam. Ma la CGL ha agito da buona diplomatica al Congresso di Livorno, e quando la questione doveva essere risolta definitivamente aggiunse questa formula: “Senza ritirarsi da Amsterdam”. Lo spirito delle esigenze reiterate delle masse (aderire senza riserve a Mosca) è stato conservato nella formula di Livorno, ma vi si è aggiunto: “Purché il Partito Socialista Italiano sia ammesso nella Internazionale Comunista”».
Repossi ricordò pure l’impegno dei comunisti per l’unità della classe operaia: «La frazione comunista della CGL non si è mai rifiutata all’idea dell’unificazione di tutte le forze delle organizzazioni sindacali. Non è passato ancora molto tempo da che abbiamo rivolto un appello a tutti i sindacati italiani, un appello a desistere per il momento dalle discordie interne, per creare un fronte di lotta unico davanti ai pericoli che minacciavano il proletariato da parte della borghesia».
Di fronte alla ridicola accusa fatta da Bianchi, secondo cui il fascismo altro non sarebbe stato che la reazione alle provocazioni comuniste, Repossi attaccava con virulenza: «Non è il Partito Comunista che è colpevole della creazione e dello sviluppo del fascismo; ma è dall’opportunismo, è dall’indecisione di cui la CGL ha dato prova nei momenti più critici della vita della classe operaia che è nato il fascismo [...] Il fascismo sarebbe impossibile senza la disfatta di novembre-dicembre 1919. Sarebbe impossibile se la CGL non si fosse mostrata tanto impotente, se la borghesia non fosse giunta a riaversi dallo spavento che aveva provato dinanzi alle inattese conquiste della classe operaia. È solo perché il movimento è stato schiacciato, perché la forza armata operaia è stata spezzata dall’assenza di unità politica e dalle vane ciarle della CGL, che la borghesia ha acquistato la convinzione che è facile vincere la classe operaia. Essa ha creata la sua armata per avere una forza solida capace di schiacciare la classe operaia [...] Il fascismo non è altro che la guardia bianca della borghesia. È la mano di ferro che la borghesia cerca di impiegare per rompere la testa al proletariato. Il movimento rivoluzionario in Italia ha indietreggiato, nonostante che il proletariato abbia tenuta fra le mani la rivoluzione. Egli ha dovuto lasciarla andare, perché la CGL e il Partito socialista si sono attaccati ai vecchi pregiudizi [...] quali il Parlamento e l’assemblea costituente [...] La rivoluzione rovescia tutto ciò, come è necessario, come è stato fatto in Russia. Ma la CGL non si è assimilata questa verità e ripete le frottole liberali».
A Congresso ormai chiuso Losowski poteva affermare: «La questione della CGL italiana ha occupato il Congresso in modo speciale. La risoluzione che fu adottata dopo una discussione accurata, è espressa in termini non equivoci, e si pronunzia contro la doppia posizione presa dalla CGL italiana [...] La risoluzione non è diretta contro i sindacati italiani – il Congresso ha perfettamente compreso che quantunque il proletariato italiano ed i suoi sindacati non siano con noi nella forma, essi in realtà sono ugualmente con l’Internazionale sindacale rossa» (Il Comunista, 11 settembre 1921).
Di seguito riportiamo la parte finale della “Risoluzione sulla questione italiana” approvata all’unanimità dal Congresso di fondazione dell’Internazionale Sindacale Rossa, nella seduta del 13 luglio 1921:
«Prendendo atto di quanto è detto sopra, il Congresso costitutivo dei Sindacati rivoluzionari stima che:
«Il proletariato italiano non è responsabile di questa politica ambigua, così nociva ai suoi interessi e a quelli della rivoluzione mondiale: questa politica equivoca è opera dei circoli dirigenti della CGL italiana, che tendono ad isolare il proletariato italiano dai sindacati rivoluzionari di tutti i paesi.
«Un tale stato di cose, di cui la Centrale sindacale di un paese aderisce verbalmente alla Internazionale Sindacale Rossa, pure aderendo realmente alla Internazionale Sindacale di Amsterdam, non può essere tollerato più a lungo. Quindi il primo Congresso dei Sindacati Rivoluzionari si rivolge ai proletari rivoluzionari d’Italia, a tutti i sindacati locali, a tutte le Camere del Lavoro e alle Federazioni nazionali, domandando loro di pronunciarsi su questa questione: chi intendono seguire i sindacati d’Italia? L’Internazionale della lotta rivoluzionaria, oppure l’Internazionale della collaborazione di classe? L’Internazionale della rivoluzione sociale e della dittatura del proletariato, oppure quella che è per la pace sociale e la dittatura della borghesia? L’Internazionale Rossa o l’Internazionale di Amsterdam?
«Il Congresso è sicuro che i proletari d’Italia faranno tra breve la loro scelta, e che nel prossimo Congresso Internazionale, la CGL italiana occuperà fra i sindacati rivoluzionari il posto che merita il proletariato rivoluzionario d’Italia».
[Le citazioni di questo capitolo delle quali non è stata menzionata la fonte sono tratte dall’opuscolo “I Sindacati Italiani al Primo Congresso dell’Internazionale dei Sindacati Rossi”, Libreria Editrice del Partito Comunista d’Italia, Roma, 1921].
(continua al prossimo numero)
Nella “Enciclopedia” di Diderot e D’Alambert del XVIII secolo, alla voce “Libertà civile”, il cui autore è il cavaliere de Jaucourt, leggiamo: «Non esistono parole, come ben dice il signor De Montesquieu, a cui gli uomini abbiano attribuito tanti significati diversi come a questa».
Nell’Illuminismo parole come Libertà, Ragione, Uomo, Coscienza e Natura hanno dominato la scena, trasportate però nel regno dell’astrazione, al di fuori del tempo e della storia. Solo il materialismo dialettico, o storico, ha permesso di comprendere che questi termini non indicano realtà eterne e immutabili come altrettante divinità, ma prodotti della storia, idee e ideologie che, in quanto tali, sono il riflesso dei rapporti di produzione e dei rapporti tra le classi, cioè dei rapporti in cui gli individui si trovano tra loro in funzione di determinati rapporti di produzione.
Le suddette concezioni dell’Illuminismo, e tra esse in particolare il “diritto di natura”, hanno avuto una enorme importanza in quanto costituenti l’ideologia rivoluzionaria della borghesia nel secolo in questione e in particolare nella Rivoluzione francese. Questa ideologia, allora rivoluzionaria, era nata nel secolo precedente con il giusnaturalismo, non a caso in paesi come l’Olanda di Grozio e l’Inghilterra di Locke, dove la borghesia era già al potere o stava per arrivarci. Secondo questa concezione l’uomo in quanto tale ha dei diritti che derivano dalla natura, sempre in quanto tale, per cui imperatori, re e papi non glieli possono negare. Tale concezione ha le sue radici nell’aristotelismo del XIII secolo, più che nel neoplatonismo rinascimentale, intriso di stoicismo, così come quello più antico.
Ci limitiamo a riportare due citazioni di Montesquieu e di Blanqui sulla libertà.
Charles-Louis de Secondat nel 1716, all’età di 27 anni, eredita dallo zio il titolo di barone De Montesquieu, assieme ad un ingente patrimonio e alla carica di presidente del parlamento di Bordeaux. La sua opera più importante è “Lo spirito delle leggi” del 1748, in cui sostiene la divisione dei poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario, sul modello inglese da lui ammirato.
Le sue concezioni sono state viste in un’ottica schiacciata su epoche successive. Nel XIX e nel XX secolo come quelle di un teorico delle democrazie borghesi del tempo, mentre nella Rivoluzione francese di un repubblicano e un rivoluzionario. L’ideologia dei giacobini e dei rivoluzionari in generale era un misto di Rousseau e Montesquieu rielaborati, con una netta preminenza del primo. Rousseau veniva depurato della sua critica alla proprietà privata e del suo pessimismo, e subiva l’innesto dell’ottimismo di Condorcet e degli enciclopedisti in generale riguardo alla possibilità di rigenerare una società corrotta dall’ignoranza, dalla superstizione e dalle disuguaglianze.
Montesquieu, avendo posto il principio della repubblica nella virtù, veniva visto come un repubblicano, e quindi un rivoluzionario. Billaud-Varenne, membro del Comitato di Salute Pubblica, scrive nell’anno III della Repubblica (dopo il Termidoro) che Montesquieu è stato il punto di svolta del pensiero politico francese, pensiero poi continuato e superato da Rousseau. Montesquieu parla di tre tipi di governo: la repubblica, la monarchia, il dispotismo. La repubblica ha per principio la virtù, la monarchia l’onore, e il dispotismo il timore. La repubblica può essere di tutto il popolo o di una parte di esso: può essere quindi democratica o aristocratica. Borghesi e aristocratici, lettori di Montesquieu e di Rousseau oltre che di Plutarco e Cicerone, potevano quindi aspirare ad essere virtuosi, depositari delle antiche virtù repubblicane nel mito della Sparta di Licurgo e della Roma repubblicana di Giunio Bruto.
Il mito di tali virtù, allora di grande diffusione, non significava automaticamente volere la repubblica, e meno ancora la rivoluzione: sarebbe altrimenti difficile comprendere l’elogio delle virtù repubblicane fatto in tali anni da un re di Polonia, pur tenendo conto che la Polonia monarchica di allora era di fatto una repubblica aristocratica, dove i re erano eletti da una aristocrazia molto numerosa, che in alcuni periodi della storia polacca arrivò a costituire più del 10% della popolazione.
Con la rivoluzione americana del 1776 si cominciò a pensare che la repubblica non riguardasse solo le antiche poleis greche o i cantoni svizzeri, ma fosse una possibilità anche per Stati di grandi dimensioni come la Francia.
Va detto che Montesquieu, che è difficile definire repubblicano, nei suoi scritti e appunti datati tra il 1716 e il 1755, riordinati in seguito da altri con il titolo di “Riflessioni e pensieri inediti”, scrive al sottotitolo “Repubbliche”: «Io non sono di quelli che considerano la Repubblica di Platone come una cosa ideale e puramente immaginaria, e di cui sarebbe impossibile l’attuazione».
La libertà politica di cui parla Montesquieu si può trovare tanto nelle monarchie quanto nelle repubbliche: non è propria delle une o delle altre in quanto tali, ma dei governi che chiama “moderati”, dove la divisione dei poteri impedisca gli abusi, come scrive ne “Lo spirito delle leggi”: «Occorre che per la disposizione stessa delle cose il potere arresti il potere». Le simpatie di Montesquieu andavano quindi tanto alla monarchia costituzionale quanto alla repubblica, purché “moderate”, con la tripartizione dei poteri.
Ovviamente nella Francia del suo tempo, assieme alla grandissima parte degli illuministi, sosteneva la soluzione meno traumatica, cioè una monarchia che, sotto l’influenza delle nuove idee, si riformasse in senso costituzionale. Sicuramente non era un rivoluzionario.
Ma la separazione dei poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario era un attacco alla monarchia assoluta e quindi un possibile strumento ideologico nelle mani della borghesia in vista della sua ascesa al potere. In questo senso, almeno fino al 1789, la separazione dei poteri ha trovato posto all’interno della ideologia rivoluzionaria borghese.
La concezione della separazione dei poteri di Montesquieu rispondeva però anche a una esigenza di stabilità e di conservazione, riallacciandosi, da tale punto di vista, alla più antica e tradizionale visione di una società di ceti. Le società di ceti erano composte da aristocrazia, clero e (futuro) terzo stato, cioè una borghesia che si esprimeva in parlamenti municipali, spesso altrettanto e più conservatori dell’aristocrazia. Il potere del re, anche se assoluto, trovava una limitazione e un condizionamento da parte dei ceti che, pur non avendo un potere decisionale, non potevano essere ignorati: diciamo che non era saggio da parte del re ignorarli, ciò gli avrebbe procurato sicuramente diversi problemi, allungato la lista dei suoi nemici e reso più instabile il suo potere. I ceti avevano quindi un limitato potere di condizionamento nei confronti del monarca, ma al tempo stesso una importante funzione di stabilizzazione in quella società, funzione compresa da tutti, a partire dallo stesso monarca.
Ciò non toglie che a volte, o spesso, la stabilità del regno saltasse per le lotte e guerre tra monarchia e aristocrazia, in cui l’una tentava di soggiogare l’altra.
Per Montesquieu la tripartizione dei poteri ha lo scopo di rendere più stabile e quindi più forte il potere stesso, evitando scossoni di varia natura. Il potere esecutivo resta nelle mani del monarca, come in precedenza; il potere legislativo dovrebbe passare nelle mani di un Parlamento, presumibilmente dominato dagli aristocratici e con partecipazione borghese; il potere giudiziario in mano a tribunali dove già i borghesi contendevano il dominio agli aristocratici. L’esempio dell’Inghilterra, ammirata dal barone, sembrava confermare l’efficacia di tale spartizione delle vesti dei poveri cristi tra monarchia, aristocrazia e borghesia. L’efficacia era nel garantire la stabilità e la “libertà dell’uomo”, che noi sappiamo essere la libertà dell’uomo proprietario, di una proprietà, nella Francia di allora, fondiaria e borghese. Quest’ultima, con la rivoluzione e il periodo napoleonico, diverrà poi di gran lunga più importante.
Veniamo ora alla citazione di Montesquieu tratta dalla già nominata raccolta al sottotitolo “Della libertà politica”: «La parola libertà nella politica non ha neppur lontanamente il significato che le attribuiscono oratori e poeti. Questa parola non esprime propriamente che un rapporto e non può servire a differenziare i vari tipi di governo: giacché lo stato popolare consiste nella libertà dei poveri e dei deboli e nella schiavitù dei ricchi e dei potenti; mentre la monarchia consiste nella libertà dei grandi e nella schiavitù dei piccoli [...] Sicché quando, in una guerra civile, si dice che si combatte per la libertà, si tratta di altro: il popolo combatte per ottenere il predominio sui Grandi, e i Grandi combattono per ottenere il predominio sul popolo».
Queste parole sono significative appunto perché non vengono da un rivoluzionario. C’è però l’intuizione che la libertà ha una connotazione di classe, e che la libertà di alcuni coincide con la schiavitù di altri.
Montesquieu, pur essendo barone, è l’esponente di una classe borghese oggettivamente rivoluzionaria, come si dimostrerà di lì a pochi anni anche in Francia. In quanto rivoluzionaria la borghesia può permettersi di dire la verità, o ciò che ritiene tale, senza doversi guardare le spalle. Non preme ancora un’altra classe rivoluzionaria nei suoi confronti. Quando poi la borghesia è diventata matura, poi fradicia e oggi in stato di decomposizione (ma da sola non muore), allora non può più permettersi il lusso di dire qualcosa che si avvicini alla verità: il materialismo e le ideologie ingenue e in parte anche generose che aveva professato vengono abbandonate. In nome della sua guerra per la vita o per la morte, del suo Armageddon contro il proletariato, la borghesia si è poi alleata con i rimasugli di tutte le precedenti classi proprietarie da lei spodestate, recuperando le ideologie di queste, come un vecchio cappotto che viene rivoltato e rattoppato, con il fine di non apparire ignuda al proletariato. La borghesia, dopo aver tagliato la testa a re e a preti e professato l’ateismo, cosparso il capo di cenere chiede perdono ai re, ai preti e a Dio, con i quali stipula una santa alleanza contro gli infedeli e blasfemi che non credono alla Divina Proprietà.
Veniamo ora al rivoluzionario Blanqui, comunista dotato di una salda visione di classe ma difettoso di scienza e dialettica. Ne “La critica sociale”, raccolta che egli fece dei suoi scritti dal 1850 al 1870 in uno del 1869-70 dal titolo “Il comunismo, avvenire della società” leggiamo: «Ora si rimprovera al comunismo di rappresentare il sacrificio dell’individuo e la negazione della libertà [...] Ma dove sono le prove a sostegno dell’accusa che gli viene mossa? È soltanto un insulto gratuito, poiché l’imputato non è mai vissuto. E in nome di chi quest’arrogante supposizione? In nome dell’individualismo, che da migliaia d’anni uccide permanentemente la libertà e l’individuo. Quanti sono gli individui della nostra specie di cui non abbia fatto degli iloti o delle vittime? Forse uno su diecimila. Diecimila martiri per un boia! Diecimila schiavi per un tiranno! E lo si sostiene in nome della libertà! [...] La libertà che accusa il comunismo la conosciamo, è la libertà di asservire, la libertà di sfruttare a piacimento, la libertà delle grandi esistenze, come dice Renan, con le moltitudini per marciapiede. Questa libertà il popolo la chiama oppressione e delitto. Non vuole più nutrirla con la sua carne e il suo sangue [...] Il comunismo è la salvaguardia dell’individuo, l’individualismo ne è lo sterminio. Per l’uno ogni individuo è sacro. L’altro non ne tiene maggior conto di un vaso di terra e l’immola con l’ecatombe alla sanguinosa trinità Loyola, Cesare e Shylock; dopodiché dice flemmaticamente: “Il comunismo sarebbe il sacrificio dell’individuo”. Rovinerebbe il banchetto degli antropofagi, questo è chiaro. Ma coloro che ne fanno le spese non troveranno fastidioso questo contrattempo [...] Nessuna libertà per il nemico [...] Nel 1848 i repubblicani, dimenticando cinquanta anni di persecuzioni, hanno accordato libertà piena e completa ai loro nemici. L’ora era solenne e decisiva. Non tornerà più. I vincitori, malgrado torti lunghi e crudeli, prendevano l’iniziativa, davano l’esempio. Quale fu la risposta? Lo sterminio. Faccenda chiusa. Il giorno in cui il bavaglio sarà tolto dalla bocca del lavoro, verrà messo su quella del capitale».
Siamo qui d’accordo con Blanqui, e sulla scia del comunismo scientifico, storico
e dialettico di Marx, affermiamo che l’unica libertà di cui disporrà il
proletariato consisterà nell’esercizio della propria dittatura di classe, con il
potere concentrato nella direzione solitaria del suo partito comunista mondiale.
Andando a rileggere la storia dai documenti ufficiali, quei pochi che la
controrivoluzione ancora imperante, in Cina e fuori, ci concede di conoscere,
per questo numero della nostra rivista abbiamo scelto:
1) Secondo intervento di Safarov al Congresso dei Toilers, gennaio/febbraio
1922.
2) Intervento della compagna Wong a nome delle donne comuniste del PCdC, quinta giornata del congresso.
3) Dichiarazione del PCdC sulla situazione attuale, del 15 giugno 1922.
4) Articolo “I Partiti Comunisti orientali sono il risultato dello sviluppo
capitalistico in Oriente”, di V. Vilensky, del 29 novembre 1922.
Si riferiscono alla fase embrionale della compagine comunista come partito. Il primo congresso si era concluso all’inizio di agosto 1921, i piccoli gruppi di comunisti che si affasciano in partito, coscienti della loro inesperienza, si domandavano da dove cominciare. Solo tre mesi dopo riescono a darsi delle direttive chiare e univoche, in stretto rapporto con i principi stabiliti al congresso. Asse del sintetico documento sono le necessità interne di sviluppo ed estensione del Partito e le linee d’azione verso la classe operaia, i giovani e le donne.
La condizione di sfruttamento, arretratezza, tanto della classe operaia come delle plebi in genere, era la premessa per un fervido e ricco lavoro di propaganda per le concezioni comuniste e di opportunità di influenzare la millenaria Cina che si stava risvegliando al mondo moderno.
Il primo documento, l’intervento di Safarov in risposta a quello di Tao, delegato del Kuomintang, si rese necessario alla decima seduta del Congresso dei Toilers in merito alla questione nel movimento comunista della centrale tattica nella doppia rivoluzione. Si affianca in questo ai rapporti di Zinoviev.
Dice Safarov nel suo intervento: «Sappiamo che il partito che è alla testa del Governo della Cina del Sud è un partito democratico-rivoluzionario e non mettiamo in discussione il fatto. Siamo convinti che questo partito ha fatto un grande lavoro rivoluzionario che era assolutamente necessario in Cina, e speriamo di combattere fianco a fianco con questo partito in futuro. Ma, dall’altra parte, non siamo così ingenui da immaginare che questo partito sia un partito comunista rivoluzionario. Noi non siamo così ingenui da confonderci sull’origine di questo partito disegnandocelo come il partito comunista del proletariato».
Continua: «Noi diciamo: nei paesi coloniali e semi-coloniali il primo periodo del movimento rivoluzionario deve essere necessariamente un movimento democratico nazionale. Noi diamo il nostro sostegno a questo movimento, se è diretto contro l’imperialismo. Noi lo sosteniamo, lo abbiamo sempre sostenuto, e faremo così nel futuro, ma, d’altra parte, non possiamo riconoscere questa lotta come la nostra lotta, come la lotta per la rivoluzione proletaria».
Questa l’impostazione della Terza Internazionale al primo congresso, confermata al secondo, sulla questione nazionale e coloniale, derivata dall’indagine storico-dialettica della successione delle forme di produzione nella teoria marxista.
Il secondo è l’intervento, alla quinta giornata del congresso dei Toilers, della compagna Wong che parla a nome delle donne comuniste del PCdC, organizzate nella Lega delle donne comuniste, che si era costituita fra il primo e secondo congresso del partito.
Il movimento femminile in Cina era stato iniziato dalle donne aristocratiche e borghesi, che avevano avuto la possibilità di andare a studiare in Europa o in Giappone. Le contraddizioni del Celeste Impero esplodevano: la penetrazione imperialista, il crollo della dinastia, la distruzione dell’artigianato, la nascita e diffusione della classe borghese, la lotta di classe proletaria. Negli ultimi cinquanta anni la Cina era stata sconvolta e divisa. La sottomissione della donna, la lezione confuciana vacillava, le donne iniziavano ad organizzarsi, in generale, poi come donne proletarie e comuniste. Subito le rivendicazioni democratiche del movimento femminile non appaiono sufficienti a difendere e liberare la donna proletaria. È solo il partito comunista che può dirigere ed organizzare la lotta finale dell’emancipazione sociale delle donne.
Il terzo documento dell’epoca che qui ripubblichiamo, la Dichiarazione, risale al giugno 1922, cioè anticipa di più di un mese il secondo congresso. Vi era per i comunisti la necessità di chiarire e discriminare il ruolo dei comunisti nella rivoluzione democratica, allora diretta dal Kuomintang. Vi si denuncia la politica compromissoria del Kuomintang con i Signori della Guerra legati agli imperialisti. Il Kuomintang viveva da anni senza un programma politico e a seconda delle situazioni si comportava come partito democratico rivoluzionario o conservatore e si appoggiava all’uno o all’altro Signore, comportandosi come una delle tante bande a difesa del proprio potere nei territori conquistati dagli eserciti mercenari.
La Dichiarazione pone la questione: è il Kuomintang il partito che potrà portare fino in fondo la rivoluzione democratica? Al punto 10 si risponde che il Partito comunista, avanguardia dell’esercito proletario, si deve porre materialmente alla testa del fronte unito rivoluzionario, smascherando la politica di compromesso del Kuomintang.
Il quarto è un articolo tratto da Imprecor, rivista in inglese della Internazionale Comunista. Fu pubblicato nel novembre del 1922 ma risale certamente a qualche mese prima, quando già nell’Internazionale si poneva la questione della costituzione dei partiti comunisti in oriente. Lo scritto di Vilensky è infatti pubblicato nel settore “Confronti e discussioni”. Afferma l’articolo: «L’esperienza della Rivoluzione russa ha dimostrato che il proletariato, anche se in minoranza, può diventare il capofila della lotta per gli interessi delle grandi masse di contadini. L’India e la Cina, per la loro struttura sociale, hanno molto in comune con la Russia pre-rivoluzionaria e questo rende l’esperienza della Rivoluzione russa particolarmente preziosa per i popoli di questi Paesi».
L’articolo pone l’urgenza della necessità di formare il Partito comunista in Oriente «che opponga il suo programma a quello dei liberali nazionali e che cerchi di assorbire le varie sfumature di opinione socialista che abbondano tra gli intellettuali dei popoli orientali». «Contando sulla solida base del movimento operaio (il movimento sindacale), i partiti comunisti dell’Est possono assimilare e fare buon uso dei vari circoli socialisti. Assorbire questi circoli è il compito tattico più urgente per i comunisti dell’Est, mentre tutti i discorsi di conciliazione, di fronte comune con questi circoli intellettuali, sono un errore tattico che involontariamente conferma questi circoli intellettuali nella loro insularità».
All’epoca, nel 1922, il Kuomintang si definiva più come un circolo simpatizzante di ideali socialisti, nella sua parte più progressista, e non ancora come partito ufficiale della rivoluzione democratica nazionale.
Vilensky prende la giusta strada, in polemica con quella intrapresa da Maring, di porre in primo piano il Partito comunista che, attraverso la lotta sindacale, attrae le forze operaie e intellettuali suscitate dalla lotta di classe fra proletariato e borghesia.
Nostre le traduzioni dall’inglese - Con questo Archivio si fermano le pubblicazioni riguardanti la rivoluzione in Cina, sia per la impossibilità di reperire ulteriori documenti sia perché dalla metà del ’22 il Partito intraprende una strada che diverge dalla corretta impostazione comunista e rivoluzionaria. I prossimi testi che torneranno nell’Archivio riguarderanno l’opposizione di Trotski contro la politica menscevica dello stalinismo in Cina.
Il congresso dei toilers
Intervento di Safarov
Decima sessione, 27 gennaio 1922, sera
Il compagno Tjan-Go-Tao alla presidenza.
PRESIDENTE. Dichiaro la sessione aperta e chiamo il comp. Safarov.
SAFAROV. Compagni, la questione fondamentale esistente davanti al nostro congresso è quella del rapporto, e della giusta comprensione di questo rapporto, nei paesi dell’Estremo Oriente fra il movimento nazional-rivoluzionario da una parte e il movimento proletario rivoluzionario dall’altra. Le discussioni avute luogo sulla mia relazione mi fanno credere che alcuni compagni sono arrivati ad errate concezioni di questo rapporto.
Quindi, per cominciare, il rappresentante del Partito Kuomintang, il comp. Tao, ha affermato che i principi del sistema dei soviet e le rivendicazioni di base in relazione alla rivoluzione dei soviet non sono niente di nuovo in Cina. Ha detto, se non mi sbaglio, che il Partito Kuomintang ha già diffuso queste idee negli ultimi venti anni. Io non voglio affatto mettere in discussione lo sviluppo rivoluzionario del partito, ma sono convinto che, per arrivare alla comprensione fra i comunisti da una parte, ed i rivoluzionari nazionalisti dall’altra, è assolutamente necessario per entrambe le parti conoscersi bene l’un l’altro.
Sappiamo che il partito che è alla testa del Governo della Cina del Sud è un partito democratico-rivoluzionario e non mettiamo in discussione il fatto. Siamo convinti che questo partito ha fatto un grande lavoro rivoluzionario che era assolutamente necessario in Cina, e speriamo di combattere fianco a fianco con questo partito in futuro. Ma, dall’altra parte, non siamo così ingenui da immaginare che questo partito sia un partito comunista rivoluzionario. Noi non siamo così ingenui da confonderci sull’origine di questo partito disegnandocelo come il partito comunista del proletariato. Questo tipo di valutazione non corrisponde alla realtà e imposterebbe in modo sbagliato le relazioni con questo partito.
Da questa autorevole tribuna noi abbiamo il coraggio di dire, apertamente e definitivamente, che sosterremo, dobbiamo sostenere e stiamo sostenendo ogni movimento democratico-borghese nei paesi coloniali e semi-coloniali, nella misura in cui questo movimento democratico borghese è veramente per l’emancipazione nazionale dei popoli oppressi. Credo che questa affermazione racchiude le nostre posizioni in poche parole. Con questa affermazione, che è stata ufficialmente fatta al Secondo Congresso del Comintern e che era già espressa nel Manifesto del suo Primo Congresso, abbiamo chiaramente fissato il nostro punto di vista. Noi diciamo: nei paesi coloniali e semi-coloniali il primo periodo del movimento rivoluzionario deve essere necessariamente un movimento democratico nazionale. Noi diamo il nostro sostegno a questo movimento, se è diretto contro l’imperialismo. Noi lo sosteniamo, lo abbiamo sempre sostenuto, e faremo così nel futuro.
Ma, per contro, non possiamo riconoscere questa lotta come la nostra, come la lotta per la rivoluzione proletaria. Se affermassimo ciò sbaglieremmo, faremmo un pessimo servizio agli operai e ai contadini di Cina e Corea, alle masse contadine, alle masse proletarie e semi-proletarie di Cina e Corea che hanno un compito più alto da assolvere di quello dell’emancipazione nazionale. Hanno davanti il compito della completa liberazione dei loro paesi. Se queste masse, elementi del proletariato e semi-proletariato delle città e dei villaggi, assumessero il compito su sé stessi dell’emancipazione sociale delle masse sfruttate dei paesi oppressi, su questo susciterebbero fatalmente illusioni errate.
Se noi, comunisti di Cina o Corea, solleviamo la parola d’ordine di un governo democratico, di una imposta sul reddito unica, della nazionalizzazione della terra, parole d’ordine che sono della rivoluzione democratica, dimostreremmo di essere pronti a cooperare con tutte le organizzazioni onestamente nazional-democratiche, se hanno a cuore gli interessi della maggioranza degli sfruttati del loro paese.
Ma dall’altra parte il proletariato e gli elementi del semiproletariato si devono organizzare in modo indipendente nei loro sindacati di classe.
Non possiamo considerarli di classe i sindacati che si sono formati adesso come organizzazioni corporative di arti e mestieri direttamente collegati con il Partito Kuomintang. Non capiscono la teoria classista, non sono gli organi della lotta di classe del proletariato per la sua emancipazione.
Quindi in rapporto a voi, seguaci del Partito Kuomintang, così come con i nostri alleati, amici e compagni, vi diciamo apertamente e francamente che, mentre stiamo sostenendo e continueremo a sostenere la vostra lotta in quanto è una rivolta nazionale e democratica per l’emancipazione nazionale, allo stesso tempo noi continueremo a portare avanti indipendentemente il nostro lavoro comunista di organizzazione del proletariato e delle masse semi-proletarie in Cina. Questa è la causa delle masse proletarie stesse, e deve essere compiuta dagli operai cinesi, dal proletariato cinese. In questo senso il movimento cinese dei lavoratori si deve sviluppare in modo completamente indipendente dalla mentalità radicale borghese e dalle organizzazioni e partiti democratici. Penso che questo sia assolutamente chiaro a tutti i presenti di questo Congresso. Svariate contestazioni contro le affermazioni del compagno Tao arrivate alla Presidenza lo confermano.
Per un delimitato periodo storico possiamo organizzare una divisione del lavoro fra noi, i rappresentanti del proletariato rivoluzionario, cioè la classe proletaria e gli elementi semi-proletari fra i contadini da una parte, e i rappresentanti del risveglio della Cina degli elementi nazional-radicali e democratici, dall’altra. Entrambe le parti devono comprendere che questa divisione del lavoro deve essere basata su un accordo volontario. Le masse proletarie non devono rinunciare alla loro propria visione, hanno bisogno di non astenersi dall’organizzare il proprio partito di classe. Solo sotto queste condizioni è possibile collaborare ed avere un accordo volontario.
Non capisco chi potrebbe trarre vantaggio dalla affermazione che le masse cinesi sono già mature per la rivoluzione dei Soviet, per l’instaurazione del sistema dei Soviet. Il principio del sistema dei Soviet consiste nella auto-organizzazione delle masse sfruttate, nelle loro organizzazioni in un potere rivoluzionario indipendente di classe. In Cina, la classe operaia sta appena imparando a camminare, sta iniziando a svilupparsi. La massa contadina è intimorita e ignorante e comunque non avanza le proprie rivendicazioni e la propria visione.
L’affermazione del compagno Tao sulla questione della nazionalizzazione della terra ne è la miglior prova. Come ha detto, il Governo del Sud, preso in considerazione il progetto della nazionalizzazione della terra, non l’avrebbe portato avanti solo perché questa importante misura rivoluzionaria richiederebbe uniformità, sarebbe necessario che la Repubblica cinese si estendesse dappertutto. Quindi, secondo il Partito Kuomintang sarebbe necessario prima liberare il territorio cinese dell’imperialismo, e dai saccheggiatori Dudziuns. Sarebbe necessario prima instaurare la democrazia in Cina.
Questo non è il modo corretto di affrontare la questione. Se si vuole organizzare le masse sotto la nostra bandiera avendo la maggioranza del popolo dalla nostra parte noi dobbiamo toccare gli interessi vitali delle masse, perché queste masse ci seguano fino in fondo, che siano pronte a morire per la nostra e la loro causa. Per i contadini cinesi della Cina del Sud la questione della nazionalizzazione della terra non è una cosa da regolare dall’alto con riforme amministrative, per loro è una necessità vitale. Noi dobbiamo comunque anticipare questa misura rivoluzionaria anche in una piccola porzione del paese, per mostrare ai contadini cinesi che vivono nei territori occupati dalle forze ostili che dove un regime democratico viene instaurato i contadini vivono mille volte meglio, che i loro interessi sono mille volte più sicuri. Senza una chiara comprensione di ciò, senza un corretto atteggiamento sulla questione della terra, le grandi masse non possono essere trascinate nella lotta dalla nostra parte.
Non è abbastanza presentare un buon programma, non è abbastanza dirsi favorevoli a questo programma in una ristretta cerchia della cosiddetta società colta, è necessario farla l’ardente rivendicazione delle masse sfruttate. Solo dopo, questo programma diventa un programma reale, un programma di azione rivoluzionaria.
Quindi, contraddico l’affermazione del compagno Tao e rivendico che per risvegliare le masse sfruttate cinesi è necessario darsi una maggiore organizzazione preliminare ed un maggiore lavoro di agitazione. Perché le masse sfruttate cinesi possano organizzare il sistema statale che rappresenta meglio gli interessi degli sfruttati di tutti i paesi – il sistema dei Soviet – è necessario fare più lavoro preparatorio, è necessario portare avanti una accanita battaglia non solo contro l’imperialismo straniero, non solo contro i saccheggiatori Dudziuns, ma anche contro gli usurai indigeni nei villaggi e contro la borghesia indigena in città.
Non è la questione della presa del potere, è quella della protezione del contadino nella sua vita quotidiana da coloro che lo opprimono e lo sfruttano caricandolo di ingenti affitti, lasciandogli una miseria.
Il compagno Tao ha parlato qui della questione mongola. Non ho toccato questa questione nel mio rapporto perché la questione fondamentale è quella della relazione fra il movimento rivoluzionario nazionale e quello comunista, ed è quindi naturale che la questione mongola sia stata messa da parte. Finché la base economica della Mongolia è l’allevamento del bestiame contraddistinto da caratteristiche tribali patriarcali, predicare il comunismo e la rivoluzione proletaria è ridicolo, per questo è del tutto chiaro che non ha senso mettere il carro davanti ai buoi, che è impossibile saltare una serie di inevitabili gradini storici. Il nostro programma, cioè il programma del Comintern riguardo alla Mongolia consiste nel sostenere quegli elementi che aspirano all’emancipazione nazionale, quegli elementi che sono ora al potere i cui rappresentanti sono presenti a questo congresso a nome del Partito Rivoluzionario del Popolo. Sulla questione delle relazioni fra Mongolia e Cina il compagno Zinoviev ha dato una adeguata risposta.
Per altro l’esperienza della rivoluzione russa e della costruzione dei Soviet in quelli che erano gli Stati limitrofi della Russia è in se stessa una risposta completa a questo riguardo.
Vado adesso ad affrontare una nuova questione. I compagni non hanno abbastanza giustamente interpretato le affermazioni mie e del compagno Zinoviev a proposito del ruolo di avanguardia del Giappone nel movimento rivoluzionario dell’Estremo Oriente. Questo non deve essere interpretato in un angusto senso nazionalista, che potrebbe portare confusione nel nostro movimento. Inoltre, compagni, non dobbiamo essere troppo utopisti, e non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte ai fatti reali.
È assolutamente vero che l’imperialismo giapponese è abominevole tanto quanto l’imperialismo zarista, e che è odiato nell’intero Estremo Oriente. Ma sicuramente, compagni, ammetterete che in tutto il mondo è stato odiato l’imperialismo zarista. Si, l’imperialismo zarista è stato il boia e il gendarme internazionale. Questo a causa del fatto che la Russia zarista costringeva i popoli a vivere all’interno dei sui confini, perché è stato il peggior oppressore di Stati, che la rivoluzione sociale, la rivoluzione degli operai “e dei contadini” ha sconvolto in modo grandioso nel novembre. È stata così grandiosa perché questi popoli sono stati attratti dal vortice rivoluzionario e in grado, con le loro proprie forze e con l’appoggio del proletariato russo, di instaurare il sistema sovietico e di realizzare non solo la loro emancipazione nazionale ma quella sociale. Dovete ammettere che la distruzione della più importante roccaforte dell’imperialismo nel Vicino Oriente e nell’Europa dell’Est, lo zarismo russo, ha avuto una influenza decisiva sul destino di tutti i popoli che vivono nel Vicino Oriente e nell’Europa dell’Est. Si deve essere ciechi per non vederlo.
Consideriamo la posizione del Giappone. Il Giappone è un potere rapace quanto lo era la Russia zarista. Il Giappone è un grande predone ed un brutale gendarme quanto lo era la Russia zarista. Se questo mostro imperialista sarà rovesciato dalla forza unita della classe operaia giapponese, se sarà distrutto dalla forza del proletariato giapponese, questo non costituirà un grande sconvolgimento rivoluzionario per l’intero Estremo Oriente? Se la rivoluzione russa è stata veramente l’inizio della rivoluzione proletaria mondiale e della lotta dei popoli oppressi dell’Est per la loro emancipazione, il rovesciamento dell’imperialismo giapponese non sarebbe l’inizio dell’emancipazione rivoluzionaria nazionale ed internazionale nell’Estremo Oriente?
In questa questione dobbiamo eliminare il ristretto punto di vista nazionalistico e considerare la situazione così come è realmente. Non solo l’operaio e il contadino, ma ogni onesto democratico e difensore del suo popolo deve capire che ci sono due Giapponi. C’è il Giappone del Mikado e della plutocrazia, del militarismo dell’imperialismo e della coercizione. Ma c’è anche un altro Giappone – la classe operaia e proletaria giapponese alla quale appartiene il futuro e che risolverà il problema dell’Estremo Oriente. È imperativo distinguere fra questi due inconciliabili campi e non chiudiamo gli occhi di fronte ai fatti. L’emancipazione nell’Estremo Oriente e nel mondo intero può essere realizzata solo dalla solidarietà internazionale.
Uno dei rappresentanti coreani ha messo l’accento sul fatto che l’operaio giapponese tratta con disprezzo il proletariato coreano e che in Corea è uno sciovinista e un nazionalista. Ancora dobbiamo tornare all’esempio russo. Prima della rivoluzione del 1917 le organizzazioni rivoluzionarie fra gli operai russi erano estremamente deboli nei paesi confinanti, per esempio in Turkestan, Kirghizistan, e in una parte del Caucaso non esistevano partiti bolscevichi. La parte europea della popolazione in questi Stati confinanti non aveva alcun passato rivoluzionario. E la ragione di questo è che lo zarismo aveva trasferito in questi paesi confinanti i settori più arretrati del proletariato, la parte più povera della popolazione russa. Il peggio della popolazione russa fu portato dallo zarismo in queste colonie, e l’imperialismo giapponese sta facendo esattamente lo stesso. Ma sarebbe la rovina della causa proletaria e per il movimento rivoluzionario considerare il proletariato giapponese come un grosso ostacolo sulle scale della rivoluzione proletaria semplicemente perché l’imperialismo giapponese manda i suoi agenti in Corea e compra e corrompe là le classi povere fra i lavoratori.
Senza un movimento proletario in Giappone nessuno dei paesi dell’Estremo Oriente può raggiungere la propria emancipazione. Ma sarebbe piccolo borghese e stupido immaginare che il proletariato giapponese si renda capace di fare tutto questo da solo. No, il movimento proletario giapponese è significativo nel senso che è il primo decisivo colpo dato dal proletariato giapponese, essendo meglio organizzato e il più forte, contro l’imperialismo straniero e rapace e contro la coercizione imperialista. L’organizzazione è un risultato dello sviluppo industriale e della vita di fabbrica. Se dovessimo prendere gli eserciti di occupazione e dovessimo aggiungere a loro le truppe mercenarie dei Dudziun e le bande dei Khunkhuz, tutti questi insieme formerebbero una trascurabile quantità rispetto ai 400.000.000 di contadini cinesi. Questa manciata di ladri e annessionisti è soltanto capace di sfruttare 400.000.000 di uomini perché di fatto non sono organizzati. È invece molto più difficile sfruttare gli operai giapponesi e metterli in una simile condizione. La questione non è dare a qualcuno dei privilegi o dargliene di più che ad altri. Al contrario, noi diciamo agli operai giapponesi: “tanto vi è stato dato e quindi di più vi sarà richiesto”.
Il motivo per cui ci stiamo appellando alla classe operaia giapponese è perché quando era disorganizzata è stata disonorata da innumerevoli atti sanguinari nell’Estremo Oriente. Per questo motivo deve essere la prima a spezzare le armi dell’imperialismo giapponese. Perciò con questo appello non diamo alcuna preferenza a quello o all’altro. Parliamo esattamente come abbiamo parlato al proletariato russo. I comunisti bolscevichi russi hanno parlato così agli operai russi, perché i russi, compresa la classe operaia russa, erano diventati la maledizione dell’Est e dell’Europa. E questo è perché loro hanno dovuto essere i primi a fare la rivoluzione ed essere di esempio di eroismo rivoluzionario a tutti gli altri popoli. Sono stati necessari gli operai russi per sferrare il primo colpo contro gli imperialisti.
Non sono d’accordo con il compagno Kato che dipinge un quadretto roseo e rappresenta le masse operaie giapponesi come completamente coscienti. Non dobbiamo dimenticare il potere che esercita il pregiudizio sciovinista della piccola borghesia. L’influenza piccolo borghese è ancora molto forte sulla classe operaia giapponese, e il proletariato giapponese ci deve lottare strenuamente contro.
È stato molto bello sentire che gli operai giapponesi hanno dimostrato il primo maggio 1921 davanti al Palazzo Imperiale, gridando che i suoi nemici erano all’interno del Palazzo, e sentire i compagni dichiarare da quella tribuna che non si sarebbero più limitati a gridare semplicemente, ma molto presto avrebbero fatto i conti con i loro nemici del Palazzo. I rivoluzionari non devono mai dipingere la situazione con colori patinati. Devono vedere il loro lavoro nella giusta misura.
Riassumendo, noi diciamo che, nei paesi coloniali e semi-coloniali, come Cina e Corea, che sono attualmente colonie del capitale straniero, l’Internazionale Comunista e i partiti comunisti sono obbligati a sostenere il movimento nazional-democratico. In questi paesi il Partito Comunista deve spingere per l’abbattimento dell’oppressione imperialista e appoggiare le rivendicazioni democratiche, come la nazionalizzazione della terra, l’auto-governo, ecc. Nello stesso tempo, comunque, i partiti comunisti non devono abbandonare il loro programma comunista, così come non devono astenersi dall’organizzare la classe operaia in sindacati, indipendentemente dall’influenza borghese. Né devono astenersi da organizzare la classe operaia in un Partito Comunista indipendente.
In Giappone, il compito fondamentale della classe operaia è cominciare ad assestare colpi contro l’imperialismo giapponese, per far vacillare la sua posizione nell’Estremo Oriente, per dare alle nazioni oppresse della Cina e della Corea la libertà nazionale per il loro movimento rivoluzionario, per garantire la libertà del lavoro in questi paesi e, infine, per dare al proletariato giapponese stesso la possibilità di emanciparsi dal lavoro salariato.
Poi spieghiamo il nostro punto di vista con chiarezza e senza riserve rispetto alle relazioni fra noi, i comunisti, i rappresentanti della borghesia democratica e quegli elementi nazional-democratici. Desideriamo evitare ogni confusione possibile sulle prospettive e sulle idee in questa questione. Noi combattiamo nettamente per eliminare gli inutili tentativi di dipingere ogni nazionalista col colore comunista, anche certi nazionalisti che hanno combattuto per l’uguaglianza del capitalismo cinese e giapponese.
Noi diciamo, molto francamente che sosteniamo questi nazionalisti borghesi, borghesi fino al midollo, perché le forze più reazionarie sono gli imperialismi giapponese, americano e inglese. Non abbiamo paura di dire che sosterremo la borghesia nazionalista che sta combattendo per emancipare le forze produttive in Cina e in Corea dal giogo del capitalismo straniero. Dall’altra parte, comunque, noi certamente esigiamo da questi borghesi democratici, da questi elementi radical democratici, che non facciano alcun tentativo per dominare il giovane movimento operaio di Cina e Corea e che non facciano alcun tentativo per deviarlo dal suo vero percorso sostituendo i suoi ideali con ideali radical democratici tinti del colore dei Soviet.
Noi potremo più facilmente arrivare a comprenderci se ci diciamo chi siamo veramente. Abbiamo tutte le opportunità di iniziare a capire apertamente e dobbiamo avvantaggiarci di questo perché i nostri compiti credo che siano molto chiari: realizzare questi compiti, adempiere al grande scopo rivoluzionario a cui tutti noi aspiriamo, il grande obbiettivo dell’emancipazione nazionale dei popoli coloniali e l’emancipazione del lavoro dall’oppressione imperialista.
(Forti applausi).
Intervento della compagna Wong a nome della Lega delle donne comuniste
Quinta sessione,
24 gennaio 1922, ore 18
Presidente: Compagno Pak-Kieng.
PRESIDENTE. Dichiaro la sessione aperta. Il primo intervento sarà della compagna Wong.
WONG. Devo tenere il mio rapporto oggi sulla condizione delle donne cinesi, ma visto che il mio tempo è limitato non posso trattare la questione nei dettagli, toccherò soltanto i temi più importanti.
C’è un vecchio proverbio cinese che dice che la donna deve concentrare la sua attenzione sull’uomo e deve fare ciò che l’uomo desidera. Fin dai primi tempi in Cina viene inculcato nelle donne che ogni desiderio dell’uomo sia giusto e debba essere rispettato. Questo ha ingenerato una profondo effetto e una grande influenza nella psicologia delle donne. Non c’è uguaglianza di diritti nella società cinese oggi. Potremmo inoltre dire che l’intera società consiste di soli uomini, che tutti i diritti appartengono solo agli uomini.
Effettivamente non a tutti gli uomini, ma ad una manciata di funzionari, di burocrati, di capitalisti e imperialisti. Sono tutti strettamente alleati al fine di nascondere i loro crimini e farne di nuovi. In questa società godono del diritto esclusivo del dominio, per impedire di andare al potere non solo alle donne, ma anche ai lavoratori maschi. Questo non è possibile nella moderna società cinese. Le donne non possono assurgere alle funzioni pubbliche in quanto ne sono state escluse. L’unica ragione è che gli uomini non glielo consentono.
Per molto tempo gli uomini hanno privato le donne della loro individualità, e ci sono riusciti così a fondo che adesso ci sono donne che pensano di essere completamente ignoranti e credono di non avere alcuna possibilità di contribuire alla gestione dei pubblici affari. Tuttavia, questa concezione è sbagliata.
Fin dai primi tempi, la prospettiva della donna cinese nella sua posizione sociale è stata fondata su tre oggetti di culto e quattro regole di vita, o quattro virtù. Le prime tre divinità sono il padre, il marito, e dopo la sua morte il figlio maggiore. Le quattro virtù sono: la prima la felicità della famiglia e la creazione del focolare domestico; la seconda il pudore nel parlare; terza l’aspetto curato e l’eleganza nel vestire; quarta la bravura nel lavoro manuale. Tutto questo è come a una religione che sottomette completamente la psicologia femminile strappandola dal mondo esterno, subendo pazientemente tutti i torti.
Esiste oggi una qualche eguaglianza economica nella posizione delle donne cinesi? Per prima cosa una donna non può ereditare proprietà e non può cercare lavoro. Formalmente le donne non sono ammesse nelle fabbriche, è così che le donne sono state costrette a fare affidamento solo sugli uomini. Questo ha rafforzato gradualmente il dominio dell’uomo e ha ridotto definitivamente la donna in uno stato di schiavitù.
Le donne non hanno mai svolto importanti funzioni politiche nella storia cinese. Rivoluzioni di palazzo o l’esistenza di una imperatrice sul trono sono state rare eccezioni; così, in generale, le donne non hanno esercitato alcuna influenza e svolto alcun ruolo in politica.
Ma oggi, nella Cina moderna, le donne sono in parte riuscite, dopo una lunga lotta per l’emancipazione e per il voto, ad ottenere i loro diritti elettorali, e ci sono adesso due donne membri del Parlamento del Sud della Cina. I recenti avvenimenti che hanno portato Cina ed Europa più vicine, hanno spinto molte donne cinesi ad andare all’estero, per avere un’educazione europea, a conoscere la questione femminile a scala mondiale, a liberarsi dai loro pregiudizi, e in questo modo il punto di vista che si sta diffondendo è quello che lo stato attuale della famiglia non è quello che dovrebbe essere, che c’è bisogno di più libertà, e che le riforme vanno fatte.
Tuttavia, tutte queste riforme e le speranze per modificare le relazioni familiari non ci danno ancora la chiave alla soluzione della questione delle donne. Le donne che tornano dall’Europa vedono finalmente la terribile oppressione che subiscono dalle mani degli uomini che prima non avevano notato. Credo che ci siano molte poche donne adesso in Cina che non si sentano oppresse. Le donne cinesi stanno iniziando a desiderare di essere libere da questo giogo, a lavorare in campo sociale, a guidare le masse verso l’emancipazione, a partecipare al movimento per ottenere la libertà.
Finora hanno ottenuto poco successo. Le donne dell’aristocrazia che hanno avuto la possibilità di visitare l’Europa, le donne cinesi aristocratiche continuano ad avere un atteggiamento rispettoso verso i mariti, li adulano, vestono in modo squisito, in breve mantengono le vecchie abitudini e tradizioni a dispetto del fatto che molte di loro hanno conosciuto le condizioni europee. Perché succede questo? Perché nell’attuale situazione delle relazioni familiari in Cina, che esistono dai tempi dei tempi, le donne possono tenere i loro mariti solo con questi metodi.
Ricordate che la poligamia è ancora in voga in Cina, così che una moglie non attraente è in pericolo di essere respinta per sempre dal proprio marito. Nel loro ambiente le donne aristocratiche cinesi si comportano orgogliosamente, in modo presuntuoso, e continuano con eterni intrighi. Sono invidiose, gelose e continuamente litigiose. Gli piace vestirsi bene, mangiar bene.
Un’altra ragione dello loro scarsa inclinazione per l’attività pubblica è per il fatto che sono le rappresentanti dell’aristocrazia che ha fatto veramente poco per il popolo e rabbrividiscono alla semplice parola “proletariato”. Le donne dell’aristocrazia cinese non solo ignorano del tutto la situazione del proletariato, ma addirittura non hanno alcun interesse in questioni come l’educazione dei bambini e degli adolescenti delle classi non proletarie.
Mentre le donne proletarie ne sono interessate, intendo le operaie, le contadine e le serve, sono completamente prive di educazione, non sono rispettate in società, non se ne parla mai, come se non esistessero. Così, quando l’appello del comunismo ci ha raggiunte in Cina, noi, le donne oppresse, l’abbiamo ricevuta come in una nave che affonda riconosce il suono della sirena di un’altra nave che si affretta a salvarla.
La situazione delle nostre donne è per noi un incentivo al lavoro di unificazione del nostro proletariato con quello di tutto il mondo, con lo scopo di condurre una lotta unita contro il comune nemico. I nostri compiti sono uguali ai vostri, e i nostri scopi sono i vostri: la distruzione del capitalismo. Il nostro scopo è creare in Cina una società basata su eguali diritti per tutti, uguale per uomini e donne.
Non possiamo ancora parlare dei metodi di propaganda che possono essere applicati, ma di alcuni ne possiamo qui discutere. In primo luogo dobbiamo sforzarci per una istruzione e formazione universale. Dobbiamo attrarre le masse proletarie al movimento cooperativo nelle industrie e nelle officine. Questo porterà ad un cambiamento nella psicologia delle masse proletarie in generale, e delle donne in particolare. Questo darà loro una opportunità di avere un ruolo nell’attività sociale.
A causa della insufficienza di donne organizzate, secondo me, andrebbe costituito un gruppo di donne propagandiste in Cina. È anche indispensabile portare avanti un’ampia propaganda in collegamento con i movimenti di massa delle donne e del proletariato, attraverso la stampa, la pubblicazione di opuscoli, manifesti e volantini, ecc. Per realizzarlo velocemente con successo completo, abbiamo bisogno di energia, di operaie attive, conoscere bene la propaganda femminista. È solo così che possiamo sperare di ottenere il successo per il nostro grande movimento.
(Applausi)
Dichiarazione del Partito Comunista
di Cina sulla situazione attuale
15 giugno 1922
1) Prima della rivoluzione del 1911 la Cina soffriva la condizione economica feudale e l’aggravarsi dell’invasione straniera.
2) La rivoluzione del 1911 ha fallito nel tentativo di trasformare il sistema feudale in un regime politico democratico. Il Kuomintang ebbe un atteggiamento conciliatorio con Juan Shikai nel 1912 e con Duan Qirui nel 1916. Il PCdC chiama il Kuomintang a evitare una terza sconfitta attraverso la conciliazione tenendo fede al “patto della lotta rivoluzionaria”. Una continua guerra civile in Cina aiuta soltanto l’imperialismo e ostacola lo sviluppo dell’industria indigena.
3) La lotta fra il Kuomintang ed i suoi oppositori quali Juan Shikai e Duan Qirui dimostra che la lotta per realizzare la democrazia è la lotta di una classe per rovesciare un’altra; è la sostituzione di un sistema con un altro. Non può essere vista come una lotta di un individuo o un gruppo per rovesciare un altro individuo o gruppo.
4) Un genuino partito democratico deve mostrare al popolo due cose: 1) il suo programma di partito e la sua politica devono essere in relazione con il concetto di democrazia e 2) dall’inizio alla fine la sua azione deve sostenere la democrazia nella lotta ai signori della guerra. È da mettere in conto che di tutti i partiti politici in Cina, solo il Kuomintang può essere definito come un partito relativamente rivoluzionario e relativamente genuinamente democratico. Il programma del partito non è ancora stato completamente elaborato. Comunque la sua pubblica posizione dei Tre Principi del Popolo e il suo piano di sviluppo economico hanno un carattere democratico. La partecipazione al movimento rivoluzionario e altre azioni del Kuomintang attestano il suo spirito democratico, come la condotta dei suoi parlamentari nel 1911, 1913, e 1917 durante la lotta in parlamento e contro i partiti di opposizione. Il governo di Canton (diretto da Sun-Yat-sen nel 1921-22) non limitò il movimento dei lavoratori, abolì i regolamenti di polizia riguardo “all’ordine pubblico e la sicurezza nazionale”, abolì la legge per la quale i lavoratori erano privati del diritto di sciopero. Spesso comunque le azioni di questo partito sono state di natura contraddittoria. Talvolta il Kuomintang manifesta atteggiamenti amichevoli verso gruppi di tendenza imperialista, in due occasioni ha lavorato mano nella mano con i militaristi di Beyang. Se il Kuomintang vuole mantenere il suo posto nella rivoluzione democratica deve cambiare questo genere di politica altalenante.
5) Rivitalizzare la Presidenza e ristabilire il potere legale del parlamento non risolverà gli attuali problemi. I Signori della Guerra continuano a dominare e Li Yuanhong ha dimostrato la sua inadeguatezza quando fu Presidente l’ultima volta nel 1916-17.
6) Una federazione di province autonome non è la soluzione.
7) Stanno sbagliando coloro che sono convinti che Wu Peifu sia un sostenitore della democrazia ed è diverso dalle altre nazioni dei Signori della Guerra e quindi avrebbe la capacità di risolvere gli attuali problemi. Deve essere appoggiato contro i Signori della Guerra del nord/est, Zhang Zuolin, ma Wu non è democratico. Sebbene si sia opposto ai gruppi filo giapponesi a Pechino, è sostenuto dagli stranieri. Il suo uso delle truppe contro il sud fu antidemocratico, mentre tentava di consolidare il nord con metodi feudali.
8) Fintanto ci saranno, i Signori della Guerra combatteranno le forze democratiche e fra di loro. Sono la causa della guerra civile in Cina. I Signori della Guerra impediscono la creazione del cosiddetto buon governo, così come un governo militare può solo essere un “cattivo governo”.
9) Sostenitori del buon governo! Appena dopo aver gridato “Avanti”, “Lotta” e “Fare la guerra alle forze del male” Xu Shichang fu esiliato e vi siete immediatamente opposti alla spedizione del nord. In linea con tutte le lezioni rivoluzionarie, vi compromettete con il pacifismo della piccola borghesia, che è un ostacolo per la realizzazione delle parole d’ordine “Avanti”, “Lotta” e “Fare la guerra alle forze del male”.
Potete voi realizzare il cosiddetto buon governo mentre si è sotto il potere dei Signori della Guerra? Data l’attuale atmosfera a Pechino, Tianjin, Baoding [quartier generale di Wu Peifu], pensate di poter mettere in atto i vostri Tre Principi e i sei obbiettivi concreti del vostro programma? Dopo la caduta della dinastia Qing [1911], il Partito Unificato di Zhang Binglin e altri sostennero strenuamente il compromesso con Yuan Shikai e l’opposizione alla guerra continua. Dopo la morte di Yuan Shikai il Partito Progressista di Liang Qichao e altri ha sostenuto strenuamente il compromesso con Duan Qirui e l’opposizione alla guerra continua. Il risultato furono tumulti reazionari. Voi con la vostra piccola borghesia pacifista state sottoscrivendo lo stesso patto.
Membri del Kuomintang! All’inizio eravate combattenti rivoluzionari per il trionfo della democrazia. È molto meglio combattere e perdere che fare un compromesso con i Signori della Guerra e poi morire. Durante il primo anno della Repubblica cinese [1912] Yuan Shikai fece delle promesse per sostenere la Repubblica e voi vi siete accordati con lui. Nel 1916 quando Duan Qirui propose il ripristino del parlamento, voi ancora vi siete accordati. Adesso non potete ancora una volta accordarvi con i Signori della Guerra del Nord che propongono di ripristinare il parlamento e la costituzione, per abolire il Sistema Dujun e smobilizzare le truppe. Differisce l’attuale parlamento costituzionale in qualcosa da quello del quinto e sesto anno della repubblica [1916-17]?
Non sono le speranze per l’abolizione del Sistema Dujun e la smobilitazione solo delle speranze come la tigre che cambia la pelle? Farebbe qualche differenza il cambiamento del nome da Dujun a Comandante Supremo come nelle province dello Yunnan, Sichuan, e Hunan? C’è qualche speranza per la smobilitazione delle truppe quando la guerra tra i militaristi è al suo apice, quando si combattono l’un l’altro aumentando il numero delle truppe? Il generale Xu Shuzeng disse: “Sono un sostenitore del disarmo, ma aspetto che i miei soldati siano addestrati ed equipaggiati adeguatamente per disarmare i soldati dei miei avversari”. Il generale Zang Shaozeng disse: ”Ci sono molti problemi nelle province come quelle dello Zhili, Jiangxi, e Henan e ogni provincia necessita di essere messa sotto controllo. Se i generali Cao Kun e Wu Peifu metteranno all’ordine del giorno la smobilitazione si può immaginare cosa succederà alle province?”. In realtà non si prenderanno la briga di smobilitare le truppe e abolire il Sistema Dujun, questo lo si può vedere dalle candide parole dei due rappresentanti del Beiyang.
Voi dovete completare il compito storico della rivoluzione democratica; non agite come questa gente; intendete le loro vuote parole per i bugiardi che sono.
Lavoratori, contadini, studenti, soldati, polizia, e mercanti! Finché i Signori della Guerra non saranno rovesciati non ci saranno speranze di disarmo degli eserciti delle province, né l‘abolizione del Sistema Dujun. Finché i Signori della guerra non saranno rovesciati non ci saranno speranze di ridurre la richiesta di fondi per coprire le spese militari, e questo sconvolgerà ulteriormente l’intero sistema finanziario locale e nazionale. Finché i Signori della guerra non saranno rovesciati saranno fedeli protettori dei capitali stranieri, portatori dell’influenza straniera in Cina. Finché i Signori della guerra non saranno rovesciati le esorbitanti tasse e imposizioni continueranno, continuerà il disordine e il caos e non ci saranno speranze di ritorno all’ordine. Finché i signori della guerra non saranno rovesciati l’industria non potrà decollare, e come può mantenersi e promuoversi l’educazione? Finché i Signori della guerra non saranno rovesciati non ci sarà speranza che la lotta per estendere le loro sfere d’influenza possa cessare.
Contadini, lavoratori e mercanti sono sempre le vittime di questi conflitti. Soldati innocenti e poliziotti cadono colpiti dalle loro pallottole. La loro guerra è senza fine. Noi dobbiamo mettere fine a questo interminabile sacrificio.
Solo unendosi alla lotta democratica può essere abbattuto il sistema dei Signori della Guerra e una vera pace e prosperità arriveranno. Non c’è altra via; sicuramente utilizzare metodi di compromesso per ottenere una falsa pace non può essere un’alternativa. Alcuni personaggi piccolo borghesi e politicanti usano le loro tendenze al compromesso per raggiungere una falsa pace da opporre alla lotta democratica, ma noi non dobbiamo ascoltarli. Ovviamente tutti noi vogliamo la pace, ma quella vera non quella falsa. Salutiamo la guerra per realizzare la democrazia, distruggere i signori della guerra, e liberare il popolo. Noi cantiamo le lodi di questo tipo di guerra.
10) Il Partito Comunista di Cina è l’esercito d’avanguardia del proletariato che lotta per il proletariato e agisce come suo partito rivoluzionario. Prima che il proletariato sia capace di prendere il potere nelle sue mani, considerando la condizione politica ed economica attuale di sviluppo della Cina e tutti i processi storici che stanno accadendo adesso, il compito urgente per il proletariato è di unirsi ai partiti democratici per opporsi ai Signori feudali e così creare un governo democratico.
Lo scopo concreto della lotta politica attuale non può essere limitato alla
battaglia per la pubblicazione dei dati della finanza pubblica o per la
sorveglianza alle elezioni, ecc. I nostri scopi immediati sono:
a) Riforma del sistema tariffario; abolizione della extraterritorialità e dei
privilegi speciali delle grandi potenze in Cina, stima delle sovvenzioni alle
ferrovie fatte dal capitale straniero e immediato trasferimento di tutte le
ferrovie alla gestione statale.
b) Eliminazione dei Signori della Guerra e dei burocrati, confisca delle loro
proprietà e distribuzione delle loro terre ai contadini poveri.
c) Adozione del sistema del suffragio universale.
d) Garanzie delle libertà per il popolo, di associazione, assemblea, parola e
stampa; annullamento del regolamento di polizia riguardo la salvaguardia
dell’ordine pubblico e della legge criminale sulla soppressione degli scioperi.
e) Legislazione per la protezione dell’infanzia e il lavoro femminile, leggi
sulla sicurezza sul lavoro e assicurative.
f) Legge per la riduzione delle tasse sul suolo.
g) Realizzare l’istruzione obbligatoria.
h) Abolizione del sistema lijin e di altre sovrattasse.
i) Revisione del codice legale con l’abolizione della pena di morte e della
tortura.
l) Introduzione della tassazione progressiva.
m) Organizzazione di un sistema di uguali diritti di uomini e donne di fronte
alla legge.
Sotto l’ordinamento dei signori feudali niente di questo programma minimo potrà essere realizzato con i metodi del compromesso e della petizione. Il metodo del Partito Comunista di Cina è quello di invitare il Kuomintang, gli altri partiti democratici e tutti i gruppi rivoluzionari socialisti a partecipare a un convegno e, sulle basi dei principi sopra, esposti,realizzare un fronte unito democratico per continuare a combattere contro i Signori della guerra. Questo fronte di lotta è per liberare il popolo cinese dalla doppia oppressione delle grandi potenze e dei Signori della Guerra, guerra inevitabile perché è necessaria alla Cina adesso.
I P.C. orientali sono il risultato dello sviluppo capitalistico in Oriente
di V. Vilensky
Imprecor, vol. 2, n. 104, 29 novembre 1922 - “Confronti e dibattiti”
La penetrazione del capitalismo nei paesi coloniali e semicoloniali dell’Est ha liberato le forze produttive di questi paesi e le ha fatte avanzare sulla strada dello sviluppo delle possibilità capitalistiche autoctone. Il risultato è stato che l’Oriente coloniale ha iniziato a costruire le proprie industrie, creando le proprie basi di sviluppo capitalistico. La guerra ha interrotto i collegamenti tra l’Europa e le sue colonie in Oriente, lasciando a queste ultime le proprie risorse; ciò ha accelerato a sua volta la crescita delle industrie capitalistiche autoctone, nonché la concentrazione del capitale autoctono e il suo adattamento a un’esistenza indipendente.
Ciò ha portato alla lotta rivoluzionaria in Oriente, che mira a rigettare le forme di vita estranee inadatte e a sostituirle con altre più adatte alla struttura sociale delle nazioni orientali.
Questo ha portato le nazioni orientali a confrontarsi con la necessità della lotta per la liberazione nazionale. L’odio orientale per l’imperialismo europeo porta a volte al rifiuto di tutto ciò che è europeo, comprese quelle forme di costruzione sociale che sono oggettivamente tappe inevitabili del movimento progressista dell’Est. Questo atteggiamento complica naturalmente il problema sociale all’Est e il processo del movimento rivoluzionario assume forme particolarmente complesse, profondamente colorate da tinte nazionaliste.
L’unica via sicura che può condurre le nazioni dell’Est verso il grande sbocco alla libertà dall’imperialismo è la via della rivoluzione proletaria russa. L’unica classe in grado di affrontare con successo il difficile compito della liberazione delle nazioni orientali dalla schiavitù imperialista è la classe operaia, che cresce di numero insieme alle industrie locali. Sotto le tettoie delle botteghe e delle fabbriche del Giappone, dell’India e della Cina cresce la forza organizzata dell’Oriente, che è storicamente chiamata a prendere la guida della lotta dell’Oriente contro la schiavitù dell’imperialismo. L’esperienza della Rivoluzione russa ha dimostrato che il proletariato, anche se in minoranza, può diventare il dirigente della lotta per gli interessi delle grandi masse di contadini. L’India e la Cina, per la loro struttura sociale, hanno molto in comune con la Russia pre-rivoluzionaria e questo rende l’esperienza della Rivoluzione russa particolarmente preziosa per i popoli di questi Paesi.
Lo sviluppo capitalistico in alcuni distretti della Cina e dell’India ha provocato un vasto movimento di sciopero in quei Paesi. Questo conferma ancora una volta il fatto che le leggi dello sviluppo capitalistico sono comuni all’Oriente e all’Occidente e che il movimento proletario cresce di pari passo con la crescita dell’industria.
E se il proletariato dell’Est, nato dallo sviluppo capitalistico dei Paesi orientali, trova la forza sufficiente per affermare i propri interessi di classe quando sciopera, non si può negare la necessità di formare partiti di classe rivoluzionari dell’Est. In ogni paese dell’Est dovrebbe esistere un partito comunista che opponga il suo programma a quello dei liberali nazionali e che cerchi di incanalare le varie sfumature di opinione socialista che abbondano tra gli intellettuali dei popoli orientali.
Contando sulla solida base del movimento operaio (il movimento sindacale), i partiti comunisti dell’Est possono assimilare e beneficiare dei vari circoli socialisti. L’assorbimento di questi circoli è il compito tattico più urgente per i comunisti dell’Est, mentre tutti i discorsi di conciliazione, di fronte comune con questi circoli intellettuali, sono un errore tattico che involontariamente conferma questi circoli intellettuali nella loro insularità. L’esperienza del movimento operaio giapponese, coreano e cinese ha dimostrato che questo isolamento intellettuale provoca una scissione delle forze e crea condizioni difficili per la lotta interna, ostacolando il radicamento dei partiti comunisti in questi Paesi.
È giunto il momento di ammettere che, nell’interesse della rivoluzione sociale in Oriente (almeno in Giappone, Cina e India), è imperativo dirigere tutti gli sforzi verso il rafforzamento dei partiti comunisti, che, sotto un’adeguata guida tattica e nelle condizioni delle moderne realtà politiche in Oriente, sono in grado di diventare una forza potente e attiva, che sarà in grado di intraprendere la lotta per la liberazione dei popoli dell’Oriente dal giogo dell’imperialismo europeo e americano.